EUROPA. Il giudizio universale di maggio
Nel 2019 l’euro compie vent’anni, e non si può dire che sia un giovanotto molto desiderato. Da quel lontano 1999, anno nel quale entrò nel sistema finanziario una nuova moneta che doveva unire una parte forte del mondo ricco (ed erano undici degli Stati europei, compresa l’Italia che era entrata per il rotto della cuffia e con una tassa apposita, poi restituita ai cittadini), al 2002, quando monete e banconote entrarono concretamente nei portafogli e famiglie e imprese si fecero due conti; al 2011, anno della grande paura del default greco; al 2018, con l’assalto dei populisti alla cattedrale monetaria. Vent’anni.
Nel mezzo, ci sono stati gli attacchi alle Due torri, le guerre in Iraq e Afghanistan, le primavere arabe dall’altra parte del Mediterraneo e la Grande Recessione proveniente dall’altra parte dell’oceano Atlantico. La guerra in Siria, la crisi dei rifugiati, gli accordi e i disaccordi sul clima che intanto continuava a riscaldarsi, il trionfo cinese sulla globalizzazione. Dei tanti disastri, molti sono stati attribuiti all’attuale ventenne euro, alcuni più genericamente alla più vecchia e più larga Europa; tutti alle élite che nell’ultimo ventennio – e anche prima – hanno guidato questi processi, in quelle stanze non fisiche, fatte di reti di relazioni, competenze e persino linguaggio, che connettono Bruxelles e le capitali europee. Per questo le elezioni che si terranno a maggio per eleggere il nuovo parlamento europeo si presentano, più che come un rinnovo, come un giudizio universale, populisti vs Europa. Poco importa che i cosiddetti populisti, che più correttamente bisognerebbe chiamare nazionalisti, siano distinti e divisi, quando non confusi, sul da farsi: nel giudizio universale di maggio saranno accomunati dalla viscerale retorica contro i mostri di Bruxelles, contro l’Europa unita, contro le sue leggi che limitano e umiliano le sovranità nazionali.
Sarà un voto importante, nel quale tutti coloro che hanno creduto o credono ancora che nell’unione europea (senza maiuscole) ci sia una possibilità di progresso per le sue popolazioni dovranno trovare il modo per non essere schiacciati dall’etichetta di establishment; e i nuovi establishment – perché tali sono, almeno in Italia, Ungheria, Polonia, Austria, Repubblica Ceca – dovranno trovare il modo per nascondere le contraddizioni e i conflitti che «l’unione dei nazionalismi» porta con sé. Se ne è avuto un primo esempio proprio nella trattativa sul bilancio italiano, con i cosiddetti alleati dei gialloverdi d’Italia schierati in prima fila tra i «falchi» che reclamavano un maggior rigore finanziario. Ma quest’esempio non porta a sperare bene, perché proprio nella lunga trattativa che ha portato alla fine all’accordo che ha evitato per ora all’Italia la procedura d’infrazione c’è stato il trionfo delle parole e l’oscuramento dei fatti.
l’indeterminatezza utile alla manovra
Sulla parte italiana delle barricate di parole, molto già si sa: tutto è iniziato la sera in cui la manovra è stata varata, e i suoi proponenti hanno voluto non solo – com’è legittimo anzi doveroso – mettere nero su bianco il rispetto delle promesse elettorali, ma farlo sfidando le regole contabili europee.
Rapidamente quella sfida è diventata essa stessa l’oggetto della manovra, facendo passare in secondo piano quelli più concreti con i loro punti forti e deboli: cos’è, esattamente, «quota 100» sulle pensioni? Chi, dove, quando andrà in pensione? E sarà possibile costruire in pochissime settimane la macchina amministrativa per introdurre il reddito per i poveri? Chi, dove, quanti sono i poveri? L’indeterminatezza di questi capitoli della manovra – i più importanti, ma non i soli, ci sono poi rilevanti modifiche fiscali che sono state un po’ oscurate – è tornata utile nella fase successiva, quella della trattativa.
Eh già, perché i toni di sfida e trionfo iniziali si sono man mano stemperati, i due azionisti del governo hanno fatto un passo di lato per far entrare in scena, a giorni alterni, presidente del consiglio e ministro dell’economia, a gestire la trattativa, resa necessaria dal fatto che il semplice bullesco annuncio di voler spezzare le reni all’Europa ha spezzato un bel po’ di risorse qui in Italia, accelerando una fuga dei capitali già iniziata da maggio.
E nella trattativa è tornata utile la totale indeterminatezza delle misure «bandiera»: una aggiustatina ai requisiti, un’altra elle previsioni sulle adesioni, un piccolo rinvio, qualche finestra in più ed ecco venire fuori qualche miliardo di spesa in meno per il 2019.
Ne servivano ancora altri, e allora sono stati tagliati anche quei pochi investimenti, che in realtà erano comparsi a un certo punto un po’ a caso nella lista della manovra, tra l’altro proprio per compiacere l’Europa che lamentava l’assenza di spese in conto capitale, destinate davvero a stimolare la crescita.
Un ulteriore aiutino – per la eterogenesi dei fini, e anche dei conti – è venuto dalla correzione delle ottimistiche previsioni sul Pil: il fatto che l’Italia è quasi in recessione in realtà peggiora tutto, nella sostanza, e anche i conti pubblici; però la riduzione del Pil previsto ha consentito al governo gialloverde di mantenersi sopra la soglia simbolica del 2% del deficit (la stessa cifra assoluta di deficit sarebbe risultata in una percentuale inferiore, se avesse avuto, al denominatore un Pil più grande).
polvere sotto futuri tappeti
Dunque non c’è stato nessun tradimento o annacquamento delle misure populiste – anche se tra gli elettori gialloverdi il dubbio serpeggia – per il semplice motivo che le stesse misure erano già ampiamente annacquate o vaghe da prima. C’è stato un rinvio delle spese più grosse di qualche mese e nessuna nuova entrata reale e strutturale per finanziarle: come nella più antica tradizione italiana, la polvere sotto futuri tappeti.
Da parte europea, si è acconsentito a questo gioco per non forzare troppo la mano in vista delle elezioni, e anche perché le stesse rigidissime regole europee da tempo si prestano a eccezioni, flessibilità, annacquamenti vari. Lo diciamo non con rimpianto o delusione: è stata la linea della Commissione, quella di non ammettere di aver sbagliato linea negli anni duri della crisi e trovarsi a contrattare flessibilità con tanti pesi e tante misure. E non ha portato né ad aiutare davvero i governi amici dell’Europa né a dare una immagine nuova, diversa, dell’Europa e delle sue istituzioni, capace di contrastare i populismi.
trionfo di due ipocrisie
Terreno sul quale l’Europa, richiamandosi ai suoi princìpi fondatori, potrebbe invece davvero fare la differenza. Colpendo i regimi in formazione laddove attaccano le libertà, demoliscono gli sforzi verso la parità di genere, chiudono le frontiere e alzano muri. Inaugurando una nuova politica economica comune, chiedendo ai Paesi in surplus commerciale e fiscale di fare da locomotiva per gli altri. Combattendo il dumping fiscale e salariale, nonché quello in tema ambientale. Usando insomma gli strumenti che ci sono, a Bruxelles, e costruendone di nuovi. Invece c’è stato il trionfo di due ipocrisie, due false manovre: quelle populiste, che promettono senza mantenere oppure mantengono le promesse a spese dei più deboli e delle generazioni future; e quelle rigoriste, ridotte ormai al simulacro di se stesse ma ancora in piedi, se non altro come alimento alla contro-propaganda antieuropea.
Roberta Carlini
—————————————
ROCCA 1 GENNAIO 2019
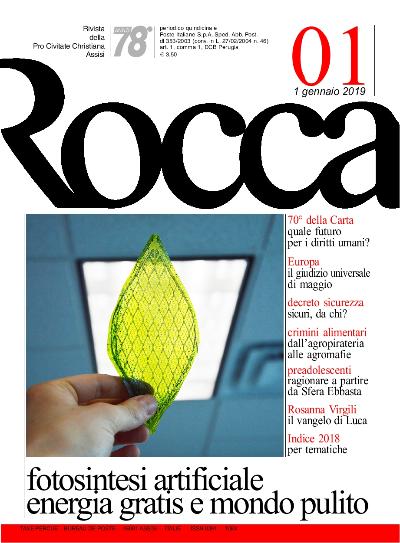
—————————————
Dibattito&Commenti
—————————————

 Il voto meridionale ai 5 stelle
Il voto meridionale ai 5 stelle
31 Dicembre 2018 by Forcesi | su C3dem
Secondo la vulgata maggioritaria, il voto a valanga che il Mezzogiorno ha riservato al M5S si spiega con la voglia, quasi atavica, di assistenzialismo delle popolazioni meridionali, espressione, a sua volta, di una generalizzata predisposizione al lamento e alla rivendicazione di compensazioni e di risarcimenti quale conseguenza necessaria per il fatto di essere ultimi. Ultimi per ricchezza, per qualità dei servizi, per infrastrutture, etc. In effetti, dall’intervento straordinario in poi, sino alla sperimentazione delle prime politiche di sviluppo locale, le risorse in più destinate al Mezzogiorno hanno avuto questa motivazione: contrastare le asimmetrie che condannavano il sud a subire processi di crescita molto più lenti rispetto a quelli delle aree più avanzate del Paese. E tuttavia, nonostante gli ingenti flussi finanziari che dalla Cassa per il Mezzogiorno sino ai fondi strutturali europei che si sono riversati nel sud, la questione del ritardo meridionale resta in tutta la sua portata di questiona nazionale. Colpa dei meridionali? Delle loro classi dirigenti? Della cattiva politica? Del familismo, tratto tipico della società in tutti i suoi livelli? Dello scarso capitale sociale? Della criminalità organizzata? Di una pubblica amministrazione arcaica? Di una naturale inclinazione delle popolazioni a preferire la rendita alla innovazione? Dello scarso senso del bene comune? Certo, quelle elencate, insieme a chissà quante altre ancora, sono plausibili cause di una arretratezza che continua inesorabilmente a spingere il sud verso la periferia di un Paese, l’Italia, che di per se già vive – come ha acutamente osservato il cardinale Bassetti – una situazione di “sospensione”: può progredire, ma potrebbe anche regredire. Tutto dipende da quale “visione” prevale: quella della chiusura, della difesa di un piccolo mondo antico oppure quella della apertura e della rinascita del sogno europeo. E, soprattutto per la società meridionale, tutto dipende da quale speranza essa si lascia abitare.
Il voto meridionale ai 5 stelle, in dimensioni che neppure la Dc negli anni d’oro riusciva a raggiungere, con il conseguente prosciugamento del Pd, trova in una fragorosa domanda di cambiamento la sua motivazione prevalente. Sì, il voto ai 5stelle, esprime nel profondo una speranza: non una generica speranza di cambiamento, bensì quella di un riscatto e di uno sviluppo. Si è trattato, indubbiamente, di una speranza malriposta e poco pensata, ma pur sempre, espressione di una volontà di “prendere le distanze dalla interpretazione rancorosa del passato e del presente”, come ha di recente osservato Panebianco. Si è sempre affermato che il voto nel sud è stato un voto clientelare, di scambio, difficilmente catturabile da una idea di politica come bene comune. Ebbene, da questo punto di vista, le elezioni del 4 marzo hanno rappresentato una grande discontinuità: un pezzo significativo della società meridionale ha voluto esercitare, come mai prima, la libertà di voto: ha voluto dire basta con i cacicchi locali; basta con i loro cerchi magici; basta con la pervasività di una politica che colonizza ogni ganglio della vita delle persone. Un pezzo di società che rifiuta qualunque forma di paternalismo statale, che non è disposta a nascondere i propri vizi dietro un ridicolo revanscismo borbonico paradossalmente contiguo alla cultura nazional-populista. Un pezzo di società civile che non ne poteva più dei soliti politici candidati a tutto pur di conservare la loro fetta di micropotere, con il solito linguaggio inconcludente ma presuntuosamente onnisciente che nascondeva pochezza progettuale e povertà spirituale. I soliti politici che quando li incrociavi per strada cambiavano direzione.
A questo pezzo importante di società meridionale la classe dirigente democratica, che negli ultimi decenni ha egemonizzato l’amministrazione di tutte le Regioni del sud, non ha saputo offrire non dico un disegno ma almeno qualche cenno di politica riformista, tranne rare eccezioni come Guglielmo Minervini, l’assessore alle politiche giovanili e alla trasparenza della Regione Puglia, purtroppo, scomparso qualche anno fa al quale si devono gli unici innovativi interventi di sviluppo dal basso attraverso la valorizzazione dei “bollenti spiriti giovanili”.
Nessuna espressione della politica autoreferenziale è in grado di interloquire con questa società non solo perché non possiede la grammatica giusta ma neppure quella cultura del progetto che ha contraddistinto il grande pensiero meridionalista. Come avverte De Rita “non è questione di casta o non casta; davanti al rischio di deriva occorre una élite competente e capace di farsi carico della crisi”. Occorrono quelle minoranze profetiche di choc di cui parlava Maritain, linfa essenziale della democrazia nei momenti di crisi. Ma per formare queste élite, queste minoranze profetiche occorre una idea generale di società intorno alla quale catalizzare le competenze e le passioni. Una visione che oggi non è dato scorgere. La crisi del Pd si spiega anche in questi termini. Nessuno nel Pd oggi è capace di visione.
Col risultato, che questo pezzo di società civile meridionale, disillusa di fronte alla pochezza pentastellata, si trova davanti ad un bivio: potrebbe rifugiarsi nell’astensionismo o peggio, consegnarsi ormai esausta alle lusinghe demagogiche e perciò estremamente pericolose della Lega nazionale di Salvini. Un epilogo che potrebbe segnare la fine della questione meridionale non per raggiungimento degli obiettivi ma per consunzione della società meridionale.
Luigi Lochi










 AService Studio
AService Studio
[…] EUROPA. Il giudizio universale di maggio di Roberta Carlini, su Rocca. […]