DIBATTITO. Un governo gialloverdenero. Fra populismo ed establishment c’è una terza via? Il paese è altrove, finiamola con le geremiadi M5S-Lega. Sono andati in pezzi i modi in cui si sono formate tutte le nostre categorie politiche, le identità, dalla destra alla sinistra
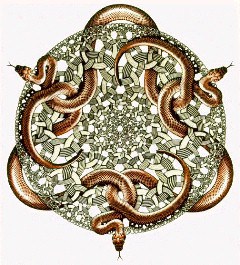
Un governo gialloverdenero
di Roberta Carlini
Con il nuovo governo giallo-verde, nato al termine di una lunghissima trattativa continuamente oscillante tra il grottesco e il drammatico, l’Italia ha assunto una nuova collocazione in Europa. Più lontana dal blocco dei Paesi fondatori, quelli del centro, distaccata anche dagli esperimenti e dai problemi del blocco del Sud, che una volta si definiva ironicamente il Club Mediterranee; e vicina al cosiddetto «blocco nero», costituito dai Paesi dell’Est e guidato dall’Ungheria di Orban. Non ci sono dubbi infatti sull’identità politica della coalizione che – non votata dalle urne come alleanza, perché fatta da partiti investiti di un voto popolare forte ma distinto – ha trovato infine l’accordo sulla presa del potere.
l’immigrato come bersaglio
La cartina di tornasole è la presenza di Matteo Salvini all’Interno – l’uomo che ha portato la Lega da Bossi alla Le Pen e che è entrato al Viminale poche ore dopo aver fatto l’ennesimo tweet con un immigrato come bersaglio. Non si tratta solo di una visione del nostro prossimo, e del ruolo di una società evoluta in un mondo complesso (che già non è poco), ma dell’uso sistematico e spregiudicato del capro espiatorio come modo per dirottare il disagio e la protesta sociale, indicando un nemico. Meglio se debole, non organizzato, ovviamente non votante, esterno a noi, e antipatico. Salvini è il pilota di tutto ciò, ma non sarebbe riuscito a portare questa ideologia al potere se non avesse avuto l’apporto dell’indistinto magma del Movimento Cinque Stelle – che già da tempo sul tema aveva cominciato a fare le sue scelte, con la campagna dell’estate scorsa contro i salvataggi in mare – al quale si è poi aggiunto, non a caso, l’appoggio esterno degli eredi tecnici del fascismo, i Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni.
l’euro responsabile di tutti i mali
Con la stessa tattica – la costruzione del capro espiatorio – i nuovi governanti hanno costruito il consenso attorno alle loro proposte economiche. Il nemico in questo caso è l’euro. Ma trattandosi di una materia infiammabile, sia la Lega di Salvini, che stampava felpe «no euro», che il M5S di Grillo, che sull’euro voleva fare un referendum, hanno sbianchettato il tema sia dalla campagna elettorale che dalle bozze definitive del proprio programma. Finché non è esploso, grazie all’intervento del presidente della Repubblica che ha ritenuto necessario usare le sue prerogative contro la nomina di Paolo Savona all’economia. Il problema non era tanto in posizioni euroscettiche, o critiche verso la difettosa architettura che regge la moneta unica; ma nell’esistenza di un piano, scritto e pubblicato, per gestire la concreta uscita dell’Italia dall’euro. Spostato Savona – paradossalmente agli Affari Europei – e nominato al suo posto un mini-Savona, ossia un altro navigato, ma meno famoso, professore che frequenta lo stesso establishment universitario-amministrativo, il problema resta: cosa vogliono fare i nostri dell’euro, indicato come responsabile di tutti i mali? Davvero pensano che la base produttiva del Nord, come l’ex ceto medio spaventato che li ha votati, vogliano l’avventura di una Italexit? E davvero pensano che il loro governo abbia la forza e l’autorevolezza per intraprendere la strada della trattativa per far invertire la rotta all’Europa matrigna dell’austerità? Ma soprattutto, a che scopo?
la proposta fiscale
Qui veniamo all’altro elemento che dà identità e sostanza al nuovo governo: la proposta fiscale, della quale già si è parlato sulle colonne di Rocca. Il patto fiscale è quello fondante della cittadinanza, non è una questione tecnica o da lasciare agli esperti. E la flat tax, cavallo di battaglia della Lega recepito con piccolissime modifiche dal contratto Salvini-Di Maio, ha una precisa idea del patto fiscale: non solo quella che le tasse debbano scendere (popolarissima: a chi piace pagare le tasse?) ma che debbano scendere di più per i più ricchi. Che il primo governo populista salito al potere in Europa possa averlo fatto sulla base di una politica che premierà solo una élite, ossia i più ricchi, può sembrare incomprensibile. Ma è esattamente quel che è successo negli Stati Uniti con Trump, che della classe sociale dei super-ricchi incarnava anche personalmente il profilo. Per l’Italia, la proposta contenuta nel contratto di governo comporterebbe la più drastica redistribuzione del reddito dai ceti bassi e medi a quelli abbienti, comunque la si finanzi: con altre tasse – addirittura, il neoministro dell’economia Giovanni Tria ha aperto alla possibilità di finanziarla con un aumento dell’Iva, che è l’imposta che grava di più su chi consuma una quota maggiore del proprio reddito, ossia i più poveri; con tagli alla spesa sociale, come chiedono i rigoristi; o con nuovo debito.
Sulla possibilità di finanziare il taglio fiscale in deficit torna il tema del vincolo/ nemico europeo. Quello che impedirebbe di realizzare i fantastici piani del governo gialloverde sulla base dei suoi diktat. In una situazione normale, per un paese che non è già gravato da un enorme debito, il deficit non è buono o cattivo in sé: dipen- de da quello che se ne fa.
Traducendo con un esempio: si possono regalare 10000 euro al mese a un dirigente benestante – appunto, con la flat tax – o mettere gli stessi soldi in un asilo nido. Nel primo caso, il dirigente ne spenderà una piccola parte e la metterà in circuito nell’economia; nel secondo, i soldi andranno a pagare stipendi delle maestre, sedi, mense, ed entreranno tutti nel circuito dell’economia.
il match del debito
Ma non siamo in una situazione normale, ci sono limiti alla possibilità di ricorrere a deficit. E la colpa non è tutta della cattiveria dell’Europa, della Germania, di Bruxelles. Un Paese che ha un debito pubblico pari al 132% del proprio prodotto, e che ogni anni deve rifinanziarlo sul mercato, cioè cercare risparmiatori disposti a comprare o rinnovare titoli per 400 miliardi, può ignorare fare nuovi debiti a cuor leggero? Anche se l’euro e l’Europa non ci fossero, o cambiassero di colpo politica, il moloch del debito sarebbe sempre lì. Bisogna gestirlo, usando gli spazi di manovra – cosa non fatta dal governo Renzi, che ha dilapidato la breve tregua data dalla politica monetaria accomodante della Bce. Prima, di fronte a questa realtà, c’era una linea predominante di pensiero: non c’è alternativa, non possiamo fare niente, o quasi niente. Adesso, dalle urne italiane, è venuta fuori confusamente un’alternativa nazionalista, travestita da anti-establishment ma in realtà dannosa soprattutto per le classi subalterne.
l’alternativa
Uscire dalla confusione può essere un effetto positivo della nuova fase politica. A patto però che da qualche parte – da quella che un tempo si definiva la sinistra – venga fuori anche la chiara indicazione di una alternativa europeista, di Europa sociale, indirizzando subito l’attenzione e le risorse comuni alle vere vittime della globalizzazione e della grande trasformazione che stanno vivendo le nostre economie, e costruendo le istituzioni di un bilancio, un governo, una politica sovranazionali. Una strada difficile ma obbligata; possibile però solo se che in tutt’Europa, nelle sue élite come nei suoi popoli, e soprattutto tra gli eredi della sua tradizione socialdemocratica, si prende atto del fallimento politico dell’unificazione monetaria ed economica, che si è manifestato un po’ ovunque ma che adesso ha portato alla svolta italiana; e si passi a una pagina nuova, che sola può arginare il minaccioso blocco nero giunto da Visegrad fino a Roma.
Roberta Carlini
——–
POLITICA E SOCIETÀ
fra populismo ed establishment c’è una terza via?
di Ritanna Armeni su Rocca
E’ possibile oggi una strada che non sia la scelta fra sovranismo e mercati? In Italia sembra non esistere. Anzi dopo i risultati elettorali del 4 marzo, lo stallo che ne è seguito, le difficoltà emerse nella formazione del governo e infine la crisi istituzionale e la decisione di nuove elezioni, la divaricazione tra i due estremi, se è possibile, si è accentuata. Da una parte i populisti – partiti e cittadini – che non accettano l’Europa, le regole imposte dai grandi centri economici e finanziari, che ritengono dannosa la moneta unica almeno nella sua realizzazione, coercitive le regole di Bruxelles, mortale il rigore imposto in questi anni. Dall’altra chi pensa che non sia possibile per alcun paese del vecchio continente vivere fuori dal contesto europeo, ne accetta le regole (al massimo ne contesta, e flebilmente, alcune) anche quando queste sono dolorose. Per la classe dirigente la globalizzazione economica così come interpretata e codificata dalle istituzioni europee costituisce la strada principale da seguire. Che porterà pur attraverso innegabili sacrifici al rilancio dello sviluppo.
È stato impossibile finora uscire da questa divisione con una proposta che tenga conto delle verità che le due visioni contengono e ne respinga gli elementi ideologici. Difficile in Europa dove la battaglia fra partiti populisti ed establishment è in corso e ha raggiunto una delle sue punte nella Brexit; difficile in altre parti del mondo come gli Stati uniti dove la presidenza di Donald Trump ha sancito la vittoria del populismo.
Che cosa rende difficile una mediazione sociale e politica fra queste due istanze che nascono e si muovono a partire da fenomeni concreti ed esigenze altrettanto reali? I populisti hanno dalla loro sicuramente la sofferenza di gran parte del popolo, della parte meno abbiente e fortunata dei cittadini cui le regole europee hanno imposto sacrifici duri senza offrire la speranza di un’uscita dalla crisi e di un nuovo sviluppo. Rappresentano una base di rabbia reale di cui è sbagliato non tenere conto. Anche se – e questo e il secondo punto importante – essa ha come conseguenza politica il sovranismo, l’idea che senza Europa, fra italiani, la strada per lo sviluppo sarebbe senza ostacoli. E comprende la soluzione con la forza e la brutalità il problema dell’immigrazione, tragedia planetaria di cui non sono responsabili le attuali istituzioni europee, ma che l’Europa certamente non ha aiutato e risolvere.
L’establishment, la classe dirigente del paese, con un seguito consistente anche se ora non maggioritario, ritiene che nessuna politica economica e sociale possa essere perseguita senza un’integrazione europea, che gran parte delle regole imposte dalle istituzioni di Strasburgo costituiscano comunque la base inevitabile tenuto conto anche del nostro debito, che lo sviluppo in un’economia e in una società chiuse sia non solo difficile ma irrealizzabile. Infine che al popolo vada offerta una soluzione credibile e non solo la possibilità di sfogo della rabbia e dell’insofferenza.
Per uscire da questa divisione, per riprendere un discorso realmente politico i due fronti dovrebbero scomporsi. Il motivo per cui questo non avviene sta nell’assenza di un terzo protagonista che in Italia fino a qualche tempo fa era presente, e che anzi nel passato ha rappresentato gran parte del paese e che oggi sembra scomparso. Parliamo di un soggetto di sinistra capace di portare nella società e nel dibattito quella che un tempo e con un termine antico era definita «discrimi- nante di classe». Solo mettendosi le potenti lenti che essa fornisce è possibile oggi distinguere senza pregiudizi quel che c’è di vero nel fiume in piena del populismo: la sofferenza degli ultimi, la delusione dei lavoratori, la paura di un ceto medio impoverito, i timori di tutti per un futuro sempre più incerto. E condannare con severità e convinzione quel che invece porta inevitabilmente verso una società chiusa e razzista, la repulsione verso il diverso, la lotta contro i migranti, l’appiattimento su miti e tradizioni retrive, una cultura povera e provinciale perché impermeabile alle grandi trasformazioni planetarie.
Solo tenendo presente le reali condizioni del popolo – che non è una massa priva di consapevolezza e intelligenza, come gran parte dell’establishment europeista tende a credere – si può pensare a una modifica delle condizioni imposte dalle istituzioni economiche e finanziarie, a una battaglia che superi tutti gli egoismi non solo quelli italiani.
La ricostituzione di un dialogo e poi di un legame fra classe dirigente e il popolo è oggi difficile, anzi alla luce dei recenti avvenimenti politici italiani, appare quasi impossibile se questa non riconosce, traendone le conseguenze, che finora le politiche europee rigoriste e antipopolari, non adeguatamente contrastate, hanno prodotto impoverimento e incertezza. Finché quindi non si elaborano progetti diversi che muovano dalle condizioni sociali degli italiani. Finché non si chiede e pretende un’Europa che sia davvero la patria di tutti.
Fino a qualche tempo fa la presenza di forze dichiaratamente di sinistra, anche se divise e non sempre adeguate, aveva reso questo possibile. Oggi la sinistra è schiacciata nella cultura e nella pratica della classe dirigente, identificata come una casta chiusa nel proprio status, insomma, parte dell’«alto» della società.
Ed ecco che la terza via si stempera fino a scomparire. E i rappresentanti delle vecchie classi dirigenti da un lato e le nuove forze politiche che pensano di rappresentare il popolo dall’altro percorrono strade diverse e inconciliabili. In una lotta che non conosce mediazioni, che non rispetta né le istituzioni né un comune sentire democratico. Che lascia sul terreno tanti e tali detriti e veleni da rendere non più fertile il terreno su cui si muovono.
Ritanna Armeni

———————————–
 Il paese è altrove, finiamola con le geremiadi
Il paese è altrove, finiamola con le geremiadi
M5S-Lega. Sono andati in pezzi i modi in cui si sono formate tutte le nostre categorie politiche, le identità, dalla destra alla sinistra
di Marco Revelli, su il manifesto
EDIZIONE DEL 23.05.2018
Da oggi, come si suol dire, «le chiacchiere stanno a zero». Nel senso che le nostre parole (da sole) non ci basteranno più. D’ora in poi dovremo metterci in gioco più direttamente, più “di persona”: imparare a fare le guide alpine al Monginevro, i passeur sui sentieri di Biamonti nell’entroterra di Ventimiglia, ad accogliere e rifocillare persone in fuga da paura e fame, a presidiare campi rom minacciati dalle ruspe. Perché saranno loro, soprattutto loro – non gli ultimi, quelli che stanno sotto gli ultimi – le prime e vere vittime di questo governo che (forse) nasce.
Dovremmo anche piantarla con le geremiadi su quanto siano sporchi brutti e cattivi i nuovi padroni che battono a palazzo. Quanto “di destra”. O “sovranisti”. Forse fascisti. O all’opposto “neo-liberisti”. Troppo anti-europeisti. O viceversa troppo poco, o solo fintamente. Intanto perché nessuno di noi (noi delle vecchie sinistre), è legittimato a lanciare fatwe, nel senso che nessuno è innocente rispetto a questo esito che viene alla fine di una lunga catena di errori, incapacità di capire, pigrizie, furbizie, abbandoni che l’hanno preparato. E poi perché parleremmo solo a noi stessi (e forse non ci convinceremmo nemmeno tanto). Il resto del Paese guarda e vede in altro modo. Sta già altrove rispetto a noi.
Forse resta dubbioso sulla realizzabilità dei programmi, forse indugia incerto per horror vacui, ma non si sogna neppure di usare le vecchie etichette politiche del Novecento per qualificare un evento fin troppo nuovo e nel suo contenuto sociale inedito, come inedita è la struttura della società in cui è maturata la svolta.
IL FATTO è che questo governo è la diretta espressione del voto del 4 di marzo. E che quel voto ha costituito e rivelato non un semplice riaggiustamento negli equilibri politici, ma un terremoto di enorme magnitudine, una vera apocalisse culturale, politica e sociale. Piaccia o non piaccia (a me personalmente non piace) ma questa coalizione giallo-verde esprime – per quanto sia esprimibile – il messaggio emerso più che maggioritariamente dalle urne. Traduce in termini istituzionali l’urlo un po’ roco che veniva dalle due metà dell’Italia, e che diceva, con toni e sotto colori diversi, che come prima non si voleva e non si poteva più continuare. Che non se ne poteva più. E che quegli equilibri andavano rotti.
FORSE SOLO l’asse tra Cinque stelle e un Pd de-renzizzato avrebbe potuto corrispondere a quegli umori (e malumori), ma la presenza ingombrante del cadavere politico di Matteo Renzi in campo dem l’ha reso impossibile. Non certo un governissimo con tutti dentro, avrebbe potuto farlo. O un governo del Presidente. Che avrebbero finito per generare una gigantesca bolla di frustrazione e rancore da volontà tradita, velenosa per la democrazia quant’altra mai. Cosicché non restava che questo ibrido a intercettare i sussurri e le grida di una composizione sociale esplosa, spaesata e spaventata come chi abiti un paesaggio post-catastrofico, geneticamente modificato da una qualche mutazione di stato.
ED È QUESTO il secondo punto su cui riflettere. Questo nostro trovarci a valle di una «apocalisse» come l’ho chiamata, pensando all’accezione in cui Ernesto De Martino usava l’espressione «apocalisse culturale». Cioè una «fine del mondo» (questo era il titolo del suo libro). Anzi, la fine di un mondo. Che è appunto la nostra condizione. Perché un mondo è davvero finito. È andato in pezzi: il mondo nel quale si sono formate pressoché tutte le nostre categorie politiche, e si sono strutturate tutte le nostre pregresse identità, dalla destra alla sinistra, e si sono formalizzati i nostri linguaggi e concetti e progetti. Nessuna di quelle parole oggi acchiappa più il reale. Nessuno di quei modelli organizzativi riesce a condensare un qualche collettivo. Nessuna di quelle identità sopravvive alla prova della dissoluzione del “Noi” che parte dal default del lavoro e arriva a quello della democrazia.
CONTINUIAMO testardamente a cercar di cacciare dentro il cavo vuoto dei nostri vecchi concetti i pezzi di una realtà che non vuol prenderne la forma e si ribella decostruendosi prima ancor di uscire di bocca. Continuiamo a sognare la bella unità tra diritti sociali e diritti umani universali che il movimento operaio novecentesco aveva miracolosamente realizzato, e non ci accorgiamo che non sono più “in asse”. Che oggi i primi sono giocati contro i secondi, da questo stesso governo che a politiche feroci sul versante della sicurezza – alla negazione dei diritti umani – associa un’attenzione alle politiche sociali (per lo meno per quanto riguarda il loro riconoscimento nel programma) sconosciuta ai precedenti.
LIQUIDIAMO come «il più a destra, in tutta la storia della Repubblica» questo governo (non è che il governo Tambroni nel 1960 o quelli Berlusconi-Fini della lunga transizione scherzassero…), senza riflettere sul fatto che i due partiti che lo compongono hanno in pancia una bella percentuale di elettorato “di sinistra” (un buon 50% i cinque stelle, un 30% o giù di lì la Lega). Mentre pressoché tutta la stampa “di destra” (da Vittorio Feltri a quelli del Foglio e del Giornale), i quotidiani mainstream, gli opinion leaders “di regime” (pensiamo a Bruno Vespa), le agenzie di rating, i Commissari europei, ostenta pollice verso. Qualcosa evidentemente si è rotto nei meccanismi della nostra produzione di senso.
D’ALTRA PARTE nemmeno il popolo è più quello di una volta: il popolo dei populismi classici, unità morale portatrice di virtù collettive, unito a coorte e pronto alla morte. È al contrario una disseminazione irrelata di individualità. L’ha mostrato perfettamente la ricerca su «Chi è il popolo» realizzata da un gruppo di giovani ricercatori nelle nostre periferie e presentata sabato scorso a Firenze: il tratto comune a tutte le interviste era l’assenza di denominatori comuni. La perdita del senso condiviso della condizione e dell’azione. La scomparsa dall’orizzonte esistenziale del conflitto collettivo, in un quadro in cui l’unica potenza sociale riconosciuta, l’unico titolare del comando, è il denaro, inattingibile nella sua astrattezza e quindi incontrastabile.
SE UN NOME vogliamo dargli, è “moltitudine”, non tanto nel senso post-operaista del termine, come nuova soggettività antagonistica, ma in senso post-moderno e post-industriale: l’antica «classe» senza più forma né coscienza. Decostruzione di tutte le aggregazioni precedenti. In qualche misura «gente»… Cosicché anche i populismi che si aggirano, nuovi spettri, per il mondo sono populismi anomali: populismi senza popolo.
Per questo è bene rimetterci in gioco «in basso». Nella materialità della vita comune. Corpi tra corpi. A imparare il nuovo linguaggio di un’esperienza postuma. Lasciando da parte, almeno per il momento, ogni velleità di rappresentanza che non riuscirebbe a essere neppure rappresentazione.
———————————————————–









 AService Studio
AService Studio
Lascia un Commento