Tag Archives: EuropaCheFare? ALADINEWS
Oggi giovedì 30 marzo 2017





—————————————————————————————————
![]() Editoriali di Aladinews. EuropaCheFare?
Editoriali di Aladinews. EuropaCheFare?
————————————————
SOCIETÀ E POLITICA »TEMI E PRINCIPI» DIFENDERE LA COSTITUZIONE

Schiavitù, le promesse mancate
di Stefano Rodotà
«Articolo 36 della Costituzione “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”». la Repubblica, 29 marzo 2017 (c.m.c.)
EuropaCheFare?
 L’Europa è in crisi perenne: ecco cinque punti (necessari) per uscirne
L’Europa è in crisi perenne: ecco cinque punti (necessari) per uscirne
Perché i documenti e i proclami di unità non vengano disattesi dai fatti e dalla storia è necessario che alcuni punti del patto che unisce i paesi europei siano rivisti: dall’idea di EU a più velocità, alle politiche di difesa
di Francesco Grillo

«L’Europa sarà forgiata dalle sue crisi e sarà la somma delle soluzioni trovate per risolvere tali crisi»: Jean Monnet, primo presidente della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio e padre del progetto di cui si sono appena celebrati i sessanta anni, spiegò – meglio di chiunque altro – che la forza dell’Unione Europea era nella sua precarietà. E nel fatto di non avere alternative.
Ma quali sono oggi le soluzioni disponibili all’Europa alle prese con la sua crisi più acuta? Quali soluzioni concrete riusciamo a intravedere dietro la valanga di parole, comprese quelle di una dichiarazione firmata a Roma che rassicura che “l’Europa è indivisa ed indivisibile” proprio quattro giorni prima che all’Europa arrivi ufficialmente, per la prima volta, la richiesta di uno dei propri membri di separarsi dagli altri? Io credo che siano tre gli elementi che stanno emergendo e che, forse, fanno una proposta sulla quale cominciare a costruire un progetto politico transnazionale. Rinunciando ad una retorica – priva di risultati – che è, forse, il nemico peggiore di un sogno che appartiene a tutti.
Anche tra i paesi fondatori dell’Unione Europea esistono vere e proprie faglie, come quelle che hanno messo l’Italia contro la Germania sulle politiche di austerità, e focolai di dissenso nei confronti dell’Europa (come quelli che in Francia fanno del Fronte Nazionale il primo partito)
Più che a “multi velocità”, l’Europa del futuro sarà a “piani”. A ciascuno, però, dovrà corrispondere una condivisione di poteri piena e senza più ambiguità. L’idea delle “diverse velocità” è, in effetti, sbagliata in partenza. Sbagliata perché fa pensare che tutti si dirigono verso lo stesso obiettivo, distinguendo però tra Soci “d’oro” ed altri di caratura più bassa. E gettando, quindi, basi solide per ulteriori liti nel club. Ma sbagliata anche perché ipotizza che tra quelli di Serie A, ci siano, necessariamente, tutti e sei i Paesi fondatori (come ha precisato Gisgard D’Estaing) trascurando che, invece, anche tra i fondatori esistono vere e proprie faglie (come quelle che hanno messo l’Italia contro la Germania sulle politiche di austerità) e focolai di dissenso nei confronti dell’Europa (come quelli che in Francia fanno del Fronte Nazionale il primo partito).
Più interessante, invece, è ipotizzare (come fa l’Economist) che l’Europa accentui quella che è già una sua caratteristica: a diverse tipologie di politiche da condividere, corrispondono diverse aggregazioni. Succede già con l’Unione che è a 27 membri, ma che nel “mercato comune” arriva a 32 e scende a 19 con l’Euro. La differenza, però, è che, da questo momento, le scelte volontarie, dovranno essere chiare e non ambigue.
Far parte di una Schengen riformata, non potrà che comportare – per ragioni logiche e valoriali – l’accettazione di una frontiera comune, con un’unica polizia doganale e, ovviamente, un unico diritto d’asilo. Continuare a far parte dell’Euro non potrà che significare, mettere insieme le politiche fiscali ed economiche ed avere un unico Ministro responsabile di fronte ai contribuenti. Lo stesso varrà per le politiche di sicurezza o di difesa che sono tecnicamente impossibili se non rispondono ad un unico comando e ad apparati che condividono informazioni. Un’Europa fatta di scelte serie ma a geometria variabile; capace di superare i limiti dell’idea stessa hegeliana) di Stato moderno (indivisibile); ma anche di estendersi ulteriormente a chi non ne fa parte (ad Israele o alla Tunisia che, forse, sarebbero più forti se più vicini).
Continuare a far parte dell’Euro non potrà che significare, mettere insieme le politiche fiscali ed economiche ed avere un unico Ministro responsabile di fronte ai contribuenti. Lo stesso varrà per le politiche di sicurezza o di difesa che sono tecnicamente impossibili se non rispondono ad un unico comando
La scelta di far parte dell’Europa (in una delle sue configurazioni) dovrà, però, essere anche pienamente democratica. È impensabile pensare di continuare ad andare avanti con gli sherpa. Così come è impensabile costruire una qualsiasi delle integrazioni che abbiamo appena citato, senza fare la fatica di coinvolgere i cittadini. Sono loro i beneficiari, il motore e i difensori di ultima istanza di un progetto che non può più appartenere ad élite che hanno fallito. È, dunque, velleitaria qualsiasi ulteriore ipotesi di integrazione se non ci porremo – subito – il problema di incoraggiare lo sviluppo di un’opinione pubblica capace di aggregarsi sui grandi temi in movimenti transnazionali (come proverà a fare Varoufakis). Di istituire per il Parlamento Europeo collegi elettorali non più su basi nazionali (e con un forte utilizzo di voto elettronico). Di investire in un demos europeo, a partire dalle generazioni più giovani per le quali occorre rendere ERASMUS immediatamente disponibile a tutti.
Infine, poi, a ciascun matrimonio dovrà corrispondere una realistica possibilità di divorzio. Le unioni peggiori sono, proprio, quelle che non si possono sciogliere. Perché trasformano l’amore in una spirale di ricatti. Come è successo con la Grecia. L’Unione del futuro dovrà avere anche questa forma di flessibilità. Proprio per rendere meno traumatiche le crisi e le scelte iniziali; più liberi i suoi contraenti e più capaci di reinventare le ragioni per stare insieme senza litigare. Ovviamente non è pensabile che – all’improvviso – si possa sciogliere una politica di difesa comune. E, tuttavia, deve essere ipotizzabile che – dopo un certo periodo di tempo, più o meno lungo a seconda della politica – gli alleati abbiano la possibilità di verificare i termini dell’accordo e, eventualmente, uscire secondo regole pre-definite.
L’Europa attuale ovviamente non si butta domani. Ma va studiato un percorso per arrivare ad una configurazione molto più flessibile e concreta. E, dunque, capace nei fatti di traghettare nel ventunesimo secolo un sogno che cominciò mettendo insieme le industrie del carbone e dell’acciaio. Più del populismo, il nemico è l’inerzia: rischia di portarci, all’improvviso, in quella dimensione che stanno sperimentando milioni di giovani inglesi ed europei che studiano e lavorano a Londra e che si sono trovati in una situazione che non avevano, mai, seriamente preso in considerazione.
—————————————–
Il vero argine ai populisti si chiama papa Francesco
Nessuno a Roma a marciare contro o a favore dell’Europa. Tutti a Milano per il pontefice, che si scaglia contro l’Europa della paura. Il successo di folla del Papa “pop” mostra il disorientamento in cui sono caduti sia il populismo, sia la politica “tradizionale”, sia il sistema dell’informazione
di Flavia Perina
C’è una durissima lezione per la politica e per i media nel week end appena trascorso, una lezione data dal confronto – che tutti hanno notato – tra le colossali folle mobilitate dal Papa nella sua giornata milanese e la risibile partecipazione popolare alle manifestazioni anti-europee indette a Roma, che pure erano state preannunciate come temibili, enormi, probabilmente violente e avevano beneficiato di un battage pubblicitario intensissimo.
Non è la prima volta che succede. Da molto tempo le persone, le folle – le masse, si sarebbe detto una volta – si muovono all’improvviso per eventi imprevedibili e imprevisti, del tutto fuori dall’agenda dei partiti e del sistema della comunicazione. Secondo questa agenda, al centro della preoccupazione e quindi della mobilitazione popolare, dovrebbero esserci in questa fare i temi dettati dal populismo e dal cosiddetto sovranismo, di destra e di sinistra: insicurezza, immigrazione, ma soprattutto critica all’Europa, e talvolta odio per l’Europa. Un sentimento che si rappresenta come travolgente e diffuso fino al punto che persino i leader di partiti di governo, da Matteo Renzi a Silvio Berlusconi, hanno giudicato indispensabile negli ultimi anni inseguirlo, farsene partecipi talvolta con proposte strampalate pur di recuperare consenso.
Da molto tempo le persone, le folle – le masse, si sarebbe detto una volta – si muovono all’improvviso per eventi imprevedibili e imprevisti, del tutto fuori dall’agenda dei partiti e del sistema della comunicazione
E’ una percezione della realtà che appare, alla luce degli eventi del week end, di scarsissimo fondamento. E non c’entra solo l’innegabile carisma di Francesco. Nel settembre dello scorso anno si scoprì all’improvviso, grazie a colossali manifestazioni in Germania – un Paese poco aduso alla protesta – che un tema laterale e giudicato “specialistico” come il Ttip, il trattato di libero scambio Europa-Usa, era in realtà ben conosciuto e assai inviso a larghissime fasce della popolazione, pronte a scendere in piazza per fermare i governi (che infatti si fermarono). Il 26 novembre scorso, qui da noi, in Italia, centomila donne invasero Roma per una protesta contro la violenza, un corteo di cui nessuno aveva previsto la consistenza, poco pubblicizzato, non sostenuto dalle consuete “macchine della partecipazione” sindacali o poliche che in quel momento erano occupate col referendum costituzionale. E allo stesso modo, in anni precedenti, la politica e i media furono stupiti da fenomeni di massa come gli Indignados, o Occupy Wall Street, che da un giorno all’altro rivelavano l’esistenza di sentimenti così radicati e forti da rompere l’abituale disincanto del Villaggio Globale e spingere le persone a vestirsi, uscire di casa, partecipare “fisicamente” a qualcosa anziché limitare l’adesione a qualche click.
Ora, a sorprenderci, sono le masse che si muovono per ascoltare di persona Francesco. Ed il suo discorso per i sessant’anni dell’Europa – quello in cui mette in guardia contro la cultura della paura, dell’egoismo, della difesa piccina del proprio orto – non è solo il più “alto” e convincente, ma anche il più partecipato. Quello che può rivendicare il maggiore e più visibile consenso popolare, mentre i sedicenti “portavoce del popolo” restano isolati nelle loro nicchie rancorose o nella loro sterile visibilità social. La politica avrebbe il dovere di approfondire, anziché limitarsi alla spiegazione consolatoria del “Papa Pop” (come titola l’ultimo numero di Rolling Stones, mettendolo in copertina in una posa alla Fonzie). Dovrebbe, ad esempio, interrogarsi consenso effettivo dei cosiddetti populismi e sovranismi, e più in generale dell’intero racconto anti-europeo: quanto di esso corrisponde davvero a un sentimento diffuso, e quanto è legato a una resa culturale delle elìtes, al loro “dare per scontato” che quello sia il campo dove competere?
La politica avrebbe il dovere di approfondire, anziché limitarsi alla spiegazione consolatoria del “Papa Pop” (come titola l’ultimo numero di Rolling Stones, mettendolo in copertina in una posa alla Fonzie)
Angelo Panebianco ci ha spiegato, di recente, che le egemonie politico-culturali non nascono necessariamente dalla forza e dall’intelligenza di chi le costruisce e le cavalca con spregiudicatezza, ma assai spesso dalla resa di chi dovrebbe coltivare un pensiero critico e suggerire altre strade, altre soluzioni. In Italia questa resa è più palese che altrove perché non c’è area che si sottragga all’inseguimento della xenofobia, dell’approccio securitario ai problemi, della logica del sospetto e della paura, e naturalmente al racconto dell’Europa matrigna, nella convinzione che il consenso ormai si possa conquistare solo così, parlando alle famose “pance del Paese”. Dopo la giornata di sabato, dopo aver visto da una parte il populismo senza popolo e dall’altra le colossali folle radunate intorno a questo Papa e al suo messaggio totalmente controcorrente, qualche dubbio bisognerebbe cominciare a porselo.
——————————————–
SardegnaCheFare?

EuropaCheFare?
 SOCIETÀ E POLITICA »EVENTI» 2015-ALTRA EUROPA
SOCIETÀ E POLITICA »EVENTI» 2015-ALTRA EUROPA
L’Europa deve essere politica e federale. Ma resta un’utopia
di Nadia Urbinati

«Il Trattato di Roma ha messo al centro il diritto di movimento delle persone e delle merci; come nella tradizione settecentesca ha associato la libertà ai fattori economici o di produzione, la cittadinanza all’apertura dei mercati». Huffingto Post online, 25 Marzo 2017 (c.m.c.)
Il processo di unificazione Europea, di cui celebriamo il sessantesimo compleanno, ha aperto la strada a una nuova cittadinanza. Studiosi della politica e giuristi hanno abbondantemente illustrato il paradigma post-nazionale e sovranazionale della libertà politica che dissocia la cittadinanza dalla nazionalità. Si tratta di una rivoluzione non meno epocale di quella del 1789 che, per ripetere le parole di Hannah Arendt, inaugurò la «conquista dello stato da parte della nazione» e in questo modo l’inizio della democratizzazione.
La storia dell’Europa moderna conferma che mentre la formazione dello stato territoriale ha unificato il corpo dei sudditi della legge è stata la sovranità nazionale a rendere gli stati democratici. Il diritto che ha segnato questo mutamento epocale è quello di e/immigrazione, ovvero la libertà di movimento, delle persone e dei beni.
L’Unione europea nacque sulla libertà di movimento ma con un’ambiguità economica che non è scomparsa, nemmeno quando con il trattato di Lisbona la cittadinanza europea è stata consolidata da una famiglia di diritti costruiti attorno al “libero movimento” e alla “non discriminazione” tra gli Stati membri e all’interno di essi. Pur riconoscendo che l’immigrazione è un fatto fondamentale della vita umana, che riflette la ricerca di individui e collettività di migliorare la propria condizione di vita, ha scritto Ulrich Preuss, essa non mai ha di fatto tolto di mezzo le ragioni economiche per il diritto di movimento e il ruolo degli Stati membri. È vero che, comunque, le ragioni economiche non furono mai così preponderanti da bloccare lo sviluppo di decisioni riguardo la cittadinanza dell’Unione europea e da dare a quest’ultima uno status giuridico formale (il Trattato di Maastricht del 1993) e aumentarlo incrementalmente con i successivi trattati di Amsterdam (1999), Nizza (2003) e Lisbona (2009). Ma tutto questo è avvenuto prima della grande crisi finanziaria.
———-
È stata sufficiente questa crisi a mostrare le ambiguità: il Trattato di Roma ha messo al centro il diritto di movimento delle persone e delle merci; come nella tradizione settecentesca ha associato la libertà ai fattori economici o di produzione, la cittadinanza all’apertura dei mercati.
———-
All’inizio del processo europeo di unificazione, quell’ambiguità si applicava essenzialmente all’immigrazione interna (l’antica preoccupazione degli anni ’50 e ’60). Successivamente si è applicata all’immigrazione extracomunitaria, formando sia la politica di integrazione con gli immigrati irregolari (descritti come cittadini di Paesi terzi) sia quella della repressione con i migranti sans-papiers. Joseph Weiler ha così argomentato che «la cittadinanza europea equivale a poco più di un cinico esercizio di pubbliche relazioni e che anche il più sostanziale diritto (al libero movimento e alla residenza) non è concesso secondo uno status dell’individuo in quanto cittadino ma in ragione delle capacità dei singoli come fattori di produzione».
Se il diritto fondamentale di libertà di movimento è così direttamente connesso a ragioni economiche – la circolazione di una forza lavoro concorrenziale – ciò significa che i confini nazionali sono interpretati e utilizzati come meccanismi funzionali a una divisione internazionale del lavoro. Essi diventano il centro del conflitto tra opposti interessi, nel senso che i lavoratori stranieri (che minacciano la classe lavoratrice di una nazione accettando di lavorare senza la stessa protezione sociale e gli stessi salari della classe lavoratrice nazionale), incontrano gli interessi di quei settori economici la cui competitività si basa sul lavoro a basso costo. Questo è stato il ragionamento (populista ma non irrazionale) che ha guidato gli elettori nel referendum su Brexit.
Questo conflitto è il cuore di ciò che James Hollifiel ha chiamato il “paradosso liberale”, il fatto che una società democratica basata sul libero mercato e sulla libertà di movimento conserva un tratto di chiusura legale al fine di proteggere il contratto sociale tra lavoro e capitale, così riconoscendo che il proprio welfare presuppone una società chiusa e uniforme. Strategie di chiusura legale non sono necessariamente e brutalmente di tipo diretto (bloccando i confini, incarcerando e rimpatriando gli immigrati irregolari).
Di fatto, sono strategie per la maggior parte indirette, in modo particolare quando sono rivolte agli immigrati regolari, per esempio limitando i loro diritti civili e sociali, rendendo loro difficile la naturalizzazione, restringendo il loro accesso ai servizi sociali o impedendo i ricongiungimenti familiari. Dunque, per gli Stati europei, e ora anche per l’Unione europea, riguadagnare il controllo dei propri confini equivale ad ammettere che “il controllo dell’immigrazione può richiedere una riduzione dei diritti civili e dei diritti umani per i non cittadini”.
È sull’immigrazione che si gioca quindi il futuro dell’Unione: su questo diritto è sorta e su questo stesso diritto può cadere se lascerà che i singoli stati membri regolino le loro politiche delle frontiere in maniera nazionalistica (come del resto stanno già facendo ad Est). Non sembrano esserci altre soluzioni al problema europeo: perché l’Unione sopravviva deve farsi politica e avere un potere federale capace di imporsi ai governi degli stati membri. Una soluzione più utopistica oggi di sessant’anni fa, nonostante quell’Europa venisse da una carneficina mondiale e questa da sei decenni di pace.
——————————-
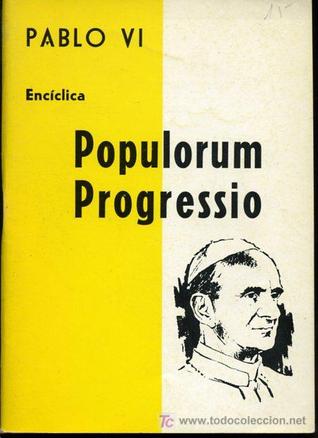
SOCIETÀ E POLITICA » TEMI E PRINCIPI » DE HOMINE
Cinquant’anni fa l’enciclica indicava la via
di Giorgio Nebbia
«Scritto da Paolo VI nel 1967, il testo denuncia il malaugurato sistema che considera il profitto come motore essenziale del progresso economico, la concorrenza come legge suprema dell’economia, la proprietà privata dei mezzi di produzione come un diritto assoluto, senza limiti né obblighi sociali corrispondenti». il manifesto, 26 marzo 2017 (c.m.c.)
Sembrano passati secoli, eppure sono passati solo cinquant’anni dal 1967, quando è stata pubblicata l’enciclica Populorum progressio, scritta da Paolo VI.
Tempestosi e ricchi di speranze quegli anni sessanta del Novecento; si erano da poco conclusi i lavori del Concilio Vaticano II che aveva aperto al mondo le porte della chiesa cattolica; era ancora vivo il ricordo della crisi dei missili a Cuba, quando il confronto fra Stati uniti e Unione sovietica con le loro bombe termonucleari, aveva fatto sentire il mondo sull’orlo di una catastrofe; i paesi coloniali stavano lentamente e faticosamente procedendo sulla via dell’indipendenza, sempre sotto l’ombra delle multinazionali straniere attente a non mollare i loro privilegi di sfruttamento delle preziose materie prime; la miseria della crescente popolazione dei paesi del terzo mondo chiedeva giustizia davanti alla sfacciata opulenza consumistica dei paesi capitalistici del primo mondo; nel primo mondo studenti e operai chiedevano leggi per un ambiente migliore, per salari più equi, per il divieto degli esperimenti nucleari.
In questa atmosfera il malinconico Paolo VI aveva alzata la voce parlando di nuove strade per lo sviluppo. Progressio, ben diverso dalla crescita delle merci e del denaro, la divinità delle economie capitalistiche.
L’enciclica sullo sviluppo dei popoli diceva bene che «il fine ultimo e fondamentale dello sviluppo non consiste nel solo aumento dei beni prodotti né nella sola ricerca del profitto e del predominio economico; non basta promuovere la tecnica perché la Terra diventi più umana da abitare; economia e tecnica non hanno senso che in rapporto all’uomo che esse devono servire».
La Populorum progressio metteva in discussione lo stesso diritto umano al «possesso» dei campi, dei minerali, dell’acqua, degli alberi, degli animali, che non sono di una singola persona o di un singolo paese, ma «di Dio», beni comuni come ripete papa Francesco nella sua enciclica Laudato si’ e continuamente.
L’enciclica Populorum progressio indica diritti e doveri dei popoli della Terra divisi nelle due grandi «classi» dei ricchi e dei poveri, ben riconoscibili anche oggi: i ricchi, talvolta sfacciatamente ricchi, dei paesi industriali ma anche quelli che, nei paesi poveri, accumulano grandi ricchezze alle spese dei loro concittadini; i poveri che affollano i paesi arretrati, ma anche quelli, spesso invisibili, che affollano le strade delle dei paesi opulenti, all’ombra degli svettanti grattacieli e delle botteghe sfavillanti.
La Populorum progressio fu letta poco volentieri quando fu pubblicata e da allora è stata quasi dimenticata benché le sue analisi dei grandi problemi mondiali siano rimaste attualissime.
I popoli a cui l’enciclica si rivolge sono, allora come oggi, quelli che lottano per liberarsi dal giogo della fame, della miseria, delle malattie endemiche, dell’ignoranza; che cercano una partecipazione più larga ai frutti della civiltà, una più attiva valorizzazione delle loro qualità umane; che si muovono con decisione «verso la meta di un pieno rigoglio».
L’enciclica denuncia il malaugurato (dice proprio così) sistema che considera il profitto come motore essenziale del progresso economico, la concorrenza come legge suprema dell’economia, la proprietà privata dei mezzi di produzione come un diritto assoluto, senza limiti né obblighi sociali corrispondenti. E condanna l’abuso di un liberalismo che si manifesta come «imperialismo internazionale del denaro».
In quegli anni sessanta era vivace il dibattito sulla «esplosione» della popolazione, in rapida crescita specialmente nei paesi poveri, e la domanda di un controllo della popolazione, resa possibile dall’invenzione «della pillola», aveva posto i cattolici di fronte a contraddizioni. Paolo VI ricorda che spetta ai genitori di decidere, con piena cognizione di causa, sul numero dei loro figli, prendendo le loro «responsabilità davanti a Dio, davanti a se stessi, davanti ai figli che già hanno messo al mondo, e davanti alla comunità alla quale appartengono». Il tema della «paternità responsabile» sarebbe stato ripreso nel 1968 dallo stesso Paolo VI nella controversa enciclica Humanae vitae e, più recentemente, da papa Francesco che ha detto che per essere buoni cattolici non è necessario essere come conigli.
Il progresso dei popoli è ostacolato anche dallo «scandalo intollerabile di ogni estenuante corsa agli armamenti», una corsa che si è aggravata in tutto il mezzo secolo successivo con la diffusione di costosissime e sempre più devastanti armi nucleari, oggi nelle mani di ben nove paesi, oltre che di armi convenzionali.
In mezzo secolo è cambiata la geografia politica; un mondo capitalistico egoista e invecchiato deve fare i conti con vivaci e affollati paesi emergenti, pieni di contraddizioni, e con una folla di poverissimi.
I poveri di cui l’enciclica auspicava il progresso, nel frattempo cresciuti di numero, sono quelli che oggi si affacciano alle porte dell’Europa per sfuggire a miseria, guerre fratricide, oppressione imperialista, per sfuggire alla sete e alle alluvioni, alla fame e all’ignoranza, quelli che i paesi cristiani non esitano a rispedire in campi di concentramento africani pur di non incrinare il loro benessere, magari dopo avere strizzato la vita e salute degli immigrati nei nostri campi. I pontefici dicano pure quello che vogliono; le cose serie sono i propri interessi e commerci.
Eppure è fra i poveri disperati e arrabbiati che trova facile ascolto l’invito alla violenza e al terrorismo; noi crediamo che la sicurezza dei nostri negozi e affari si difenda con altre truppe super-armate, con sistemi elettronici che si rivelano fragili e violabili, e invece l’unica ricetta, anche se scomoda, per rendere la terra meno violenta e più «adatta da abitare», sarebbe la giustizia.










 AService Studio
AService Studio