Risultato della ricerca: DIBATTITO – VALUTAZIONI e DIBATTITO
Rinnovabili. Lo Stato delle cose

 :
:
https://www.change.org/p/si-all-energia-rinnovabile-no-alla-speculazione-energetica?recruiter=52679190&recruited_by_id=fb3745a0-af82-0130-04ab-00221964dac8&utm_source=share_petition&utm_campaign=share_for_starters_page&utm_medium=copylink .
————IL DOCUMENTO————
https://gruppodinterventogiuridicoweb.com/2024/08/16/sardegna-speculazione-energetica-come-possiamo-salvare-il-territorio-e-attuare-una-corretta-transizione-energetica/
In queste settimane è sempre più acceso il dibattito sulla difficile situazione per il territorio della Sardegna, assediato da una sempre più arrogante speculazione energetica.
La realtà della speculazione energetica, con particolare riferimento alla Sardegna.
La realtà della speculazione energetica è di banale quanto spaventosa evidenza. Essere a favore dell’energia prodotta da fonti rinnovabili non vuol dire avere ottusi paraocchi, non vuol dire aver versato il cervello all’ammasso della vulgata dell’ambientalismo politicamente corretto.
Ma non sono solo le associazioni e i comitati realmente ambientalisti a sostenerlo.
E’ online Rocca numero tredici/ventiventidue
 A PARTIRE DA UN ARTICOLO DI ENZO BIANCHI
A PARTIRE DA UN ARTICOLO DI ENZO BIANCHI
l’operazione del granchio
Editoriale di Mariano Borgognoni, Rocca 13/2022
Ho sempre apprezzato la chiarezza con cui Enzo Bianchi ha affrontato le questioni essenziali della fede cristiana, la sua capacità di spogliarla di tutte le sovrastrutture e di coglierne il nucleo, quell’elemento sul quale essa sta o cade. Per questo non sono rimasto sorpreso, come altri, quando ho letto un suo recente articolo su Repubblica, nel quale afferma che: «se non si crede che Gesù Cristo è vivente, è risorto da morte e ha vinto la morte, che ragione c’è a professarsi cristiani? Se non si crede che la morte è solo un esodo, che ci saranno un giudizio sull’operato umano e una vita oltre la morte, perché si dovrebbe diventare cristiani e perseverare in questa appartenenza?». Sono andato subito a ripescare nella mia libreria un piccolo libro-intervista dal titolo Ricominciare, pubblicato dalla Marietti nel 1991. In esso il fondatore della Comunità di Bose, citando un Padre della Chiesa del IV secolo, scrive una cosa che allora, 31 anni fa, mi colpì molto: «è come nella caccia alla volpe, dove i cani che non l’hanno vista, prima o poi si stancano, rinunciano e tornano a casa; mentre quei pochi che hanno visto la volpe proseguiranno la loro caccia fino in fondo». «Ecco» – chiosa fratel Enzo – «il problema è far vedere la volpe ai giovani, far conoscere Gesù Cristo. Poi il resto, compreso l’agire etico, viene da sé». Per questo non mi sorprendo nemmeno quando Bianchi, in un articolo successivo, torna a criticare il moralismo e l’ossessione sessuofobica delle gerarchie ecclesiastiche e apre, semmai, una questione che chiamerei di democrazia nella Chiesa. Perché certo la Chiesa non è una democrazia ma nel senso che dovrebbe essere più che democratica, non meno. Mi sento francamente vicino alle posizioni espresse con molta
parresia da Enzo Bianchi. Credo che anche nell’areopago moderno bisogna osare l’annuncio nella sua essenzialità ed intierezza, anche scontando l’incomprensione a cui andò incontro Paolo ad Atene. I surrogati non conquistano nessuno. La riduzione della fede ad etica, del paradosso evangelico ad istanza morale, direi perfino della redenzione a giustizia sociale, è un’operazione che non porta lontano, perché non c’è bisogno della religione per essere in grado di darsi istanze etiche, morali, sociali, spirituali. In questa direzione, storicamente parlando, le religioni hanno talvolta aiutato, talaltra ostacolato il cammino della convivenza e della giustizia umane. Ai cristiani, peraltro, non può bastare il «non possiamo non dirci cristiani» di Benedetto Croce, una specie di milieu genericamente cristiano nel quale una sorta di religione civile inghiotte la scorza e sputa la polpa della fede. Alla fine questa via porta a una diluizione del tutto analcoolica del messaggio evangelico. Bisogna invece fare l’operazione del granchio che per rigenerarsi si libera del carapace.
Se la corazza ti soffoca devi liberartene, sarai più fragile, avrai bisogno di un periodo di nascondimento, ma questo infine ti riporterà a contatto con la linfa vitale delle origini che, altrimenti, rischia di essere sepolta dal nobile e dall’ignobile di una lunga storia. Ciò che è decisivo non è aggiungere ma togliere. Detto questo, cioè detto il cosa annunciare, non si può non affrontare il come, che è altrettanto importante.
Non sarebbe una cattiva idea scegliere la strada indicata dalla Lettera a Diogneto: vestire, lavorare, vivere come tutti nella città comune ma saper dire o fare in molti modi la parola o il gesto della fede. Essere «liberi sopra ogni cosa e non sottoposti ad alcuno e servi in ogni cosa e sottoposti ad ognuno» secondo la celebre definizione luterana. E così rendere ragione della nostra speranza. Avere radici ma senza che esse diventino catene. Lungo questa impostazione, direi a caduta, dovrebbero essere messe sul tavolo le scelte a cui il Sinodo, sinodalmente è chiamato. Poche e chiare decisioni e non un parlare a vuoto di tutto. Faccio per dire: in un universo ecclesiale clericocentrico, con i ruoli fondamentali tutti al maschile aprire almeno al diaconato femminile per inaugurare una riflessione ancor più di fondo sui ministeri; operare un rinnovamento liturgico che renda comprensibili e vive le celebrazioni; rendere possibile a tutti i battezzati di presiedere gli organismi parrocchiali, diocesani, fino alla Curia romana, etc.
Quanto al come non è poi irrilevante affrontare il contesto sociale e culturale, saperne leggere le caratteristiche e le tendenze di fondo. Non è questo un perditempo sociologico poiché, fermo l’annuncio nella sua nudità, è necessario comprendere la cornice nella quale collocarlo, bisogna capire la «lingua» dei contemporanei se non si vuol rischiare di essere fraintesi o del tutto inascoltati. O, come spesso nella liturgia, proporre formule insapori, inodori e incolori o, peggio, talvolta del tutto non accettabili a noi stessi che le recitiamo (nel senso peggiore della recita). Il problema è che se il moderno ha secolarizzato l’idea di salvezza affidandola per intero alla scienza o alla rivoluzione, il contemporaneo ha secolarizzato la secolarizzazione rendendo irrilevante l’idea stessa di salvezza. La parola redenzione, anche in termini laici, è scomparsa. Nella sua seconda enciclica, la Spe salvi (2007), Benedetto XVI parla di una crisi della speranza che erode la base della fede. Viene in mente il verso leopardiano: «nonche’ la speme il desiderio è spento». Nello schiacciamento sul presente e sull’immediato non solo si attenua la capacità di pensiero lungo, ma anche la coltivazione di desideri profondi che domandano perseveranza e senso dell’attesa. E se non si attende un non ancora si colpisce con il martello il nervo scoperto della fede dei cristiani, che sta molto in questo attendere inteso come fare e aspettare insieme, secondo la ricchezza del suo etimo nella nostra lingua. Eppure tanti segni ci dicono come sotto un apparente debole narcisismo, si nasconde il «calderone ribollente» tipico della condizione umana, perché in fondo resta vero che il presente non basta a nessuno. Le grandi narrazioni di senso, tutte, anche quelle totalmente immanenti avevano un elemento di trascendimento, un orizzonte, starei per dire un territorio del sacro, dell’oltre, che resta decisivo non solo per la salvezza ma anche per la salute dei terrestri. Ma quell’oltre e specificamente quello che indicano i cristiani deve anche evitare, per essere credibile, che il non ancora mangi del tutto il già. Per questo la Chiesa non può blindarsi nei recinti dove spesso il troppo umano viene sacralizzato. La Chiesa in uscita che insieme a tutti prova ad alleggerire il mondo dalle ingiustizie e a curare i percorsi di umanizzazione, non è l’alternativa all’annuncio della risurrezione ma è l’unico modo per anticiparne, sia pure poveramente, la logica, il senso, il bisogno, il sogno.
———————————–
Dibattito
Autodeterminazione dei popoli e responsabilità globale
di Giannino Piana su Esodo
Chi è favorevole all’invio delle armi all’Ucraina dice che per la difesa della libertà si deve rischiare di perdere la vita, tra la libertà e la vita il primato è della libertà, come nel caso del fine vita. Consideri valida questa contrapposizione e pensi legittimo il paragone con il caso del suicidio assistito?
La libertà è senz’altro un grande valore che non può essere sottovalutato: ne va dell’identità stessa del soggetto umano. Ma occorre intanto distinguere tra la libertà personale e quella di un popolo, del rispetto cioè della sua autonomia territoriale e di governo a livello socio-economico e politico. Nel primo caso – quello della libertà personale – il singolo, laddove gli venga negata la possibilità di vivere nella fedeltà ai valori in cui crede, e sia dunque obbligato ad andare contro la propria coscienza, o venga costretto a rinnegare la propria fede religiosa può anche mettere a rischio, fino a perderla, la propria vita. Non è stata forse questa la testimonianza dei martiri cristiani?
Diverso e più complesso è il discorso relativo alla difesa della libertà da parte di una nazione ingiustamente invasa da un’altra nazione. La reazione a questa situazione dando vita a una vera guerra, sia pure difensiva (e di conseguenza la fornitura di armi da parte di altri Paesi come sta avvenendo in Ucraina), è eticamente inaccettabile. Non esiste guerra giusta! Il dilemma libertà-vita non può dunque che risolversi a favore della vita, e questo tanto più se si considera che l’autorità che decide l’intervento bellico coinvolge la vita di altri, che non sempre sono d’accordo a metterla a repentaglio (o a perderla) per una causa che possono anche non condividere. Questo non significa che si debba rimanere inermi di fronte a un attentato alla propria libertà nazionale, ma che occorra scegliere altre vie di difesa, che vanno dalle operazioni di polizia internazionale – purtroppo oggi di difficile esecuzione per l’inesistenza di organismi internazionali adeguati, Onu inclusa – alla difesa nonviolenta e alla mediazione diplomatica. D’altra parte, a spiegare l’esasperazione dei conflitti, che conducono alla guerra – il caso della Russia e dell’Ucraina rientra in questo quadro – concorre oggi la rinascita esasperata dei nazionalismi e dei patriottismi, che rappresentano una forma di reazione nei confronti del declino degli Stati-nazione, il cui potere è sempre più limitato dall’avanzare della globalizzazione, a causa della quale i processi socioeconomici e politici scavalcano di continuo le loro frontiere. Quanto al paragone con il suicidio assistito non mi pare esistano le condizioni per un confronto. Intanto nel caso del suicidio assistito si tratta di una scelta del singolo individuo, la cui legittimità dovuta all’applicazione del principio di autodeterminazione non è lasciata, anche da parte di chi la sostiene per motivazioni etico-religiose – si vedano gli interventi puntuali di Hans Kung e delle chiese protestanti – all’arbitrarietà della decisione personale, ma comporta il verificarsi di precise condizioni oggettive dalle quali non è possibile prescindere. Il principio di autonomia e di autodeterminazione non è assoluto; deve fare i conti in bioetica con altri principi – beneficenza e giustizia sociale – che ne limitano l’esercizio.
Nel caso della guerra attuale, viene affermato il valore assoluto della libertà e dell’autodeterminazione del popolo ucraino: se si porta fino in fondo questo principio, oltre al rischio nucleare, ci sono conseguenze terribili per le fasce più povere in Europa ma soprattutto in Africa. Intere popolazioni rischiano la fame e la morte. Questa è una conseguenza indiretta, ma facilmente prevista, che va considerata, in una valutazione etica? In un mondo interconnesso, che peso hanno le valutazioni etiche di un’azione legittima e doverosa con conseguenze negative per la vita e la libertà in altre aree del mondo?
L’autodeterminazione (e la libertà) anche in questo caso come in quello della bioetica non può essere considerato un principio assoluto. Le terribili conseguenze ventilate sono realistiche. Il rischio è di scatenare una vera guerra mondiale, con pesanti ricadute negative soprattutto sulle fasce più povere della popolazione. E questo anche perché il sempre più consistente incremento delle diseguaglianze sociali e tra i popoli – incremento dovuto alla persistenza di un sistema economico, che, nonostante le molte falle non solo di ordine etico, ma anche produttivo (si pensi soltanto al primato dell’economia finanziaria su quella reale) – rende impossibile la realizzazione di un’equa distribuzione della ricchezza e, grazie al prevalere della logica consumista, impedisce che si giunga a un effettivo cambiamento degli stili di vita, reso necessario anche dalle dimensioni drammatiche assunte dalla questione ecologica. L’interconnessione del mondo, in ragione del fenomeno già ricordato della globalizzazione, conferisce un peso determinante a scelte come quella cui si fa qui riferimento. La valutazione etica dei processi che si innescano in un’area circoscritta del pianeta non può limitarsi a considerare gli effetti che si producono su tale area; deve avere come referente la situazione mondiale. E questo anche in presenza di buone ragioni per ritenere legittimi i processi che si intendono attivare ma le cui conseguenze vanno valutate in una prospettiva universalistica.
Putin viene paragonato a Hitler come il “male assoluto”: la difesa dell’Ucraina è quindi la difesa del Bene contro il Male, dei valori assoluti contro i disvalori assoluti. Siamo in un nuovo “scontro di civiltà”. Non c’è quindi spazio per la democrazia e l’accordo. Da un punto di vista etico è corretta questa impostazione? Che significa la distinzione fatta da Giovanni XXIII tra il peccato e il peccatore?
Il paragone tra Putin e Hitler è assolutamente inaccettabile. Intanto per il mutato contesto storico. Ma soprattutto per la diversa gravità degli interventi. Non va certo sminuita la responsabilità di Putin nei confronti di delitti efferati, frutto di un regime autoritario, che si difende non lasciando alcuno spazio alla critica e al dissenso, anzi cancellandoli anche attraverso operazioni di tragica violenza. Così come si deve condannare con forza, senza se e senza ma, la sua invasione dell’Ucraina. Il che non deve tuttavia condurre alla sottovalutazione delle responsabilità dell’Occidente – America ed Europa – che ha concorso con alcune prese di posizione a esasperare la
tensione. La contrapposizione tra Male assoluto e Bene assoluto non è plausibile e contribuisce, se esasperata, a dare vita a quel deplorevole “scontro di civiltà”, che vanifica ogni possibilità di mediazione diplomatica. La situazione della guerra in Ucraina non può certo trovare sbocco positivo se – come peraltro purtroppo finora avviene – si assumono da ambo le parti posizioni di radicale intransigenza. La possibilità di una trattativa efficace è legata, oltre che all’abbandono di giudizi drastici come quelli ricordati, alla volontà di trovare un punto di accordo, che presuppone la rinuncia a qualcosa da tutte e due le parti. La distinzione proposta da papa Giovanni tra il peccato e il peccatore (o tra l’errore e l’errante) riflette il “non giudicate” evangelico, che non riguarda tanto l’azione, che deve essere valutata con rigore e di cui va denunciato con forza quando si rende necessario il contenuto negativo, ma il soggetto della stessa, di cui non è possibile conoscere fino in fondo l’intenzionalità profonda, in quanto la disposizione interiore rimane sempre e comunque avvolta nel mistero.
—————

Sinodo e cammini sinodali
Oggi&Domani Che fare? “Se ne esce solo con più scienza e non con un improbabile ritorno al passato”. Ce lo dice un Nobel


La percezione della scienza nella società: intervista a Giorgio Parisi, nobel per la fisica
Alberto Silvani
Sbilanciamoci! 5 Ottobre 2021 | Sezione: Alter, Nella rete
“La scienza era associata alla garanzia di un futuro migliore. Ora non è più così, anzi spesse volte alla scienza vengono addebitate colpe e responsabilità. Se ne esce solo con più scienza e non con un improbabile ritorno al passato”. Intervista al premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi da Articolo33.
È passato un po’ di tempo da quando, a fine maggio il Senato ha approvato un Disegno di legge sull’Agricoltura biologica, col solo voto contrario della Sen. Elena Cattaneo, che ha equiparato – in un passaggio del testo – l’agricoltura biologica con quella biodinamica, caratterizzata da pratiche e codici di comportamento ascientifici. La questione ci fornisce lo spunto, ripresa con la giusta distanza temporale, per sviluppare alcune riflessioni sul ruolo della scienza, sul processo di avanzamento scientifico, sul rapporto tra scienza e società.
Il primo interlocutore a cui ci rivolgiamo è il Prof. Giorgio Parisi, eminente fisico della Sapienza di cui è appena terminato il mandato di Presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei*.
Il Prof. Parisi ha ricevuto il 5 ottobre 2021, il premio nobel per la fisica. Premiato per le sue ricerche sui sistemi complessi insieme agli studiosi del clima Syukuro Manabe e Klaus Hasselmann. Era dal 1984 con Carlo Rubbia che l’Italia non vinceva un Nobel per la fisica.
Parisi ha sempre associato l’eccellenza scientifica con la capacità di intervenire sulle problematiche della politica scientifica e non solo, come è avvenuto anche nell’ultimo anno e mezzo di pandemia. Pubblichiamo una sua intervista rilasciata per noi da Alberto Silvani.
Cosa si dovrebbe fare per aumentare la percezione del ruolo della scienza nella società e, su questa base, motivare le scelte in suo favore, approfittando del rinnovato interesse da parte dell’opinione pubblica?
La comunità scientifica tende a comunicare poco con la società perché in fondo non crede che questo sia il suo mestiere. Ciò viene confermato da come viene realizzata questa comunicazione, come abbiamo visto in questi mesi di sovraesposizione mediatica. Bisogna formare figure professionali di “comunicatori” ma anche intervenire sulla capacità di trasferire la metodologia scientifica anziché limitarsi ad accendere l’interesse sul singolo risultato. Il processo scientifico porta a realizzare un consenso a partire da ipotesi diverse, a volte contrapposte. La scienza lavora così, per avanzamenti successivi, e questo richiede tempo anche perché il processo presuppone la peer review dei diversi contributi. Il vero successo del singolo contributo dipende sia dalla rivista su cui è pubblicato ma, soprattutto, da come reagiscono i lettori, da come fanno proprio il contenuto e da come danno seguito, nel proprio lavoro e nelle citazioni, a quanto l’articolo vuole comunicare.
La sanità costituisce una realtà specifica, evidenziata dall’esperienza della pandemia. In cosa si caratterizza?
La sanità richiede “sicurezza” circa la rilevanza e il significato dei risultati e, soprattutto, una consapevolezza del rapporto tra i benefici e i rischi, in particolare sugli effetti che si generano, non necessariamente limitati a quelli auspicati o aspettati. Potrei citare vari esempi, anche come testimonianza diretta…senza dimenticare che esistono interessi che ne condizionano le scelte. Ogni risultato deve essere sempre sottoposto a commenti e validazioni che presuppongono procedure, gruppi di controllo e numerosità statisticamente significative.
La sanità è stata associata, in particolare in questo periodo, al grande tema delle fake news. Perchè il metodo scientifico non basta per sconfiggere le fake news? Che fare?
In alcuni casi vanno anche contro il senso comune: bisogna, ovviamente, smascherare le falsità. Le fake news si propagano perché spesse volte confermano le opinioni che avevano già le persone. Ad esempio il caso dei vaccini è emblematico in tal senso perché, pur di evitare il vaccino, si ipotizza l’esistenza di cure e terapie domiciliari ma non comunicate. Curare la comunicazione, e non è un gioco di parole, richiede che i comunicatori siano in grado di non attirare su di sé pregiudizi negativi che ostacolino la comprensione e la credibilità del messaggio che si vuole fornire. Non basta cioè dire le cose corrette se non si è in grado di costruire il messaggio e di veicolarlo nel modo giusto, potendo utilizzare le competenze e i contributi a supporto. Le trasmissioni televisive in particolare soffrono di due problemi: una certa tendenza a favorire gli scontri e le contrapposizioni (che fanno audience) e i tempi stretti che impediscono lo sviluppo di ragionamenti compiuti e articolati. Faccio una modesta proposta: prevedere l’obbligo di un incontro precedente alla formale messa in onda per consentire un confronto approfondito e preventivo in modo da realizzare poi, anche nei tempi ristretti delle trasmissioni, la focalizzazione delle questioni e delle opinioni.
Più conoscenza e più formazione hanno rappresentato da sempre gli obiettivi per realizzare una società più giusta e più equilibrata, indirizzata al futuro piuttosto che condizionata dal passato. La tecnologia ha spesso fornito il supporto per rendere praticabili questi obiettivi. Bisogna aggiornare la formula? Aggiungere elementi?
Uno dei problemi seri derivava dal fatto che la scienza era associata alla garanzia di un futuro migliore. Ora non è più così, anzi spesse volte alla scienza vengono addebitate colpe e responsabilità. Se ne esce solo con più scienza e non con un improbabile ritorno al passato. Ma questo non è ben percepito. La tecnologia, come applicazione della scienza, risente di avanzamenti scientifici non pensati in una mera prospettiva tecnologica. La gran parte della popolazione coglie (e usa) la tecnologia senza interrogarsi quanta e quale scienza ci sia dietro. Dai transistor, alla crittografia dei messaggi o ai led ad alta potenza.
Quanta è democratica la scienza? Qual è la tua opinione in proposito? In che misura l’opinione pubblica condiziona l’avanzamento della scienza?
La scienza deve fare i conti con le risorse. Se queste sono scarse, finiscono per condizionare le scelte, se non altro perché bisogna convincere i cittadini/elettori/contribuenti che i soldi sono ben spesi. E la ricerca non è democratica non perché “non si può votare”, ma perché richiede che ci sia un riconoscimento reciproco che deriva da un bagaglio conoscitivo condiviso anche se non necessariamente convergente.
Questo però implica un rischio di conservazione ovvero di ostacolo e freno al nuovo, già a partire dalle valutazioni di peer review.
Le nuove idee si affermano non perché si convincono gli oppositori ma perché i portatori di quelle precedenti muoiono, come diceva Planck. Per le idee estremamente nuove ci vuole tempo per il consenso.
Un’ultima domanda sul caso italiano e sul peculiare momento che stiamo vivendo. Conosciamo l’appello per le risorse, noto come Piano Amaldi, e la tua convinta adesione. Ma accanto alle risorse ci sono altre priorità concretamente spendibili nello scenario che si prospetta nei prossimi anni?
Ci sono tanti problemi. La ricerca è a macchia di leopardo: accanto ad eccellenze ci sono inefficienze. Alcuni poi hanno utilizzato la propria influenza come effettivo centro di potere, senza bilanciamenti adeguati. E questo ha dato luogo a scandali (certamente da non sottovalutare) ma quando va male si finisce sui giornali, quando va bene questo non ha visibilità. Da molti anni si cerca di realizzare un punto di riflessione con scienziati di ottimo livello in grado di costituire un interlocutore per le scelte governative ma anche quando un tale organo viene istituito non se ne tiene conto nell’operatività. La stessa Agenzia Nazionale, oltre a non essere decollata, richiede tempi lunghi e consensi politici. Ha senso solo se raccoglie risorse distribuite oggi in altre sedi, se resta “leggera” e se impiega il tutto in una logica competitiva e verso obiettivi chiari ed espliciti. Non che di ripensamenti organizzativi non ci sia bisogno ma questi hanno molto faticato a tenere insieme dichiarazioni e scelte e, soprattutto, a consolidarsi nel tempo.
Siamo ora in presenza della grande opportunità del PNRR ma questo non può essere l’unica scelta, se non altro perché tocca una parte dei problemi ed è a scadenza. L’importante è già porsi oggi il disegno complessivo ed accompagnare il sostegno delle risorse addizionali con nuove risorse “stabili”, ovvero a valere sul bilancio ordinario. Registro una nuova sensibilità su questi temi ma la conferma non può che essere a breve termine. La legge di bilancio del prossimo anno sarà una cartina di tornasole tra dichiarazioni, volontà e comportamenti.
————————-
L’INTERVISTA SU ARTICOLO 33
05 OTTOBRE 2021
——————————–
NEWS CNR
 A Giorgio Parisi il Wolf Prize per la Fisica 2021
A Giorgio Parisi il Wolf Prize per la Fisica 2021
10/02/2021 (2 ottobre 2021)
Giorgio Parisi
——–
Nobel per la fisica a Giorgio Parisi
Ott 2021
“L’assegnazione del premio Nobel al fisico Giorgio Parisi inorgoglisce tutta l’Italia e anche il Consiglio nazionale delle ricerche, con il quale il fisico ha sempre intrattenuto stretti rapporti di collaborazione proseguiti ancora di recente con le attività svolte in associatura al nostro Istituto Nanotec”, ha dichiarato Maria Chiara Carrozza, presidente del Cnr. “Oltre a compiacerci per questo straordinario risultato – che segue di poco quello del *Clarivate Citation Laureates 2021 che lo riconosce studioso più citato al mondo per le pubblicazioni scientifiche – *la nostra comunità scientifica lo ringrazia sentitamente per il contributo fondamentale nello studio dei sistemi complessi disordinati alla base di tante linee di ricerca del Cnr, dallo studio dei sistemi vetrosi, ai sistemi di lasing e trasmissione della luce in mezzi random, dalle reti neurali e IA, alle reti metaboliche e alla biofisica. Lamentiamo spesso, e purtroppo a ragione, le molte difficoltà nelle quali si dibatte la ricerca italiana, dalla scarsità di risorse umane e finanziarie alla burocratizzazione, ma questo premio è solo l’ultima e straordinaria conferma dell’eccellenza della ricerca scientifica italiana”.
————————–
Il Nobel segue un altro prestigioso premio
Il fisico teorico Giorgio Parisi, attuale presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e professore alla Sapienza Università di Roma, è stato insignito del prestigioso Wolf Prize per la Fisica 2021 “per le sue scoperte pionieristiche nella teoria quantistica dei campi, in meccanica statistica e nei sistemi complessi”.
Il riconoscimento, istituito dalla Fondazione Wolf di Israele nel 1978 per gli scienziati e gli artisti che hanno prodotto “risultati nell’interesse dell’umanità e relazioni amichevoli tra le persone, indipendentemente dalla nazionalità, razza, colore, religione, sesso o opinioni politiche”, è stato attribuito, in passato, a personalità come Giuseppe Occhialini, Bruno Rossi, Riccardo Giacconi, Leon Lederman, Roger Penrose, Stephen Hawking, Peter Higgs, per citare solo alcuni degli scienziati più noti.
“Sono estremamente contento ed onorato per aver ricevuto questo premio prestigioso non solo per essere stato inserito in una compagnia molto prestigiosa, nella quale ritrovo con molti amici, ma anche per essere stato messo in relazione diretta con Riccardo Wolf, persona che ammiro moltissimo per le sue capacità scientifiche e il grande impegno civile. Il merito di questo premio va anche a tantissimi collaboratori che ho avuto, con i quali ci siamo divertiti nel cercare di svelare quelli che una volta si chiamavano i “misteri della natura”, ha affermato lo studioso.
Laureato in fisica nel 1970 presso la Sapienza Università di Roma sotto la guida di Nicola Cabibbo, Giorgio Parisi collabora da molti anni con il Consiglio nazionale delle ricerche: è associato all’Istituto di nanotecnologia (Nanotec) e ha contribuito alla nascita e allo sviluppo, all’inizio del 2000, del centro “Statistical Mechanics and Complexity” dedicato allo studio di concetti come i sistemi disordinati, il caos e la complessità, poi confluito nell’Istituto dei sistemi complessi (Isc) del Cnr di Roma.
Nella sua lunga carriera scientifica, in parte svolta presso istituzioni estere come la Columbia University di New York (1973-1974), l’Institut des Hautes Etudes Scientifiques a Bures-sur-Yvettes (1976-1977), l’Ecole Normale Superieure di Parigi (1977-1978), Parisi ha dato contributi determinanti e ampiamente riconosciuti anche in altre aree della fisica: fisica delle particelle, meccanica statistica, fluidodinamica, materia condensata, supercomputer.
È stato vincitore di due advanced grant dell’ERC European Reasearch Council, nel 2010 e nel 2016, e ha ricevuto numerosi premi nazionali e internazionali, tra i quali la Medaglia Boltzmann della International Union of Pure and Applied Physics (1992), la Medaglia Max Planck (2011), la Medaglia Dirac per la fisica teorica (1999), il Nature Award Mentoring in Science (2013), l’High Energy and Particle Physics dell’EPS European Physical Society (2015).
È membro dell’Accademia dei Quaranta, dell’Académie des Sciences, dell’Accademia Nazionale delle Scienze degli Stati Uniti, dell’Accademia Europea, dell’Academia Europea e dell’American Philosophical Society, ed è autore di oltre seicento articoli e contributi a conferenze scientifiche e quattro libri
——–
Le immagini di Giorgio Parisi e la sua biografia sono tratte dal sito del CNR: https://www.cnr.it/it/news/10006/a-giorgio-parisi-il-wolf-prize-per-la-fisica-2021
———————————————

Giorgio Parisi, un manifesto per la giustizia climatica
Il discorso. La critica del premio Nobel per la fisica alla Pre-Cop26 in Parlamento: “Governi inadeguati sulla crisi”. «il Pil non è una buona misura per economia e clima». E poi un nuovo appello per l’istruzione e la ricerca pubblica: “Dare ai bambini un’educazione scientifica a partire dalla scuola materna”
di Roberto Ciccarelli
il manifesto
EDIZIONE DEL 09.10.2021 – PUBBLICATO 8.10.2021, 23:59
Oggi lunedì 27 aprile 2020




 –
– ![]()
![]()



—————————Opinioni, Commenti e “Riflessioni, Appuntamenti——————————————————
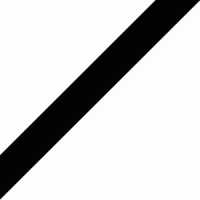
 Addio Giulietto Chiesa.
Addio Giulietto Chiesa.
Loris Campetti su il manifesto sardo
————————————–
Il 25 aprile è fondamentale per l’Italia democratica, anche per il futuro prossimo venturo
Alfiero Grandi su Democraziaoggi.
Il 25 aprile è una data fondamentale dell’Italia democratica e repubblicana. La sconfitta del nazifascismo dovuta agli alleati e alla Resistenza italiana, che ha riscattato la vergogna del regime fascista, che aveva portato il nostro paese in guerra a fianco dei nazisti, è una data da ricordare oggi più che mai. L’orgoglio della vittoria […]
—————————————————
La nostra classe dirigente
27 Aprile 2020 Luca Sofri su Wittgenstein
[segue]
Coronavirus. Pensare, analizzare, agire.
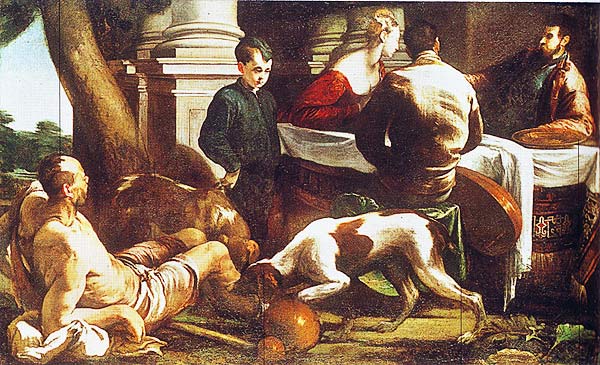
Proponiamo alle nostre lettrici e ai nostri lettori il sesto contributo, un intervento di Gianfranco Sabattini, economista, condiviso dalle redazioni de il manifesto sardo, Democraziaoggi e aladinpensiero, nell’ambito dell’impegno comune che qui si richiama.
———-
Il reddito di cittadinanza non è un provvedimento-tampone contro la povertà o contro gli esiti distruttivi di eventi eccezionali
di Gianfranco Sabattini
Lo scoppio della pandemia da Covid-19 sta rilanciando l’idea dell’introduzione nel sistema di sicurezza nazionale del reddito di cittadinanza, con le finalità che hanno inteso assegnargli coloro che per primi l’hanno proposto, non già in contrapposizione, ma ad integrazione (per il maggior rispetto della dignità umana e la maggiore efficacia sul piano della valorizzazione dell’attività lavorativa), del sistema di welfare State, introdotto dopo la fine del secondo conflitto mondiale nella seconda metà del secolo scorso.
La cosiddetta “prova dei mezzi” e le molte “condizionalità” alle quali devono sottostare i fruitori della “difesa sociale” garantita dal sistema welfarista sono la conseguenza dei molti pregiudizi che caratterizzano una malintesa tutela della “dignità del lavoro”, che hanno giustificato, sino ai nostri giorni, le critiche portate da un arco di forze sociali (tra loro molto distanti sul piano ideologico) contro la possibile introduzione del reddito di cittadinanza, riproposte di continuo da quando sono iniziate ad emergere gli irreversibili motivi di crisi del sistema del welfare State sinora realizzato. Tali forze sociali hanno sempre considerato “offensive” della dignità personale l’erogazione di un reddito cui non corrispondesse una “prestazione lavorativa” da parte del fruitore.
Ciò che ha accomunato l’intero arco di tali forze ideologicamente eterogenee è stato il convincimento che la tutela del lavoro come valore in sé fosse irrinunciabile, perché il lavoro è “vita”, “partecipazione”, “autonomia” ed altro ancora. Sulla base di questo radicato assunto, sia le forze politiche e sindacali di sinistra, sia quelle che si rifanno ai principi della dottrina sociale della Chiesa cattolica, hanno sempre sostenuto che la tutela del lavoro dovesse essere garantita attraverso la creazione di posti di lavoro, malgrado tale obiettivo divenisse sempre più difficile da perseguire nei moderni sistemi economici.
In tal modo, le “buone intenzioni” dell’ampio arco di forze sociali critiche del reddito di cittadinanza ha finito col subire gli esiti di un’eterogenesi dei fini, che ha condotto le loro intenzioni ad essere sostituite dalle “conseguenze inintenzionali” di un convincimento volto a tutelare il lavoro; in tal modo, la loro posizione è servita, non già a difendere la dignità del lavoro, bensì a tutelare gli interessi delle forze conservatrici, motivate a conservare gli esiti spontanei connessi al libero svolgersi delle forze di mercato.
Tra le voci contrarie al reddito di cittadinanza, una delle più autorevoli è stata quella espressa tempo addietro da Papa Francesco in un discorso tenuto a Genova davanti ad un’assemblea dei lavoratori dell’Ilva; ora, però, a fronte dello scoppio della pandemia da Covid-19, anche il Papa sembra essersi convinto dell’urgenza, come di recente ha dichiarato, di una “retribuzione universale di base”, cioè di una forma di reddito in grado di garantire e realizzare un tipo di società che rispetti i suoi stessi membri. L’apertura del Papa all’introduzione di un reddito di cittadinanza incondizionato ha suscitato un coro di consensi anche tra quelle forze politiche di sinistra e sindacali (forse anch’esse indotte a cambiare parere di fronte agli effetti distruttivi della pandemia da Covid-19) tradizionalmente contrarie all’introduzione di ogni forma di reddito universale e incondizionato.
La rapida conversione ad accettare di istituzionalizzare una proposta sempre avversata sotto l’incalzare dello stato dell’urgenza e della necessità non può che essere apprezzata da quanti, da tempo, nell’ambito del dibattito politico-culturale in corso in Sardegna, sottolineano la positività dell’introduzione del reddito di cittadinanza nel sistema di sicurezza sociale, a motivo della crisi irreversibile del welfare State; ne è prova l’attività del Comitato Regionale d’Iniziativa Costituzionale e Statutaria, i cui promotori ed organizzatori hanno ospitato nei loro “Blog” (Democraziaoggi, Aladinpensiero e Il Manifesto sardo), scritti e riflessioni sull’opportunità di introdurre il sempre criticato reddito di cittadinanza incondizionato nel sistemi sociali democratici ad economia di mercato; del dibattito, protrattosi negli anni non senza contrasti, fa fede la
 celebrazione, ad iniziativa del suaccennato “Comitato” e dell’“Europe Direct Regione Sardegna”, di un Convegno sul lavoro (svoltosi a Cagliari il 4-5 ottobre 2017, i cui atti sono stati raccolti nel volume “Lavorare meno, lavorare meglio, lavorare tutti”), nel corso del quale sono stati esposti gli aspetti positivi del reddito di cittadinanza, rispetto alla tutela di chi involontariamente è privato della disponibilità di un reddito di base necessario alla sua sopravvivenza. Qui di seguito vengono riassunte le motivazioni che hanno caratterizzato la proposta dell’introduzione di tale reddito di base, intorno al quale sembra essersi finalmente realizzato un generale consenso.
celebrazione, ad iniziativa del suaccennato “Comitato” e dell’“Europe Direct Regione Sardegna”, di un Convegno sul lavoro (svoltosi a Cagliari il 4-5 ottobre 2017, i cui atti sono stati raccolti nel volume “Lavorare meno, lavorare meglio, lavorare tutti”), nel corso del quale sono stati esposti gli aspetti positivi del reddito di cittadinanza, rispetto alla tutela di chi involontariamente è privato della disponibilità di un reddito di base necessario alla sua sopravvivenza. Qui di seguito vengono riassunte le motivazioni che hanno caratterizzato la proposta dell’introduzione di tale reddito di base, intorno al quale sembra essersi finalmente realizzato un generale consenso.
Il welfare State, il sistema di protezione sociale oggi esistente, è stato formulato sul piano teorico tra le due guerre mondiali del secolo scorso, per tradursi in strutture pubbliche operative nei Paesi ad economia di mercato e retti da regimi democratici, a partire soprattutto dalla fine del secondo conflitto mondiale, legittimando sul piano sociale che l’intervento dello Stato nell’economia costituisse la base portante del benessere dei cittadini, da conseguirsi attraverso la conservazione dello stabile funzionamento del sistema economico; ciò ha prodotto la trasformazione dello Stato di diritto liberale in Stato sociale di diritto, legittimando in tal modo un intervento pubblico costante di natura strutturale nel governo dell’economia. Le riforme istituzionali introdotte hanno dato luogo alla costruzione del sistema di sicurezza sociale, la cui funzione è stata quella di rendere operante la stipula di un patto politico tra capitale e lavoro, fondato sull’apporto teorico di John Maynard Keynes al pensiero economico dominante.
Il welfare State è divenuto così, sul piano dell’azione politica dei Paesi che l’hanno adottato, il presidio della realizzazione delle condizioni volte a garantire lo stabile funzionamento del sistema economico, con una crescente creazione e conservazione di opportunità lavorative. In particolare, il sistema welfarista ha assunto anche la funzione di assicurare alla forza lavoro, nel caso fosse risultata temporaneamente e involontariamente disoccupata, la garanzia di un reddito da corrispondere sotto forma di sussidio, a fronte di contribuzioni previdenziali a carico di imprese e lavoratori.
Negli anni successivi alla sua introduzione, il welfare State ha perso gran parte della sua funzionalità, a causa del formarsi di una diffusa disoccupazione sempre più difficile da “governare”; fatto, quest’ultimo, che ha messo progressivamente in crisi il sistema di sicurezza sociale realizzato, a causa delle profonde trasformazioni delle modalità di produzione del prodotto sociale e della crescente partecipazione dei cittadini alle procedure decisionali dell’attività politica.
E’ però opportuno ricordare che il welfare State fondato sulle idee di William Beveridge, si contrapponeva una proposta alternativa, avanzata da James Edward Meade (premio Nobel per l’economia 1977 e già docente alla London School of Economics e alla Cambridge University). Meade proponeva che la sicurezza sociale fosse garantita in termini radicalmente diversi da quelli previsti dal sistema suggerito da Beveridge; la sicurezza sociale, a suo parere, poteva essere meglio assicurata, invece che con la corresponsione ai soli disoccupati di sussidi condizionati (vincolando, ad esempio, il disoccupato a reinserirsi nel mondo del lavoro e a sottoporsi a un insieme di controlli non sempre rispettosi della dignità della persona), attraverso l’erogazione di un reddito di cittadinanza universale e incondizionato, da corrispondere a tutti i cittadini senza alcun vincolo. Meade chiamava tale forme di reddito “dividendo sociale”, da finanziarsi senza alcun inasprimento del sistema fiscale ad integrazione del welfare State. Il dividendo sociale, doveva essere corrisposto a ciascun cittadino sotto forma di trasferimento pubblico, indipendentemente da ogni considerazione riguardo ad età, sesso, salute, stato lavorativo, stato coniugale, prova dei mezzi e funzionamento stabile del sistema economico.
Il fine ultimo della proposta di Meade era quello di realizzare un sistema di sicurezza sociale che riconoscesse ad ogni singolo soggetto, in quanto cittadino, il diritto ad un reddito di base, erogato in termini assolutamente ugualitari. Tuttavia, tale proposta non è stata accolta, non solo per il maggior accreditamento sociale delle idee keynesiane sulle quali era stato formulato il sistema di welfare, ma anche perché i “Gloriosi Trent’Anni” (1945-1975), nell’arco dei quali i sistemi sociali democratici ad economia di mercato hanno vissuto un periodo di crescita sostenuta, sono valsi a giustificare il consenso in pro dei welfare State nazionali, aperti ad allargare sempre di più le loro funzioni.
Se il processo di allargamento delle finalità dei sistemi di welfare, ha avuto l’effetto di promuovere l’espansione e la sicurezza economica dei cittadini, esso ha anche portato ad una continua crescita della spesa pubblica, la cui copertura, per via dell’aumentata frequenza dei periodi di instabilità dei sistemi economici, è stata la causa del rallentamento del processo di crescita e sviluppo delle economie, con la formazione di crescenti livelli di disoccupazione strutturale irreversibile. Tali fenomeni, oltre ad incrinare l’antico patto tra capitale e lavoro, hanno anche determinato una crisi più generale del welfare State, progressivamente trasformatosi in struttura caritatevole nei confronti di una crescente massa di disoccupati, contribuendo ad allargare l’area della povertà, a causa delle sempre più limitate prestazioni sociali nei confronti di chi perdeva la stabilità del posto di lavoro.
Alla fine degli anni Settanta del secolo scorso, il rallentamento della crescita e dello sviluppo, nonché la conseguente crisi del welfare, hanno comportato il “ricupero” di antiche ideologie economiche e politiche conservatrici, dando vita al neoliberismo; imputando la causa della stagnazione del sistema economico al crescente livello della spesa pubblica, questa nuova ideologia ha individuato la soluzione del problema del rilancio della crescita e dello sviluppo nella riduzione delle prestazioni sociali (considerate un disincentivo al lavoro) e del carico fiscale (col quale veniva finanziato il sistema di sicurezza sociale).
Quali siano stati gli esiti di questo nuovo orientamento politico è ormai nell’esperienza di tutti. Ma se il connotato principale degli attuali sistemi produttivi ad economia di mercato è stato quello di causare crescenti livelli di disoccupazione strutturale (complici, da un lato, l’internazionalizzazione senza regole delle economie nazionali e, da un altro lato, l’elevata velocità dei processi di miglioramento delle tecnologie produttive), quale prospettiva può essere offerta ai disoccupati irreversibili (e, in generale, a tutti coloro che risultano privi di reddito) di partecipare alla distribuzione del prodotto sociale, perché sia loro reso possibile di perseguire dignitosamente il proprio progetto di vita?
La risposta a questo interrogativo può essere data solo prendendo in considerazione una riforma delle modalità di distribuzione del prodotto sociale, erogando a tutti i cittadini un dividendo sociale (come originariamente lo ha denominato Meade), indipendentemente dalla loro età e dal fatto di essere occupati, disoccupati o poveri; una soluzione però ignorata dai Paesi sempre più frequentemente colpiti da crisi economiche, le cui forze politiche hanno preferito, al contrario, continuare a “rabberciare” il vecchio sistema welfarista.
Da tempo, a livello internazionale, si propone di ricuperare l’originaria proposta di Meade, per istituzionalizzare un reddito di inclusione, una forma di trasferimento pubblico (a favore di chi è privo di reddito) diversa da quella prevista dal sistema welfarista; tale è, ad esempio, il trasferimento che, con la denominazione impropria di reddito di cittadinanza, viene corrisposto sulla base dei provvedimenti adottati di recente in Italia. In realtà, questa forma di erogazione fondata su un’impropria identificazione tra povero e disoccupato ed un approccio caritatevole, che vede nel percettore del reddito un potenziale approfittatore da tenere sotto sorveglianza ed al quale prescrivere persino i consumi, è tutto fuorché un dividendo sociale (o reddito di cittadinanza) universale e incondizionato.
Una riforma delle regole di distribuzione del prodotto sociale fondata sull’introduzione di un reddito di cittadinanza à la Meade renderebbe inutile, quasi totalmente, l’intero apparato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, qualora essa fosse associata ad una riqualificazione dell’attuale sistema di welfare, indirizzandolo a curare prevalentemente, se non esclusivamente, la formazione professionale e lo stato di salute dei cittadini. Tale riforma renderebbe plausibile il rilancio di uno stabile processo di crescita e sviluppo, evitando ogni possibile spreco della risorsa più preziosa (cioè la capacita lavorativa e creativa dei cittadini) della quale ogni sistema dispone anche nelle fasi di crisi.
Con l’introduzione di un reddito di cittadinanza (universale e incondizionato) e la riqualificazione del sistema di welfare diventerebbe realistico pensare che il settore pubblico, liberato dall’incombenza di risolvere i problemi distributivi di momento in momento insorgenti, possa essere orientato prevalentemente ad allargare e diversificare l’offerta di beni collettivi, utili a massimizzare la valorizzazione delle capacità lavorative di tutti i cittadini; i quali, attraverso la loro creatività, potranno concorrere a plasmare, non solo l’economia, ma anche la società alla quale appartengono.
Che senso può avere la costituzione di un’organizzazione della società fondata su un’attività d’investimento pubblico volto a rendere massima la valorizzazione delle capacità lavorative individuali? Se si riflette sulle difficoltà delle moderne economie industriali a creare nuovi posti di lavoro, l’introduzione di un reddito di cittadinanza universale e incondizionato risponderebbe all’urgenza che le politiche pubbliche tradizionali divengano conformi alla soluzione dei problemi del nostro tempo, quali – tra i molti – la povertà, la disoccupazione, la salute pubblica e la bassa produttività dell’attività politica, ora perennemente “schiacciata” sul presente e poco orientata a progettare il futuro.
Questi problemi possono essere adeguatamente affrontati da una riorganizzazione del sistema sociale che, eliminando le disuguaglianze, la disoccupazione, la povertà e le minacce allo stato di salute della collettività, crei sempre più spazio ad attività d’investimento pubblico volte a massimizzare il prodotto sociale, attraverso la promozione di attività produttive autodirette, come fonte di reddito alternativo al lavoro eterodiretto (o dipendente), del quale il processo di accumulazione capitalistica contemporanea tende ad avere sempre meno bisogno.
————————————

Rammentiamo che è in corso una Campagna per l’istituzione del Reddito di cittadinanza incondizionato e universale in Italia e in tutti gli altri paesi dell’Unione Europea, promossa da Unconditional Basic Income Europe e da BIN Italia. Aladinpensiero, il manifesto sardo, Democraziaoggi e Giornalia appoggiano detta Campagna e invitano a firmare l’apposito appello.
—————————————————-
Materiali per il Dibattito su Lavoro e Reddito di Cittadinanza
[segue]
Che succede nel pianeta?

![]() Da tempo su Aladinpensiero e in altre pubblicazioni insistiamo sulla pertinente/felice convergenza tra l’analisi e le indicazioni dell’enciclica di Papa Francesco, Laudato sì’, e quelle dell’Agenda Onu 2030. Siamo stati anche tra gli organizzatori di importanti convegni in argomento. Al riguardo prendiamo atto con soddisfazione delle rilevanti iniziative di approfondimento che vedono impegnate importanti organizzazioni, tra le quali – come risulta dagli articoli che sotto riportiamo – la Pontificia Accademia per le scienze sociali e l’AsVis – Associazione per lo Sviluppo sostenibile (della quale ultima come Associazione aladinpensiero siamo soci). Ci piacerebbe vedere su queste tematiche uno spiccato impegno anche dell’Università della Sardegna (il singolare è voluto) e di tutto l’associazionismo economico, politico, sociale e culturale degli ambiti territoriali di nostro primo riferimento, (la Sardegna) e oltre. È questione vitale. Stiamo infatti parlando della nostra sopravvivenza come umanità, al di là della stessa persistenza del nostro pianeta. In tutto questo discorso troviamo pertinente il nostro recente impegno nella Scuola per la Costituente della Terra, della quale non a caso riportiamo in testa al presente articolo il logo che la rappresenta con felice grafica.
Da tempo su Aladinpensiero e in altre pubblicazioni insistiamo sulla pertinente/felice convergenza tra l’analisi e le indicazioni dell’enciclica di Papa Francesco, Laudato sì’, e quelle dell’Agenda Onu 2030. Siamo stati anche tra gli organizzatori di importanti convegni in argomento. Al riguardo prendiamo atto con soddisfazione delle rilevanti iniziative di approfondimento che vedono impegnate importanti organizzazioni, tra le quali – come risulta dagli articoli che sotto riportiamo – la Pontificia Accademia per le scienze sociali e l’AsVis – Associazione per lo Sviluppo sostenibile (della quale ultima come Associazione aladinpensiero siamo soci). Ci piacerebbe vedere su queste tematiche uno spiccato impegno anche dell’Università della Sardegna (il singolare è voluto) e di tutto l’associazionismo economico, politico, sociale e culturale degli ambiti territoriali di nostro primo riferimento, (la Sardegna) e oltre. È questione vitale. Stiamo infatti parlando della nostra sopravvivenza come umanità, al di là della stessa persistenza del nostro pianeta. In tutto questo discorso troviamo pertinente il nostro recente impegno nella Scuola per la Costituente della Terra, della quale non a caso riportiamo in testa al presente articolo il logo che la rappresenta con felice grafica.

“È la fine del mondo, bellezza, e tu non puoi farci niente”
di Rachele Gonnelli
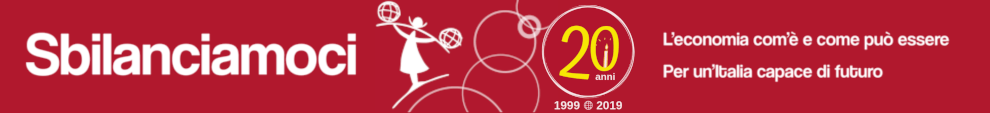 Sbilanciamoci, 9 Febbraio 2020 | Sezione: Ambiente, Apertura.
Sbilanciamoci, 9 Febbraio 2020 | Sezione: Ambiente, Apertura.
Due convegni, in Vaticano e alla Farnesina, hanno approfondito il dibattito su come uscire dalla crisi del capitalismo con politiche di sviluppo sostenibile e attento al benessere delle popolazioni, sull’agenda Onu 2030. Hanno partecipato esperti tra cui Stiglitz e Georgieva, persino il papa. La stampa italiana era distratta.
Due importanti conferenze sull’economia della transizione e su come impostare un diverso modello di sviluppo, di livello internazionale, si sono svolti a Roma nella prima settimana di febbraio; la stampa nazionale non ha dato pressoché notizia.
Il 5 febbraio in una splendida palazzina cinquecentesca a ridosso della Basilica di San Pietro, la Casina Pio IV o Casa delle scienze della Città del Vaticano, la Pontificia accademia delle scienze sociali ha chiamato a convegno, per una discussione che è durata l’intera giornata, bei nomi degli studi economici e protagonisti istituzionali di primo piano (il premio Nobel per l’economia Joseph Stiglitz e la nuova direttrice del Fondo monetario internazionale Kristalina Georgieva, nominata lo scorso ottobre, ma anche ministri come l’argentino Martin Guzman, il paraguaiano Benigno Lopez, la salvadoregna Maria Luisa Hayem, il francese Bruno Le Maire, la spagnola Nadia Calvino, il messicano Arturo Herrera, il presidente della Banca europea degli investimenti Werner Hoyer e il presidente del Banco centroamericano de intergracion economica Date Mossi e altri) sul tema “Nuove forme di solidarietà”. E già nel sottotitolo della conferenza – “inclusione, integrazione, innovazione” – c’era un evidente riferimento agli obiettivi dell’agenda delle Nazioni Unite per i prossimi dieci anni. (l’evento è interamente visibile su https://www.youtube.com/watch?v=mNoraYBzbtE)

L’altro appuntamento, che si è svolto alla Farnesina solo due giorni più tardi, era la presentazione del rapporto dell’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (AsVis), rete di associazioni, imprese, ong, università, rappresentare delle organizzazioni internazionali in Italia ed enti territoriali per promuovere politiche economiche, sociali e ambientali coerenti con il raggiungimento dei 17 “goals” o obiettivi fissati dalle Nazioni Unite per il 2030, in grado cioè di far fronte al cambiamento climatico con politiche che contengano le emissioni inquinanti e aiutino le popolazioni a resistere agli sconvolgimenti ambientali e agli altri disequilibri del mondo che minano la pace e il benessere, tra cui le migrazioni.
L’AsVis (qui il report sulla legge di bilancio https://asvis.it/presentazione-analisi-legge-di-bilancio/), – nata quattro anni fa su impulso dello statistico Enrico Giovannini, che oggi ne è portavoce, e dall’università di Tor Vergata a Roma – con la collaborazione di oltre 600 esperti ha messo a punto indicatori specifici per monitorare lo stato di avanzamento delle politiche italiane ed europee per l’avvicinamento ai target 2030. “Solo dieci anni di tempo per salvare il mondo, non il pianeta che continuerà forse anche meglio di così, ma l’uomo, l’umanità”, ha detto Giovannini nel suo intervento iniziale per spiegare il senso del condensato di obiettivi, riconosciuti come esiziali a livello internazionale, nel cronoprogramma messo a punto dall’Onu.
I due eventi non hanno fatto che parlarsi, anche senza espliciti rimandi l’uno all’altro. In entrambi la parola che è risuonata più spesso è stata “diseguaglianze”, con la specificazione – sottolineata da Alicia Barcena Ibarra in Vaticano, segretaria della Cepal, organizzazione economica dei paesi dell’America latina e Caribe legata all’Onu – che quando si parla di diseguaglianze non si parla di povertà, ma ad esempio dei movimenti di studenti che in Cile rivendicano, anche attraverso azioni di disobbedienza civile, un più ampio e gratuito accesso a servizi essenziali che vengono loro sempre più negati, dalla sanità a una formazione di qualità, a servizi di trasporto locali. Un’altra parola che è risuonata in entrambi gli eventi è stata “bene comune”, un obiettivo che secondo Stiglitz è andato disperso dopo quarant’anni di ricette neoliberiste che hanno mandato in crisi “il capitalismo”.
Quindi è di tentativi di riforma del sistema, che non sembra più in grado di assicurare anche solo la speranza di un progresso sociale e di benessere, che si è parlato in ambedue le assise. Esiste un enorme problema macroeconomico, è stato riconosciuto da più oratori, tra cui Jeffrey Sachs, della Columbia. Un enorme deficit di capacità della politica di affermare un’agenda diversa da quella ormai fallita dell’austerity e del neoliberismo che sta portando l’umanità alla distruzione di risorse essenziali, libertà, diritti e speranze di miglioramento.
I due convegni hanno avuto anche espliciti riconoscimenti reciproci del medesimo cammino. Riferimenti all’enciclica “Laudato Sì’” da parte di Giovannini, dal presidente AsVis Pierluigi Stefanini e da altri alla Farnesina, riferimenti continui agli impegni per il Millennio delle Nazioni Unite in Vaticano, oltre che al primo testo economico della Dottrina della Fede: “Oeconomicae et pecuniaria quaestiones”, che toglie dal campo qualsiasi possibilità di doppia morale per l’imprenditore, il banchiere, il politico cattolico.
Nella Casa della scienza della Santa Sede, Jorge Bergoglio, a sorpresa, si è appalesato nel pomeriggio, pronunciando un accorato discorso a braccio, in spagnolo, a proposito soprattutto della necessità di garantire uno sviluppo sostenibile anche consentendo la ristrutturazione del debito dei paesi più poveri – evidente il riferimento alla sua Argentina e gli sforzi dello stesso pontefice per evitare un altro disastroso default a causa del prestito più oneroso della storia del Fondo monetario internazionale contratto dal governo neoliberista di Macri e lasciato in eredità al nuovo corso kirchnerista.
Nessuno ha usato la parola “populismo” né qui né là, Oltretevere, neanche quando sono state incidentalmente evocate le speranze tradite da Peron negli anni Trenta dell’altro secolo. Ed è sembrata prevalere una analisi, implicita negli interventi, che vede casomai il popilusimo come un epifenomeno del più vasto problema di scollamento della democrazia e di cronicizzazione delle enormi diseguaglianze.
Di tutto ciò la stampa italiana non si è interessata, evidentemente convinta che questi argomenti siano scarsamente interessanti per i politici di riferimento, meno degli starnuti dell’ex ministro dell’Interno. O delle psicosi alimentate dalla cattiva informazione sul coronavirus, cioè di una infezione che, in effetti, riguarda le diseguaglianze, l’accesso a servizi essenziali, la dissipazione delle risorse attraverso la guerra e la nuova guerra fredda tra Pechino e Washington. Senza che parlare della paura del coronavirus possa però aiutarci a uscire da questo gorgo distruttivo. Non sembra così incomprensibile che la scelta di privilegiare solo notizie che creino ansia, paura, senso di ineluttabilità, comporti poi l’abbandono di tanti lettori: da sei milioni i lettori di giornali sono passati, in meno di dieci anni, a quasi due. Le testate mainstream – ma anche quelle che si dichiarano controcorrente – sembrano affette dallo stesso morbo che colpisce la politica: l’incapacità ad abbandonare il quarantennale palinsesto neoliberista, fatto di valutazioni che derivano dalle analisi delle agenzie rating, piuttosto che dall’attenzione a cosa succede alle persone fisiche e ai loro contesti. Giornali e telegiornali risultano sordi alla scienza, ai richiami che vengono dalle Nazioni Unite o dal papa, come se questi fossero discorsi marginali, da riservare al secondo sfoglio, insieme alle cure per l’invecchiamento della pelle e al vegetarianismo.
——————————–
Disuguaglianze
occorrono più crescita e sicurezza
Francesca Cicoria, su Rocca.
Una delle sfide più importanti che andrebbero affrontate nell’epoca contemporanea è certamente la riduzione delle disuguaglianze. Esse inevitabilmente generano instabilità politica, proteste di massa, conflitti che possono evolvere in guerre. L’allarme è stato lanciato dall’Onu, nel World Social Report, che registra dal 1990 una crescita della disuguaglianza per più di due terzi della popolazione mondiale. L’1% della popolazione di 18 Paesi, tra cui Stati Uniti, Russia, India e Brasile, detiene oltre il 20% della ricchezza mondiale. La quota di reddito che va all’1% più ricco della popolazione mondiale è aumentata in 46 Paesi sui 57 per i quali sono disponibili i dati 1990-2015, mentre il 40% con i redditi più bassi ha guadagnato il 25% in meno in 92 Paesi. Del problema se n’è parlato in Vaticano alla Casina Pio IV nel giorno di apertura del workshop «Nuove forme di fraternità solidale, di inclusione, integrazione e innovazione» promosso dalla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Per il Presidente Stefano Zamagni «La novità dell’ultimo trentennio è che sono le regole, cioè la struttura delle relazioni economiche, a generare le disuguaglianze indipendentemente dalla volontà delle persone. Oggi le disuguaglianze sono provocate dal modo in cui funziona la finanza speculativa Internazionale». Oggi la finanza è autoreferenziale, non persegue più il suo vero fine che è quello di favorire l’economia reale e lo sviluppo. L’economista Zamagni ritiene che sia necessario «un patto globale per modificare le regole del gioco economico, a livello soprattutto internazionale». Non meno importante è la «solidarietà» tra i popoli, i governi e le organizzazioni internazionali, uno dei «tre pilastri della Dottrina Sociale della Chiesa, assieme alla sussidiarietà e al bene comune».

Europa, Europa

La Germania e l’Europa: intervista a Achim Truger
di Alessandro Bramucci

Sbilanciamoci. 2 Maggio 2019 | Sezione: Apertura, Europa
Ue al bivio/ Gli errori dell’Europa, una Germania con l’economia che rallenta e fatica a cambiare modello, il ritardo dell’Italia. L’analisi di Achim Truger.
Achim Truger è dall’aprile 2019 professore di finanza pubblica presso l’istituto di socio-economia dell’università di Duisburg-Essen ed è membro del consiglio di esperti economici del governo tedesco. Si occupa di politiche fiscali ed è stato un critico dell’austerità in Europa e dei limiti alla spesa pubblica in Germania. Visita spesso l’Italia e legge molto bene l’italiano.
A breve ci saranno le elezioni europee. In Italia, in Germania, come in altri molti paesi dell’Unione è cresciuto sensibilmente il malcontento nei confronti delle istituzioni europee ma anche dell’idea stesse di Europa unita. Ha ancora senso parlare oggi di Europa?
Assolutamente sì e occorrono buone idee per rafforzarla. Il problema e che negli ultimi dieci anni dall’Europa sono arrivate proposte spesso sgradite. L’Europa ha proposto politiche economiche di stampo fortemente neoliberale come una politica monetaria indipendente, rigidi trattati fiscali, deregolamentazione dei mercati, insieme a quelle che amichevolmente vengono definite riforme strutturali ma che in realtà significano tagli alla spesa pubblica e al welfare. Questo tipo di politiche hanno chiaramente dimostrato il loro fallimento con la crisi dell’euro colpendo duro nelle cosiddette “periferie” dell’Europa, specialmente in Italia. Non c’è quindi da sorprendersi se l’atteggiamento verso l’Europa non sia poi così benevolo. Questo non significa che l’idea stessa di Europa o che l’amicizia tra popoli sia responsabile di politiche sbagliate e irrazionali. Occorre riflettere seriamente su che cosa fare e proporre riforme istituzionali serie sia a breve che a lungo termine. Tuttavia dato il contesto politico attuale diventa sempre più difficile trovare punti di accordo e se continua così bisogna preoccuparsi davvero per la tenuta dell’Europa. Trovo triste che non sia più la diplomazia e la politica estera a mantenere le relazioni tra i Paesi europei quanto piuttosto i ministri delle Finanze che cercano di darsi ordini a vicenda ognuno facendo i conti in tasca all’altro. Certo, per le persone nei Paesi colpiti non è un buon segnale.
In Germania crescono le diseguaglianze. In base a dati Eurostat, la quota dei disoccupati che sono a rischio povertà è del 70 per cento, il più alto nell’Unione europea. Quali sono, secondo lei, le cause delle crescenti diseguaglianze? Quali sono i suoi suggerimenti a riguardo?
La crescita delle diseguaglianze in Germania è un argomento controverso. Molti economisti si occupano di questo tema mostrando ad esempio come dal 1995 le disuguaglianze siano aumentate enormemente. C’è bisogno di un’analisi seria a riguardo. Il coefficiente di Gini è senza dubbio uno strumento, ma non il solo. Il tasso di povertà come anche il tasso di concentrazione della ricchezza sono altri importanti indicatori. Ma occorre molto di più. Credo che nel complesso sia importante monitorare il contesto socio-istituzionale nel quale le persone vivono e lavorano. Penso ad esempio all’aumento della precarietà, al rincaro del costo degli affitti, alla paura della povertà in età avanzata. Tutti questi fattori hanno contribuito al crescente senso d’insoddisfazione e ingiustizia sentito da molti in Germania. Occorre prendere sul serio questi segnali. Non basta dire come fanno alcuni che il coefficiente di Gini dal 2005 non ha subito grossi cambiamenti per liquidare il problema. Il problema c’è, eccome, e occorre fare qualcosa al più presto. Certamente ci sono tante ragioni che contribuiscono a spiegare l’aumento delle diseguaglianze, come ad esempio il cambiamento tecnologico. Anche se personalmente credo che ci siano delle chiare cause politiche. Negli ultimi 30-40 anni abbiamo assistito alla progressiva deregolamentazione del mercato del lavoro, le cosiddette riforme strutturali. Mentre le imposte sulle imprese sono diminuite, lo Stato sociale è stato gradualmente smantellato. Questo tipo di deregolamentazione ha portato all’indebolimento della contrattazione salariale, all’indebolimento dei sindacati e quindi a una ad una bassa crescita dei salari nel Paese. Si è voluto creare inoltre un settore a bassi salari, i cosiddetti “mini-jobs”. Queste sono tutte ragioni che contribuiscono a spiegare l’evoluzione del reddito primario insieme a tassazione e trasferimenti operati dallo Stato sociale nella distribuzione secondaria del reddito. Spesso il dibattito si è limitato alle tasse. Credo che sia importante che i ricchi paghino più tasse, rafforzando così lo Stato sociale, ma penso che si debba tornare molto più indietro nel senso di regolamentare di nuovo il mercato del lavoro. Solo così si possono rafforzare le posizioni dei lavoratori e dei sindacati contribuendo alla crescita dei salari. Anche l’introduzione del salario minimo ha avuto un ruolo importante e trovo positivo che sia cresciuto, anche si può fare ancora di più.
Il Consiglio Economico – di cui lei fa parte – ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita della Germania anche in base ai segnali negativi che arrivano dall’economia mondiale sottolineando la forte dipendenza dell’economia tedesca dall’export. Prevede nei prossimi anni un cambiamento nel modello di crescita tedesco?
A marzo il Consiglio ha rivisto allo 0,8 le previsioni per l’anno corrente basandosi in gran parte sul fatto che gli ultimi due trimestri del 2018 sono stati molto più deboli del previsto facendo di conseguenza abbassare il tasso di crescita medio per il 2019. Tuttavia se si guarda alle dinamiche della congiuntura economica prevista per il 2019 su base trimestrale, sembra che la crescita rimanga ancora relativamente sostenuta. Allo stesso tempo, le esportazioni sono diminuite insieme ad altri fattori negativi che nelle ultime settimane hanno fatto aumentare le preoccupazioni per l’economia tedesca. Se ci sia il pericolo di una vera e propria recessione o sia soltanto una breve fase negativa del ciclo è difficile da dire ma il rischio di recessione è senza dubbio aumentato. Ci sono inoltre i rischi legati alla Brexit, qualora si dovesse arrivare all’uscita non concordata del Regno Unito. Ci sono poi i rischi legati alla Cina e all’andamento dell’economia cinese anche in vista di una possibile escalation della guerra commerciale. Si potrebbe dire che la Germania ha già apportato un leggero cambiamento al suo modello economico. Mentre fino alla crisi finanziaria il settore estero ha contribuito in gran parte alla crescita del Paese, è adesso la domanda interna ad avere un ruolo trainante. Dopotutto è l’economia nazionale che al momento tira e che può quindi compensare nel caso di eventuali recessioni all’estero. Certo che se si dovesse registrare davvero una caduta delle esportazioni e degli investimenti allora ci sarebbe il pericolo reale di una recessione in Germania. In questo senso non si può ancora parlare di un definitivo cambiamento del modello economico. Personalmente credo che ci sia bisogno di un cambiamento nel modello di crescita per essere meno dipendenti dal commercio estero e far crescere di più la domanda domestica. Surplus elevati nella bilancia commerciale a lungo termine non funzionano e portano anche a reazioni di tipo politico come con Trump, rappresentando di fatto un rischio di instabilità per il Paese.
L’Italia è uno dei paesi dell’Europa “del Sud” che continua a soffrire maggiormente della crisi. Pensa che l’Italia sia stata svantaggiata dall’attuale assetto monetario ed istituzionale dell’Europa?
L’Italia è davvero un caso tragico. Trovo la questione molto importante e trovo che ciò che sta accadendo, inclusi i problemi che deve affrontare il governo nelle istituzioni europee, non sia dovuto alla crisi economica o alle attuali politiche, quanto piuttosto a problemi che risalgono in parte al passato. L’Italia ha avuto una pesante eredità e, considerato il contesto attuale, è estremamente difficile per il Paese uscire dalla crisi da solo. Molti sostengono che l’Italia ha bisogno di riforme strutturali. Non ne so molto della struttura economica italiana e temo che molti di quelli che fanno suggerimenti a riguardo ne sappiano altrettanto poco. Mi chiedo come queste riforme strutturali possano veramente favorire la crescita e l’occupazione e non piuttosto aggravare la crisi. L’Italia è stata tra i protagonisti del processo di unificazione europeo ma ha perso progressivamente capacità di negoziazione e spazi di manovra. Nel mercato interno ora l’Italia si trova a competere con i paesi dell’Est Europa. C’è poi stata la globalizzazione e l’entrata della Cina dell’economia globale. Tutti questi fattori hanno colpito duramente il ruolo politico ed economico dell’Italia. Allo stesso tempo le regole fiscali europee hanno ridotto il controllo della spesa pubblica come strumento di politica economica. La politica monetaria è ora in mano alla Banca centrale europea e l’Italia non ha più la capacità di svalutare, tantomeno quello di finanziare, la spesa pubblica. Questi sono gradi di libertà che il Paese ha perso e che rendono l’uscita dalla crisi molto difficile. Ritengo che sarebbe stato intelligente aiutare l’Italia prima. Credo inoltre che nell’attuale contesto istituzionale sia molto difficile per l’Italia tornare alla crescita senza maggiori possibilità di spesa o perfino senza l’aiuto di altri Paesi. Al momento è difficile cooperare con il governo italiano anche perché questo sta cercando lo scontro aperto. Dall’altro lato se l’Italia dovesse sprofondare di nuovo nella crisi sarebbe la fine dell’euro. Ci si sarebbe dovuti arrivare molto prima, prima della fase dei ricatti e dei contro-ricatti. Penso che a questo punto non si tratti più solo di economia. Dobbiamo ristabilire la fiducia tra i popoli. Come ho detto, una situazione molto brutta e deprimente.
Quale strategia si sente di suggerire all’Italia anche alla luce delle ultime riforme dell’attuale governo M5S-Lega?
Anche se al momento il governo sta cercando lo scontro e le riforme potrebbero risultare in qualche modo dubbiose (non conosco i dettagli di queste politiche), occorre dare all’Italia più margine di manovra. Se l’Italia dovesse concentrarsi esclusivamente sul consolidamento dei conti pubblici, c’è il rischio che la crisi si aggravi ancora di più. Credo che ciò di cui l’Italia ha bisogno nel medio e lungo termine sia una politica macroeconomica europea insieme ad una strategia di politica industriale europea, in cui l’Italia – ed in particolare il Sud del Paese – svolgano un ruolo centrale.
Lei è uno degli esponenti di spicco tra gli economisti eterodossi in Germania ed Europa. Qual è la sua visione della disciplina economica?
Occorre separare il pluralismo metodologico da quello che invece è il pluralismo in tema di politiche economiche. Si può essere metodologicamente “mainstream” o perfino neoclassici e tuttavia progressisti dal punto di vista delle politiche. I modelli saranno solo più complessi, ma funziona nel senso che si può arrivare a valutazioni e proposte sostanzialmente differenti da quelle ortodosse. Non bisogna essere per forza metodologicamente eterodossi. Certo che, se si è keynesiani, l’impostazione di base è già differente ed è quindi più facile supportare certe posizioni rispetto a un economista neoclassico. Per quanto riguarda il lavoro del Consiglio, per me è importante che le proposte di politica economica seguano un approccio ispirato dalla pluralità delle teorie economiche. Per quanto riguarda la disciplina economica in quanto tale, io mi considero pluralista anche in ambito metodologico e trovo che negli ultimi 10-15 anni si sia fatto molto. La scienza economica si è aperta a nuove metodologie, si lavora molto di più con i dati, si sono aperti nuovi orizzonti di ricerca come l’economia comportamentale e tanto altro. Penso inoltre che, per avere un vero approccio multi-paradigmatico in economia, sia importante imparare la storia economica, conoscere la storia del pensiero economico, nel senso della storia dei dogmi del pensiero economico, come anche la filosofia, la filosofia della scienza e la metodologia. L’insegnamento di queste tematiche dovrebbe essere rafforzato nei programmi di economia delle università. In questo modo si potranno formare degli economisti più aperti e con un ampio orizzonte culturale, che sappiano capire e interpretare un ampio spettro di dottrine economiche insieme ai loro risvolti politici. In ultima analisi, economisti che sappiano consigliare meglio la politica. Questo è possibile solo se si ha una formazione economico-culturale più ampia possibile. In fondo la visione di Keynes era simile.
Qual è il ruolo del Consiglio di esperti economici della Germania?
Il Consiglio di esperti economici è stato istituto per legge nel 1963. I cinque consiglieri vengono anche comunemente definiti i cinque saggi. È un organismo indipendente che ha il compito di monitorare l’andamento economico del Paese ed eventualmente di formulare proposte di politica economica nei cosiddetti “quattro punti magici”: crescita economica continua e sostenuta, alti livelli di occupazione, stabilità dei prezzi, equilibrio nei conti con l’estero. Il Consiglio ha iniziato la sua attività negli anni Sessanta influenzato da uno spirito keynesiano, si può dire. Quello era il tempo in cui la politica economica aveva un ruolo fondamentale nel guidare il ciclo economico. Negli anni Settanta e Ottanta è poi arrivata la svolta monetarista e da allora si può dire che il Consiglio è in gran parte d’ispirazione conservatrice e ordoliberale. I cinque saggi sono nominati dal Presidente federale su proposta del governo federale, ma di solito solo tre sono nominati dal governo, mentre uno è nominato dalle organizzazioni degli industriali e l’altro dai sindacati. Io sono stato nominato dai sindacati.
Prenderà il posto di Peter Bofinger, l’unico economista di tradizione keynesiana nel Consiglio, che ha spesso espresso il voto di minoranza. Come funziona e qual è il ruolo del voto di minoranza all’interno del Consiglio? Ha intenzione di seguire l’esempio del suo predecessore?
La possibilità di esprimere il voto di minoranza è sancita dalla legge. Se uno o più di uno dei membri non condivide le posizioni del Consiglio, questo o questi hanno la possibilità di esprimere posizioni alternative. Al Consiglio spetta l’obbligo di metterle agli atti. In passato sono stati espressi numerosi voti di minoranza e a Peter Bofinger, che è stato per quindici anni nel Consiglio, spetta il record di voti di minoranza. Certamente io ho opinioni simili a quelle di Bofinger ma non posso dire in anticipo se utilizzerò o meno questo strumento. Dipende dagli argomenti che si affronteranno di volta in volta e dalle proposte che vengono fatte e ovviamente se io possa accettarle o no. Credo che la migliore rappresentazione dell’attività del Consiglio sia proprio quella formulata nel testo di legge. Il Consiglio deve prendere in considerazione diverse ipotesi discutendone il loro impatto senza tuttavia formulare raccomandazioni specifiche per un determinato provvedimento. Questa è anche la mia visione dell’economia. In materia di politica economica c’è un ampio spettro di possibili raccomandazioni a disposizione e, a mio avviso, spetta al Consiglio presentare questo spettro chiarendone bene le condizioni e le conseguenze. Finché questo spettro viene appropriatamente rappresentato, non c’è motivo di esprimere voti di minoranza.
Quale sarà il suo ruolo all’interno del Consiglio? Prevede spazi di cambiamento nella politica economica del governo tedesco?
Non ci sono delle responsabilità specifiche anche se le previsioni economiche sono una delle attività principali. Per questo tipo di lavoro c’è anche un gruppo di 15 economisti che lavora a tempo pieno per il Consiglio e che svolge un ruolo fondamentale nella preparazione del materiale prima che gli stessi consiglieri se ne occupino personalmente. In passato mi sono occupato molto di conti pubblici, di politiche fiscali e di tassazione e continuerò con questo tipo di lavoro anche nel Consiglio. Al momento trovo interessante che il dibattito economico in Germania sia di nuovo ripreso. Per anni non c’è stato alcun dibattito serio ma negli ultimi mesi si è tornati a discutere del Patto di stabilità e crescita e del tetto al debito pubblico. Ci sono molti economisti che iniziano a dire come queste regole fiscali lascino troppo pochi spazi di manovra rendendo gli investimenti sempre più difficili. Si fanno anche proposte di riforma a riguardo, anche se a me sembra che sia la politica a non voler recepire il messaggio. All’interno del ministero delle Finanze ci sono già delle idee su come si potrebbe fare ad avviare, ad esempio, un fondo per gli investimenti. A mio avviso questo è già un segno positivo. Tuttavia per quanto riguarda il freno al debito pubblico occorrerebbe cambiare la Costituzione con una maggioranza di due terzi il che non è sicuramente facile. Tuttavia qualcosa sta cambiando. Il momento critico arriverà proprio nel caso dovesse realizzarsi una congiuntura economica negativa per il Paese. Il deficit aumenterà, aumentando di conseguenza la pressione sui conti pubblici. Sarà allora da vedere se la maggioranza degli economisti sarà per un consolidamento dei conti, per uno stimolo fiscale o per guidare un programma di stimolo economico. Staremo a vedere. Io spero in quest’ultimo.
Dibattito
 Ciò che la sinistra non ha fatto
Ciò che la sinistra non ha fatto
LA VERA NATURA DEL REDDITO DI CITTADINANZA
Il suo scopo non è di far sopravvivere una platea più o meno ristretta di persone che cercano e non trovano lavoro, ma di garantire il diritto all’esistenza di tutti, e la loro autodeterminazione, come prima responsabilità di uno Stato sociale, quando milioni di persone sono in povertà assoluta.
di Giuseppe Bronzini
(da “Volere la luna”)
Finalmente ha visto la luce il decreto legge istitutivo di un “reddito di cittadinanza” voluto dal Movimento 5Stelle come elemento “identitario” della sua partecipazione all’attuale governo.
[segue]
Il dibattito economico impegnato nella ricerca della “riforma chiave”
 Una “riforma chiave” del capitalismo per superare lo stato presente dell’Italia
Una “riforma chiave” del capitalismo per superare lo stato presente dell’Italia
di Gianfranco Sabattini
Di fronte ai postumi della Grande Recessione iniziata nel 2007/2008, Laura Pennacchi, economista e politica di sinistra, già sottosegretario al Tesoro nel primo governo Prodi, nell’articolo “Il Piano del lavoro, una riforma per trasformare il capitalismo”, apparso in “Italianieuropei” nn. 5/6 del 2018, si chiede quale potrebbe essere, per l’Italia, una “riforma chiave” in grado “di trasformare radicalmente lo stato di cose presenti”. A parere dell’autrice, l’urgenza maggiore per le forze progressiste e di sinistra risiederebbe nella necessità di uscire da “un silenzio, un’inerzia, una cura di spiccioli affari di bottega che durano ormai da troppo tempo e le condannano alla scomparsa, attivando, al contrario, un cantiere culturale alternativo di vastissima portata, in grado di generare pensiero, analisi, linguaggi di altissimo profilo”. Quale sarebbe la “riforma chiave” che dovrebbe essere concepita e formalizzata da tale cantiere culturale?
Il dilagare dei movimenti populisti e l’emergere di tante somiglianze della situazione attuale dell’Italia (e di quella di tanti altri Paesi), formatasi in conseguenza dello scoppio della crisi del 2007/2008, con quella della fine degli anni Venti, causata dalla Grande Depressione del 1929-1932, devono rappresentare, secondo la Pennacchi, la sfida odierna che le forze di sinistra devono affrontare, puntando su “una riforma in grande del capitalismo, una riforma profonda, come quella che si delineò ai tempi di Keynes, quando una radicalità inusitata di progettazione teorica e di critica ideologica congiunse il pensiero innovativo keynesiano alle rivoluzionarie iniziative di Roosevelt e al riformismo radicale europeo [...], che si opponevano anche idealmente ai totalitarismi”.
Per capire la necessità della riforma del capitalismo attuale, con cui porre rimedio allo status quo dell’Italia, occorre tener presente, secondo la Pennacchi, che il capitalismo, come da molti suoi critici è stato sottolineato, ha avuto successo lungo la sua storia, proprio perché si è sempre presentato nella veste di un sistema che poteva “prendere molte forme”, nel senso che esso non ha mai dato vita necessariamente a “un modello unico”, potendo, al contrario, assumere forme organizzative alternative.
La riflessione sulle diverse forme organizzative che hanno caratterizzato l’evoluzione del capitalismo consentirebbe – afferma la Pennacchi – di “mettere a monte e al centro” dell’analisi economica la “problematica dei fini”, orientandola alla ricerca di possibili forme organizzative alternative a quella del capitalismo attuale, affermatasi con l’avvento dell’egemonia dell’ideologia neoliberista. Ciò permetterebbe, da un lato, di individuare tra queste, quelle conformi al perseguimento di fini diversi da quelli suggeriti dalla globalizzazione e dalla finanziarizzazione delle economie, promosse dall’ideologia neoliberista; dall’altro lato, di evidenziare il ruolo centrale che possoo tornare a svolgere lo Stato e le istituzioni pubbliche, le cui funzioni sono state “oscurate dal parassitismo” delle attività predatrici che i mercati finanziari internazionali senza regole hanno promosso e specializzato “nell’estrazione delle rendite piuttosto che nella produzione di autentico valore”.
L’approfondimento della riflessione sulla riformabilità del capitalismo consentirebbe anche, secondo la Pennacchi, di rendersi conto della improponibilità di tesi, come ad esempio quella sostenuta da Wolgang Streeck, secondo il quale l’idea di riformare il capitalismo contemporaneo sarebbe priva di prospettiva, in quanto qualsiasi politica riformatrice avrebbe solo l’effetto di conservarlo stretto all’interno dell’organizzazione raggiunta, valendo tutt’al più a fargli “guadagnare tempo” riguardo al momento della crisi finale. In alternativa alle tesi che ricalcano quella di Streeck, la Pennacchi sostiene che proprio l’approfondimento del dibattito sulle varie forme organizzative possibili del capitalismo potrebbe offrire all’economia italiana la “via di fuga” dalle secche nelle quali essa è ora incagliato.
Al contrario di Streeck, la Pennacchi ritiene che una riforma del capitalismo, condotta nella prospettiva della “variety of capitalism”. possa essere destinata ad avere sicuro successo, se formulata tenendo conto dei termini che hanno connotato la discussione svoltasi nel passato sulla “secular stagnation”; discussione, questa, che avrebbe consentito di “mettere a fuoco un aspetto del funzionamento del capitalismo”, che si ripresenta anche nelle attuali modalità di funzionamento delle moderne economie industriali in crisi, nella forma di una disconnessione degli investimenti rispetto al “destino del lavoro”.
Questa disfunzione, rispetto ad uno stabile funzionamento delle economie di mercato avanzate, era stata messa in evidenza – ricorda la Pennacchi – dall’economista keynesinao Alvin Hansen, già alla fine degli anni Trenta, dopo che le economie avanzate erano state investite dagli effetti negativi della Grande Depressione; Hansen aveva sostenuto che la grande crisi, iniziata nel 1929, “non fosse un episodio ciclico ma fosse, in realtà, il sintomo dell’esaurimento di una dinamica di lungo periodo” e dell’inizio di una “stagnazione secolare”, divenuta la rappresentazione della nascita del problema della continuità dell’occupazione, trasformatosi nella causa principale dell’allargamento e dell’approfondimento delle disuguaglianze distributive. Le argomentazioni di Hansen sono riproposte oggi da diversi economisti, in particolare da Larry Summers, accademico e politico statunitense che, nell’articolo, pubblicato nel 2013, “Why stagnation might pove to be the new normal”, ha imputato la “secular stagnation” alla carenza di domanda aggregata, “attribuita ad un eccesso di risparmio desiderato rispetto all’investimento desiderato”.
Per rimediare alla insufficienza della domanda aggregata, Lammers rinviene – ricorda la Pennacchi – la via da percorrere nel ricorso allo Stato, inteso come “operatore pubblico animato dalla volontà di procedere ad investimenti propri”, individuando nella “politicizzazione” di tale volontà il motore fondamentale col quale attuare la riforma del capitalismo, al fine di orientarlo alla crescita e allo sviluppo delle società in crisi.
Secondo la Pennacchi, con riferimento alle argomentazioni di Hansen, pur essendo state successivamente smentite dai risultati conseguiti nell’arco dei “gloriosi trent’anni” del secondo dopoguetta (1945-1975), occorre riconoscere che in esse “c’era qualcosa di ‘profetico’” [...] che oggi si rivela fecondo”, cioè che il problema dell’esaurimento della dinamica di lungo periodo del capitalismo e quello dell’occupazione possono essere risolti non con interventi di politica economica che si collochino dal lato dell’offerta (ovvero con misure volte ad erogare incentivi indiretti alle imprese, attraverso tagli fiscali o trasferimenti monetari diretti alle famiglie come sta facendo l’attuale governo italiano), ma con “investimenti pubblici per imprimere impulsi dinamici all’economia e realizzare la piena occupazione”, attraverso il conseguimento di nuove invenzioni, la scoperta di nuovi prodotti e l’incremento della popolazione.
Non è possibile, quindi, a parere della Pennacchi, affidare il rilancio della crescita e dello sviluppo dell’Italia (e in generale di quello degli altri Paesi dell’Unione Europea) ad una “supplay side economics”; né si può pensare che possano essere efficaci, sempre per il rilancio della crescita e dello sviluppo, provvedimenti di natura ordoliberale, quali il “Patto di stabilità” e il “Fiscal compact” stipulati a livello europeo; né, infine, il rilancio della crescita e dello sviluppo può essere atteso dal progresso tecnologico guidato unicamente dalle forze del libero mercato, per cui, anziché essere “indirizzato politicamente”, sia lasciato all’andamento spontaneo determinato dall’evoluzione incontrollata delle forze economiche.
In alternativa a queste iniziative occorre invece, a parere della Pennacchi (tenendo conto delle riflessioni teoriche di Hansen e riproposte oggi da Summers), elaborare e mettere a punto su scala europea una “riforma chiave” dell’attuale modo di funzionare del capitalismo, sulla quale fondare l’attuazione di un “Piano del lavoro” per risolvere “la questione della disoccupazione, non come un ‘fallimento di mercato’ tra gli altri, ma come la contraddizione fondamentale ricorrente del capitalismo”; un “Piano del lavoro”, così finalizzato, rappresenterebbe, per l’intera Europa e per l’Italia, la fonte di una rivitalizzazione della domanda aggregata interna, la quale potrebbe così trasformare i bisogni dei cittadini dell’intera area europea nel volano del rilancio della crescita e dello sviluppo.
Il “Piano del lavoro” dovrebbe essere caratterizzato da un mix di investimenti pubblici e privati, nella prospettiva però che lo Stato sia considerato “occupatore di ultima istanza”, attraverso l’offerta “di lavori pubblici utili socialmente, anche temporanei, al salario minimo legale ai disoccupati che cerchino e non trovino lavoro o per integrare l’occupazione di coloro che abbiano un lavoro parziale involontario”. Solo così, secondo la Pennacchi, sarebbe possibile “tornare a prendere nuovamente sul serio l’obiettivo della piena occupazione”, non in termini pietistici o caritatevoli, ma nella consapevolezza che, così operando, l’efficacia dell’intervento dello Stato sul piano economico e sociale (rispetto al funzionamento spontaneo del capitalismo), risulterebbe ottimale proprio quando il sistema economico, non creando naturalmente occupazione, prefigurasse la formazione di una “società senza lavoro”, predisponendola a sicura catastrofe.
Lasciare che il capitalismo neoliberista conduca il sistema economico e sociale verso la catastrofe è – afferma la Pennacchi – “il rischio contenuto nelle proposte di generalizzazione dei trasferimenti monetari, qual è il reddito di cittadinanza che sarà erogato in Italia, a compensazione e a risarcimento di un lavoro che non c’è, costruendo un ‘welfare per la non piena occupazione’”. Con questa affermazione, la Pennacchi non intende negare che l’erogazione di un reddito di cittadinanza possa servire, ad esempio, a contrastare la povertà; sottolinea però che la sua pratica è gravata da “fondamentali problemi culturali e morali”, che darebbero al reddito di cittadinanza “un sapore di resa, di rinuncia, di abdicazione [...] a far valere la responsabilità collettiva nella trasformazione profonda e strutturale dei meccanismi economici contemporanei, ritenuta impossibile”. Per tutte queste ragioni, occorre prendere atto che una “riforma chiave” del capitalismo neoliberista non può che essere fondata su un intervento pubblico finalizzato a finanziare, col concorso dei privati, un volume di investimenti adeguato ad assicurare la piena occupazione della forza lavoro.
Verso quali fini – si chiede la Pennacchi – deve essere finalizzato l’intervento pubblico? L’ex sottosegretario al Tesoro non ha dubbi: occorre salvare l’economia reale, investendo nella creazione di comparti produttivi nuovi, in protezione ambientale, in disinquinamento, in risparmio di materiali e, naturalmente, in infrastrutture, per accrescere la domanda da parte dei governi, dei consumatori, delle imprese, premiando i consumi collettivi su quelli individuali.
In questa prospettiva di intervento dello Stato, conclude la Pennacchi, l’attuazione del “Piano del lavoro” varrebbe a ricuperare “dignità antiche” (sacrificate o disperse a spese del lavoro dall’imperante ideologia neoliberista) e a prefigurare un nuovo modello di crescita e sviluppo, oltre che dell’economia, dell’intero sistema società.
L’articolo della Pennacchi è di difficile valutazione, perché in esso si intrecciano, sia “desideri” d’ispirazione ideologica, sia valutazioni critiche sulle modalità di funzionamento del capitalismo contemporaneo, che da tempo l’esperienza è valsa a comprovare. Inoltre, l’idea di concepire una “riforma chiave” del capitalismo attuale attraverso l’effettuazione di un alto volume di investimenti (di natura prevalentemente pubblica) evoca una sorta di “Big push” (grande spinta), al quale un tempo si faceva riferimento per promuovere la crescita e lo sviluppo dei Paesi arretrati; così, come tra i molti problemi che l’idea del “Big push” sollevava, vi era quello del “reperimento delle risorse finanziarie con cui attuarlo”; ugualmente, l’ipotesi della Pennacchi di realizzare la “riforma chiave” per il superamento della situazione attuale dell’economia italiana attraverso un “forte investimento pubblico”, rende inevitabile chiedersi dove possano essere reperite le risorse necessarie per la sua attuazione.
Al riguardo, vale la pena ricordare che, se per l’attuazione del “Big push” nei Paesi arretrati, si poteva supporre che le risorse necessarie potevano essere fornite dagli aiuti internazionali, nel caso dell’Italia, lo Stato può rivolgersi all’Europa? E’ plausibile nutrire molti dubbi sulla possibilità che l’Unione Europea, come sta a dimostrate il suo “severo” atteggiamento nei confronti dell’Italia e degli altri Paesi coi conti pubblici non in regola, il “wishful thinking” della Pennacchi possa essere soddisfatto.
A parte queste considerazioni, nella narrazione complessiva dell’ex sottosegretario di Stato vi è, implicito, un altro problema, ben più importante di quello concernente il possibile finanziamento dell’auspicata “riforma chiave”; problema che deve essere attentamente valutato. Non è privo di sorpresa il fatto che la Pennacchi, da economista qual ella è, confonda il reddito di cittadinanza, così com’è inteso dall’attuale governo italiano (e, ahi noi, dall’intera classe politica italiana) con quello proposto, ad esempio, da James Mead, per contrastare, non la disoccupazione temporanea e congiunturale, ma quella strutturale e irreversibile, qual è quella che il capitalismo moderno, anche se riformato nel senso indicato dalla Pennacchi, tenderebbe a determinare (come la profezia di John Maynard Keynes vuole e i moderni processi produttivi impongono).
A fronte della disoccupazione strutturale irreversibile non sono proponibili lavori pubblici socialmente rimunerati a un “salario minimo legale”; molte sono le controindicazioni connesse a tale tipo di lavori; questi, infatti, non solo mancano di far ricuperare alla forza lavoro (disoccupata, sottoccupata o “precarizzata” involontariamente) la dignità perduta, ma possono anche determinare frustrazioni psichiche nei lavoratori stessi, se i lavori socialmente utili loro assegnati fossero percepiti (come l’esperienza e le ricerche sul campo convalidano), stando alla terminologia di David Graeber, come “lavori del cavolo”.
In conclusione, la vera “riforma chiave” da apportare al capitalismo, se si vuole salvare l’economia reale, fermi restando il ruolo e la funzione dello Stato riguardo all’offerta di tutti quei beni pubblici che l’economia privata non può produrre, è la riforma “ab imis” dell’attuale welfare State, realizzata sulla base di un cambiamento delle regole distributive tradizionali del prodotto sociale e dell’istituzionalizzazione del reddito di cittadinanza universale e incondizionato correttamente inteso.
Con questa forma di reddito è plausibile ipotizzare realisticamente, non solo un ridimensionamento del problema della povertà e della disoccupazione, ma anche la riduzione delle burocrazie di qualunque forma (che “bruciano” risorse, sottraendole ad altre finalità molto più convenienti sul piano economico e su quello sociale) e, quel che più conta, la garanzia della libertà assicurata ad ogni cittadino di perseguire il proprio progetto di vita mediante forme di ”occupazione autodiretta”.
———–
Il dipinto in testa: https://www.aladinpensiero.it/?tag=autoritratto-del-pittore-austriaco-ferdinand-georg-waldmuller
Materiali dell’Incontro “Lavorare meno Lavorare meglio Lavorare tutti”. Intervento di Silvano Tagliagambe.



![]() Con il contributo di Silvano Tagliagambe proseguiamo nella pubblicazione degli interventi all’Incontro-dibattito sul Lavoro, che si è tenuto venerdì scorso, con la partecipazione del sociologo del lavoro Domenico De Masi. Abbiamo chiesto a ciascun relatore di inviarci il proprio contributo per iscritto, anche con eventuale rielaborazione rispetto a quello effettivamente svolto, pur rispettando contenuti e sintesi. Procederemo a pubblicare le relazioni nell’ordine in cui ci perverranno. Questa occasione potrà essere colta anche da quanti non abbiano avuto spazio nel convegno e vogliano intervenire nelle pagine della nostra News, che volentieri mettiamo a disposizione.
Con il contributo di Silvano Tagliagambe proseguiamo nella pubblicazione degli interventi all’Incontro-dibattito sul Lavoro, che si è tenuto venerdì scorso, con la partecipazione del sociologo del lavoro Domenico De Masi. Abbiamo chiesto a ciascun relatore di inviarci il proprio contributo per iscritto, anche con eventuale rielaborazione rispetto a quello effettivamente svolto, pur rispettando contenuti e sintesi. Procederemo a pubblicare le relazioni nell’ordine in cui ci perverranno. Questa occasione potrà essere colta anche da quanti non abbiano avuto spazio nel convegno e vogliano intervenire nelle pagine della nostra News, che volentieri mettiamo a disposizione.
——
Lavorare meno, lavorare meglio, lavorare tutti
di Silvano Tagliagambe
Il 5 ottobre è stato presentato il volume Lavorare meno, lavorare meglio, lavorare tutti, curato da Fernando Codonesu, a un anno esatto dal Convegno tenutosi a Cagliari, di cui contiene gli Atti.
La discussione, avviata da un corposo intervento di Domenico De Masi, ha affrontato sotto traccia, grazie soprattutto alle stimolanti riflessioni di Antonio Dessì, il tema del destino del lavoro dell’uomo nell’era della crescente (e inarrestabile) digitalizzazione e globalizzazione. Le ragioni delle inquietudini suscitate da questo quadro generale sono ben note: sulla base di una ricognizione analitica, settore per settore, C.B. Frey e M.A. Osborne nel loro documentato articolo “The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation?”, comparso l’anno scorso nel numero 114 della rivista Technological Forecasting and Social Change (pp. 254-280) stimano che circa il 47% dei compiti lavorativi in essere siano automatizzabili nel corso dei prossimi dieci o venti anni.
L’Indagine MGI-McKinsey Global Institute, del gennaio dello scorso anno, valuta il tempo-lavoro che le macchine intelligenti si prevede possano sostituire nell’economia degli Stati Uniti in condizioni di fattibilità tecnica “a tecnologie esistenti”. Il tasso medio di sostituzione del tempo-lavoro viene previsto, per l’intera economia, con un valore piuttosto elevato (49%). Ma, soprattutto, emergono forti differenze tra i diversi settori: la sostituzione prevista arriva fino all’81% del tempo lavoro nelle lavorazioni materiali codificate (in pratica nei lavori di fabbrica che si svolgono in modo programmato e in condizioni prevedibili), tra il 60 e il 70% nel campo dell’elaborazione e raccolta dati (una gran parte dei lavori di ufficio regolati da procedure burocratiche e amministrative). Una quota assai minore di sostituzione (26%) si ha invece per il lavoro di fabbrica poco programmato o che si svolge in condizioni poco prevedibili, e una quota ancora minore (intorno al 20%) per i lavori di relazione, creativi o dal forte contenuto decisionale. Minima (9%) è la sostituzione prevista per le attività di gestione delle persone.
In ogni caso il dato che emerge è che il lavoro delle macchine tende a sostituire sempre più il lavoro dell’uomo, con effetti ormai visibili a occhio nudo sulla possibilità di trovare un’occupazione, stabile o occasionale che sia, soprattutto (ma non solo) da parte dei giovani.
Le prospettive che emergono da questa situazione sono diverse a seconda delle lenti con le quali le si valuta. Gli ottimisti ritengono che le innovazioni digital driven, quelle che nascono dal saper cogliere in pieno le potenzialità della rivoluzione digitale in essere, in termini di riduzione dei costi e di aumento delle prestazioni direttamente connesse alla tecnologia applicata, non potranno subentrare in toto alle innovazioni human driven, frutto di proposte e azioni derivanti dalla creatività e dall’intraprendenza umana, che genera valore immaginando nuovi usi (innovazioni d’uso), proponendo esperienze coinvolgenti o realizzando significativi processi di creazione di nuovo significato. A loro giudizio le esperienze riguardanti le relazioni, i legami, le emozioni, la bellezza, il gusto, la contemplazione, il desiderio, l’autenticità, la genuinità, la salubrità, la tradizione, il sogno, la libertà, la fiducia la ricerca della felicità sono di pertinenza esclusiva della creatività umano e disegnano un ampio territorio di produzione di beni materiali e immateriali in cui la macchina non potrà mai sostituirsi all’uomo.
Per questi apologeti della rivoluzione digitale, pertanto, il futuro, prossimo e remoto ci proporrà soluzioni di crescente interazione e collaborazione tra l’innovazione human driven, la quale crea soluzioni di valore unitario più elevato, incorporando nei prodotti e nei servizi elementi intangibili quali design, unicità, emozione ecc., e la tecnologia digital driven, che svolge il suo ruolo di “moltiplicatore”, perché consente la circolazione e il confronto delle buone idee e delle informazioni utili ad alimentare i processi di creazione del nuovo e di sperimentazione del possibile, utilizzando le conoscenze di un vasto circuito sociale ed economico, messo in rete dalla comunicazione digitale. In questa funzione, il digitale rende conveniente la scelta della open innovation, rivolta ad utilizzare al massimo le conoscenze in possesso di altri, riducendo i costi e aumentando il valore della creazione e sperimentazione dei nuovi prodotti e dei nuovi processi. Da questa interazione scaturiranno una fusione di “menti” e “strumenti” e l’incremento di interconnessioni tra intelligenza naturale e intelligenza artificiale destinato non solo a retroagire – tramite un ciclo virtuoso di auto-rinforzo – sulla creazione stessa del valore, ma anche e soprattutto a fungere da amplificatore delle stesse capacità umane, con conseguente aumento (e non decremento) dei processi di innovazione human driven.
Se le cose stessero effettivamente così ciò che si può ragionevolmente ipotizzare è il crescente spostamento del lavoro umano dai mestieri puramente esecutivi, che abbiamo in gran numero ereditato dalla stagione della meccanizzazione rigida, durante la prima modernità, a forme di occupazione sempre più creative, che saranno protagoniste del futuro nel mondo del lavoro e richiederanno nuove forme di apprendimento, che consentano alle persone di usare in modo creativo i linguaggi formali della scienza e delle macchine per generare valore nel mondo reale e siano ancorate ad una visione convinta e condivisa del porto di arrivo verso il quale indirizzare la navigazione. Infatti, come osserva Enzo Rullani nel suo contributo introduttivo a un libro che considero di fondamentale importanza per comprendere i processi in corso e quelli a venire, curato in collaborazione con Alberto F. De Toni (Uomini 4.0: Ritorno al futuro. Creare valore esplorando la complessità), pubblicato quest’anno da Franco Angeli, nel mare della complessità e dell’innovazione, contrariamente a quello che a volte si crede, non si può navigare a vista. Se manca la mappa, per tracciare la rotta serve almeno avere un porto di arrivo ideale, una meta che consenta di distinguere, in ogni momento del presente, i venti favorevoli da quelli contrari, in modo da alzare le vele quando le contingenze ci mettono di fronte ai primi, e da fermarsi e resistere quando, invece, arrivano i secondi. Andando così avanti, passo per passo, e con tutti gli adattamenti tattici del caso, lungo un percorso dotato di senso, che punta verso il porto prescelto. Lo scriveva già Seneca: “Non c’è mai vento a favore per il marinaio che non sa qual è il suo porto”.
De Masi invece, sia nel Convegno dell’anno scorso, rispondendo alle acute domande di Fernando Codonesu, sia nella presentazione degli Atti di quest’anno, è molto meno ottimista riguardo a questa possibile coesistenza di innovazione human driven e digital driven. A suo modo di vedere quest’ultima finirà col subentrare totalmente alla prima, per cui l’umanità è fatalmente destinata ad avviarsi verso una condizione di non-lavoro, che secondo lui va però vista non come una minaccia, bensì come una opportunità che lascia all’uomo uno spazio crescente, da impiegare sia per attività di formazione (che, specialmente in Italia, hanno bisogno di essere accresciute e qualificate), sia per sviluppare condizioni di vita e di cultura sociale che riservino uno spazio sempre maggiore all’«ozio creativo». Come del resto avveniva, a suo giudizio, nella Grecia antica, che ci ha lasciato un patrimonio di cultura sul quale l’umanità sta tuttora prosperando. Un concetto, questo, su cui De Masi insiste da tempo, prefigurando una liberazione (positiva) dallo stato di necessità a cui l’uomo lavoratore è sempre stato vincolato nella storia passata, che va ovviamente accompagnato da misure di equa distribuzione della ricchezza prodotta dall’automazione digitale, nel presente e soprattutto in prospettiva, usando in modo appropriato il surplus che ne deriva.
Ne scaturiscono due opposte valutazioni del lavoro, che per De Masi è un fardello dal quale possiamo liberarci senza troppi rimpianti, anzi con prospettive sicuramente allettanti per il futuro dell’umanità, che ci ricollegano ai momenti più felici della sua storia, come quello dell’antica Grecia appunto, mentre per i fautori della valorizzazione dell’innovazione human driven si tratta di un processo che, a patto di sapersi trasformare in modo da fornire una gestione efficace della maggiore complessità e di trarne positivamente le enormi potenzialità, non va considerato un semplice fattore di costo, da ridurre al minimo, ma diventa al contrario una risorsa trainante, che accresce non solo la quantità, ma soprattutto la qualità delle prestazioni richieste, innalzando il livello dell’intelligenza umana, individuale e collettiva. Il lavoro come valore, quindi, che nel futuro, prossimo e remoto, se ben indirizzato potrà rendere le persone sempre più capaci non solo di rispondere in modo flessibile alle domande e alle sfide che si presentano loro di volta in volta, ma anche di immaginare e identificare nuove soluzioni, di elaborare progetti innovativi, di alimentare significati e relazioni coinvolgenti, di organizzare esperienze emotivamente ricche, di creare identità partecipate e comunità di senso corrispondenti. Il lavoro, dunque, come strumento per creare valore, esplorando livelli di complessità (varietà, variabilità, interdipendenza, indeterminazione) sempre maggiori.
Ciascuno è libero, ovviamente, di optare per l’una o l’altra soluzione. Ci sono però una constatazione e una domanda, quella che appunto affiorava dal citato intervento di Antonio Dessì, che è impossibile evitare di porsi. Un futuro come quello prospettato da De Masi presuppone una rivoluzione che non è solo economica e sociologica, ma antropologica. La domanda che ne consegue è la seguente: l’uomo è predisposto per una vita puramente contemplativa, fatta di ozio creativo e null’altro? Che nel passato si sia effettivamente data una condizione di questo genere è opinabile (l’interpretazione della vita dell’antica Atene, interamente concentrata nell’agorà, il luogo delle adunanze, il centro politico, religioso, amministrativo e commerciale della città, in cui tutti gli uomini liberi si ritrovavano per prendere decisioni politiche importanti e concludere affari, e totalmente assorbita da essa, è suggestiva ma controversa e messa fortemente in discussione). Il problema però è un altro: le neuroscienze ci stanno dicendo, in maniera difficilmente contestabile, che il motore principale del nostro cervello, ciò che è alla base del suo mirabile funzionamento, non è costituito dalla percezione, come si credeva fino a poco tempo fa, né dal semplice movimento, ma dall’azione, caratterizzata dalla presenza di un progetto e di uno scopo. I processi cerebrali non appaiono, pertanto, semplici artefici di sensazioni e controllori di movimenti: alla base della loro organizzazione funzionale c’è la nozione teleologica di scopo.
Questi risultati hanno condotto a una riformulazione della risposta alla domanda: «a cosa serve il sistema motorio?» Per molti anni la risposta è stata: per produrre movimenti. Oggi sappiamo che questa risposta è errata, o quantomeno parziale. Il sistema motorio non produce solo movimenti ma atti motori e azioni, cioè movimenti dotati di uno scopo, come afferrare un oggetto, o sequenze di movimenti atte a conseguire uno scopo più distale, come afferrare un bicchiere e portarlo alla bocca per bere. Un movimento è una semplice dislocazione di parti corporee, come flettere o estendere le dita di una mano. Un atto motorio consiste invece nell’utilizzare quegli stessi movimenti per conseguire uno scopo motorio, per esempio afferrare un oggetto, manipolarlo, romperlo, posizionarlo, tenerlo ecc.
L’uomo, dunque, sembra fatto per progettare e agire. Quale sarà allora il suo destino se lo si costringe esclusivamente a contemplare e a oziare? Non c’è il rischio che l’ozio prolungato e forzato, anziché sfociare in opere creative e formative edificanti, conduca ad agitazioni insensate, che proprio perché non più progettate e indirizzate verso uno scopo, non più controllate razionalmente e frutto invece della prevalenza del puro istinto e delle passioni, rischiano di avere conseguenze opposte rispetto a quelle desiderabili che ci vengono prospettate? Questo sì è già successo e continua purtroppo a succedere nella storia dell’umanità. E non è davvero desiderabile.
—————————-
Oggi giovedì 11 ottobre 2018

![]()







![]()
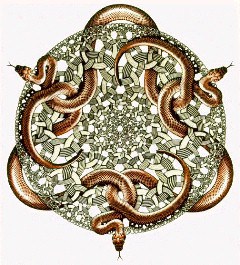

———-Avvenimenti&Dibattiti&Commenti———————————–
![]() Gli Editoriali di AladinewAladinAladinpensiero
Gli Editoriali di AladinewAladinAladinpensiero
 INTERNAZIONALE. La Cina investe in (si prende l’?) Africa.
INTERNAZIONALE. La Cina investe in (si prende l’?) Africa.
—————————————————–Emergenza ———–
 ALLARME MALTEMPO – Esprimiamo solidarietà e vicinanza alle popolazioni cosi gravemente colpite da condizioni meteo avverse. Dopo la grande sete delle passate stagioni, quando si invocava la pioggia perfino con le processioni religiose, è arrivata la grande abbondanza di pioggia con effetti catastrofici. Al momento non si registrano vittime, e questa è già una grande fortuna. I danni sono ancora da valutare ma saranno certamente di grande entità. In questi giorni non servono analisi e valutazioni sulla scarsa attenzione alle strutture viarie e al governo del territorio, ci sarà tempo per parlarne. Ora è il tempo della solidarietà e dell’aiuto materiale e morale. Dovremo sentirci uniti nel richiedere a politici e funzionari da fare quanto in loro potere per tutelare la sicurezza della gente e il ripristino di condizioni di vita migliori, appena possibile. Si comincia ad avere notizia di episodi spontanei di grande solidarietà attivate da privati (locali aperti per ospitare i viaggiatori, offerte di aiuto e servizi). I Sardi sapranno fare la loro parte. Un abbraccio a tutti.(Lettori/vt).
ALLARME MALTEMPO – Esprimiamo solidarietà e vicinanza alle popolazioni cosi gravemente colpite da condizioni meteo avverse. Dopo la grande sete delle passate stagioni, quando si invocava la pioggia perfino con le processioni religiose, è arrivata la grande abbondanza di pioggia con effetti catastrofici. Al momento non si registrano vittime, e questa è già una grande fortuna. I danni sono ancora da valutare ma saranno certamente di grande entità. In questi giorni non servono analisi e valutazioni sulla scarsa attenzione alle strutture viarie e al governo del territorio, ci sarà tempo per parlarne. Ora è il tempo della solidarietà e dell’aiuto materiale e morale. Dovremo sentirci uniti nel richiedere a politici e funzionari da fare quanto in loro potere per tutelare la sicurezza della gente e il ripristino di condizioni di vita migliori, appena possibile. Si comincia ad avere notizia di episodi spontanei di grande solidarietà attivate da privati (locali aperti per ospitare i viaggiatori, offerte di aiuto e servizi). I Sardi sapranno fare la loro parte. Un abbraccio a tutti.(Lettori/vt).
—————————————————————Rdc-ReI-Reis——–—-
Canea reazionaria per 780 euro agli indigenti ed altro. Che fare?.
11 Ottobre 2018
Andrea Pubusa su Democraziaoggi.
—————————-

![]() In argomento un intervento del direttore di Aladinews*.
In argomento un intervento del direttore di Aladinews*.
Suvvia! Il reddito di cittadinanza bollato come la rovina dell’Italia!
Intervengo limitatamente alla questione del “Reddito di cittadinanza”, associandomi allo stupore (si fa per dire) e alla stigmatizzazione di Andrea Pubusa (su Democraziaoggi) per la reazione a questa misura da parte di “istituzioni europee e internazionali, grandi gruppi editoriali e destra”, uniti in una “canea reazionaria per 780 euro agli indigenti”. Purtroppo a questi si aggiungono anche intellettuali progressisti di area cattolica, cito per tutti il prof. Leonardo Becchetti (https://www.aladinpensiero.it/?p=87954), che arriva addirittura a dare ragione a Renato Brunetta (intervistato dal quotidiano cattolico Avvenire del 28 settembre 2018.), che della manovra governativa boccia, guarda caso, soprattutto e in modo puntiglioso il “reddito di cittadinanza”, additato come sicuro responsabile della imminente rovina dell’Italia. In questo dimostrando ignoranza e malafede. [segue]







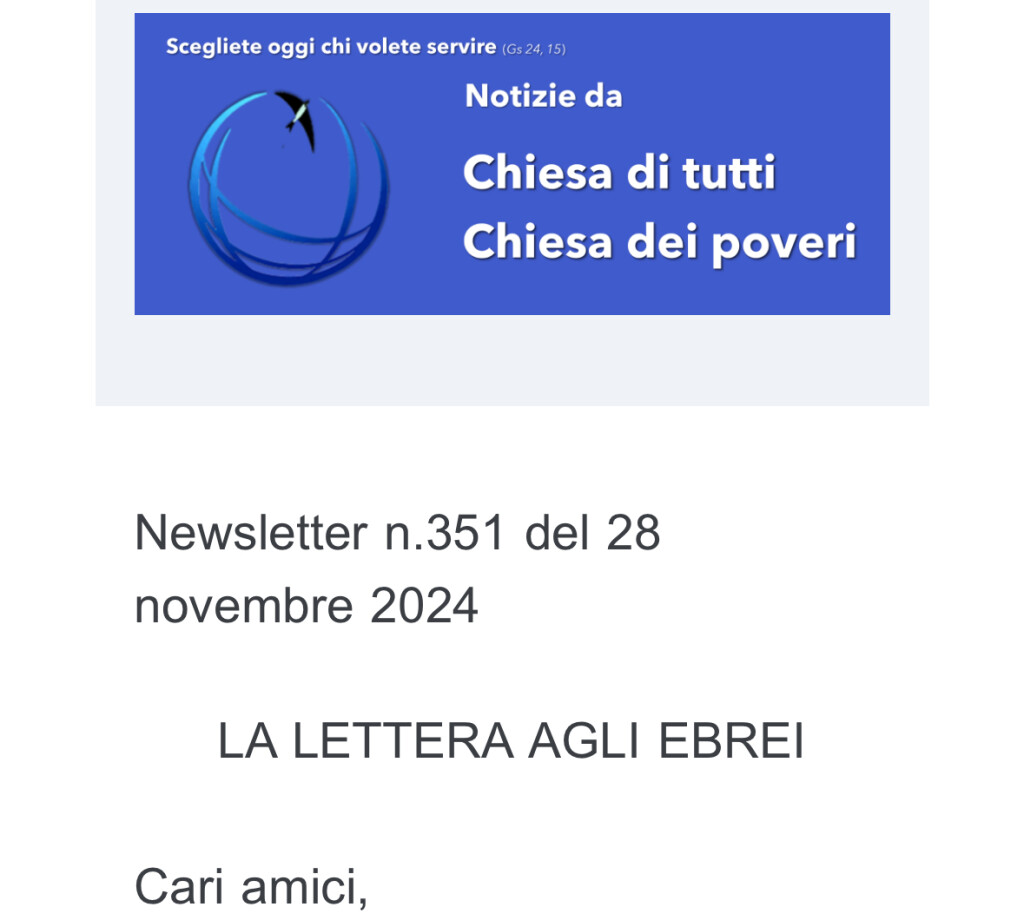









 AService Studio
AService Studio