Risultato della ricerca: reddito di cittadinanza Gianfranco Sabattini
Oltre l’attuale RdC: ripensare il Welfare State

I limiti del reddito di cittadinanza introdotto in Italia nel 2019
di Gianfranco Sabattini
Nei decenni anteriori alla Grande Recessione il dibattito politico denunciava il fatto che l’Italia fosse l’unico Paese europeo (assieme alla Grecia) a disporre di un sistema di sicurezza sociale che non includeva la possibilità di erogare un “reddito minimo”, inteso come una forma di reddito da corrispondere solo a chi, in età lavorativa, disponesse di un reddito inferiore ad una determinata soglia ritenuta di povertà.
Massimo Baldini e Cristiano Gori, in “Il reddito di cittadinanza” (Il Mulino, n. 2/2019) affermano che, dal 2017, alla lacuna del sistema si sicurezza sociale vigente è stato posto rimedio con l’introduzione del “reddito di inclusione” (REI); tale forma di reddito ha però avuto vita breve, perché nel 2019 è stata sostituita dal “reddito di cittadinanza” (RDC), il quale – affermano gli autori – ha consentito di aumentare in modo considerevole “i fondi per il contrasto della povertà di circa 6 miliardi di euro annui addizionali”, che hanno permesso di passare dai 2 miliardi del REI agli 8 del RDC. Si è trattato, secondo Baldini e Gori, del più ampio trasferimento di risorse pubbliche a favore dei poveri mai effettuato in Italia, contribuendo a risolvere il “difficile” rapporto che è sempre esistito nel nostro Paese tra politica e povertà.
Per lungo tempo, le forze politiche italiane di ogni colore hanno ignorato il problema della povertà, tranne che in quelle parti di tali forze (cattoliche e di sinistra) più sensibili ai problemi sociali. Al centro dell’attenzione di cattolici è sempre stata la tutela della famiglia, ma con l’avvento di Papa Francesco al soglio pontificio – sottolineano Baldini e Gori – per i cattolici impegnati nella politica nazionale si è sostenuta anche la necessità “di un intervento pubblico che contrastasse l’esclusione sociale”, considerata sino ad allora non rientrante tra gli obiettivi primari dell’impegno sociale cattolico. Dal canto suo anche la sinistra ha sempre “trascurato” il problema della povertà, in quanto ancorata a una “concezione della cittadinanza di tipo lavoristico, che vedeva i diritti sociali derivare principalmente dalla posizione degli individui nel mercato del lavoro”; per le forze di sinistra, pertanto, promuovere il welfare “significava tutelare non tutti i cittadini, bensì i lavoratori di oggi e di ieri, cioè chi il lavoro l’ha già oppure chi l’ha avuto e ora è a riposo”.
Nella legislatura 2013-2018 è cambiato l’atteggiamento della politica verso la povertà con l’introduzione del REI, per la pressione su di essa esercitata dalla crescita dei tassi di povertà e dal diffondersi della protesta sociale, a seguito all’affermarsi dei movimenti populisti. La limitatezza dei fondi stanziati con l’introduzione del REI ha però continuato a segnalare l’importanza ancora contenuta che veniva assegnata alla lotta contro la povertà, per cui – a parere di Baldini e Gori – l’introduzione del RDC ha rappresentato “un passo in avanti storico”; esso, non solo ha comportato un aumento delle risorse dedicate al problema specifico della povertà, ma ha anche istituito una forma di reddito corrisposto indipendentemente da altri redditi percepiti e da eventuali patrimoni dei quali fossero stati titolari i riceventi, non contemplando nessun altro requisito oltre la cittadinanza. Quale giudizio complessivo, si chiedono Baldini e Gori, può essere espresso sull’introduzione di questa forma di reddito?
L’istituzione del RDC, pur subordinando il fruitore alla necessità di reinserirsi nel lavoro, per via del fatto che la povertà viene assunta come conseguenza della mancanza di occupazione, ha riconosciuto che spesso lo stato di povertà risulta legato “ad aspetti diversi da quello lavorativo”, siano essi familiari, di salute, di istruzione, psicologici, abitativi, relazionali e di altra natura; ciò comporta l’attribuzione di “un ruolo importante ai percorsi di inclusione sociale”, affiancati “a politiche di rilievo per l’inserimento lavorativo”.
La scelta di enfatizzare le finalità occupazionali del RDC, rilevano Baldini e Gori, ne ha depotenziato il ruolo e la funzione. Ciò perché, se l’erogazione del RDC viene subordinata alla necessità che il fruitore debba reinserirsi nel lavoro in un contesto economico come quello italiano, caratterizzato dalla crescita delle disoccupazione strutturale, è quasi certo il suo insuccesso; per cui tenderà ad allargarsi il novero di coloro di quanti sostengono “che sono le stesse politiche di contrasto alla povertà” ad essere la causa prima di quest’ultima. In questo modo, concludono gli autori andrà persa l’occasione di consolidare l’evento storico, che con l’introduzione del RDC si pensava di aver raggiunto nella lotta contro la povertà.
In realtà, il discredito cui andrà incontro il RDC, per il suo improprio impiego, pregiudicherà la possibilità che ad esso si faccia ricorso per la cura della principale disfunzione cui sono esposti i sistemi economici capitalisticamente avanzati. Di fronte al dilagare della disoccupazione strutturale irreversibile, è maturata l’idea che occorresse creare, all’interno dei sistemi sociali economicamente avanzati, condizioni tali da consentire, non tanto la lotta contro la povertà, quanto il finanziamento di una domanda sufficiente a garantire lo stabile funzionamento del sistema economico.
L’esperienza riguardo al modo di funzionare dei moderni sistemi industriali ha da tempo evidenziato che, quando la gestione del sistema economico è lasciata all’azione discrezionale della politica, il perseguimento dei livelli occupativi, in assenza di un qualche automatismo autoregolatore, rende possibile una manipolazione dei flussi di reddito, tale da creare dei disavanzi nei conti pubblici a danno dei cittadini; è questa la ragione per cui sarebbe stata giustificata, l’introduzione nel sistema economico nazionale, che da tempo ha subito gli esiti negatuvi del deteriorarsi dei propri “fondamentali” economici, la necessità di una riforma radicale del welfare esistente.
Il sistema di sicurezza sociale, basato sul modello elaborato nel Regno Unito nel 1942 da William Henry Beveridge, aveva tre funzioni: fornire alla forza lavoro disoccupata la garanzia di un reddito, corrisposto sotto forma di sussidi a fronte di contribuzioni assicurative; garantire un reddito alle categorie sociali che, per qualsiasi motivo, avessero avuto bisogno di un’assistenza, nel caso in cui esse non godessero di alcun sussidio; assicurare al sistema economico servizi regolativi e di supporto all’occupazione, attraverso la realizzazione delle condizioni che davano titolo a ricevere i sussidi.
L’obiettivo fondamentale del welfare State è stato, sin dal suo inizio, univocamente determinato; il sistema però, a causa delle perdita della flessibilità del mercato del lavoro, ha scontato una crisi progressiva. Ciò perché la sua ragion d’essere era basata sulla premessa che l’economia operasse in corrispondenza del pieno impiego, o ad un livello molto prossimo ad esso, cosicché le contribuzioni della forza lavoro bilanciassero le erogazioni previste in suo favore. Pertanto, il sistema, così come era stato concepito all’origine, è divenuto largamente insufficiente rispetto all’evoluzione successiva della realtà economica e sociale, essendo stato progressivamente chiamato a coprire le emergenze conseguenti all’aumentata complessità dei sistemi economici; in tal modo, esso è divenuto costoso ed inefficiente, a seguito dell’espandersi delle varie forme di sussidio che è stato necessario corrispondere e dei costi burocratici per le “prove dei mezzi” (le prove, cioè, di trovarsi realmente in stato di bisogno) alle quali i beneficiari dei sussidi devono sottoporsi.
Le insufficienze del welfare State hanno orientato l’analisi economica ad assumere che la sicurezza sociale dovesse avere principalmente lo scopo di assicurare una costante flessibilità del mercato del lavoro e non quello di compensare la crescente insicurezza reddituale della forza lavoro. Il modo per rendere tra loro compatibili, in regime di libertà, da un lato, la flessibilità del mercato del lavoro e la sicurezza reddituale individuale, e dall’altro, l’efficienza del sistema economico, è stato individuato nell’istituzionalizzazione del RDC, da erogarsi incondizionatamente a favore di tutti e finanziato con le medesime risorse impegnate nel funzionamento del sistema di sicurezza sociale (l’attuale welfare); oppure mediante la distribuzione di un “dividendo sociale”, finanziato con le risorse derivanti dalla vendita dei servizi di tutti i fattori produttivi di proprietà collettiva, gestiti dallo Stato, mediante la costituzione di un “Fondo-capitale nazionale”, per conto e nell’interesse di tutti i cittadini. E’ stata questa l’idea originaria con cui James Edward Meade, insignito nel 1977 del premio Nobel per l’economia, parlando di dividendo sociale, ha introdotto nell’analisi economica il problema dell’istituzionalizzazione del RDC.
Il dividendo sociale, doveva essere corrisposto di diritto a ciascun cittadino sotto forma di trasferimento, indipendentemente da ogni considerazione riguardo ad età, sesso, stato lavorativo, stato coniugale, prova dei mezzi e funzionamento stabile del sistema economico. Il suo fine ultimo doveva essere quello di realizzare un sistema di sicurezza sociale che avesse riconosciuto ad ogni singolo soggetto, in quanto cittadino, il diritto ad uno standard minimo di vita, in presenza di una giustizia sociale più condivisa; un sistema di sicurezza, cioè, che avesse consentito di raggiungere, sia pure indirettamente, tale fine, in termini più efficienti ed ugualitari di quanto non fosse possibile con qualsiasi altro sistema alternativo.
Un problema assai dibattuto riguardo all’istituzionalizzazione del Reddito di Cittadinanza è stato quello di stabilire le modalità del suo finanziamento. Esso poteva essere assicurato con il ricupero delle risorse utilizzate per il funzionamento del sistema di sicurezza sociale esistente; in alternativa, Meade ipotizzava la distribuzione di un dividendo sociale finanziato con le rimunerazioni derivanti dalla vendita sul mercato dei servizi di tutti i fattori produttivi di proprietà collettiva, gestiti dallo Stato mediante la costituzione di un “Fondo Capitale Nazionale”, per conto e nell’interesse di tutti i cittadini.
In Paesi come l’Italia, dove è problematico pensare di poter realizzare in tempi brevi una riforma radicale del welfare esistente, o di reperire le risorse necessarie per finanziare il RDC mediante la costituzione di un “Fondo Capitale Nazionale”, la soluzione del problema può essere inserita nella prospettiva di un riordino dei diritti di proprietà, senza eccessivi stravolgimento degli istituti giuridici esistenti. I cambiamenti della vita sociale, imputabili alle modalità di funzionamento dei moderni sistemi economici, valgono infatti a giustificare una migliore ridefinizione dei diritti di proprietà; su questa nuova base, sarebbe possibile costituire un patrimonio collettivo per il finanziamento del “Fondo” da utilizzare per finanziare il RDC, concepito come reddito sul quale fondare la costruzione di un sistema di sicurezza sociale più efficiente di quello realizzato da William Henry Beveridge.
All’interno del nuovo sistema di sicurezza sociale, il RDC (o dividendo sociale, o reddito di base), oltre che garantire lo stabile funzionamento del sistema economico, svolgerebbe anche la funzione di risolvere sul piano sociale i problemi inevasi con l’attuale welfare State; in particolare, quella di assicurare una maggiore flessibilità al mercato del lavoro e un costante contrasto della povertà. Tali obiettivi diventerebbero perseguibili attraverso una responsabile politica riformista, idonea a riproporre su basi nuove l’organizzazione dello stato di sicurezza sociale vigente, ponendo definitivamente fine all’uso di provvedimenti-tampone, per rimediare alle situazioni sociali negative causate dalla crescente disoccupazione strutturale e dall’insorgenza di possibili crisi economiche inaspettate. Inoltre, sarebbero create le condizioni per la promozione, da parte dei percettori del RDC, di possibili gratificanti attività produttive autonome, i cui benefici effetti risulterebbero affrancati dalla natura di “prestazione caritatevole” dei sussidi di sopravvivenza corrisposti dall’assistenza statale.
———————————————

Il governo razionale dei beni comuni e il problema della scarsità
di Gianfranco Sabattini*
Il continuo dibattito sulla natura e l’uso dei beni comuni è condizionato dall’incertezza che pesa sulla loro definizione; da esso tuttavia sembra “emergere” una definizione che considera beni comuni tutte quelle risorse che risultano necessarie alla vita (perché preordinate a soddisfare stati di bisogno di particolare rilevanza per gli individui) e che, investendo i diritti fondamentali delle persone, si caratterizzano per la non esclusione dall’uso generale, con conseguente non assoggettabilità ad un prezzo, quale corrispettivo per il loro uso.
In tempi di crisi economica persistente, il dibattito pubblico in corso in Italia tende a porre la gestione dei beni comuni in controtendenza rispetto all’assoggettamento delle risorse alle logiche del mercato. Tuttavia, le incertezze persistenti sulla definizione di bene comune impediscono che dal dibattito emergano le linee di una politica di riforma istituzionale utile a prefigurare una loro razionale gestione; ciò, al fine di sottrarre i beni comuni alla cosiddetta “tragedia dei commons” che, in considerazione della loro non esclusione dall’uso generale, potrebbe condurre alla loro totale “distruzione”.
Il governo razionale dei beni comuni può essere infatti prefigurato solo tenendo conto, al pari di tutte le risorse economiche, della loro scarsità. Ciò perché, il fatto d’essere di proprietà comune comporta che all’intera platea dei proprietari sia assegnato a titolo individuale il diritto d’uso, mentre a nessuno di essi è concessa la facoltà di escludere gli altri. Se i proprietari che dispongono del diritto d’uso sono troppi, le risorse di proprietà comune potrebbero essere esposte al rischio della sovrautilizzazione; le stesse risorse, potrebbero essere esposte anche al rischio della sottoutilizzazione, a causa, ad esempio, di una definizione del diritto di proprietà dei beni comuni che potrebbe “margini” di interferenza nelle modalità del loro uso (come accade, per esempio, in Italia, nell’uso di ciò che resta dei cosiddetti “usi civici”, la cui utilizzazione da parte dell’operatore pubblico – di solito i comuni – è spesso contestata dall’intera comunità municipale, titolare del diritto di proprietà). In entrambi i casi, i proprietari dei beni comuni sarebbero “condannati” a subire gli esiti negativi della “tragedia dei commons”.
La “tragedia” è connessa al rischio che i beni comuni possano essere gestiti, come sostengono i “benecomunisti”, da operatori diversi dai loro legittimi proprietari, in quanto fruitori; i titolari della proprietà indivisa di beni devono infatti sostituirsi direttamente a qualsiasi forma di potere, privato o pubblico, nel determinare come gestire la conservazione e le forme di fruizione di tali beni. Tuttavia, perdurando lo stato di scarsità, la loro gestione di questi beni non può prescindere dalle leggi economiche tradizionali che indicano le modalità ottimali, sia per la loro conservazione, che per il loro uso.
La proprietà comune, in quanto riferita all’insieme dei soggetti che compongono una determinata comunità, è diversa dalla proprietà pubblica. A differenza dei beni comuni, quelli di proprietà pubblica possono essere gestiti direttamente dagli enti pubblici proprietari, sulla base di processi decisionali maggioritari (cioè sulla base delle maggioranze politiche pro-tempore esistenti). Poiché l’insieme dei proprietari-fruitori dei beni comuni non dispone di autonomi meccanismi decisionali, l’esercizio del diritto di proprietà comune e la gestione dei beni cui tale forma di proprietà si riferisce devono essere delegati alla responsabilità di un “soggetto operante” (quale, ad esempio, una cooperativa) che deve esercitarli in nome e per conto del delegante, la comunità, in funzione della volontà collettiva che essa esprime.
Con riferimento al governo e all’uso dei beni comuni, sorgono perciò gli stessi problemi presenti ancora oggi in Italia in molte realtà territoriali, con riferimento agli antichi “usi civici”, dove gli enti locali, sulla base di decisioni maggioritarie, amministrano risorse che, in quanto beni comuni, possono essere gestite solo dalla comunità olisticamente intesa come “un tutto”.
Il suggerimento di Elinor Ostrom, l’economista premio Nobel per l’economia 2009, che ha approfondito il tema dei beni comuni, si presta poco ad essere utilizzato per realizzare in termini efficienti il governo della proprietà di tali beni, secondo forme cooperative. L’intento del suo contributo è stato quello di pervenire ad una teoria adeguatamente specificata delle azioni collettive, mediante le quali un gruppo di operatori può organizzarsi volontariamente per utilizzare il frutto del suo stesso lavoro, o dei suoi beni di proprietà indivisa.
La Ostrom non crede nei risultati delle analisi teoriche condotte a livello di intero sistema sociale, ma solo nelle spiegazioni empiricamente confermate del funzionamento delle organizzazioni umane relative a specifiche e particolari realtà. Ciò perché, secondo la Ostrom, le analisi teoriche condotte a livello di intero sistema sociale comportano l’astrazione dalla complessità dei contesti concreti, per cui diventa probabile il rischio di rimanere “intrappolati” in una “rete concettuale” che astrae dalle realtà particolari.
Molte analisi condotte a livello di intero sistema sociale sarebbero perciò niente di più che metafore; ma affidarsi a metafore per gestire specifiche realtà può portare a risultati sostanzialmente diversi da quelli attesi. Un conto è spiegare come possono essere gestite in modo efficiente le risorse scarse di proprietà comune di una comunità di pescatori, oppure quelle di una comunità di allevatori; altro conto è spiegare come può essere realizzato, in condizioni di equità e di giustizia distributiva, il governo di tutte le risorse di proprietà comune di una determinata comunità nazionale.
In Italia il dibattito su come affrontare i problemi connessi alla realizzazione di uno stato del mondo più confacente alla gestione dei beni comuni si è svolto sinora prevalentemente con riferimento alla struttura istituzionale esistente. Questa, a causa dell’egemonia della logica capitalistica, secondo i “benecomunisti” avrebbe subito trasformazioni tali da determinare la crescente privatizzazione delle risorse disponibili. A partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, infatti, all’insegna del “terribile diritto” della proprietà privata e del misconoscimento di alcuni dettati costituzionali che ne salvaguardavano la funzione sociale, è stata realizzata la distruzione dell’economia pubblica e la privatizzazione di buona parte del patrimonio pubblico; processo, questo, che, non essendo ancora ultimato, è giusto motivo di preoccupazione per i “benecomunisti”.
Il movimento “benecomunista”, dotato prevalentemente di un’anima giuridica, considera i beni comuni, non già come beni economici aventi caratteri peculiari, ma come dei diritti universali, la cui definizione non può essere “appiattita” su considerazioni esclusivamente derivanti dalla teoria economica. Per dirla con le parole di Stefano Rodotà, il giurista che è stato tra i primi ad introdurre la questione dei beni comuni in Italia, “se la categoria dei beni comuni rimane nebulosa, e in essa si include tutto e il contrario di tutto, [...] allora può ben accadere che si perda la capacità di individuare proprio le situazioni nelle quali la qualità ‘comune’ di un bene può sprigionare tutta la sua forza», in funzione della soddisfazione dei diritti universali corrispondenti ai bisogni esistenziali incomprimibili degli esseri umani.
I “benecomunisti” sostengono che, per evitare lo smarrimento della loro vera qualità comune, i beni comuni devono essere tolti dal mercato e salvaguardati giuridicamente per garantire a tutti la loro fruibilità. Ma come? Rodotà manca di dirlo; mentre è ineludibile, considerata la loro natura di risorse scarse, la necessità che siano stabilite le procedure da istituzionalizzate per governare la proprietà e la gestione dei beni comuni. Ciò al fine di evitare che la sola definizione dal lato del consumo di tali beni (intesi come fonte di soddisfazione di diritti universali) li esponga al rischio di un loro possibile spreco.
Tra l’altro, è necessario pervenire a una precisa definizione dei beni comuni, anche per stabilire quali dovrebbero essere realmente, tra le risorse disponibili, quelle da sottrarre alle leggi di mercato; se ci si riferisce, ad esempio, al trasporto pubblico locale, la mobilità delle persone nel territorio è un bene comune o è solo, tra gli altri, un bene il cui governo deve essere lasciato alle leggi di mercato? L’interrogativo potrebbe essere esteso ad una molteplicità di situazioni, sino ad includere nella classe dei beni comuni la maggior parte di tutto ciò che di momento in momento viene prodotto ed utilizzato all’interno del sistema sociale.
L’incertezza nella definizione dei beni comuni causa l’impossibilità di fare appropriati passi in avanti nella riflessione sulla riorganizzazione del quadro istituzionale che sarebbe necessario per una loro razionale gestione. I “benecomunisti”, mancando perciò di uscire dalla vaghezza definitoria su cosa sia un bene pubblico e quali siano le condizioni che valgono a trasformare una data risorsa in bene comune, “soffrono” dell’atteggiamento di chi è sempre propenso a valutare ex ante le proposte destinate a fare fronte a specifiche emergenze, senza il conforto di una valutazione sia pure potenziale ex post della loro desiderabilità ed attuabilità. Essi, infatti, trascurano che le proposte formulate in sede preventiva, senza un confronto con la modalità necessarie alla loro attuazione, corrono il rischio di rivelarsi fallimentari a posteriori.
Inoltre, le critiche che i “benecomunisti” rivolgono alla situazione istituzionale esistente mancano di prefigurare una struttura istituzionale alternativa, idonea ad esprimere “una progettualità di lungo periodo”. Tali critiche, infatti, si limitano ad affermare, in astratto, gli ostacoli che si oppongono al rispetto del mandato costituzionale che coniuga l’equità distributiva con l’efficienza economica e gestionale delle risorse delle quali dispone il Paese, mancando di considerare i problemi connessi con la forte territorializzazione che caratterizza di solito i beni comuni; nessun cenno viene fatto, inoltre, alle “politiche di infrastrutturazione” necessarie per garantire, a livello nazionale, l’accesso all’uso dei beni comuni localizzati solo in un dato territorio.
Per queste ragioni, le critiche dei “benecomunisti” tendono a risultare, dal punto di vista economico, quasi delle “scatole vuote”, utili solo a mobilitare sul piano ideologico l’opinione pubblica contro gli esiti della logica capitalistica; si tratta di critiche del tutto prive di ogni riferimento alla struttura istituzionale che dovrebbe essere realizzata, per garantire, a livello di intero sistema sociale ed economico, un razionale soddisfacimento dei diritti universali cui si fa riferimento. In altri termini, i “benecomunisti” mettono il carro davanti ai buoi, nel senso che la loro progettualità risulta finalizzata, non a prefigurare un possibile riformismo istituzionale, utile a consentire una gestione razionale dei beni comuni di proprietà collettiva, ma solo a correggere e contenere gli esiti indesiderati del funzionamento dei sistemi sociali capitalistici attuali; tutto ciò senza preoccuparsi di evitare gli esiti negativi dell’eccessiva propensione a rifiutare quanto dell’economia standard può risultare ancora idoneo a governare e salvaguardare i beni comuni.
Ciò sarebbe invece necessario, al fine di evitare che il rischio connesso al rifiuto ideologico delle leggi dell’economia standard possa causare anche inintenzionalmente la formulazione di strategie riformiste di lungo periodo svincolate dalla realtà. Uno dei peggiori sbagli che si possa commettere, nelle condizioni in cui versa attualmente l’Italia sul piano sociale ed economico, è pensare che una proposta astratta possa essere realmente attuata; sarebbe il peggior servizio reso al Paese, per via del fatto che esso finirebbe con l’essere ulteriormente penalizzato sovrastato dal funzionamento del proprio sistema economico in assenza di regole certe e concrete.
* Già pubblicato su Aladinpensiero online il 10 settembre 2019.
Reddito di cittadinanza universale e incondizionato: da Marx a Van Parijs…

L’attualità della critica marxiana del capitalismo
di Gianfranco Sabattini
E’ singolare il fatto che siano molti coloro che, pur non essendo mai stati marxisti militanti, trovino in Marx molte idee con cui spiegarsi i fenomeni negativi che affliggono le società capitalistiche contemporanee a regime democratico. Il fatto sorprende ancora di più, se si pensa che la maggior parte dei marxisti di ogni tendenza hanno “cestinato” Marx, giungendo persino a condividere e ad appoggiare la realizzazione di situazioni economiche che già Marx, pur nella diversità delle condizioni del suo tempo rispetto a quelle attuali, aveva individuato come causa della disuguaglianza distributiva del prodotto sociale; causa, questa, di uno dei mali che maggiormente destabilizzano il “normale” e stabile funzionamento delle società industriali contemporanee.
 Malgrado il generale disinteresse attuale per le analisi e il pensiero di Karl Marx, secondo Sebastiano Maffettone, docente di Filosofia politica presso la LUISS Guido Carli, in “Karl Marx nel XXI secolo”, non si può non riconoscere che, nel corso dell’Ottocento, il grande critico del capitalismo, comunque lo si voglia giudicare, è “oggi e per il prossimo futuro un pensatore da tenere assolutamente presente nell’analisi dei problemi e delle crisi che caratterizzano la vita del capitalismo contemporaneo”. Oggi, infatti, le sue idee servono a comprendere “il nostro tempo, le sue caratteristiche precipue, i suoi problemi sociali ed economici più profondi”.
Malgrado il generale disinteresse attuale per le analisi e il pensiero di Karl Marx, secondo Sebastiano Maffettone, docente di Filosofia politica presso la LUISS Guido Carli, in “Karl Marx nel XXI secolo”, non si può non riconoscere che, nel corso dell’Ottocento, il grande critico del capitalismo, comunque lo si voglia giudicare, è “oggi e per il prossimo futuro un pensatore da tenere assolutamente presente nell’analisi dei problemi e delle crisi che caratterizzano la vita del capitalismo contemporaneo”. Oggi, infatti, le sue idee servono a comprendere “il nostro tempo, le sue caratteristiche precipue, i suoi problemi sociali ed economici più profondi”.
L’interesse attuale per le analisi e il pensiero di Marx non sta tanto nelle sue previsioni circa un futuro salvifico dalla società capitalistica, da rinvenirsi nel comunismo, quanto nel fatto che, mediante un approccio multidisciplinare ai problemi sociali, egli abbia per primo compreso che il capitalismo è un modo di funzionare transitorio dei sistemi produttivi e delle società da essi plasmate e che i suoi “meccanismi di funzionamento” costituiscono le premesse di possibili ricorrenti crisi di stabilità, sia del sistema economico che di quello sociale; ma egli ha spiegato anche che il manifestarsi delle crisi è la conseguenza del fatto che i meccanismi di funzionamento del capitalismo danno origine ad una distribuzione ingiusta del prodotto sociale, a causa del fatto che “pochi profittano di molti e sfruttano la capacità di lavoro di altri per arricchirsi alle loro spalle”.
Inoltre, nella sua critica radicale della società capitalistica, Marx, ricorda Maffettone, non solo ha messo in risalto l’importanza che la scienza e le innovazioni tecnologiche rivestono nello svolgimento del processo della crescita economica e dello sviluppo civile, ma ha anche evidenziato gli effetti destabilizzanti che scienza e tecnica provocano sui rapporti sociali. Né alla critica marxiana del capitalismo – continua Maffettone – sono “sfuggiti” gli effetti negativi della globalizzazione delle economie nazionali che, per quanto ai tempi di Marx fossero ancora contenuti, sono stati da lui individuati come impliciti all’internazionalizzazione del capitale.
Per tutti i motivi indicati, di fronte alla crisi delle moderne società capitalistiche, è sostanzialmente impossibile, per chiunque ne voglia comprenderne le cause, e soprattutto per i responsabili dell’azione politica volta alla loro rimozione o al loro contenimento, ignorare il patrimonio di riflessioni critiche sui limiti dei meccanismi di funzionamento del capitalismo, che Marx ha lasciato in eredità del mondo contemporaneo; ciò significa che, per avere contezza dello stato incerto e destabilizzato in cui versano le società capitalistiche contemporanee e per formulare possibili azioni politiche volte al suo superamento, non si possa, oggi, non “sentirci tutti marxisti”.
Di fronte alla ponderosa produzione di scritti filosofici, storici ed economici di Marx, per capire il senso del suo pensiero, si è soliti fare riferimento alla sua “opera maxima”, il “Capitale”, nel cui “Libro primo” sono contenuti gli elementi di base che egli ha posto a fondamento della sua analisi critica del funzionamento del capitalismo e dell’”iniqua distribuzione” del prodotto sociale causata dallo sfruttamento della forza lavoro.
Punto di partenza della costruzione marxiana dello schema esplicativo dello sfruttamento è la merce, intesa come tutto ciò che viene prodotto perché “utile” alla soddisfazione dei bisogni sociali. In quanto tale, la merce ha un “valore d’uso”; ma possiede anche un “valore di scambio”, che consente di scambiarla con altre merci. L’atto dello scambio, perciò, stabilisce un rapporto quantitativo tra merci qualitativamente diverse, in quanto dotate di valori d’uso differenti.
Perché le merci qualitativamente diverse possano essere scambiate, occorre che abbiano una dimensione in comune (che Marx chiama “valore”) che consenta di confrontarle. Dallo scambio nasce un “plusvalore” delle merci che, secondo la prospettiva marxiana (e, in generale, secondo quella di gran parte degli economisti della scuola classica che si rifanno al pensiero di Ricardo), è dato dalla differenza tra il valore delle merci scambiate, prodotte grazie all’impiego della forza lavoro, e la rimunerazione a quest’ultima corrisposta, sotto forma di salario, appena sufficiente alla sola sua “riproduzione”. Nei regimi capitalistici, secondo Marx, del plusvalore si appropriano gli imprenditori-capitalisti; esso, denominato da Marx “sfruttamento del lavoratore”, derivando dalla differenza tra il valore della quantità di lavoro conferito per la produzione delle merci e quello contenuto nelle merci necessarie alla riproduzione della forza lavoro, esprime un’appropriazione indebita di valore prodotto con lavoro non rimunerato.
A differenza degli altri autori classici, tuttavia, Marx ha formulato con maggior precisione il concetto di sfruttamento, inquadrando la sua formazione in una situazione di “concorrenza perfetta”; in questo modo, egli ha potuto collegarlo al concetto di “esercito industriale di riserva”, cioè a quella massa di disoccupati che, competendo con gli occupati in termini di salario, “spingeva” la rimunerazione della forza lavoro al ribasso, sino al suo livellamento al salario di sussistenza. L’esistenza dell’esercito industriale di riserva poteva, in tal modo, essere assunta come strumentale alla propensione degli imprenditori-capitalisti ad accumulare capitale, attraverso l’appiattimento del salario al livello minimo di sussistenza; quest’ultimo consentiva infatti agli imprenditori-capitalisti di “estrarre” il massimo “pluslavoro”, originante il plusvalore del quale “senza merito” essi appropriavano.
Su queste basi, Marx ha potuto sostenere che il sistema capitalistico era teso, nel suo complesso, alla continua e illimitata crescita del valore di scambio del prodotto sociale, indipendentemente da ogni valutazione riguardante la sua destinazione alla soddisfazione dei bisogni dei componenti la società. Inoltre, sulla base della dimostrazione che i meccanismi intrinseci al funzionamento del sistema capitalistico erano tali da supportare un’accumulazione capitalistica fondata sullo sfruttamento della forza lavoro occupata (grazie alla presenza di un esercito permanente di disoccupati), Marx ha potuto trarre la conclusione che era proprio la disoccupazione permanente a costituire la condizione che rendeva instabile il processo economico, a causa del verificarsi di continue crisi di sovrapproduzione.
Come non rinvenire, mutatis mutandis, nelle condizioni di operatività descritte e denunciate da Marx sul del sistema capitalistico del XIX secolo, una similitudine con quelle prevalenti nei sistemi capitalistici attuali? In questi ultimi, infatti, a causa della finanziarizzazione dell’attività economica e della crescente automazione dei processi produttivi dell’economia reale, si sono diffusi, da un lato, i processi di estrazione di valore, che concorrono ad approfondire le disuguaglianze distributive, e dall’altro, i processi di espulsione dalla stabilità occupazionale di quote crescenti di forza lavoro, che contribuiscono a formare una disoccupazione strutturale irreversibile (moderno esercito industriale di riserva); estrazione di valore e disoccupazione strutturale che, oltre a generare disuguaglianze distributive, sono anche cause di instabilità economica, come nei sistemi capitalistici dei tempi di Marx.
Il problema che Marx non è riuscito risolvere (assieme a lui, l’intera scuola classica alla quale come economista egli apparteneva) è stato, com’è noto, quello di non essere riuscito trasformare “i valori in prezzi”. A questo problema, sia pure indirettamente e dopo un prolungato dibattito, ha offerto una soluzione Piero Sraffa, il quale, partendo da una critica del marginalismo della teoria economica neoclassica e negando che la distribuzione del prodotto sociale potesse essere determinata da circostanze naturali o tecniche, né giustificata da “leggi ferree”, è giunto alla conclusione che, per la spiegazione del fenomeno distributivo, fosse necessaria una ricostruzione della teoria economica attraverso il ricupero della teoria marxiana del plusvalore, con conseguenze non di poco conto sul piano delle regole sottostanti il funzionamento del sistema economico-sociale.
Infatti, secondo Sraffa, non tutte le grandezze economiche (quantità da produrre, consumo, salario, profitto, ecc.), costituiscono fenomeni determinabili all’interno dell’economia, ma lo divenivano solo grazie ad “approcci procedurali”, la cui insufficiente formalizzazione ed istituzionalizzazione legittima il ruolo e la funzione del “conflitto sociale”. Ciò significa che quasi tutte le grandezze economiche devono essere calcolate solo su “basi tecniche” (come il foraggio per il bestiame ed il combustibile per le macchine), mentre il profitto va considerato in termini residuali, dovendosi identificare in ciò che resta del prodotto sociale dopo avere rimunerato il lavoro e reintegrato i capitali anticipati.
La soluzione del problema della trasformazione dei valori in prezzi proposta da Sraffa non è servita a porre termine al dibattito tra gli economisti, circa il modo in cui stimare lo sfruttamento e il grado di ineguale distribuzione del prodotto sociale da esso causato; la prosecuzione del dibattito, però, è valsa a determinare la reazione di una robusta schiera di economisti filosofi sociali marxisti che, sulla base di un metodo proprio della filosofia analitica, hanno inaugurato la corrente di studio del problema distributivo detta, appunto, del “marxismo analitico” (analytical marxism).
Tale corrente, impostasi tra la fine degli anni Settanta e la metà degli anni Ottanta del secolo scorso (in particolare, per il contributo di Allen E. Buchanan, Gerald Allan Cohen, Jon Elter e John Roemer), ha tentato una lettura in termini innovativi dei testi marxiani e dei concetti chiave del materialismo storico (quali quelli di sfruttamento, classe, forze produttive e rapporti di produzione), partendo dal presupposto, come afferma Maffettone, che fosse necessario salvare le problematiche distributive evidenziate da Marx, al fine di sottrarle alle lungaggini di un dibattito inconcludente, evitando così di esporle al rischio di una rimozione dal novero di quelle considerate come le cause principali delle crisi di natura economica e sociale del capitalismo contemporaneo.
Secondo gli esponenti del marxismo analitico, era possibile interpretare il problema distributivo formulato di Marx, fuori dalle difficoltà proprie di quello della trasformazione dei valori in prezzi, ricuperando, in alternativa, il tema dello sfruttamento, considerato come un aspetto strutturale della dinamica del capitalismo contemporaneo.
Considerate le difficoltà in cui ci si imbatte, se si continua ad insistere nel tentativo di dimostrare la fondatezza dello sfruttamento, facendo riferimento agli elementi quantitativi della teoria del valore in funzione della derivazione da questo dei prezzi, non resta che prendere in considerazione la dimensione “qualitativa e normativa” del problema distributivo; ciò, nella consapevolezza che un simile “ripiegamento”, se può – come sostiene Maffettone – “sopire la disputa” circa la mancata trasformazione del valore delle merci in prezzi, esso (il ripiegamento), però, “non risolve il problema” della dimostrazione su basi logiche del processo dello sfruttamento.
Un approccio in termini qualitativi e normativi appare tuttavia l’unico modo oggi possibile per contrastare l’annoso problema dello sfruttamento, continuando però, da un lato, a rinvenire, come ha fatto Marx, la causa del suo continuo approfondimento nella struttura basilare dei meccanismi di funzionamento del capitalismo; dall’altro lato, a trovare, con la formulazione di una teoria normativa della giustizia sociale, una possibile prospettiva di azione politica per contrastarlo, o quantomeno per contenerlo.
A tal fine, per i marxisti analitici, si è imposta la necessità di scegliere se la giustizia distributiva dovesse essere valutata in termini di “utilità per i componenti il sistema sociale” (come presumibilmente avrebbe voluto Marx), oppure in termini delle possibilità o libertà di cui essi possono disporre all’interno di una società giusta sul piano distributivo. Tenendo conto che una giustizia distributiva fondata sul principio dell’utilitarismo era criticata da molti cultori di scienze politiche e sociali, per via della sua tendenza a privilegiare gusti e preferenze della maggioranza, senza tenere sufficientemente conto delle minoranze, è prevalsa la scelta di altri principi alternativi a quello utilitaristico; ciò, sulla base dell’assunto che l’equità distributiva possa essere meglio realizzata, non garantendo a tutti la disponibilità di qualcosa che fosse dotata di una “qualità” differente da quella implicita nel principio dell’utilitarismo: quella di “beni primari” per John Rawls, di “capabilities o capacità di funzionamento” per Amartya Sen, di “carte vincenti” per Ronald Dworkin, di “libertà reale” per Philippe Van Parijs.
Il principio che accomuna queste “qualità” sta nel fatto che tutte fanno riferimento, non a ciò che con una distribuzione “giusta” i singoli soggetti possono provare o si attendono di provare, ma alla “libertà”, intesa come insieme delle opzioni entro le quali essi possono liberamente scegliere come realizzare il loro programma di vita. La “libertà reale”, per Van Parijs, uno dei massimi teorici del reddito di cittadinanza universale e incondizionato, proposto per risolvere il problema dello sfruttamento e dell’iniqua distribuzione del prodotto sociale, è uno dei presupposti irrinunciabili per creare le condizioni istituzionali proprie di una società libera e di un’economia stabile, liberate da ogni forma di estrazione di valore, ovvero da ogni forma di appropriazione senza merito di una quota del prodotto sociale.
Per Van Parijs, e per gli altri autori che, come lui, propongono di rimuovere o di ridimensionare lo sfruttamento attraverso l’introduzione del reddito di cittadinanza universale e incondizionato, la libertà non è un vincolo a ciò che la giustizia impone, ma il bene nella cui equa distribuzione consiste propriamente la giustizia. In questa prospettiva, la giustificazione etico-politica del reddito di cittadinanza, posto a fondamento dell’equità distributiva, risiede nel fatto che con esso è assicurata, non una “libertà formale”, ma una “libertà reale”, idonea in linea di principio a garantire a ciascun cittadino la capacità di effettuare le scelte ritenute più consone alla realizzazione del proprio progetto di vita.
———————————
![]()
IL TARLO
In una vecchia casa,
piena di cianfrusaglie,
di storici cimeli,
pezzi autentici ed anticaglie,
c’era una volta un tarlo,
di discendenza nobile,
che cominciò a mangiare
un vecchio mobile.
Avanzare con i denti
per avere da mangiare
e mangiare a due palmenti
per avanzare.
Il proverbio che il lavoro
ti nobilita, nel farlo,
non riguarda solo l’uomo,
ma pure il tarlo.
Il tarlo, in breve tempo,
grazie alla sua ambizione,
riuscì ad accelerare
il proprio ritmo di produzione:
andando sempre avanti,
senza voltarsi indietro,
riuscì così a avanzar
di qualche metro.
Farsi strada con i denti
per mangiare, mal che vada,
e mangiare a due palmenti
per farsi strada.
Quel che resta dietro a noi
non importa che si perda:
ci si accorge, prima o poi,
ch’è solo merda.
Per legge di mercato,
assunse poi, per via,
un certo personale,
con contratto di mezzadria:
di quel che era scavato,
grazie al lavoro altrui,
una metà se la mangiava lui.
Avanzare, per mangiare
qualche piccolo boccone,
che dia forza di scavare
per il padrone.
L’altra parte del raccolto
ch’è mangiato dal signore
prende il nome di “maltolto”
o plusvalore.
Poi, col passar degli anni,
venne la concorrenza
da parte d’altri tarli,
colla stessa intraprendenza:
il tarlo proprietario
ristrutturò i salari
e organizzò dei turni
straordinari.
Lavorare a perdifiato,
accorciare ancora i tempi,
perché aumenti il fatturato
e i dividendi.
Ci si accorse poi ch’è bene,
anziché restare soli,
far d’accordo, tutti insieme,
dei monopoli.
Si sa com’è la vita:
ormai giunto al traguardo,
per i trascorsi affanni
il nostro tarlo crepò d’infarto.
Sulla sua tomba è scritto:
PER L’IDEALE NOBILE
DI DIVORARSI TUTTO QUANTO UN MOBILE
CHIARO MONITO PER I POSTERI
QUESTO TARLO VISSE E MORI’.
Oggi. Dialogo con Gianfranco Sabattini, economista. Realista e insieme “campione dell’impossibile”.
Oggi martedì 5 febbraio 2019 alle ore 17.00 a Cagliari nella sala conferenze della Fondazione di Sardegna in via San Salvatore da Horta 2, si svolgerà l’incontro pubblico denominato “Dialogo con Gianfranco Sabattini”. Una presentazione della recente produzione editoriale del prof. Gianfranco Sabattini: “Europa Perché” (Tema), “La ricerca del benessere” (Tema) e “Lo sviluppo locale della Sardegna” (Cuec).

Appunti di Franco Meloni.
Gianfranco Sabattini, classe 1935, è professore universitario, formalmente in pensione, in realtà in servizio permanente ed effettivo. Perciò non chiamatelo “ex professore” perché a lui non si addice. Per lui è appropriato il richiamo biblico del “Tu es sacerdos in æternum secundum ordinem Melchisedech”, nel senso di “professor in æternum” secondo non so quale Ordine. Laicamente potremo anche dire che Gianfranco Sabattini fa parte di una virtuale a virtuosa “riserva democratica della Repubblica”, formata da quelle persone che sono sempre disponibili a dare il proprio contributo intellettuale per il bene comune, al “servizio esclusivo della Nazione” nel prolungamento dell’impiego pubblico, che con la pensione passa da prestazione contrattuale a prestazione volontaria e gratuita. Di questo impegno e di questa dedizione che si prolungherà fino a quando vorrà e potrà, il più a lungo possibile, gli siamo tutti grati.
————-
Negli appunti che seguono non ho alcuna pretesa di rappresentare la complessità e il valore delle opere editoriali del professore. Mi dispiace non dare adeguatamente conto della sua ricerca anche per le tematiche di forte investimento innovativo, quali 1) la riforma del welfare soprattutto con l’adozione del vero “reddito di cittadinanza“, che chiama anche “dividendo sociale” o “reddito di base”; 2) i beni comuni, con una ridefinizione dei concetti di proprietà pubblica e privata, in relazione al perseguimento del bene comune… Mi limito a richiamare, anche per semplice elencazione, alcuni “spunti” tratti dalla lettura di suoi molti scritti, libri, saggi, articoli (di questi ultimi, molti pubblicati nelle News online Aladinpensiero, Democraziaoggi e il manifesto sardo, con le quali collabora da alcuni anni “in pianta stabile”), in particolare del volume “Lo sviluppo locale della Sardegna” (Cuec Editrice), che sarà occasione e pretesto della mia interlocuzione con il professore nell’ambito dell’incontro odierno.
Parto proprio dalla considerazione finale dell’introduzione a detto libro fatta dal professor Pietro Maurandi, nella quale viene riconosciuto un grande merito a Gianfranco Sabattini: quello di far prevalere, gramscianamente, l’ottimismo della volontà sul pessimismo della ragione in relazione all’attuale situazione della Sardegna. Tanto da convincere lo stesso Maurandi e, speriamo, molti altri. Ma, a quali condizioni la Sardegna può uscire dal permanente stato di crisi che l’attanaglia per avviare un processo di sviluppo? Proprio a quelle formulate da Sabattini, che più avanti in estrema sintesi riassumo.
Scrive Pietro Maurandi:
“(…) la mobilitazione di forze endogene è in effetti l’unica possibilità che si offre alla Sardegna. Sabattini sostiene che la chiave di volta, il punto di partenza è la riforma federalista dello Stato, con tutto ciò che consegue, anche nelle articolazioni interne della Regione. Io sono d’accordo, ma sono pessimista per due ragioni:
1. La riforma federalista dello Stato non ci sarà (…)
2. La classe dirigente sarda, segnatamente la classe politica, non ha mostrato di essere all’altezza, né per volontà di porre il problema, né per capacità di affrontarlo (…).
Di fronte [alla situazione della classe politica regionale] diventa impossibile non essere pessimista; devo dire però che, nel libro curato da Sabattini, quando vengono analizzate le condizioni per realizzare la mobilitazione delle forze endogene, si manifesta un ottimismo implicito, che nasce, non da un atteggiamento di maniera o fideistico, ma da un lavoro di analisi e di indagine approfondita nei suoi diversi aspetti. Questo mi fa pensare e sperare che il mio pessimismo sia ingiustificato. Ben venga allora questo libro, con l’ampiezza del quadro presentato e con la vastità delle prospettive adottate, a guidarci attraverso un’analisi critica dei limiti delle politiche meridionalistiche, e di quelle attuate per la Sardegna, e a prospettarci, con la cultura e gli strumenti propri dello sviluppo locale, possibili via d’uscita dalle attuali condizioni”.
Ecco allora, almeno per titoli, le quattro condizioni formulate da Sabattini:
I) Evitare la “sindrome del fallimento” o il “complesso del fallimento” [in questo passaggio, anche se Sabattini non dovesse ammetterlo, trovo un’assonanza con l’esortazione di Papa Francesco ai giovani: “Non lasciatevi rubare la Speranza!”].
II) Avviare e praticare un processo di profonda trasformazione della struttura organizzativa del contesto regionale, che abbia come esito finale 1) il momento identitario (costituente), 2) la riscrittura del piano di sviluppo sociale ed economico, 3) la riscrittura dello Statuto.
III) Realizzare una piena ed estesa società civile regionale integrata
IV) Creare strutture di governo regionali capaci di assumere un obiettivo di medio-lungo periodo. Ciò varrà ad aumentare la fiducia dei cittadini regionali…
—–
Alcuni spunti di correlate questioni
. Come uscire dall’attuale stato di confusione istituzionale, per un “ritorno al territorio”?
. Come procedere a un adeguato riordino delle autonomie locali sulla base dei concetti che seguono?
– sussidiarietà e solidarietà;
– bio-area;
– spessore istituzionale;
– governance dal basso dello sviluppo di ogni singola area;
– città diramata.
Su tutte queste questioni Gianfranco Sabattini fa ragionamenti e proposte di grande spessore culturale. Si tratta di Utopia o di “impresa possibile” portata avanti da un “campione dell’impossibile”? Ce ne faremo un’idea più precisa nell’incontro di questo pomeriggio, a cui siete tutti invitati caldamente a partecipare.
————————————————-
 Gianfranco SABATTINI
Gianfranco SABATTINI
Comacchio, 01/06/1935
Gianfranco Sabattini è stato titolare della cattedra di Politica economica presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Cagliari. È autore di numerose pubblicazioni su temi di carattere generale e sui problemi della crescita e dello sviluppo del Mezzogiorno e della Sardegna.
Tra quelle di carattere generale: Saggi di politica economica (FrancoAngeli, 1987); Il ruolo della “mano visibile” dello Stato (FrancoAngeli, 1999); Globalizzazione e governo delle relazioni tra i popoli (FrancoAngeli, 2003); Riforma del welfare State e problema distributivo nell’economia di mercato (FrancoAngeli, 2007); Welfare State. Nascita, evoluzione e crisi. Le prospettive di riforma (FrancoAngeli, 2009); Elogio della sostenibilità dello sviluppo. Critica della teoria della decrescita di Serge Latouche (Tema, 2016); La ricerca del benessere. Riflessioni sulle prospettive dell’economia globale e locale (Tema, 2018). Tra le pubblicazioni sui problemi della crescita e dello sviluppo del Mezzogiorno: Le regioni, lo Stato e la nazione (Mondoperaio, 2010, n. 2); Il Mezzogiorno nella storia d’Italia (Il Risparmio, 2010, n. 2); I limiti delle politiche meridionalistiche. Il caso Sardegna (Tema, 2015). Tra le pubblicazioni sui problemi della crescita e dello sviluppo della Sardegna: Quale autonomia istituzionale per rimuovere la dipendenza politica ed economica della Sardegna? (FrancoAngeli, 2006); Sardegna anno zero. Quale futuro istituzionale ed economico? (Economia e Società Regionale, 2005, n. 1); Capitale, sociale, crescita e sviluppo della Sardegna (FrancoAngeli, 2006).
Nel 2017 ha curato, per conto dell’Istituto Gramsci della Sardegna, il volume collettaneo Le città e i territori (Tema, 2017); nel 2018-2019 ha curato, per conto dello stesso Istituto e con il contributo della Fondazione di Sardegna, i volumi collettanei La città metropolitana di Cagliari (Aipsa Edizioni, 2018), Lo sviluppo locale della Sardegna (Cuec, 2018), “Europa Perché” (Tema, 2019), “La ricerca del benessere” (Tema, 2019).
AladinewsEditoriali
![]() Elezioni.
Elezioni.  Non facciamo vincere “i gatti”. Raffaele Deidda su Aladinews.
Non facciamo vincere “i gatti”. Raffaele Deidda su Aladinews.
——————————————————————
 Una “riforma chiave” del capitalismo per superare lo stato presente dell’Italia. Gianfranco Sabattini su Aladinews.
Una “riforma chiave” del capitalismo per superare lo stato presente dell’Italia. Gianfranco Sabattini su Aladinews.
———————————————————-
 Il reddito di cittadinanza: molti limiti e qualche opportunità. Remo Siza | 14 Gennaio 2019 su welforum.it, ripreso da Aladinews.
Il reddito di cittadinanza: molti limiti e qualche opportunità. Remo Siza | 14 Gennaio 2019 su welforum.it, ripreso da Aladinews.
———————————————————–
Il dibattito economico impegnato nella ricerca della “riforma chiave”
 Una “riforma chiave” del capitalismo per superare lo stato presente dell’Italia
Una “riforma chiave” del capitalismo per superare lo stato presente dell’Italia
di Gianfranco Sabattini
Di fronte ai postumi della Grande Recessione iniziata nel 2007/2008, Laura Pennacchi, economista e politica di sinistra, già sottosegretario al Tesoro nel primo governo Prodi, nell’articolo “Il Piano del lavoro, una riforma per trasformare il capitalismo”, apparso in “Italianieuropei” nn. 5/6 del 2018, si chiede quale potrebbe essere, per l’Italia, una “riforma chiave” in grado “di trasformare radicalmente lo stato di cose presenti”. A parere dell’autrice, l’urgenza maggiore per le forze progressiste e di sinistra risiederebbe nella necessità di uscire da “un silenzio, un’inerzia, una cura di spiccioli affari di bottega che durano ormai da troppo tempo e le condannano alla scomparsa, attivando, al contrario, un cantiere culturale alternativo di vastissima portata, in grado di generare pensiero, analisi, linguaggi di altissimo profilo”. Quale sarebbe la “riforma chiave” che dovrebbe essere concepita e formalizzata da tale cantiere culturale?
Il dilagare dei movimenti populisti e l’emergere di tante somiglianze della situazione attuale dell’Italia (e di quella di tanti altri Paesi), formatasi in conseguenza dello scoppio della crisi del 2007/2008, con quella della fine degli anni Venti, causata dalla Grande Depressione del 1929-1932, devono rappresentare, secondo la Pennacchi, la sfida odierna che le forze di sinistra devono affrontare, puntando su “una riforma in grande del capitalismo, una riforma profonda, come quella che si delineò ai tempi di Keynes, quando una radicalità inusitata di progettazione teorica e di critica ideologica congiunse il pensiero innovativo keynesiano alle rivoluzionarie iniziative di Roosevelt e al riformismo radicale europeo [...], che si opponevano anche idealmente ai totalitarismi”.
Per capire la necessità della riforma del capitalismo attuale, con cui porre rimedio allo status quo dell’Italia, occorre tener presente, secondo la Pennacchi, che il capitalismo, come da molti suoi critici è stato sottolineato, ha avuto successo lungo la sua storia, proprio perché si è sempre presentato nella veste di un sistema che poteva “prendere molte forme”, nel senso che esso non ha mai dato vita necessariamente a “un modello unico”, potendo, al contrario, assumere forme organizzative alternative.
La riflessione sulle diverse forme organizzative che hanno caratterizzato l’evoluzione del capitalismo consentirebbe – afferma la Pennacchi – di “mettere a monte e al centro” dell’analisi economica la “problematica dei fini”, orientandola alla ricerca di possibili forme organizzative alternative a quella del capitalismo attuale, affermatasi con l’avvento dell’egemonia dell’ideologia neoliberista. Ciò permetterebbe, da un lato, di individuare tra queste, quelle conformi al perseguimento di fini diversi da quelli suggeriti dalla globalizzazione e dalla finanziarizzazione delle economie, promosse dall’ideologia neoliberista; dall’altro lato, di evidenziare il ruolo centrale che possoo tornare a svolgere lo Stato e le istituzioni pubbliche, le cui funzioni sono state “oscurate dal parassitismo” delle attività predatrici che i mercati finanziari internazionali senza regole hanno promosso e specializzato “nell’estrazione delle rendite piuttosto che nella produzione di autentico valore”.
L’approfondimento della riflessione sulla riformabilità del capitalismo consentirebbe anche, secondo la Pennacchi, di rendersi conto della improponibilità di tesi, come ad esempio quella sostenuta da Wolgang Streeck, secondo il quale l’idea di riformare il capitalismo contemporaneo sarebbe priva di prospettiva, in quanto qualsiasi politica riformatrice avrebbe solo l’effetto di conservarlo stretto all’interno dell’organizzazione raggiunta, valendo tutt’al più a fargli “guadagnare tempo” riguardo al momento della crisi finale. In alternativa alle tesi che ricalcano quella di Streeck, la Pennacchi sostiene che proprio l’approfondimento del dibattito sulle varie forme organizzative possibili del capitalismo potrebbe offrire all’economia italiana la “via di fuga” dalle secche nelle quali essa è ora incagliato.
Al contrario di Streeck, la Pennacchi ritiene che una riforma del capitalismo, condotta nella prospettiva della “variety of capitalism”. possa essere destinata ad avere sicuro successo, se formulata tenendo conto dei termini che hanno connotato la discussione svoltasi nel passato sulla “secular stagnation”; discussione, questa, che avrebbe consentito di “mettere a fuoco un aspetto del funzionamento del capitalismo”, che si ripresenta anche nelle attuali modalità di funzionamento delle moderne economie industriali in crisi, nella forma di una disconnessione degli investimenti rispetto al “destino del lavoro”.
Questa disfunzione, rispetto ad uno stabile funzionamento delle economie di mercato avanzate, era stata messa in evidenza – ricorda la Pennacchi – dall’economista keynesinao Alvin Hansen, già alla fine degli anni Trenta, dopo che le economie avanzate erano state investite dagli effetti negativi della Grande Depressione; Hansen aveva sostenuto che la grande crisi, iniziata nel 1929, “non fosse un episodio ciclico ma fosse, in realtà, il sintomo dell’esaurimento di una dinamica di lungo periodo” e dell’inizio di una “stagnazione secolare”, divenuta la rappresentazione della nascita del problema della continuità dell’occupazione, trasformatosi nella causa principale dell’allargamento e dell’approfondimento delle disuguaglianze distributive. Le argomentazioni di Hansen sono riproposte oggi da diversi economisti, in particolare da Larry Summers, accademico e politico statunitense che, nell’articolo, pubblicato nel 2013, “Why stagnation might pove to be the new normal”, ha imputato la “secular stagnation” alla carenza di domanda aggregata, “attribuita ad un eccesso di risparmio desiderato rispetto all’investimento desiderato”.
Per rimediare alla insufficienza della domanda aggregata, Lammers rinviene – ricorda la Pennacchi – la via da percorrere nel ricorso allo Stato, inteso come “operatore pubblico animato dalla volontà di procedere ad investimenti propri”, individuando nella “politicizzazione” di tale volontà il motore fondamentale col quale attuare la riforma del capitalismo, al fine di orientarlo alla crescita e allo sviluppo delle società in crisi.
Secondo la Pennacchi, con riferimento alle argomentazioni di Hansen, pur essendo state successivamente smentite dai risultati conseguiti nell’arco dei “gloriosi trent’anni” del secondo dopoguetta (1945-1975), occorre riconoscere che in esse “c’era qualcosa di ‘profetico’” [...] che oggi si rivela fecondo”, cioè che il problema dell’esaurimento della dinamica di lungo periodo del capitalismo e quello dell’occupazione possono essere risolti non con interventi di politica economica che si collochino dal lato dell’offerta (ovvero con misure volte ad erogare incentivi indiretti alle imprese, attraverso tagli fiscali o trasferimenti monetari diretti alle famiglie come sta facendo l’attuale governo italiano), ma con “investimenti pubblici per imprimere impulsi dinamici all’economia e realizzare la piena occupazione”, attraverso il conseguimento di nuove invenzioni, la scoperta di nuovi prodotti e l’incremento della popolazione.
Non è possibile, quindi, a parere della Pennacchi, affidare il rilancio della crescita e dello sviluppo dell’Italia (e in generale di quello degli altri Paesi dell’Unione Europea) ad una “supplay side economics”; né si può pensare che possano essere efficaci, sempre per il rilancio della crescita e dello sviluppo, provvedimenti di natura ordoliberale, quali il “Patto di stabilità” e il “Fiscal compact” stipulati a livello europeo; né, infine, il rilancio della crescita e dello sviluppo può essere atteso dal progresso tecnologico guidato unicamente dalle forze del libero mercato, per cui, anziché essere “indirizzato politicamente”, sia lasciato all’andamento spontaneo determinato dall’evoluzione incontrollata delle forze economiche.
In alternativa a queste iniziative occorre invece, a parere della Pennacchi (tenendo conto delle riflessioni teoriche di Hansen e riproposte oggi da Summers), elaborare e mettere a punto su scala europea una “riforma chiave” dell’attuale modo di funzionare del capitalismo, sulla quale fondare l’attuazione di un “Piano del lavoro” per risolvere “la questione della disoccupazione, non come un ‘fallimento di mercato’ tra gli altri, ma come la contraddizione fondamentale ricorrente del capitalismo”; un “Piano del lavoro”, così finalizzato, rappresenterebbe, per l’intera Europa e per l’Italia, la fonte di una rivitalizzazione della domanda aggregata interna, la quale potrebbe così trasformare i bisogni dei cittadini dell’intera area europea nel volano del rilancio della crescita e dello sviluppo.
Il “Piano del lavoro” dovrebbe essere caratterizzato da un mix di investimenti pubblici e privati, nella prospettiva però che lo Stato sia considerato “occupatore di ultima istanza”, attraverso l’offerta “di lavori pubblici utili socialmente, anche temporanei, al salario minimo legale ai disoccupati che cerchino e non trovino lavoro o per integrare l’occupazione di coloro che abbiano un lavoro parziale involontario”. Solo così, secondo la Pennacchi, sarebbe possibile “tornare a prendere nuovamente sul serio l’obiettivo della piena occupazione”, non in termini pietistici o caritatevoli, ma nella consapevolezza che, così operando, l’efficacia dell’intervento dello Stato sul piano economico e sociale (rispetto al funzionamento spontaneo del capitalismo), risulterebbe ottimale proprio quando il sistema economico, non creando naturalmente occupazione, prefigurasse la formazione di una “società senza lavoro”, predisponendola a sicura catastrofe.
Lasciare che il capitalismo neoliberista conduca il sistema economico e sociale verso la catastrofe è – afferma la Pennacchi – “il rischio contenuto nelle proposte di generalizzazione dei trasferimenti monetari, qual è il reddito di cittadinanza che sarà erogato in Italia, a compensazione e a risarcimento di un lavoro che non c’è, costruendo un ‘welfare per la non piena occupazione’”. Con questa affermazione, la Pennacchi non intende negare che l’erogazione di un reddito di cittadinanza possa servire, ad esempio, a contrastare la povertà; sottolinea però che la sua pratica è gravata da “fondamentali problemi culturali e morali”, che darebbero al reddito di cittadinanza “un sapore di resa, di rinuncia, di abdicazione [...] a far valere la responsabilità collettiva nella trasformazione profonda e strutturale dei meccanismi economici contemporanei, ritenuta impossibile”. Per tutte queste ragioni, occorre prendere atto che una “riforma chiave” del capitalismo neoliberista non può che essere fondata su un intervento pubblico finalizzato a finanziare, col concorso dei privati, un volume di investimenti adeguato ad assicurare la piena occupazione della forza lavoro.
Verso quali fini – si chiede la Pennacchi – deve essere finalizzato l’intervento pubblico? L’ex sottosegretario al Tesoro non ha dubbi: occorre salvare l’economia reale, investendo nella creazione di comparti produttivi nuovi, in protezione ambientale, in disinquinamento, in risparmio di materiali e, naturalmente, in infrastrutture, per accrescere la domanda da parte dei governi, dei consumatori, delle imprese, premiando i consumi collettivi su quelli individuali.
In questa prospettiva di intervento dello Stato, conclude la Pennacchi, l’attuazione del “Piano del lavoro” varrebbe a ricuperare “dignità antiche” (sacrificate o disperse a spese del lavoro dall’imperante ideologia neoliberista) e a prefigurare un nuovo modello di crescita e sviluppo, oltre che dell’economia, dell’intero sistema società.
L’articolo della Pennacchi è di difficile valutazione, perché in esso si intrecciano, sia “desideri” d’ispirazione ideologica, sia valutazioni critiche sulle modalità di funzionamento del capitalismo contemporaneo, che da tempo l’esperienza è valsa a comprovare. Inoltre, l’idea di concepire una “riforma chiave” del capitalismo attuale attraverso l’effettuazione di un alto volume di investimenti (di natura prevalentemente pubblica) evoca una sorta di “Big push” (grande spinta), al quale un tempo si faceva riferimento per promuovere la crescita e lo sviluppo dei Paesi arretrati; così, come tra i molti problemi che l’idea del “Big push” sollevava, vi era quello del “reperimento delle risorse finanziarie con cui attuarlo”; ugualmente, l’ipotesi della Pennacchi di realizzare la “riforma chiave” per il superamento della situazione attuale dell’economia italiana attraverso un “forte investimento pubblico”, rende inevitabile chiedersi dove possano essere reperite le risorse necessarie per la sua attuazione.
Al riguardo, vale la pena ricordare che, se per l’attuazione del “Big push” nei Paesi arretrati, si poteva supporre che le risorse necessarie potevano essere fornite dagli aiuti internazionali, nel caso dell’Italia, lo Stato può rivolgersi all’Europa? E’ plausibile nutrire molti dubbi sulla possibilità che l’Unione Europea, come sta a dimostrate il suo “severo” atteggiamento nei confronti dell’Italia e degli altri Paesi coi conti pubblici non in regola, il “wishful thinking” della Pennacchi possa essere soddisfatto.
A parte queste considerazioni, nella narrazione complessiva dell’ex sottosegretario di Stato vi è, implicito, un altro problema, ben più importante di quello concernente il possibile finanziamento dell’auspicata “riforma chiave”; problema che deve essere attentamente valutato. Non è privo di sorpresa il fatto che la Pennacchi, da economista qual ella è, confonda il reddito di cittadinanza, così com’è inteso dall’attuale governo italiano (e, ahi noi, dall’intera classe politica italiana) con quello proposto, ad esempio, da James Mead, per contrastare, non la disoccupazione temporanea e congiunturale, ma quella strutturale e irreversibile, qual è quella che il capitalismo moderno, anche se riformato nel senso indicato dalla Pennacchi, tenderebbe a determinare (come la profezia di John Maynard Keynes vuole e i moderni processi produttivi impongono).
A fronte della disoccupazione strutturale irreversibile non sono proponibili lavori pubblici socialmente rimunerati a un “salario minimo legale”; molte sono le controindicazioni connesse a tale tipo di lavori; questi, infatti, non solo mancano di far ricuperare alla forza lavoro (disoccupata, sottoccupata o “precarizzata” involontariamente) la dignità perduta, ma possono anche determinare frustrazioni psichiche nei lavoratori stessi, se i lavori socialmente utili loro assegnati fossero percepiti (come l’esperienza e le ricerche sul campo convalidano), stando alla terminologia di David Graeber, come “lavori del cavolo”.
In conclusione, la vera “riforma chiave” da apportare al capitalismo, se si vuole salvare l’economia reale, fermi restando il ruolo e la funzione dello Stato riguardo all’offerta di tutti quei beni pubblici che l’economia privata non può produrre, è la riforma “ab imis” dell’attuale welfare State, realizzata sulla base di un cambiamento delle regole distributive tradizionali del prodotto sociale e dell’istituzionalizzazione del reddito di cittadinanza universale e incondizionato correttamente inteso.
Con questa forma di reddito è plausibile ipotizzare realisticamente, non solo un ridimensionamento del problema della povertà e della disoccupazione, ma anche la riduzione delle burocrazie di qualunque forma (che “bruciano” risorse, sottraendole ad altre finalità molto più convenienti sul piano economico e su quello sociale) e, quel che più conta, la garanzia della libertà assicurata ad ogni cittadino di perseguire il proprio progetto di vita mediante forme di ”occupazione autodiretta”.
———–
Il dipinto in testa: https://www.aladinpensiero.it/?tag=autoritratto-del-pittore-austriaco-ferdinand-georg-waldmuller
AladiNewsEditoriali


 Reddito di base universale e incondizionato: un’idea radicale per affrontare l’insicurezza economica e l’esclusione sociale del nostro tempo di Gianfranco Sabattini su AladinewsEditoriali.
Reddito di base universale e incondizionato: un’idea radicale per affrontare l’insicurezza economica e l’esclusione sociale del nostro tempo di Gianfranco Sabattini su AladinewsEditoriali.
———————————————————————————-
 Il reddito di cittadinanza: molti limiti e qualche opportunità Remo Siza | 14 Gennaio 2019 su welforum.it.
Il reddito di cittadinanza: molti limiti e qualche opportunità Remo Siza | 14 Gennaio 2019 su welforum.it.
- Su Aladinews.
—————————————————————————
Parliamo di “reddito di cittadinanza”, di quello vero: utopia da inseguire, per ora appannaggio dei “campioni dell’impossibile”?

 Reddito di base universale e incondizionato: un’idea radicale per affrontare l’insicurezza economica e l’esclusione sociale del nostro tempo
Reddito di base universale e incondizionato: un’idea radicale per affrontare l’insicurezza economica e l’esclusione sociale del nostro tempo
di Gianfranco Sabattini
Dopo la pubblicazione, nel 2013, di “Il reddito minimo universale” e, nel 2017, di “Il reddito di base”, entrambi dedicati dagli autori, Philippe Van Parijs e Yannick Vanderborght alla spiegazione del significato e della funzione del reddito di cittadinanza (assegnato a ogni individuo senza vincoli di “contropartite lavorative” e senza “prova dei mezzi”), era plausibile attendersi che la classe politica si fosse presa la briga di leggerli; ciò avrebbe consentito di evitare la confusione, ormai radicata anche nell’opinione pubblica, che solitamente viene fatta per la mancata distinzione tra la forma di reddito della quale parlano gli autori e tutte le misure monetarie di natura welfarista adottabili e adottate (come, ad esempio quella introdotta dall’attuale governo italiano) per contrastare il fenomeno della povertà.

La confusione non potrà essere d’aiuto per riflettere sui contenuti più appropriati della politica economica, presumibilmente chiamata nel prossimo futuro ad affrontare i fenomeni dell’insicurezza economica e dell’esclusione sociale che affliggono attualmente il sistema socio-politico dell’Italia, congiuntamente a quello di molti altri Paesi industrializzati di mercato, per tutte le ragioni puntualmente illustrate nei libri sopra richiamati.
Viviamo in un mondo radicalmente nuovo rispetto a quello nato e consolidatosi nei primi trent’anni successivi alla fine del secondo conflitto mondiale; si tratta – affermano Van Parijs e Vanderborght, – di un mondo “riplasmato da numerose forze: la dirompente rivoluzione tecnologica determinata dal computer e da Internet; la globalizzazione dei mercati, delle migrazioni e della comunicazioni; la crescita impetuosa della domanda mondiale di beni a dispetto dei limiti imposti dall’esaurimento delle risorse naturali e dalla saturazione dell’atmosfera; la crisi delle tradizionali istituzioni protettive, dalla famiglia ai sindacati, ai monopoli di Stato, ai sistemi di welfare; infine le interazioni esplosive di queste varie tendenze”.
Per poter valutare razionalmente come contrastare le minacce delle quali sono portatrici queste tendenze, occorre, a parere di Van Parijs e Vanderborght, definire un quadro istituzionale di riferimento alternativo a quello esistente; a tal fine, gli autori, affermati docenti di economia e di scienza politica e divulgatori dell’idea di “reddito di base” (o reddito di cittadinanza), avanzano la proposta di un “nuovo quadro istituzionale” fondato sulla libertà, “intesa come libertà sostanziale di tutti e non solo dei ricchi”.

Per realizzare il nuovo quadro istituzionale occorre agire su diversi fronti, dal miglioramento dell’uso delle risorse, alla ridefinizione dei diritti di proprietà, dal miglioramento del sistema dell’istruzione (attraverso la sua trasformazione in sistema di apprendimento permanente), alla ristrutturazione del modo in cui all’interno delle moderne società industriali ad economia di mercato si persegue l’obiettivo della sicurezza economica e dell’inclusione sociale. Lo strumento sul quale edificare il nuovo quadro istituzionale alternativo a quello attuale (non più in grado di garantire, sia la sicurezza economica, che l’inclusione sociale) consiste, secondo Van Parijs e Vanderborght, nell’introdurre nell’insieme delle regole di funzionamento delle moderne società industriali ciò che oggi “è comunemente chiamato reddito di base: un reddito regolare pagato in denaro ad ogni singolo membro di una società, indipendentemente da altre entrate e senza vincoli”.
Qual è l’incombenza, si chiedono Van Parijs e Vanderborght, che, pesando oggi sullo stabile funzionamento delle società economicamente avanzate, a rendere necessaria una riforma del loro quadro istituzionale, fondata sull’introduzione di un reddito di base universale e incondizionato? Tutti coloro che sinora si sono pronunciati in favore di tale forma di reddito chiamano in causa alcuni aspetti della dinamica propria delle moderne società industriali, quali, in primo luogo, l’ondata di automazione (di cui è prevista un’accelerazione nei prossimi anni) che sta investendo i processi produttivi, causando una crescente polarizzazione del prodotto sociale; in secondo luogo, l’approfondimento e l’allargamento della globalizzazione che, oltre ad aggravare le disuguaglianze distributive, causerà l’aumento del numero delle persone che perderanno irreversibilmente la stabilità occupazionale.
Le innovazioni dei processi produttivi (che consentono “risparmio di lavoro”, indotto dal progresso scientifico e tecnologico e dalla natura altamente competitiva del mercato globale), potrebbero non rappresentare una “calamità sociale” insormontabile, se la maggior produttività da esse determinata potesse tradursi in una maggiore crescita; ma la fiducia su una crescita senza limiti presenta diverse controindicazioni: in primo luogo, esse sono dovute ai limiti ecologici, oggi amplificati dall’impatto sull’atmosfera; in secondo luogo, al fatto che i moderni sistemi industriali, come sottolineano molti economisti, sono esposti agli esiti di una loro tendenza a una “stagnazione secolare”; in terzo luogo, alla consapevolezza che la crescita, anche per chi la ritiene auspicabile che possibile, non costituisca una soluzione alla disoccupazione strutturale e alla precarietà.
Le controindicazioni circa la possibilità che un’ulteriore crescita basti a risolvere i problemi della disoccupazione e della precarietà, nel contesto di un’automazione crescente e di un allargamento della globalizzazione, sono forse discutibili; esse, tuttavia, sono sufficienti a “spiegare e a giustificare” le richieste di una più efficace risposta alle sfide poste dall’aggravarsi dei fenomeni della disoccupazione strutturale e delle disuguaglianze distributive: secondo Van Parijs e Vanderborght, se non si troverà “un modo per assicurare un reddito di base da corrispondere alle persone che non hanno lavoro (o non hanno un lavoro decente), le moderne società industriali ad economia di mercato andranno incontro ad un futuro perennemente caratterizzato da instabilità economica e conflittualità sociale”.
La previsione che la creazione di nuovi posti di lavoro “dignitosi” sarà sempre più difficile suggerisce perciò la necessità che gli establishment dominanti si convincano che occorre assicurare le risorse necessarie alla sopravvivenza della crescente massa di disoccupati e di poveri. Van Parijs e Vanderborght indicano due alternative per rispondere a questa necessità. Un primo modo di procedere (che gli autori considerano sconveniente) potrebbe consistere nell’allargamento dell’esistente sistema di assistenza pubblica; si tratterebbe di un modo utile solo per contrastare la “povertà estrema”, ma, a causa della sua “condizionalità”, varrebbe a trasformare i beneficiari in una classe di cittadini destinati a dipendere “permanentemente dall’assistenza sociale”. L’altra possibile soluzione, fondata sul principio che la libertà sostanziale debba essere garantita a tutti, consiste nell’introdurre un reddito di base di tipo incondizionato, inteso “nell’accezione più piena del termine”.
Il reddito di base differisce da ogni altra forma di sussidio corrisposto a chi versa in stato di necessità, perché esso, oltre ad essere universale (dimensione di cui sono prive tutte le “misure” welfariste destinate ad alleviare le condizioni esistenziali di chi è privo di ogni fonte di sostentamento), è anche incondizionato, in quanto, a differenza di tutte le forme di assistenza welfarista, esso è esente da ogni accertamento della condizione economica del beneficiario. Infatti, ogni forma di assistenza condizionata presenta lo svantaggio che il sussidio sia corrisposto ai beneficiari solo “ex post” (cioè sulla base di una preliminare determinazione delle risorse materiali delle quali possono disporre gli stessi beneficiari); il reddito di base incondizionato, al contrario, è corrisposto “ex ante”, senza alcun accertamento della condizione economica degli aventi diritto.
Le conseguenze dell’incondizionalità risultano tali da rendere il reddito di base profondamente diverso da ogni forma di assistenza condizionata; dal punto di vista del disoccupato strutturale o del povero, l’elemento che più di ogni altro vale a differenziare questo tipo di reddito dai sussidi condizionati è la possibilità assicurata ai beneficiari di sottrarsi al ricatto intrinseco alla condizioni alle quali è tradizionalmente subordinata la fruizione di un sussidio condizionato; ne è un esempio il “potere di ricatto” che può essere esercitato da ogni datore di lavoro ai danni dei lavoratori, quando questi ultimi siano “obbligati a svolgere un lavoro” infimo e mal pagato, per conservarsi nella condizione di poter fruire del beneficio assistenziale.
In conseguenza di quanto sin qui osservato sulle specificità del reddito di base, si può dire che, mentre la sua universalità consente di evitare la “trappola” delle disoccupazione e della povertà, il fatto di non essere condizionato serve a contrastare la “trappola” del lavoro obbligato, spesso sottopagato o degradante. Considerati i vantaggi connessi alle specificità del reddito di base universale e incondizionato, è difficile – affermano Van Parijs e Vanderborght – negare che esso costituisca nelle moderne società industrializzate ad economia di mercato, non solo un “potente strumento di libertà”, ma anche, più che una spesa, una forma d’investimento, utile a garantire una maggior flessibilità nel governo dei moderni problemi economici e sociali delle società economicamente avanzate e integrate nell’economia mondiale.
I principali interrogativi che incombono sulla possibilità di istituzionalizzare il reddito di base universale e incondizionato (come antidoto alla crescente disoccupazione strutturale e alla diffusione della povertà nelle società industriali avanzate e ad economia di mercato) riguardano la sua sostenibilità e il sui finanziamento. Per quanto riguarda la sostenibilità, molto diffusa è la preoccupazione che l’offerta di lavoro venga negativamente influenzata dall’assenza di obblighi da parte dei beneficiari del reddito di base. Van Parijs e Vanderborght ritengono fuorviante “ridurre le conseguenze economiche del reddito di base al suo impatto immediato sull’offerta del mercato del lavoro”. Fornendo sicurezza e autonomia economica, è plausibile prevedere che il reddito di base possa incoraggiare l’imprenditorialità, promuovendo l’allargamento di forme di lavoro autodiretto; in secondo luogo, esso può motivare molti lavoratori a scegliere di optare per un lavoro a tempo parziale; in terzo luogo, liberando chi è privo di reddito dalla “trappola della disoccupazione”, il reddito di base universale e incondizionato può produrre effetti positivi sul capitale umano, motivando i fruitori ad aumentare il loro “interesse a investire nell’istruzione e nella formazione continua”.

 Secondo Van Parijs e Vanderborght, tutte queste ragioni concorrono a rendere stretta la connessione che esiste tra una maggior sicurezza garantita dal reddito di base e una maggior flessibilità del mercato del lavoro; si tratta di una connessione che tende ad assicurare ai senza reddito la libertà di non lavorare, piuttosto che l’obbligo di lavorare. Tra l’altro, la stretta connessione che esiste tra la libertà dal bisogno e la maggior flessibilità del mercato del lavoro rende possibile anche una più funzionale riorganizzazione del tradizionale sistema di welfare State; essa consente infatti la sua trasformazione da “sistema protettivo caritatevole e punitivo” in “sistema di welfare State attivo ed emacipatorio”, orientato “a rimuovere gli ostacoli allo svolgimento di un’attività lavorativa gratificante, quali sono le trappole della disoccupazione e dell’emarginazione”, e a “facilitare l’accesso delle persone all’istruzione e alla formazione”, strumentali all’intrapresa di una pluralità di attività produttive.
Secondo Van Parijs e Vanderborght, tutte queste ragioni concorrono a rendere stretta la connessione che esiste tra una maggior sicurezza garantita dal reddito di base e una maggior flessibilità del mercato del lavoro; si tratta di una connessione che tende ad assicurare ai senza reddito la libertà di non lavorare, piuttosto che l’obbligo di lavorare. Tra l’altro, la stretta connessione che esiste tra la libertà dal bisogno e la maggior flessibilità del mercato del lavoro rende possibile anche una più funzionale riorganizzazione del tradizionale sistema di welfare State; essa consente infatti la sua trasformazione da “sistema protettivo caritatevole e punitivo” in “sistema di welfare State attivo ed emacipatorio”, orientato “a rimuovere gli ostacoli allo svolgimento di un’attività lavorativa gratificante, quali sono le trappole della disoccupazione e dell’emarginazione”, e a “facilitare l’accesso delle persone all’istruzione e alla formazione”, strumentali all’intrapresa di una pluralità di attività produttive.
In questo modo, nelle moderne società industriali, il welfare State cesserebbe d’essere strumento “punitivo del lavoro” (come avviene con il sistema esistente, che rimuove il beneficio corrisposto al lavoratore disoccupato o al povero indigente che dovessero rifiutare di sottostare ai “vincoli” previsti per il loro reinserimento e/o inserimento lavorativo), per diventare, al contrario, strumento di promozione di forme gratificanti e socialmente utili di lavoro.
Per quanto riguarda l’altro interrogativo (quello relativo al finanziamento), incombente sulla possibilità di istituzionalizzare il reddito di base universale e incondizionato come antidoto alla crescente disoccupazione strutturale e alla diffusione della povertà, la preoccupazione principale che esso solleva è riconducibile all’ipotesi che le società industriali moderne, già gravate di un oneroso sistema fiscale, possano non tollerare un suo ulteriore inasprimento per finanziare il reddito di base, a meno che l’inasprimento non sia associato ad una riduzione dell’asimmetria nel trattamento fiscale dei redditi da capitale e dei redditi da lavoro, “caricando” prevalentemente sul capitale l’onere del finanziamento del reddito di base.
Un più equo trattamento fiscale delle due classi di reddito, però, si scontrerebbe con l’opposizione delle forze economiche e politiche prevalenti, per via del fatto che l’asimmetria nel trattamento fiscale a vantaggio del capitale è tradizionalmente “giustificata dalla necessità – affermano Van Parijs e Vanderborght – di incoraggiare investimenti ad alto rischio e lo spirito imprenditoriale” e di non promuovere la mobilità internazionale del capitale che, di fronte alla minaccia di perdere in parte i privilegi fiscali potrebbe “fuggire all’estero”.
Per finanziare il reddito di base esistono però – sottolineano Van Parijs e Vanderborght – delle alternative che non prevedono il ricorso alla tassazione. Tra queste, la principale consiste nella creazione di un “Fondo Sovrano Permanente”, una sorta di “salvadanaio collettivo”, nel quale fare affluire le entrate derivanti da tutte le forme di collocamento (a titolo di affitto o di cessione) delle risorse mobiliari e immobiliari di proprietà pubblica. In questo modo, il finanziamento del reddito di base avverrebbe secondo le modalità previste da James Meade nel suo “modello agathopista”; in altri termini, il reddito di base potrebbe essere finanziato senza bisogno di alcuna tassazione, mediante la distribuzione annuale a tutti i cittadini, su basi paritarie, della dotazione del “Fondo”, sotto forma di reddito di base universale e incondizionato, inteso come dividendo del rendimento economico di un capitale pubblico.
Un disegno di riforma del quadro istituzionale di riferimento, quale quello fondato sull’introduzione di un reddito di base (o di cittadinanza, come anche viene chiamato), per risolvere i problemi delle società industriali avanzate, richiede ovviamente che il loro sistema economico sia efficiente e gestito da forze economiche e politiche interessate al suo stabile funzionamento.
Ipotizzare che questo disegno sia proponibile e attuabile all’interno di un Paese qual è l’Italia di oggi può apparire temerario, considerato lo stato in cui essa versa. Una cosa però è certa: se tutte le forze sociali impegnate (sul piano culturale, politico ed economico) a risolvere i problemi che maggiormente affliggono il Paese (rilancio della crescita e contrasto della disoccupazione strutturale e della diffusione della povertà) abbandoneranno molti dei pregiudizi ideologici che hanno sinora condizionato la ricerca di adeguate soluzioni, dovranno (quelle forze) necessariamente tener conto del fatto che l’istituzionalizzazione del reddito di base universale e incondizionato è uno dei presupposti per fare dell’Italia del futuro, parafrasando un’efficace espressione di Meade, “un luogo in cui è ancora conveniente e gratificante vivere”.
———————————————————

———————————————————
- Gianfranco Sabattini su AladiNews.
- Campioni dell’impossibile: https://www.aladinpensiero.it/?p=89277
Dibattito. E la Sinistra?


Le responsabilità della sinistra di fronte alla crisi del Paese
di Gianfranco Sabattini
La cosa che più colpisce della crisi della sinistra italiana, ma in generale della sinistra che ha governato per tanti anni gran parte dei Paesi ad economia di mercato e retti da regimi democratici, è il fatto che essa (la sinistra) sia stata quasi totalmente disinteressata a cogliere le cause delle trasformazioni che il progresso della scienza e della tecnica determinava nei Paesi della cui condizione era responsabile sul piano economico e su quello sociale. Essa, in sostanza, davanti ai fenomeni che hanno mutato in profondità la vita di milioni di uomini, caratterizzando gli assetti politici, sociali ed economici degli anni a venire, è stata affetta da una grave forma di disattenzione, interessata unicamente dalla cura dei problemi connessi all’unica preoccupazione di conservarsi al potere.
Per questo motivo, la sinistra appare oggi in difficoltà più o meno dovunque, sia per la perdita di consenso, che per la scarsa capacità di comprendere la natura dei nuovi bisogni sociali e le modalità con cui offrire valide e condivise soluzioni. La sinistra è, perciò, vittima di una perdita di consapevolezza che le ha causato un complesso d’inferiorità nei confronti della destra; causa, questo complesso, della mancata considerazione dei motivi che hanno determinato le trasformazioni economiche e sociali che hanno caratterizzato la vita dei Paesi nei quali essa era una delle forze politiche egemoni.
Per affrancarsi dal complesso d’inferiorità, la sinistra deve aggiornarsi e rinnovarsi, ricostruendo l’identità perduta e riformulando una cultura politica in grado di fungere da criterio di orientamento per quanti si riconoscono ancora in un’area politica che ha bisogno di essere ridefinita, se vuole affrontare le nuove sfide poste dalla globalizzazione e dalla sempre più rapida evoluzione delle tecnologie produttive e delle condizioni di operatività del sistema economico (digitalizzazione della conoscenza, robotizzazione del sistema produttivo, trasformazione del lavoro e delle relazioni sociali); fatti, questi ultimi, che hanno determinato, con l’esplosione dei nazionalismi e dei populismi, la radicale mutazione della politica, nonché il crescente affievolimento delle procedure decisionali proprie della democrazia.
In Italia, il dibattito politico non dà alcuna impressione che la sinistra, a fronte dell’egemonia acquisita dal pensiero unico neoliberista, sia impegnata a ridefinire la sua identità, per conformarla alle esigenze del mondo contemporaneo. Il riformismo del quale essa si considera portatrice ideale, è di solito impedito dalle divergenze profonde che animano le sue diverse “anime”; mentre la riflessione sul mondo che cambia è costantemente sacrificato dall’unica preoccupazione delle sue diverse componenti di non soccombere nella resa dei conti tra loro, sempre in atto. In tal modo, la sinistra si trova ad essere impossibilitata ad arricchire l’orizzonte ideale del suo riformismo, attraverso una riflessione che le permetta di evitare l’obsolescenza del suo approccio reale ai problemi del mondo contemporaneo. Di tutto ciò, il Paese sta pagando il grave prezzo di non riuscire a risollevarsi dalla condizione di crisi nella quale è caduto, dopo l’inizio della Grande Recessione del 2997/2008.
Nella sua storia secolare, la sinistra democratica europea – afferma Massimo Mucchetti (“La sinistra di fronte all’obsolescenza del suo approccio al reale”, Italianieuuropei, n. 5/6, 2018) – è stata alternativamente ispirata da diverse idee-guida, quali “la programmazione democratica, lo Stato imprenditore e il welfare pubblico. E poi la liberalizzazione dei movimenti di capitali [...], le privatizzazioni delle partecipazioni statali e del welfare, l’impresa come generatrice di valore per gli azionisti, la scoperta della concorrenza”. Alcune di queste idee-guida appartengono alla tradizione della sinistra democratica, mentre altre sono state acquisite dalla destra neoliberista. Le idee di quest’ultima sono quelle che hanno determinato la crisi d’identità della sinistra riformista, causandone una crisi, divenuta profonda negli ultimi trent’anni.
Si tratta, secondo Mucchetti, di idee già di per sé superate nel momento stesso in cui si sono affermate; ciononostante, esse sono state condivise dalla sinistra democratica, determinandone un’”afasia” che le ha impedito di comprendere le ragioni dell’”emergere prepotente della protesta populista e sovranista”; motivo, questo, che, “prima ancora che con la modestia professionale dei suoi ultimi esponenti”, spiega l’obsolescenza culturale e ideologica della sinistra democratica, impedendole di cogliere il senso della protesta populista generata dalla stagnazione economica e dal disagio sociale causati dalla conquistata egemonia politica da parte delle idee della destra neoliberista.
La sinistra, perciò, se vorrà riacquisire la propria identità che le consenta un più appropriato approccio ai problemi della realtà contemporanea, non potrà non “ripartire – sottolinea Mucchetti – dalle ragioni dell’obsolescenza del proprio approccio al reale”; ragioni che vanno rintracciate “nella trasformazione digitale dell’economia e, più in generale, dello stile di vita e dei valori morali della società civile con i conseguenti riflessi sull’organizzazione della politica”.
L’avvento, sempre più pervasivo, dell’intelligenza artificiale avrebbe dovuto preannunciare, per la sinistra, la radicale trasformazione che stava avvenendo nella società e la tendenziale “disintermediazione” politica che la trasformazione stava determinando nei processi decisionali. Ovviamente, il manifestarsi degli effetti della trasformazione sociale, indotta dall’avvento della “Big Tech”, hanno continuato a coesistere con il modo tradizionale col quale la società ha continuato ad autoregolarsi; ciò non di meno, essi (il manifestarsi degli effetti della trasformazione) hanno rinnovato il modo di funzionare della società, riordinandola “secondo una nuova gerarchia del potere”, che ha relegato, in maniera crescente anche se impercettibile, “in secondo piano le architravi della società moderna dell’ultimo secolo, e cioè la finanza e l’industria”.
Ciò avrebbe dovuto indurre la sinistra a domandasi se l’avvento dell’intelligenza artificiale stesse per caso determinando il passaggio della società stessa nel postcapitalismo; ovvero – afferma Mucchetti – in un mondo nel quale formazione e utilizzazione del capitale sono asservite “all’accrescimento senza fine della potenza dell’impresa prima che alla rimunerazione del capitalista”, che tuttavia continuerà a sussistere, “ma solo o principalmente attraverso l’aumento delle quotazioni” delle azioni possedute dai capitalisti; ciò in conseguenza del fatto che l’avvento della “Big Tech” segnerà il “trionfo” della tecnica sul capitale.
Se la sinistra mancherà di riflettere su quanto la prevalenza della tecnica sta determinando sulle modalità di funzionamento delle società industriali del capitalismo contemporaneo, essa correrà sicuramente il rischio di “rimanere al di qua della sfida” da affrontare, che non si ridurrà, osserva Mucchetti, a contrastare gli effetti negativi senza regole della globalizzazione delle economie nazionali, in quanto dovrà investire il “nucleo teorico fondante della “Big Tech”.
Se le osservazioni sin qui fatte hanno un senso – continua Mucchetti -, per riappropriarsi della sua identità, la sinistra dovrà necessariamente ripensare la propria politica; essa potrà riproporsi per il governo del mondo contemporaneo e di quello futuro, solo se riuscirà a sopravvivere, facendo “valere nel tempo nuovo i suoi valori”. Diversamente, se la sinistra dovesse perdere la “propria ragion d’essere politica”, credere di potersi opporre alla diffusione dei movimenti populisti e sovranisti attraverso la denuncia pedagogica dei rischi ai quali essi esporrebbero la democrazia rappresentativa e il governo dell’economia e della tecnologia, senza capire l’impatto che sull’una e sull’altro essi (i movimenti) hanno avuto (e continueranno ad avere in maggior misura anche nel futuro) varrebbe solo a segnalare uno suo “spirito conservativo”, destinato a non avere efficacia né in economia, né in politica..
Poiché l’avvento della “Big Tech” è causa del manifestarsi di effetti, quali – ad esempio – il dilagare della disoccupazione involontaria irreversibile e del fenomeno della povertà, che le tradizionali forme di funzionamento del capitalismo non sono più in grado di governare, la sinistra, tradizionale presidio sul piano politico della condizione sociale degli ultimi e in generale della forza lavoro disoccupata, dovrebbe rendersi conto della necessità di concordare “adeguati compromessi”, analogamente a quanto è accaduto alla fine del secondo conflitto mondiale, con il patto stretto tacitamente tra capitale e lavoro e con la creazione del sistema di sicurezza sociale del welfare State, che hanno consentito la continuità di funzionamento del capitalismo postbellico in condizioni di stabilità.
Ciò è accaduto, però, perché la sinistra aveva saputo trasformare lo Stato in garante del patto tra capitale e lavoro e del funzionamento del sistema di sicurezza sociale adottato; ma nell’era dell’egemonia delle “Big Tech” e della disintermediazione politica, chi svolgerà – si chide Mucchetti – le funzioni dello Stato e quali potranno essere le regole necessarie a dare attuazione ai nuovi compromessi? Gli attuali poteri forti dell’economia espressi dalla “Big Tech” tendono, invece, a distruggere – afferma Mucchetti – il “potere di governare l’economia e la società da parte della politica”, facendo venir meno la possibilità di esercitare il controllo sul funzionamento dell’attività economica a garanzia dei diritti dei cittadini.
L’affievolimento del potere della politica e dello Stato è dovuto, non solo al fenomeno della disintermediazione delle istituzioni politiche nazionali, ma anche alla riduzione del potere disciplinare delle regole adottate per il controllo degli esiti connessi al funzionamento del sistema economico contemporaneo. La disintermediazione delle istituzioni politiche nazionali ha ridotto il potere regolatorio di cui esse disponevano, trasferendolo invece a svariate burocrazie internazionali, le quali, sebbene nominate dai governi nazionali, esercitano il loro potere a favore degli interessi corporativi di ristrette minoranze, che si appropriano dei vantaggi economici assicurati dal progresso scientifico e tecnologico. La disintermediazione ha così favorito la liberalizzazione dei movimenti dei capitali che hanno consentito ai detentori del capitale di investirlo solo sulla base delle proprie convenienze.
Nel momento stesso in cui la disintermediazione delle istituzioni nazionali e l’affievolimento del potere delle regole adottate a livello nazionale (grazie anche all’organizzazione della società finalizzata alla disintermediazione delle istituzioni e all’indebolimento dell’efficacia delle regole nazionali) hanno generato dei potentati economici che hanno potuto agire liberamente, indipendentemente dal fatto che la loro azione risultasse compatibile con la soddisfazione degli interessi della generalità dei cittadini, è stata inevitabile l’insorgenza della protesta populista e sovranista.
Il “luogo di valorizzazione” del capitale è diventato così una “rete senza confini”, che ha sostituito il “patto” originario che nelle società del passato legava i detentori del capitale alla soddisfazione, oltre che dei propri anche di quelli di tutti gli altri cittadini dello Stato all’interno del quale essi (i detentori) operavano; e se la “Big Tech” costituirà il paradigma in base al quale sarà riproposta la continuità di funzionamento del capitalismo, è giusto chiedersi – come fa Mucchetti – quale potrà essere la politica più conveniente che la sinistra potrà adottare per sconfiggere il nuovo “fantasma che si aggira per l’Europa”, da tutti individuato nel movimento dei populisti e dei sovranisti.
Ora, conclude Mucchetti, sin tanto che la sinistra democratica non si aprirà alla comprensione delle radicali trasformazione che nell’economia e nella società sono state causate dall’avvento della “Big Tech”, essa potrà anche sopravvivere “battagliando affinché il gettito fiscale [...] sia sufficiente a sostenere il welfare pubblico” per il sostentamento dei disoccupati, dei poveri e, in generale, di tutti coloro che sono privi di reddito; oppure potrà anche trovare, di volta in volta, tra i problemi sociali correnti quelli che potranno consentire di stendere un programma elettorale; persistendo, però, nel formulare solo politiche per il contenimento dei movimenti populisti, la sinistra continuerà a sopravvivere, senza accorgersi dei cambiamenti intervenuti nelle strutture portanti dell’economia e della società, e soprattutto di quelli che caratterizzano ora il rapporto tra capitale e lavoro.
Quando, finalmente, la sinistra si aprirà alla comprensione della natura di questi cambiamenti, soprattutto del loro impatto negativo sul tradizionale meccanismo di distribuzione del prodotto sociale (fondato, in linea di principio, sulla rimunerazione della forza lavoro occupata nel processo produttivo), solo allora essa capirà che l’istituzionalizzazione del reddito di cittadinanza universale e incondizionato (che non sia, però, una sorta di reddito di inclusione) rappresenta le risorse da elargire alla forza lavoro che la “Big Tech” ha espulso (e continua ad espellere) dal processo produttivo.
Il reddito di cittadinanza, infatti, oltre ad essere uno strumento di giustizia sociale e un modo per garantire la sopravvivenza del capitalismo contemporaneo, rappresenta l’unico valido argomento che può consentire alla sinistra di porre rimedio alla sua attuale deriva, causata dal fatto d’essere rimasta legata a valori che non hanno più ragion d’essere nelle moderne società industriali.
Oggi martedì 11 dicembre 2018

![]()








![]()
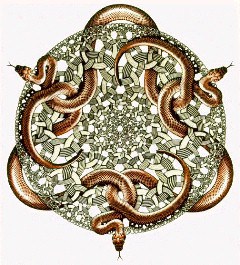

———-Avvenimenti&Dibattiti&Commenti————————————
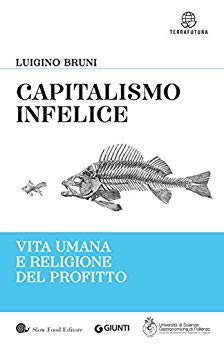 IL DIBATTITO SI ACCENDE!
IL DIBATTITO SI ACCENDE!
Una critica integralista del Reddito di cittadinanza
11 Dicembre 2018
Gianfranco Sabattini su Democraziaoggi.
————————————————————–
Oggi giovedì 6 dicembre 2018

![]()








![]()
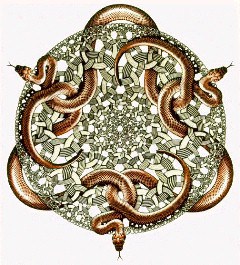

———-Avvenimenti&Dibattiti&Commenti————————————
 Welfare State: crisi e alternative (dividendo sociale o reddito di cittadinanza universale e incondizionato)
Welfare State: crisi e alternative (dividendo sociale o reddito di cittadinanza universale e incondizionato)
6 Dicembre 2018
Gianfranco Sabattini su Democraziaoggi.
(nella foto, James Edward Meade).
———————————————————————
Oggi incontro-dibattito su reddito di cittadinanza e dintorni
Il pensiero di Bauman su Etica del Lavoro e “Reddito minimo garantito sufficiente ad assicurare il rispetto della dignità umana”
 Il “Reddito di cittadinanza” trova su Aladinews due filoni di approfondimento: 1) il primo attiene al “Reddito di cittadinanza” autentico, così come lo hanno delineato e definito i teorici di questo istituto, da Keynes nei suoi tempi (in verità anche prima del grande economista di Cambridge) e più avanti da tanti altri (particolarmente economisti e sociologi) fino alla contemporaneità, denominato anche diversamente (Dividendo sociale, Reddito minimo garantito, etc.), ma sempre con le caratteristiche di essere universale e incondizionato; 2) il secondo attiene a tutti gli istituti di contrasto alle povertà (assolute e relative), che assumono denominazioni diverse, nella nostra realtà ReI e Reis (redditi di inclusione sociale). Anche la proposta governativa del cd “Reddito di cittadinanza” sostenuta soprattutto dal M5S è riconducibile a questo secondo filone, trattandosi sostanzialmente di un’evoluzione del vigente ReI, come abbiamo più volte messo in rilievo su queste pagine.
Il “Reddito di cittadinanza” trova su Aladinews due filoni di approfondimento: 1) il primo attiene al “Reddito di cittadinanza” autentico, così come lo hanno delineato e definito i teorici di questo istituto, da Keynes nei suoi tempi (in verità anche prima del grande economista di Cambridge) e più avanti da tanti altri (particolarmente economisti e sociologi) fino alla contemporaneità, denominato anche diversamente (Dividendo sociale, Reddito minimo garantito, etc.), ma sempre con le caratteristiche di essere universale e incondizionato; 2) il secondo attiene a tutti gli istituti di contrasto alle povertà (assolute e relative), che assumono denominazioni diverse, nella nostra realtà ReI e Reis (redditi di inclusione sociale). Anche la proposta governativa del cd “Reddito di cittadinanza” sostenuta soprattutto dal M5S è riconducibile a questo secondo filone, trattandosi sostanzialmente di un’evoluzione del vigente ReI, come abbiamo più volte messo in rilievo su queste pagine.
Iscrivendolo correttamente al primo dei filoni citati, di seguito ospitiamo un articolo del prof. Gianfranco Sabattini, anch’egli del vero “Reddito di cittadinanza” che nella circostanza porta a sostegno delle sue posizioni il noto sociologo Zygmunt Bauman, recentemente scomparso, che, lo ricordiamo, fu ospite della nostra città il 3 giugno 2016 (a questa occasione si riferiscono le foto a corredo del presente articolo).
In argomento ricordiamo l’iniziativa patrocinata anche dalla nostra news, prevista per venerdì 30 novembre nell’ambito del mese dei diritti umani 2018 (10 novembre/10 dicembre 2018)—————————————————-

Etica del lavoro e sviluppo capitalistico
di Gianfranco Sabattini*
L’etica del lavoro costituisce una sorta di comandamento con cui è stato imposto all’uomo l’obbligo di lavorare; per suo tramite il lavoro è divenuto, soprattutto nell’età moderna, la “condizione normale” per l’uomo, mentre non lavorare lo ha esposto, invece, alla pubblica esecrazione. Questa condizione normale è quindi fondata, nella coscienza collettiva di una comunità, sull’assunto che sia il lavoro (attraverso il quale diventa possibile procurarsi un compenso, in cambio di una qualche prestazione) a rappresentare oggettivamente il “valore morale apprezzato dall’etica del lavoro”, e non la libera scelta di chi aspira ad ottenere ciò di cui ha bisogno, oppure più di quanto già disponga.
A parere di Zygmunt Bauman, questa è la forma che tale morale ha assunto nella coscienza dei popoli, soprattutto a partire dalla Rivoluzione industriale; in “Le nuove povertà”, egli sostiene che ciò è accaduto a partire sin dalle prime fasi del processo di industrializzazione. Pur assumendo varie forme, lungo il tortuoso percorso della modernizzazione, l’etica del lavoro “è servita a politici, filosofi e predicatori come incitamento o giustificazione dei tentativi di sradicare, con le buone o con le cattive, un’abitudine considerata come il principale ostacolo all’avvento del mondo nuovo”; ovvero la tendenza dell’uomo a sottrarsi, quando fosse risultato possibile, all’obbligo morale che lo costringeva al “lavoro in fabbrica” e ad accettare la “docile sottomissione al ritmo di vita stabilita dai capireparto, dall’orologio e dalle macchine”. Nell’intento di rimuovere questa presunta mentalità distorta, si è svuotato di ogni contenuto un principio fondamentale dell’etica: che l’uomo sia libero di scegliere l’azione (giusta o sbagliata; buona o cattiva) per il raggiungimento dei propri obiettivi; tutt’altro, quindi, rispetto al comandamento di sottoporsi al lavoro (dipendente) per far fronte alle necessità esistenziali della persona.
In realtà, secondo Bauman, l’impegno profuso da politici, filosofi e predicatori per affermare l’etica del lavoro non è stata che una battaglia volta a fare accettare l’obbligo, da parte dell’uomo, di lavorare sotto il controllo e la subordinazione alle direttive di altri; dunque, si è trattato di una lotta (nella sostanza, se non nella forma) per obbligare i lavoratori ad accettare, “in nome della nobiltà del lavoro, una vita tutt’altro che nobile o rispondente ai loro principi di dignità morale”.
Inoltre, l’affermazione dell’etica del lavoro ha anche comportato una separazione del prodotto del lavoro dalle necessità esistenziali del lavoratore, dando priorità a “ciò che si doveva fare” rispetto a “ciò che bisognava fare, rendendo così – afferma Bauman – la soddisfazione dei bisogni dell’uomo irrilevante dal punto di vista della logica produttiva; il risultato è consistito nell’avere introdotto nell’attività produttiva il “paradosso della ‘crescita fine a se stessa’”.
L’etica del lavoro è servita a risolvere due esigenze fondamentali della nascente società industriale: da un lato, ha corrisposto al bisogno di soddisfare la domanda di lavoro a vantaggio delle attività produttive in rapido sviluppo; dall’altro lato, ha concorso a garantire condizioni di ordine sociale, suggerendo soluzioni adeguate al problema rappresentato da coloro che non “potevano reggere la dura fatica in fabbrica”. La questione riguardava, in altri termini, tutti quei “miserabili” che, indipendentemente dal fatto di non essere responsabili della propria condizione (invalidi, deboli, malati e vecchi), venivano considerati dei “vagabondi socialmente pericolosi”; la soluzione proposta è consistita nell’obbligo imposto a costoro di svolgere comunque un lavoro (qualsiasi e a qualunque costo), come unica condizione moralmente accettabile per giustificare il loro “mantenimento”. Si è potuto così sostenere che un decisivo contribuito alla riduzione della povertà andava riconosciuto all’etica del lavoro, cui si riconduceva la superiorità morale rispetto a qualsiasi tipo di vita (anche se vissuta in condizioni di indigenza e di mancanza di libertà).
Solo in una fase successiva, ad opera di riformatori impegnati a rimuovere il pericoloso fenomeno della diffusione del pauperismo, è stato affermato, a favore dei più svantaggiati, il diritto a un’assistenza gratuita, segnando l’inizio di un processo sociale che ha condotto all’avvento del capitalismo maturo. All’interno di questo, l’etica del lavoro ha svolto il compito di assicurare il continuo progresso materiale della società industriale, per la quale la collaborazione tra capitale e lavoro è divenuta tanto indispensabile da imporre alle istituzioni pubbliche la responsabilità (implicita nell’idea di una più ampia assistenza) di garantire a tutti un livello di vita tale da fare accettare senza resistenze il dovere morale di svolgere “volentieri e con entusiasmo” una qualche attività lavorativa, che di fatto era una “dura condizione”. L’etica del lavoro è valsa a fare accettare questa soluzione, considerata inevitabile per il successo della società capitalistica. E’ a questo scopo che, secondo Bauman, è stato introdotto nelle società capitalistiche avanzate il sistema del welfare State.
Tale sistema, infatti, è stato basato sull’idea che, al fine di assicurare una costante collaborazione tra capitale e lavoro, in condizione di stabilità politica, sociale ed economica, lo Stato avesse “l’obbligo di dover garantire il ‘benessere’ (welfare), e non soltanto la mera sopravvivenza, a tutti i cittadini, ovvero un’esistenza dignitosa, secondo gli standard di una data società in una determinata epoca”. Ciò ha comportato che l’assistenza pubblica fosse concepita come una forma di assicurazione collettiva “contratta dall’intera società ed estesa a ciascuno dei suoi membri”, per garantire prestazioni proporzionali alla dimensione dei bisogni individuali e non a quella “dei premi pagati dai singoli cittadini”.
Il welfare State ha avuto inizialmente un “ambiguo rapporto” con l’etica del lavoro, in quanto esso non ha avuto subito un’applicazione universale, a causa della mancanza di un’occupazione permanente per tutti. Per il raggiungimento della sua universalità è stato necessario estendere l’assistenza pubblica anche a chi fosse “rimasto indietro”. Affinché il welfare State potesse conservare all’etica del lavoro la sua “forza”, è stato necessario estendere l’assistenza pubblica a tutti i cittadini, indipendentemente dal loro contributo alla ricchezza comune; in tal modo, però, è stato incrinato il presupposto fondamentale dell’etica del lavoro, rendendo il diritto all’assistenza pubblica “una questione di cittadinanza politica, anziché di prestazione economica”.
Gli impulsi da cui ha tratto origine il welfare State universale sono stati talmente efficaci “da fare apparire – afferma Bauman – i suoi meccanismi di funzionamento come un fenomeno del tutto normale della vita sociale, al pari delle istituzioni democratiche”, inducendo l’opinione pubblica a considerarlo un’istituzione irreversibile, il cui “smantellamento avrebbe comportato l’abolizione delle democrazia e dei sindacati”, modificando il ruolo svolto dal sistema dei partiti. Ma, a partire dalla fine degli anni Settanta del secolo scorso, quello che prima era considerato impensabile ha cessato di esserlo, e “l’dea di un’economia capitalistica senza una rete di protezione sociale”, è divenuta nei Paesi economicamente più avanzati, una realtà. Nella legittimazione di questo rovesciamento ha concorso ancora una volta l’etica del lavoro.
L’estensione del sistema di welfare State nei Paesi capitalistici più industrializzati è stato la risultante di diverse “spinte” sociali, originate tutte dall’etica del lavoro nella forma maturata con lo sviluppo della società industriale; la sua durata è spiegabile sulla base della “funzione pacificatrice” che il sistema ha svolto, “inducendo i lavoratori ad accettare le regole stabilite dai capitalisti” a un costo inferiore rispetto a quello che un’etica del lavoro basata soltanto su misure coercitive non avrebbe mai potuto garantire.
La successiva “caduta” del welfare non è stata la conseguenza di un semplice cambiamento ideologico. Per una spiegazione convincente – a parere di Bauman – è necessario chiedersi perché la crisi del welfare si sia verificata in modo così rapido e improvviso; partendo dall’assunto che di essa non possa essere data una spiegazione esauriente, imputandola al sopravvento dell’ideologia neoliberista, la vera causa costituisce piuttosto un fenomeno “da interpretare”.
Tra le funzioni svolte dal welfare, quella di fornire una continua offerta di lavoro professionalizzata è risultata di fondamentale importanza; tuttavia, a partire dalla fine degli anni Settanta del secolo scorso, questa funzione si è notevolmente affievolita e, per alcuni settori del sistema produttivo, si è totalmente estinta. Sin tanto che la crescita e lo sviluppo della società industriale dipendevano dalla disponibilità di forza lavoro qualificata, le attività produttive fruivano del fatto che fosse lo Stato a provvedere alla formazione della forza lavoro; per quanto onerosi risultassero dal punto di vista fiscale i servizi sociali forniti dal welfare, il contributo delle attività produttive alla copertura della spesa pubblica per l’attività formativa veniva considerato conveniente; ma, dopo l’avvento della globalizzazione”, il progresso scientifico e il miglioramento delle tecnologie produttive, la convenienza delle imprese a disporre di forza lavora professionalmente formata dallo Stato è venuta meno.
In tal modo, l’interesse che stava alla base del sistema di welfare ha minato le sue stesse fondamenta; non considerando conveniente sovvenzionare la riproduzione della forza lavoro, le imprese, attraverso l’automazione dei processi produttivi, hanno teso ad approfondirsi capitalisticamente, a spese dei livelli occupazionali. Cosi, i governi, costantemente impegnati a evitare il contrasto tra capitale e lavoro, hanno dovuto affrontare l’aumento dei livelli dell’assistenza pubblica, divenuta sempre più insopportabile per lo stabile funzionamento del sistema produttivo.
Verso la fine del XX secolo, sostiene Bauman, l’etica del lavoro è tornata a svolgere l’originaria funzione, sia riguardo alla diagnosi dei “mali” dai quali le economie moderne erano afflitte, sia riguardo alle terapie necessarie per “curarli”, giustificando (ancor più rispetto al passato) il finanziamento di programmi per l’inserimento nella vita lavorativa dei poveri e di chi aveva perso il posto di lavoro, nonostante la dimostrazione storica dell’inutilità di tali programmi. Il motivo della persistenza nel finanziare questi programmi, continua Bauman, non era più rinvenibile “nei loro salutari effetti” sui livelli occupazionali, ma nell’evidente utilità che poteva essere tratta sul piano della sicurezza sociale da coloro che non erano poveri o privi delle risorse necessarie per la sopravvivenza.
Il termine disoccupazione, usato in passato per designare chi era senza lavoro, racchiudeva in sé il presupposto che la forza lavoro dovesse essere sempre occupata, ma dalla fine del secolo scorso nessuna fase successiva ad ogni ristrutturazione delle attività produttive ha portato i livelli occupativi ai livelli precedenti. In questo modo, il termine disoccupazione è stato sostituito da quello di “esubero”, che ha escluso a priori, chi era nella condizione di esubero da ogni possibilità d’essere inserito nel mondo del lavoro.
Con l’economia moderna, crescita economica e aumento dell’occupazione sono diventati antitetici, per via del fatto che il progresso tecnico, sul quale si basa l’aumento della produttività e della crescita, è stato reso possibile dalla riduzione o eliminazione di quote crescenti di posti di lavoro; perciò, la riproposizione dell’etica del lavoro, osserva Bauman, serve ora a “giustificare l’eterna presenza dei poveri e dei disoccupati strutturali e a consentire alla società di vivere più o meno in pace con se stessa”, senza porsi il problema della continua crescita del numero dei poveri. In altre parole, oggi l’etica del lavoro serve a screditare la dipendenza dell’uomo da altri, per cui la “tendenza ad elevarla a sistema, rimproverata al welfare State” è divenuta ora “uno dei principali argomenti a favore del suo smantellamento”. Denigrando la dipendenza dei poveri, qualificandola come “vizio”, l’etica del lavoro, nella sua versione attuale, serve solo a sgravare “i ricchi dal peso dei loro scrupoli morali”.
A parere di Bauman, un possibile modo di uscire dalle modalità di funzionamento di un’organizzazione sociale che considera “normale” la presenza costante nella società di poveri e di “senza lavoro” consiste nell’istituzionalizzazione di un sistema di supporto della vita dell’uomo (quando afflitta dalla povertà e dalla disoccupazione), basato non più su un salario, come vorrebbe l’etica del lavoro del passato, bensì sull’erogazione di un “reddito sociale”, che Bauman chiama “reddito minimo garantito sufficiente ad assicurare il rispetto della dignità umana”, considerato dissociato dall’obbligo di una qualche prestazione produttiva.
Bauman non va oltre ma se si considera che la logica di funzionamento delle moderne economie capitalistiche lascia intravedere una crescita continua dei poveri e dei senza lavoro, il reddito minimo garantito baumaniano, dissociato dal mercato e dalla volontà (divenuta impossibile) di inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro da parte di chi lo riceve, non può che assumere il significato di reddito di cittadiananza universale e incondizionato. Si può pensare di poter finanziare questa “nuova forma” di sistema di sicurezza sociale attraverso la leva fiscale o attraverso il cambiamento delle regole che oggi sottostanno alla logica distributiva del prodotto sociale. Se il sistema di sicurezza sociale fosse ristrutturato secondo tali linee riformatrici, i principi di libertà, di uguaglianza e di fraternità, propri della Stato sociale di diritto, potrebbero essere espressi dalla sostituzione dell’etica del lavoro (divenuta obsoleta e superata) con l’etica dell’operosità.
Ciò, tra l’altro, consentirebbe, come auspica Bauman, di rimuovere il convincimento collettivo che la corresponsione di un reddito dissociato dalla logica economica tradizionale significhi solo incentivare l’ozio; inoltre, grazie anche all’etica dell’operosità, quando fosse opportunamente “promossa” sul piano politico e culturale, si consentirebbe all’uomo di acquisire, attraverso la costituzione e la conduzione di attività autodirette (rese possibili anche dall’introduzione del reddito sociale universale e incondizionato) la dignità negatagli invece dall’etica del lavoro, che ha sorretto il funzionamento del sistema del welfare State delle moderne società capitalistiche.
A chi insistesse ancora nel considerare impossibile la riforma del sistema di sicurezza sociale secondo le linee indicate, si può rispondere, con Bauman, che invece è possibile; allo stesso modo in cui si è potuto realizzare la riforma, ugualmente ritenuta impossibile, attuata all’inizio della seconda metà del secolo scorso, che ha consentito l’accordo tra capitale e lavoro, permettendo di realizzare un miglioramento delle condizioni di vita delle società capitalistiche mai sperimentato nel passato.
* Anche su Avanti! online.
———————————————————————————
Oggi venerdì 2 novembre 2018

![]()







![]()
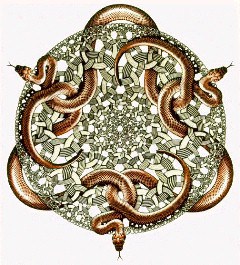

———-Avvenimenti&Dibattiti&Commenti——————————————-
Omicidi e droga in Sardegna
di Ottavio Olita su il manifesto sardo.
——————————————————————
 Mazzini: un preveggente inascoltato
Mazzini: un preveggente inascoltato
2 Novembre 2018
Gianfranco Sabattini su Democraziaoggi
——————————————————————————————————————-
COMMENTI. Redistribuire la ricchezza senza disturbare il manovratore
Manovra. Un vero programma di cambiamento, come si dice oggi, imporrebbe la predisposizione di strumenti non solo per la redistribuzione della ricchezza prodotta e accumulata, ma anche per la redistribuzione del lavoro, del tempo di lavoro, delle modifiche profonde alla vita lavorativa
Francesco Indovina su il manifesto- Articolo ripreso da Aladinews. (…) I punti di forza, nell’ambito che qui interessa, sono la quota 100 per le pensioni e il reddito di cittadinanza. Due provvedimenti allo stato dei fatti necessari, e mi azzardo a dire di un riformismo di sinistra, ma per come realizzati, di destra. Perché non mettono in moto un redistribuzione della ricchezza, ma fanno aumentare il debito pubblico, non gravano sui detentori della ricchezza accumulata, ma graveranno sulle generazioni future. Che poi i meccanismi e le regole della Ue faranno in modo che questo debito aumenti anche perché i “mercati” (composti nel caso specifico anche da quelli sui quali non si è voluto intervenire) non si fidano della solidità del paese, dipende anche dall’incapacità di questo governo.(…).
EDIZIONE DEL 02.11.2018 [segue]

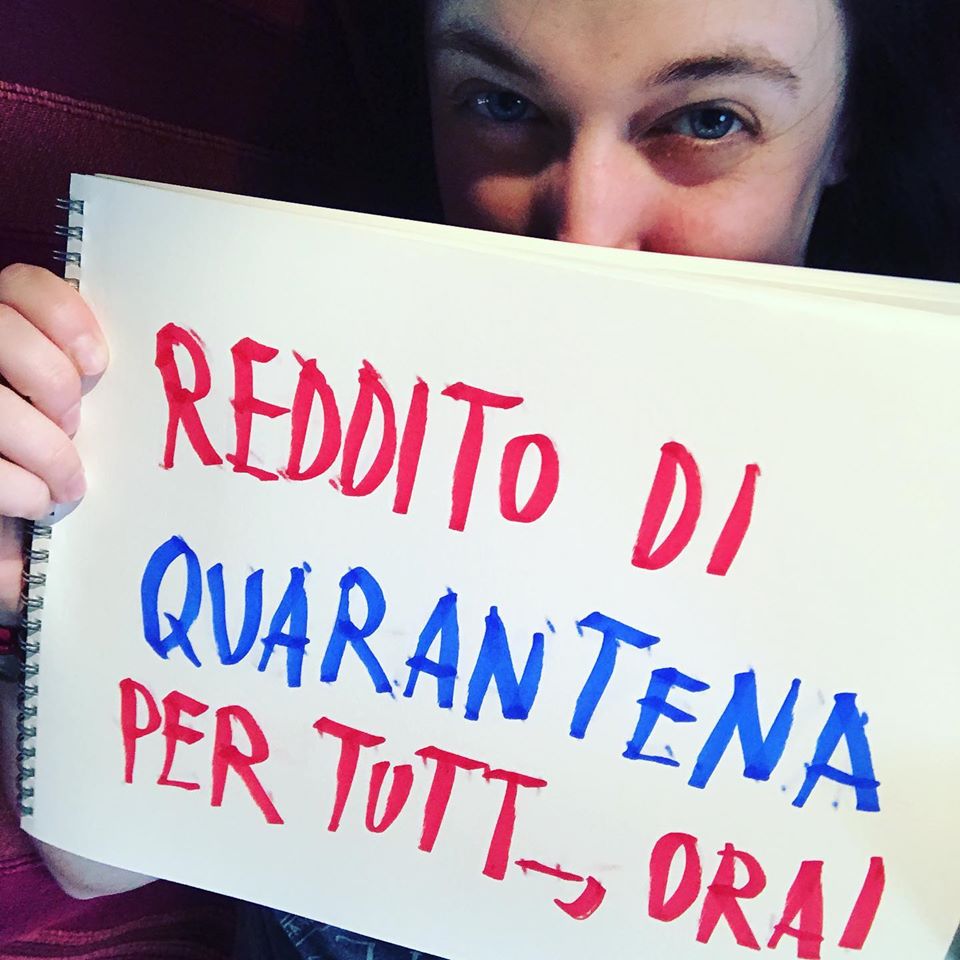













 AService Studio
AService Studio