Monthly Archives: ottobre 2018
Documentazione

 Da Giuliano Angotzi
Da Giuliano Angotzi
Vi segnalo la pagina web FAO http://www.fao.org/migration/en/ dedicata ai rapporti tra migrazione da una parte e agricoltura e sviluppo rurale dall’altra. Inoltre, un rapporto dedicato a migrazione, agricoltura e cambiamento climatico http://www.fao.org/3/I8297EN/i8297en.pdf e un altro, più corposo, dedicato ai rapporti tra migrazione, agricoltura e sicurezza alimentare http://www.fao.org/3/CA0922EN/CA0922EN.pdf.
Oggi seconda giornata di Connessioni2018

 Oggi sabato 27 ottobre 2018
Oggi sabato 27 ottobre 2018
- 09.00 Registrazione delle associazioni partecipanti alla fiera delle associazioni;
- 10.00 Introduzione ai lavori. “Approfondimento sul quadro normativo del III settore” a cura di Marco Livia, responsabile tecnico ACLI Nazionali – Dipartimento Terzo Settore;
- 10.30 Fiera delle Associazioni;
- 15.00 “I valori europei: sfide e cambiamenti”, a cura dell’Associazione Interculturale NUR; partecipa Andrea Murgia;
- 18.30 “I libri aiutano a leggere il mondo” incontra “Connessioni” e Il “Festival Transistor”- “Mi sono sentito felice camminando sulla terra”, incontro con Folco Terzani e Giacomo Mameli.
———————————————–
Pane nostro
Nel dolore del mondo
 “NON C’È PIÙ NÉ GIUDEO NÉ GRECO”
“NON C’È PIÙ NÉ GIUDEO NÉ GRECO”
La cultura della diseguaglianza ha radici antiche, viene dalla filosofia classica e dalla conquista dell’America, solo nel Novecento è stata ripudiata, ed ora ritorna. La costruzione dell’unità umana è la principale tra le attuali urgenze messianiche
Raniero La Valle*
Cari Amici,
vi potrà stupire che ci sia una citazione biblica (Gal. 3, 28) come titolo di questo mio intervento, quando né le citazioni bibliche né il cristianesimo sembrano oggi molto di moda, e anzi si sta cercando di dare una spallata per abbatterli.
Però a ben vedere anche il titolo di questa vostra Festa multiculturale è una citazione biblica, “Pane nostro”, anzi è addirittura una citazione del “Padre nostro”. E in sostanza le due citazioni vogliono dire la stessa cosa: e cioè che non c’è nulla di nostro, nemmeno il pane, che non sia anche degli altri, che non sia un nostro di tutti. E se non c’è né Giudeo né Greco è perché non c’è un mondo di soli cittadini e non anche di stranieri, non c’è da una parte un’Europa comunitaria e dall’altra un mondo barbarico di extracomunitari, non c’è un’Italia di residenti che non sia anche un’Italia di immigrati, di fuggiaschi e di nomadi.
Questa è la tesi del nostro discorso. Ma perché cominciare proprio dal mettere insieme Giudei e Greci? Per la buona ragione che nella nostra società non c’è più posto per l’antisemitismo. È vero che per arrivarci ci sono voluti milioni di morti, ma ormai su questo, a parte i negazionisti e gli accecati, sono tutti d’accordo. Allora è bene partire da una posizione da tutti condivisa, per affermarne un’altra altrettanto sacrosanta, e cioè che come non c’è Giudeo e Greco, così non c’è Italiano e Straniero; e questa affermazione è invece oggi fieramente contestata, quando si dice “prima gli Italiani” o addirittura “solo gli Italiani”, come si dice “prima l’America” o “la Francia per prima”. L’altra sera in TV la signora Santanchè diceva che i migranti devono essere respinti in quanto delinquenti, e anche sotto questo profilo doveva valere il motto “prima gli Italiani”, anzi in questo caso il messaggio era “solo gli Italiani, vogliamo solo i delinquenti italiani”; e questi ce li dobbiamo tenere almeno fino a quando non si riuscirà a togliere la cittadinanza anche a loro, come prevede il decreto sicurezza del ministro Salvini.
Allora qui bisogna sapere che è in gioco una grande questione, che ha attraversato tutta la storia, e su cui si decide tutto il nostro futuro: è la questione della diseguaglianza.
La storia della diseguaglianza
Dire non c’è più Giudeo né Greco, come dissero Paolo e il cristianesimo nascente, era una rivoluzione epocale anzitutto perché gli stessi Ebrei sostenevano una differenza invalicabile tra sé e gli stranieri, che non potevano neanche entrare nel recinto del Tempio, gli uni essendo eletti gli altri dannati; ma era una novità straordinaria anche perché il pensiero della diseguaglianza dominava non solo l’immaginario religioso, ma tutta la cultura dell’umanità, e non solo nel sentire comune e nell’opinione del volgo, ma ai livelli più alti della filosofia e del pensiero. Quella che dominava era infatti l’antropologia di Aristotele che divideva la società in signori e servi, e i servi erano tali per natura, “naturaliter servi”, come traducevano i latini. Questa diseguaglianza non dipendeva da contingenti condizioni economiche e sociali, ma era una diseguaglianza originaria; in termini colti si potrebbe dire una diseguaglianza ontologica, per essenza, e quindi umanamente irrimediabile. È la stessa cosa che valeva e vale ancora oggi per le caste in India, per cui mai lì si potrà passare dalla casta dei mercanti o dei servi alla casta dei guerrieri o dei brahamani: l’unica possibilità di cambiare casta è di morire e ricominciare un’altra vita. E non parliamo poi dei dalit, o intoccabili e “fuori casta”, con cui le caste superiori non devono nemmeno venire in contatto; anzi per la strada essi devono camminare al centro per non offuscare con la loro ombra le mura delle case delle caste alte.
In Occidente Aristotele spiegava che come per natura si uniscono maschio e femmina per la riproduzione, così deve esserci “chi per natura comanda e chi è comandato al fine della conservazione” (“Politica”, libro I), e questo rapporto di dominio si fondava su una diseguaglianza originaria, per cui si nasce liberi o schiavi, maschio e femmina, “l’uno per natura superiore, l’altra inferiore, l’uno comanda, l’altra è comandata”, e da qui scendevano a cascata le altre diseguaglianze, sociali, di classe ed etniche, per cui erano contrapposti padroni e servi, liberi dal lavoro e costretti ai lavori necessari, cittadini e non cittadini, greci e barbari, nativi e meteci (che erano poi i meticci, gli immigrati).
Fu perciò una grande rivoluzione religiosa e antropologica che Gesù, in nome di Dio Padre nostro, padre di tutti, rompesse il muro di separazione tra Giudei e Greci, tra Ebrei e Gentili e affermasse la radicale eguaglianza di tutti gli esseri umani, fino a dire con Paolo non solo che non c’è più né Giudeo né Greco, ma non c’è più maschio e femmina, non c’è Barbaro o Scita, schiavo e libero, e non c’è più circoncisione e in circoncisione (Col. 3, 11): e questo voleva dire abrogare quella divisione tra eletti e scartati che, secondo le Scritture ebraiche era addirittura di diritto divino, tanto da essere poi per sempre impressa nella carne dei membri del popolo eletto mediante la circoncisione.
Ora questa radicale unità ed eguaglianza di tutti gli uomini e le donne che Gesù ha affermato e realizzato attraverso la croce veniva ad adempiere quelle promesse messianiche, che già nell’Antico Testamento avevano prefigurato l’unità di tutte le famiglie della terra; basta pensare alla profezia di Isaia (Is. 2, 4) che annunciava che dalle loro spade fabbricheranno vomeri, dalle loro lance falci, nessuna nazione alzerà più la spada contro l’altra e non impareranno più l’arte della guerra (perché la guerra non è in natura, non si nasce “imparati” alla guerra, è un artificio, un prodotto della cultura, bisogna impararla) o la profezia di Michea che annunciava che potranno sedersi ciascuno tranquillo sotto la sua vite e sotto il suo fico senza nessuno che li spaventi, e addirittura che tutti i popoli avrebbero camminato insieme ognuno nel nome del suo Dio (Mich. 4, 4-5): cioè tutte le discriminazioni sarebbero cadute, mentre tutte le identità sarebbero state salvate. La novità del Cristo, che poi significa Messia, portava cioè quel cambiamento radicale che doveva segnare il passaggio dall’età della profezia, dell’annuncio, a quella della realizzazione delle promesse messianiche.
Purtroppo però questa antropologia nuova non è entrata di fatto nella storia successiva, e nemmeno, se non con molta fatica, nello stesso cristianesimo. È vero che, come dice la seconda lettera di Pietro un giorno è come mille anni e mille anni come un giorno al cospetto di Dio (2Pt 3,8), ma fatto sta che il pensiero della diseguaglianza ha continuato a dominare la storia. Ed è stata questa cultura della diseguaglianza che ha fondato e legittimato le società signorili e feudali, e innumerevoli forme storiche concrete di società inegualitarie, castali, razziste, sessiste e classiste.
La conquista dell’America
Per venire a tempi più recenti, possiamo dire che questa cultura della diseguaglianza è all’opera e produce il massimo della sua capacità discriminatoria agli albori della modernità, quando, con la conquista dell’America, gli europei si imbattono negli Indios, e parte la grande vicenda della colonizzazione. Nel 1500 si ricorre infatti all’antropologia di Aristotele, per dire che vi sono uomini e collettività che non essendo per limiti innati dotati di ragione sufficiente, sono incapaci di essere liberi e padroni di se stessi e quindi giustamente assoggettati dagli Spagnoli. È la tesi che Francisco De Vitoria confuterà nella sua famosa Relectio de Indis: ma intanto gli Indios vengono assoggettati e questo pensiero della diseguaglianza arriverà fino ad Hegel, a Croce, a De Gobineau e ai razzismi del Novecento europeo.
È proprio a partire dalla conquista dell’America che si sviluppa infatti nella filosofia dell’Occidente la concezione che teorizza una diseguaglianza per natura tra gli esseri umani, come dirà apoditticamente il grande dizionario Larousse alla fine del XIX secolo: “Nul ne contestera que la race blanche ne soit superieure à toutes les autres”. L’idea antica che tra gli esseri umani ci fossero i superiori e gli inferiori, i perfetti e i malriusciti, trova nella percezione europea degli Indios “scoperti” o incontrati in America la conferma irrefutabile. Se ci sono uomini e meno uomini, gli Indios ne forniscono la prova. Comincia Colombo, che non riconosce “l’altro” (come ha mostrato Cvetan Todorov in «La conquista dell’America: il problema dell’”altro”») non riconosce colui che a suo parere non “sa parlare” (in verità non sa parlare lo spagnolo), e poi c’è il conquistatore Francisco Pizarro che ha ben ragione di sentirsi superiore dal momento che con soli 168 soldati riesce a prevalere su un esercito di 80.000 uomini, e prende prigioniero Atahualpa, il re degli Inca, nella città andina di Cajamarca, uccidendo settemila Indios (ma la verità è che aveva i cavalli, non ancora domesticati nel continente americano, e perciò aveva la cavalleria, e i fucili e l’acciaio delle corazze e delle spade e delle lance, ancora ignoti agli indiani che combattevano potendo ferire, ma non uccidere); e poi c’è Hernan Cortés, che impone con la violenza il meticciato facendo sposare agli spagnoli le più belle indiane e sposando lui stesso una principessa indiana, la Malinche, che poi naturalmente ripudia, per popolare le terre conquistate con una razza nuova, non più di indigeni, ma di mestizos, cioè di indiani spagnolizzati. Ci penserà poi la teologia di Juàn de Sepùlveda a suggellare l’inferiorità degli Indios, ma purtroppo questa teorizzazione della diseguaglianza non resta isolata, si pianta nella cultura europea fino ad essere espressa nel punto più alto della filosofia occidentale, cioè nell’opera di Hegel. Il grande filosofo tedesco ha delle pagine terribili sulla presunta inferiorità degli Indios. “Dal tempo in cui gli Europei sono approdati in America, gli indigeni sono scomparsi a poco a poco, al soffio dell’attività europea”, dice nelle “Lezioni sulla filosofia della storia”, e lo spiega così: “Della civiltà americana quale si era venuta evolvendo specialmente nel Messico e nel Perù… sappiamo solo che essa era del tutto naturale, e che doveva quindi scomparire al primo contatto con lo spirito”. Ma lo scarto tra lo spirito e la natura è anche uno scarto nella stessa natura; la scomparsa degli indigeni dipende dunque per Hegel “dall’inferiorità di questi individui sotto ogni aspetto, perfino quanto a statura”.
Nel rievocare queste pagine, il filosofo del diritto Luigi Ferrajoli sottolinea come esse abbiano fatto scuola, fino a Croce. Anche il patriarca della cultura italiana adotta infatti il criterio storiografico di un’opposizione tra popoli della natura e popoli dello spirito, e scrive: “Gli uomini si distinguono tra uomini che appartengono alla storia e uomini della natura, uomini capaci di svolgimento e uomini di ciò incapaci; e verso la seconda classe di esseri, che zoologicamente e non storicamente sono uomini, si esercita, come verso gli animali, il dominio, e si cerca di addomesticarli e di addestrarli, e in certi casi, quando altro non si può, si lascia che vivano ai margini… lasciando che di essa si estingua la stirpe, come accadde di quelle razze americane che si ritiravano e morivano (secondo l’immagine che piacque) dinanzi alla civiltà da loro insopportabile”[1].
E che la soluzione migliore per gli Indiani fosse lo sterminio, è stato teorizzato da eminenti studiosi. Nel 1782 a Pittsburgh il giurista e letterato H. Henry Brackenridge così si esprime a proposito degli Indiani: “Essi hanno l’aspetto umano e forse fanno parte della specie umana”; ma “la natura dell’indiano è feroce e crudele… Il loro sterminio sarebbe utile al mondo e onorevole per coloro che vi provvederanno”.
Ma purtroppo l’Indio è solo un prototipo; infatti la diseguaglianza teorizzata per loro riguarderà poi i neri, gli ebrei ed ogni altra categoria di diversi. Locke, all’inizio della rivoluzione industriale, assimilerà agli Indios i proletari: “un manovale non è in grado di ragionare meglio di un indigeno”. E Spencer, il promotore ottocentesco della società dell’utile, applicando alla sociologia e alla società la teoria darwiniana dell’evoluzione, scriverà nel suo “Sistema di filosofia sintetica”: Tutti gli uomini sono come sottoposti a un giudizio di Dio, “se sono realmente in grado di vivere, essi vivono, ed è giusto che vivano. Se non sono realmente in grado di vivere, essi muoiono, ed è giusto che muoiano”.
Il punto d’arrivo di questa linea di pensiero è Nietzsche, il vero teorico della società della selezione. Per Nietzsche non si può parlare di uomini “eguali”: questa è l’illusione dei deboli. In diversi punti delle sue opere Nietzsche mette sotto accusa l’eguaglianza, intesa come una grande follia. “Così parla a me la giustizia: gli uomini non sono tutti eguali. E neppure devono diventarlo!” (Zarathustra); l’eguaglianza “è volontà di negazione della vita, principio di dissoluzione e di decadenza” (Al di là del bene e del male). Di qui gli effetti, le conseguenze e gli scopi dell’eguaglianza: trasformare l’umanità in sabbia: tutti molto eguali, molto piccoli, molto tollerabili, molto noiosi”); essa porta a un “guazzabuglio sociale”, a una degenerazione della razza a … sopprimere “la selezione” e rovinare la specie (Frammenti postumi). Il razzismo ha pertanto la sua copertura filosofica. Da tutto questo veniamo, altro che Salvini!
La svolta
Ma a un certo punto c’è una svolta epocale. La svolta arriva dopo i genocidi del Novecento, quello degli Armeni prima, e quello degli Ebrei poi, e arriva dopo quella tragedia della volontà di potenza che era stata la seconda guerra mondiale. L’umanità capisce il suo lungo errore, decide di cambiare pagina: sull’eguaglianza di tutti gli uomini e le donne e di tutte le Nazioni grandi e piccole è fondata l’ONU, viene messa fuori legge la guerra, il principio di eguaglianza è assunto come irrevocabile nella Costituzione italiana e nel costituzionalismo postbellico. Sembrava davvero l’inizio della realizzazione delle promesse messianiche. Invece è arrivata la guerra fredda, il terrore atomico, il riarmo nucleare; e quando i blocchi sono caduti e il comunismo è finito, il capitalismo, che era stato messo sotto scacco dalle politiche comuniste, socialdemocratiche, keynesiane e dalle stesse Costituzioni, ha preso la sua rivincita e ha potuto prendere il dominio del mondo nelle forme della globalizzazione. A questo punto la diseguaglianza è tornata a dominare la politica, l’economia e la finanza, e si è aperto il baratro di quella che papa Francesco chiama oggi la società dello scarto.
La società dello scarto
La nuova società dello scarto, che mette fuori gioco i non scelti, i non salvati, gli esuberi, i senza casa e i senza lavoro, è peggiore della vecchia società dello sfruttamento; lo ha spiegato il papa nella “Evangelii Gaudium” e lo ha ribadito nella recentissima intervista al Sole 24 ore (7 settembre 2018): “non si tratta semplicemente del fenomeno conosciuto come azione di sfruttamento e oppressione, ma di un vero e proprio fenomeno nuovo. Con l’azione dell’esclusione colpiamo nella sua stessa radice i legami di appartenenza alla società a cui apparteniamo dal momento che in essa non si viene semplicemente relegati negli scantinati dell’esistenza, nelle periferie, non veniamo privati di ogni potere, bensì veniamo sbattuti fuori. Chi viene escluso non è sfruttato, ma completamente rifiutato, cioè considerato spazzatura, avanzo, quindi spinto fuori della società. Non possiamo ignorare che un’economia così strutturata uccide perché mette al centro e obbedisce solo al denaro: quando la persona non è più al centro, quando fare soldi diventa l’obiettivo primario e unico, siamo al di fuori dell’etica e si costruiscono strutture di povertà schiavitù e di scarti”.
E noi possiamo aggiungere che mentre gli sfruttati almeno potevano lottare per riscattarsi, gli scartati non possono nemmeno lottare perché di fatto “non ci sono”. Non ci sono.
Il popolo dei migranti
Allo stesso modo non ci sono, non ci devono essere i migranti.
Lo scarto dei migranti rivela tutto il suo orrore in agghiaccianti statistiche. Nel 2016 cinquemila sono stati i morti nel Mediterraneo, in media 14 al giorno: è la cifra più alta perché nel 2015 i morti erano stati 3771, mentre nel 2017 le vittime sono state 3081.
Nel 2017 ci sono stati 68 milioni e cinquecentomila persone vaganti e costrette alle fuga. I richiedenti asilo che all’inizio dell’anno scorso erano in attesa di una decisione sulla loro richiesta di protezione erano 3 milioni centomila. La maggior parte delle persone in fuga sono giovani, nel 53 per cento dei casi sono minori, molti dei quali non accompagnati o separati dalle loro famiglie. Entro il 2050 si prevede che ci saranno nel mondo 250 milioni di migranti ambientali ed esuli che fuggono da guerre e repressioni.
Però un discorso sui migranti non si può fare sui numeri. Le persone non sono numeri. I 150 naufraghi che il governo italiano si è rifiutato per giorni e giorni di far sbarcare a Catania dalla motonave Diciotti rappresentano una tragedia morale e politica più grave rispetto ai 3000 naufraghi scomparsi in mare senza che nessuno potesse dar loro soccorso.
Tuttavia i numeri che riguardano i migranti sono importanti perché sono i numeri di un fenomeno che segnala e e nello stesso tempo produce un passaggio d’epoca. Le grandi migrazioni in corso ci dicono che stiamo passando da una a un’altra età del mondo, che siamo nel pieno di una discontinuità storica. È come se stessimo scoprendo un’altra volta che la terra è tonda, e tutto dipende da come vi reagiremo, così come tutto dipese da come si reagì alla scoperta dell’America.
Il rischio è che noi vi rispondiamo con un naufragio: ma non solo il naufragio dei profughi, ma il nostro naufragio. E il vero naufragio consiste nel ricadere in quella notte oscura da cui l’Europa e il mondo erano usciti alla fine della seconda guerra mondiale, quando decisero che mai più avrebbe dovuto esserci un genocidio. Per questo il primo atto delle Nazioni che si erano unite nella guerra antifascista e che come Nazioni Unite si incontrarono a San Francisco per dare inizio a un mondo nuovo, fu la Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio. Ma siccome non c’era stato solo il genocidio degli Ebrei, nella Convenzione si ebbe cura di affermare che si intendeva per genocidio non solo lo sterminio di un popolo intero, ma ogni atto volto “a distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale”; dunque il popolo che la Convenzione intende tutelare è ogni gruppo umano accomunato da fattori e circostanze che fortemente lo identificano; e tra gli atti sanzionati per tale crimine vengono esplicitati le lesioni gravi all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo, la sottoposizione del gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale, le misure miranti a impedire nascite all’interno del gruppo.
Se ora applichiamo tali criteri alla specifica condizione umana dei migranti, vediamo come anch’essi siano un popolo, un popolo in cammino, di uomini e donne che in gruppi ed aggregazioni le più diverse, insieme affrontano il mare o le rotte terrestri per andare da un Paese all’altro, tutti muovendosi con le stesse motivazioni e condividendo lo stesso destino; ed è questo popolo come tale, nelle sue diverse espressioni, che l’Occidente e molti Paesi d’arrivo respingono e perseguono per la sola e comune ragione che si tratta di un popolo di migranti; si tratta cioè di aggregati umani che le politiche e gli ordinamenti di questi Stati negano nel loro stesso diritto di esistere, di avere una cittadinanza, di essere ricompresi nelle regole del diritto; e proprio come è vietato nella Convenzione dell’ONU, i membri di questi gruppi sono esposti a lesioni gravi della loro integrità fisica e mentale, e i gruppi stessi sono sottoposti a condizioni che di fatto li distruggono in modo totale o parziale, le donne sono messe in condizioni per cui sono impedite le nascite, e spesso i fanciulli sono separati dal gruppo e forzatamente inclusi in un altro.
Ora possiamo dire che riguardo al popolo dei migranti l’illusione di difendersi, come fanno l’Europa e l’Italia di Minniti e di Salvini, scartando pezzi di mondo è particolarmente infelice, perché il rifiuto di accogliere migranti e profughi li rende clandestini, li trasforma in rei non di un fare, ma di un esistere. La conseguenza è che gli stessi Stati di diritto e di democrazia costituzionale tradiscono se stessi perché accanto ai cittadini soggetti di diritto concentrano masse di persone illegali, giuridicamente invisibili e perciò esposte a qualunque vessazione e sfruttamento, pur avendo tutti non solo lo stesso suolo che li accoglie ma lo stesso sangue umano che li nutre.
Gli altri problemi critici
E non ci sono solo gli scarti e i migranti, ci sono altri problemi critici, da cui veramente dipende il futuro del mondo: il ripristino della sovranità della guerra, la manipolazione genetica dell’uomo, la precarietà eretta a sistema, la crisi ecologica, tutte cose di cui non possiamo parlare ora.
Per tutte queste ragioni noi siamo in uno stato di sofferenza. E io penso che questa sofferenza abbia una qualità nuova. Per definirla potremmo chiamarla sofferenza messianica, perché tale è la sofferenza che si fa carico della sofferenza del mondo e perché sa che c’è in gioco l’avverarsi o il fallire di quella promessa di salvezza che dai tempi antichi fino ad oggi ha accompagnato e lenito l’arduo cammino dell’umanità: quella promessa messianica che è poi diventata l’annunzio cristiano, dato che Cristo e messia non sono che lo stesso nome pronunziato in due lingue diverse.
Perciò è lecito chiedersi se il cristianesimo c’entri quando noi ci domandiamo quale esito potrà avere l’attuale crisi epocale e che cosa noi possiamo sperare: sapendo che si può sperare solo ciò che si contribuisce a far accadere agendo.
E dobbiamo cominciare col chiederci, come fece il Concilio, quali sono “i problemi più urgenti”, tanto urgenti che potremmo prenderli come delle vere e proprie “urgenze messianiche”. Si tratta di problemi che mai nella storia si sono presentati con eguale gravità. Essi possono essere affrontati non da ciascuno da solo, ma dall’umanità tutta intera, uomini e donne, purché essa si riconosca nell’eguaglianza come una sola famiglia umana. Le risposte che si devono dare a queste situazioni di emergenza non sono infatti delle piccole risposte riformiste o populiste, oggi del tutto insufficienti, ma sono risposte che realizzino il passaggio da una fase infantile a una fase nuova, non “postmoderna” ma semplicemente adulta, della storia dell’umanità.
Io individuerei per ora sei di queste urgenze, sei grandi novità che ci sfidano a cui dobbiamo dare risposta.
Le novità sono le seguenti:
1) Non era mai successo che i banchieri di tutto il mondo fossero uniti e i poveri invece divisi.
2) Non era mai successo che si progettassero guerre in cui si muore da una parte sola. La tecnologia lo fa credere possibile, arma i droni, rende asimmetriche tutte le guerre, ne sopprime l’ultima razionalità.
3) Non era mai successo che il naufrago potesse erompere nel grido: “Terra! Terra!”, ma le terre gli fossero negate e gli si chiudessero i porti in faccia.
4) Non era mai successo che dire “uomini” non fosse la stessa cosa che dire: “nati da donna”. Non è più veramente necessario che siano due in una carne sola, non solo gli sposi, ma i due generi umani. Il sistema non si cura che siano maschio e femmina, gli interessa che siano eguali nel comprare e nel vendere. “Non c’è più né uomo né donna” doveva essere un’addizione, un elevare 1 al quadrato, non una sottrazione dell’altra, non che si perdesse la “loro differenza benedetta” (papa Francesco). Le donne l’hanno rivendicata, ma l’uomo globale è più maschilista di quello tribale, la donna neanche la distingue. Si può generare senza la donna, forse anche senza il suo utero. Allora non si potrà più dire: “Nel ventre tuo si riaccese l’amore” (Dante). Cessa la simbologia di Dio che “ha viscere di misericordia” (Salmo 103, 13). L’intelligenza artificiale è asessuata. Nemmeno il padre di Pinocchio voleva fare il suo burattino né maschio né femmina.
5) Non era mai successo che ai giovani fosse perfino impossibile immaginare un futuro.
6) Non era mai successo, se non nei Paesi bassi, che col caldo saltasse il chiavistello delle acque e il mare venisse su più alto delle città e della terra.
Si può fare solo un sommario delle risposte che si dovrebbero cercare
1) Che sovrano non sia il denaro ma tornino o giungano ad esserlo le persone ed i popoli.
2) Che la guerra esca da tutte le ragioni, anche dalla ragion di Stato, e perciò dalla storia.
3) Che la libertà rinasca dal mare e non ci siano più porti chiusi muri e frontiere sulla terra.
4) Che l’uomo gioisca di essere maschio e femmina con un’intelligenza di carne in una sola umanità di ogni lingua e colore, un solo Padre e molte fedi.
5) Che le Repubbliche governino il provvisorio togliendo gli ostacoli che impediscono la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, e costruiscano ponti, lavori e condizioni di vita che reggano agli insulti del tempo.
6) Che si sostituiscano le energie e le pompe di calore che inquinano l’aria e surriscaldano la terra.
7) Ma soprattutto che nessuno cerchi la felicità se non soffre del dolore degli altri.
* Raniero La Valle
Si tratta del discorso tenuto a Portici il 6 ottobre 2018 alla Festa Multiculturale “Pane nostro” del Coordinamento Campano contro le camorre e le mafie.
Nel dolore del mondo
“NON C’È PIÙ NÉ GIUDEO NÉ GRECO”
26 OTTOBRE 2018 / EDITORE / DICONO I DISCEPOLI /
—–Nota—–
[1] Benedetto Croce, “Filosofia e storiografia”, Laterza, Bari, 1949, pp. 247-248).
——————————————-
Popolo costituente e migrante
27 Ottobre 2018
Luigi Ferrajoli il manifesto 24.10.2018
STORIE. Il diritto a emigrare ha radici antiche, teoriche e politiche, che si scontrano con la miseria xenofoba del presente. Uno stralcio tratto dall’ultimo numero di «Critica marxista»**
La terra inquieta in Triennale
Il principale segno di cambiamento manifestato finora dall’attuale sedicente «governo del cambiamento» è la politica ostentatamente disumana e apertamente illegale da esso adottata nei confronti dei migranti. Di nuovo il veleno razzista dell’intolleranza e del disprezzo per i «diversi» sta diffondendosi non solo in Italia ma in tutto l’Occidente, nell’Unione Europea e negli Stati Uniti, quale veicolo di facile consenso nei confronti degli odierni populismi e delle loro politiche di esclusione.
È SU QUESTO TERRENO che rischia oggi di crollare l’identità civile e democratica dell’Italia e dell’Europa. Le destre protestano contro quelle che chiamano una lesione delle nostre identità culturali da parte delle «invasioni» contaminanti dei migranti. In realtà esse identificano tale identità con la loro identità reazionaria: con la loro falsa cristianità, con la loro intolleranza per i diversi, in breve con il loro più o meno consapevole razzismo. Laddove, al contrario, sono proprio le politiche di chiusura che stanno deformando e deturpando l’immagine dell’Italia e dell’Europa, che sta infatti vivendo una profonda contraddizione: la contraddizione delle pratiche di esclusione dei migranti quali non-persone non soltanto con i valori di uguaglianza e libertà iscritti in tutte le sue carte costituzionali e nella stessa Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, ma anche con la sua più antica tradizione culturale.Il diritto di emigrare fu teorizzato dalla filosofia politica occidentale alle origini dell’età moderna. Ben prima del diritto alla vita formulato nel Seicento da Thomas Hobbes, il diritto di emigrare fu configurato dal teologo spagnolo Francisco de Vitoria, nelle sue Relectiones de Indis svolte nel 1539 all’Università di Salamanca, come un diritto naturale universale. Sul piano teorico questa tesi si inseriva in una edificante concezione cosmopolitica dei rapporti tra i popoli informata a una sorta di fratellanza universale. Sul piano pratico essa era chiaramente finalizzata alla legittimazione della conquista spagnola del Nuovo mondo: anche con la guerra, in forza del principio vim vi repellere licet, ove all’esercizio del diritto di emigrare fosse stata opposta illegittima resistenza. Tutta la tradizione liberale classica, del resto, ha sempre considerato lo jus migrandi un diritto fondamentale. John Locke fondò su di esso la garanzia del diritto alla sopravvivenza e la stessa legittimità del capitalismo: giacché il diritto alla vita, egli scrisse, è garantito dal lavoro, e tutti possono lavorare purché lo vogliano, facendo ritorno nelle campagne, o comunque emigrando nelle «terre incolte dell’America», perché «c’è terra sufficiente nel mondo da bastare al doppio dei suoi abitanti».
KANT, a sua volta, enunciò ancor più esplicitamente non solo il «diritto di emigrare», ma anche il diritto di immigrare, che formulò come «terzo articolo definitivo per la pace perpetua» identificandolo con il principio di «una universale ospitalità». E l’articolo 4 dell’Acte constitutionnel allegato alla Costituzione francese del 1793 stabilì che «Ogni straniero di età superiore a ventuno anni che, domiciliato in Francia da un anno, viva del suo lavoro, o acquisti una proprietà, o sposi una cittadina francese, o adotti un bambino, o mantenga un vecchio, è ammesso all’esercizio dei diritti del cittadino».
Lo ius migrandi è da allora rimasto un principio elementare del diritto internazionale consuetudinario, fino alla sua già ricordata consacrazione nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948. Fino a che l’asimmetria non si è ribaltata. Oggi sono le popolazioni fino a ieri colonizzate che fuggono dalla miseria provocata dalle nostre politiche. E allora l’esercizio del diritto di emigrare è stato trasformato in delitto.
Siamo perciò di fronte a una contraddizione gravissima, che solo la garanzia del diritto di emigrare varrebbe a rimuovere. Il riconoscimento di questa contraddizione dovrebbe non farci dimenticare quella formulazione classica, cinicamente strumentale, del diritto di emigrare: perché la sua memoria possa quanto meno generare – nel dibattito pubblico, nel confronto politico, nell’insegnamento nelle scuole – una cattiva coscienza sull’illegittimità morale e politica, prima ancora che giuridica, delle nostre politiche e agire da freno sulle odierne pulsioni xenofobe e razziste.
QUESTE POLITICHE crudeli stanno avvelenando e incattivendo la società, in Italia e in Europa. Stanno seminando la paura e l’odio per i diversi. Stanno screditando, con la diffamazione di quanti salvano vite umane, la pratica elementare del soccorso di chi è in pericolo di vita. Stanno fascistizzando il senso comune. Stanno, in breve, ricostruendo le basi ideologiche del razzismo; il quale, come affermò lucidamente Michel Foucault, non è la causa, bensì l’effetto delle oppressioni e delle violazioni istituzionali dei diritti umani: la «condizione», egli scrisse, che consente l’«accettabilità della messa a morte» di una parte dell’umanità. Che è il medesimo riflesso circolare che ha in passato generato l’immagine sessista della donna e quella classista del proletario come inferiori, perché solo in questo modo se ne poteva giustificare l’oppressione, lo sfruttamento e la mancanza di diritti. Ricchezza, dominio e privilegio non si accontentano di prevaricare. Pretendono anche una qualche legittimazione sostanziale.
Un secondo effetto è non meno grave e distruttivo. Consiste in un mutamento delle soggettività politiche e sociali: non più le vecchie soggettività di classe, basate sull’uguaglianza e sulle lotte comuni per comuni diritti, ma nuove soggettività politiche di tipo identitario basate sull’identificazione delle identità diverse come nemiche e sul capovolgimento delle lotte sociali: non più di chi sta in basso contro chi sta in alto, ma di chi sta in basso contro chi sta ancora più in basso. È un mutamento che sta minando le basi sociali della democrazia. Una politica razionale, oltre che informata alla garanzia dei diritti, dovrebbe muovere, realisticamente, dalla consapevolezza che i flussi migratori sono fenomeni strutturali e irreversibili, frutto della globalizzazione selvaggia promossa dall’attuale capitalismo.
DOVREBBE anzi avere il coraggio di assumere il fenomeno migratorio come l’autentico fatto costituente dell’ordine futuro, destinato, quale istanza e veicolo dell’uguaglianza, a rivoluzionarie i rapporti tra gli uomini e a rifondare, nei tempi lunghi, l’ordinamento internazionale. Il diritto di emigrare equivarrebbe, in questa prospettiva, al potere costituente di questo nuovo ordine globale: giacché l’Occidente non affronterà mai seriamente i problemi che sono all’origine delle migrazioni se non li sentirà come propri. I diritti fondamentali, come l’esperienza insegna, non cadono mai dall’alto, ma si affermano solo allorquando la pressione di chi ne è escluso alle porte di chi ne è incluso diventa irresistibile. Per questo dobbiamo pensare al popolo dei migranti come al popolo costituente di un nuovo ordine mondiale.
** SCHEDA: Una rivista che legge le trasformazioni
Il testo integrale di Luigi Ferrajoli – con il titolo: «La questione migranti: Italia incivile, Europa incivile» – apre dopo l’editoriale di Aldo Tortorella sulla fase politica («San Giorgio, il drago e i mostriciattoli di turno») il n. 5 della rivista «Critica Marxista», dove alcuni temi di attualità sono affrontati da Tiziano Rinaldini («Il “decreto dignità” e i gravi ritardi della sinistra sul lavoro») Alberto Leiss («Il baratro di Genova»), Francesco Garibaldo («Fca e Fca Italia dopo Marchionne: un’eredità difficile»), Romeo Orlandi (La sinistra, la Cina, la globalizzazione), infine E. Igor Mineo («Le sinistre e la crisi dell’Unione europea»). Il «Laboratorio culturale» è aperto da un saggio di Ida Dominijanni sul dibattito femminista in Occidente («Femminismo in/addomesticabile»), mentre Daniele Caputo scrive su «Il regresso oligarchico». Riccardo Bellofiore ricorda la figura e il pensiero di Lucio Magri («Provarci ancora, fallire di nuovo, ma fallire meglio»
Oggi sabato 27 ottobre 2018

![]()







![]()
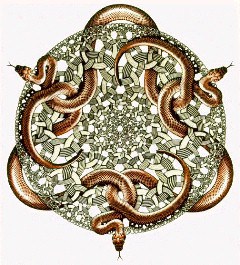

———-Avvenimenti&Dibattiti&Commenti———————————–
Popolo costituente e migrante
27 Ottobre 2018
Luigi Ferrajoli il Manifesto 24.10.2018, ripreso da Democraziaoggi.
STORIE. Il diritto a emigrare ha radici antiche, teoriche e politiche, che si scontrano con la miseria xenofoba del presente. Uno stralcio tratto dall’ultimo numero di «Critica marxista».
——————————————————-
Dibattito sulla manovra economica governativa

Economia e politica,
proprio come negli anni ’80
Anche oggi il mondo è in una fase di svolta e in Italia ci sono due partiti
in competizione tra loro al governo e il debito pubblico in crescita
di Mauro Magatti*
Il debito pubblico italiano è esploso negli anni ’80 quando, nel giro di pochi anni, il rapporto rispetto al Pil è schizzato dal 60 al 100%. Anche quelli erano anni di cambiamento: mentre il mondo virava verso un nuovo modello di crescita, il sistema politico italiano cercava i propri equilibri, con il Psi di Craxi a contendere la leadership del Paese a una Dc ormai esangue. Le cose però non andarono come sperato: tra i due principali partiti, che avevano visioni del mondo diverse, la lotta politica fu fatta dentro il governo a colpi di spesa pubblica usata per battere il proprio alleato-competitor. Così, in dieci anni, i risparmi accumulati nel periodo del boom, invece che finanziare una nuova stagione di crescita, furono bruciati nel grande falò dei titoli di Stato che, nel sostenere i disegni politici di Dc e Psi, garantirono a molti italiani rendite mai viste prima.
Tra il tempo che stiamo vivendo e gli anni 80 è possibile scorgere alcune preoccupanti analogie. Anche oggi, come allora, ci sono due partiti al governo in competizione tra loro. E come è stato evidente in queste settimane, entrambi hanno cercato di mettere nero su bianco alcune delle promesse fatte ai loro elettorati. Il risultato è una finanziaria in cui è difficile scorgere una logica unitaria: tra reddito di cittadinanza e condono fiscale c’è oggettivamente una incoerenza di fondo.
Anche oggi, come allora, stiamo attraversando un cambio di fase storica. La stagione della globalizzazione espansiva è finita e siamo in un momento in cui si vanno riscrivendo i rapporti di forza a livello internazionale. Col ritorno della politica come mediatore tra gli interessi nazionali e i processi globali. Ciò comporta la necessità di capire come si va configurando il mondo, così da attrezzarsi di conseguenza, nelle sue dimensioni economiche (vedi il tema del lavoro) e politiche (che per noi significa prima di tutto rapporti con l’Europa).
Nel dibattito pubblico, da qualche anno l’austerity è diventata il nemico numero uno. Termine che ricorda le politiche economiche volute dalla Germania, seguite da Bruxelles e arrivate in Italia attraverso il governo Monti. A dire il vero, le critiche all’austerity sono giustificate: se si fanno politiche restrittive, diminuisce il Pil e aumenta il debito. Di fronte ai problemi sociali e ai conseguenti sbandamenti delle democrazia occorre puntare sulla crescita. Giusto. Ma attenzione: la crescita deve essere sostenibile. Dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.
Per molti aspetti, la legge finanziaria che comincia l’iter in Parlamento riporta l’Italia agli anni del tramonto della prima Repubblica, agli anni cioè della spesa facile. Dei 33 miliardi di manovra, ben 22 sono in deficit dichiarato (ammesso e non concesso che gli altri 11 miliardi trovino poi le coperture indicate). Gli intenti elettorali di breve periodo sono evidenti. Non a caso il governo ha garantito la disponibilità delle principali misure già nei primi mesi dell’anno (entro marzo, cioè prima delle europee).
La manovra è espansiva ma manca di visione, quasi che si sia voluto buttare paglia su un fuoco che si sta spegnendo: la fiamma si ravviva per qualche secondo, ma poi torna tutto come prima. Anzi peggio. L’errore sta nel non capire il cambiamento storico in atto: l’epoca di una crescita trainata dai consumi è finita. Certo i consumi sono importanti. Sempre. Ma la crescita si regge nel tempo se si diventa capaci di investire seriamente sul futuro, senza bruciare le risorse (che sono limitate) per sostenere i consumi nel breve termine.
Per indicare la dipendenza dal gioco, la lingua inglese usa il termine addiction. Parola che viene dal latino addictum che indicava colui che, pur rimanendo cittadino de iure, de facto perdeva la propria libertà a causa dei troppi debiti. Una manovra espansiva tutta centrata sull’aumento del debito e sul sostegno al reddito dà un messaggio sbagliato al Paese. Finendo per renderlo addictum! Proprio come è accaduto negli anni 80.
Il cambiamento di cui l’Italia ha bisogno è molto diverso: ci vuole sì una politica economica espansiva. Ma le risorse aggiuntive devono servire per investire (davvero) nel futuro: rafforzando gli investimenti pubblici e privati, i giovani e la natalità, la formazione e la ricerca, la lotta al dissesto idrogeologico, al degrado del patrimonio culturale e delle periferie. Occorre opporsi ai diktat della finanza e dei mercati speculativi, ma dicendo loro che si sta lavorando per creare un patto sociale tra tutti gli italiani che vogliono combattere gli sprechi, lottare contro l’evasione (di recente stimata in 110 miliardi di euro!), sconfiggere la corruzione e il clientelismo. Si libera veramente il popolo se la politica si mette a capo di tutti coloro che lottano contro chi distrugge risorse e sfrutta il lavoro. Federando tutti coloro che creano nuovo valore (economico ma anche ambientale, culturale, sociale) per sé e per gli altri. Nella prospettiva di un modello che fa della logica della sostenibilità integrale il proprio criterio di riferimento. Insomma, avevamo capito che l’Italia avesse bisogno di un cambiamento profondo. Non di un ritorno alle origini del nostro declino.
———————–
* Sul Corriere della Sera
Oggi venerdì 26 ottobre 2018

![]()







![]()
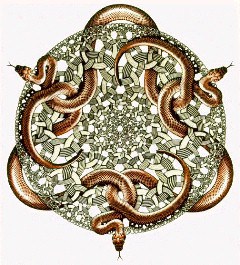

———-Avvenimenti&Dibattiti&Commenti———————————–
![]() Gli Editoriali di AladinewAladinAladinpensiero
Gli Editoriali di AladinewAladinAladinpensiero
————————————————————-
Nuova legittima difesa: la proporzione tra difesa e offesa c’è… anche se non c’è!
26 Ottobre 2018
Andrea Pubusa su Democraziaoggi.
Può il legislatore dire che ciò che è rosso è bianco? E se lo dice cosa succede? Vincola l’interprete? Perché questa domanda in apparenza assurda? Perché la nuova legge sulla legittima difesa ora passata all’esame della Camera per l’approvazione definitiva sembra, mutatis mutandis, dire che una cosa che non c’è, invece c’è.(…)
——————————————
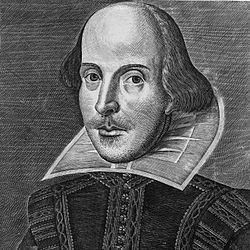 La fake democracy di Grillo
La fake democracy di Grillo
26 Ottobre 2018
“Though this is madness, yet there is method in it.”
(“Sarà pure follia, ma ha di certo una sua logica.”)
Massimo Villone su il manifesto del 23.10.2018, ripreso da Democraziaoggi.
[Democraziaoggi] Pubblichiamo questo intervento di Massimo Villone, presidente del Comitato per la democrazia costituzionale, sempre acuto e stimolante. Certo, nulla va sottovalutato, ma a me pare che Grillo e Casaleggio jr. si siano ormai ritagliati il ruolo di “provocatori” di riflessioni, di segnalatori di nuovi temi di ricerca, senza inteferire sulla politica […]
——————————————-
Presentato il dossier Idos Immigrazione 2018

Oggi presentazione Dossier Emigrazione 2018 presso l’aula magna ex Facoltà di Scienze politiche dell’Università. Dopo i saluti istituzionali (Centro Studi RI, Prefettura, Assessorato del Lavoro) relazioni di M.Tiziana Putzolu e Valeria Lai. Coordina Sergio Nuvoli. Interventi programmati di Annamaria Baldussi, Università degli Studi di Cagliari e Genet Woldu Kefly, Presidente Anolf Sardegna.
[Di seguito il comunicato stampa Idos]
Capire la realtà, anche con i dati, per combattere la battaglia sull’integrazione.
Domani
 Mahmoud Asfa presenta L’Islam nelle sfide della società moderna
Mahmoud Asfa presenta L’Islam nelle sfide della società moderna
Nuovo appuntamento della terza edizione della rassegna di intrecci culturali e letterari Storie in Trasformazione 2018. Domani, Venerdì 26 ottobre alle ore 18:00 all’Hostel Marina nelle Scalette San Sepolcro a Cagliari Mahmoud Asfa presenta il suo libro L’Islam nelle sfide della società Moderna. Introduce e coordina Michele Piras dell’Associazione Eutropia e intervengono Don Ettore Cannavera della Comunità La Collina e Patrizia Manduchi, docente di Cultura e Società dei Paesi Arabi mediterranei dell’Università di Cagliari. [segue]
Dossier Immigrazione 2018
Oggi giovedì 25 ottobre 2018

![]()








![]()
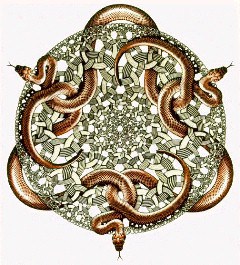

———-Avvenimenti&Dibattiti&Commenti———————————–
Oggi giovedì 25 ottobre 2018. Le nostre città invisibili: un incontro tra culture diverse.
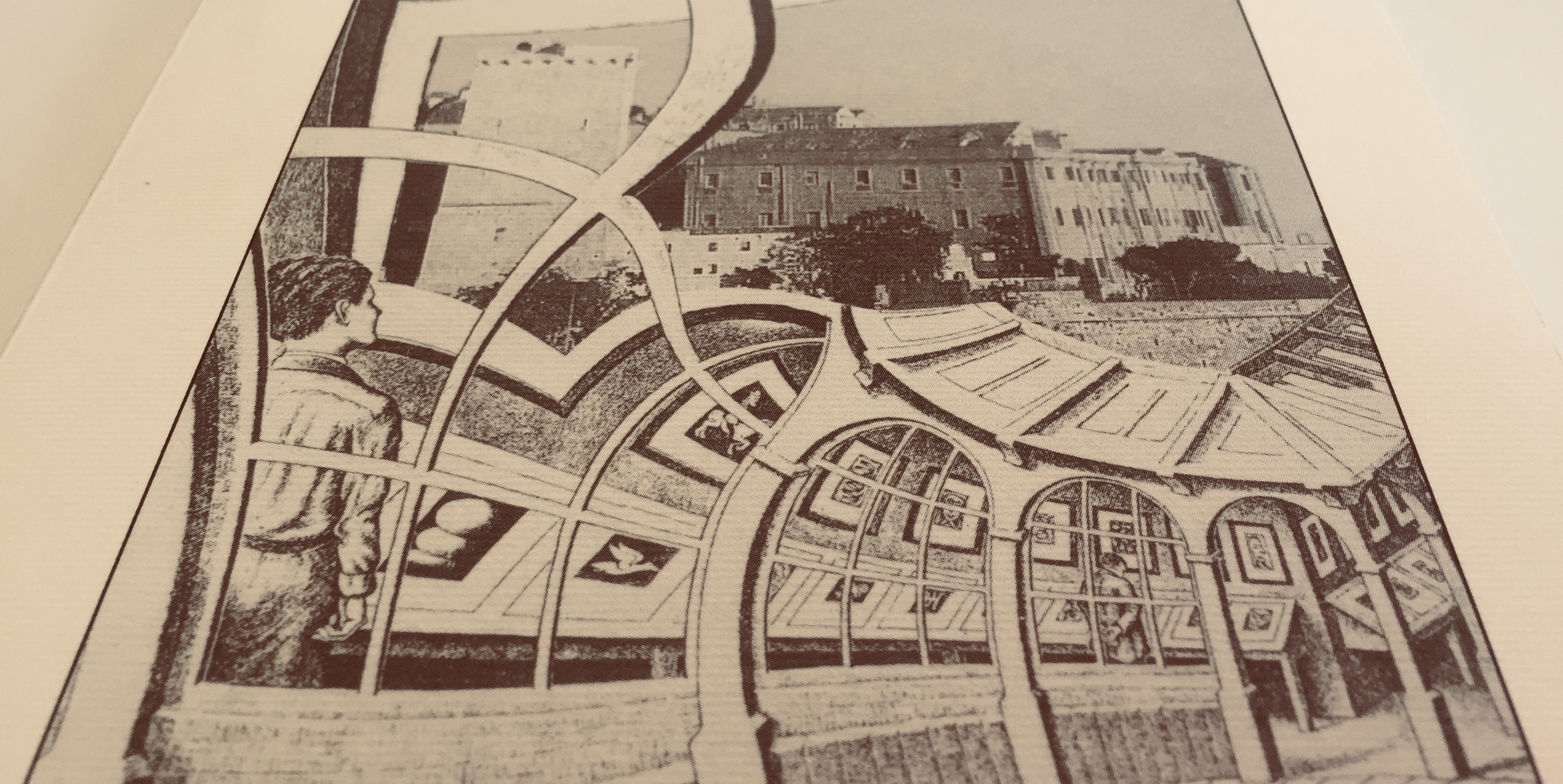
——————————————————————–
Senza distinzioni, occorre una critica dura verso questo governo.
25 Ottobre 2018
Tonino Dessì su Democraziaoggi.
Sicuramente Salvini cercherà di trarre il maggior utile propagandistico dalla bocciatura dello schema della manovra economica presentato dal Governo. L’intero gioco della Lega infatti non è sul piano europeo, ma su quello interno, in cui mira ad assorbire tutta l’eredità berlusconiana e magari erodere quanto più possibile all’attuale alleato pentastellato […]
 Due in uno.
Due in uno.
di Tonino Dessì su fb.
*****
[segue]
Dibattito. Guai ad abbandonare l’Europa! Cambiamola in meglio!
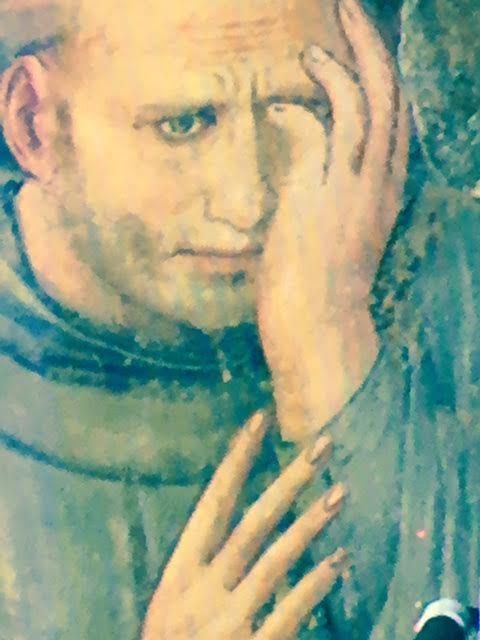
La polemica rivelatrice sul Documento economico-finanziario del governo giallo-verde
di Guido Formigoni
19 ottobre 2018 by Forcesi, segnalato da C3dem.

La vicenda del Def è istruttiva, sia sui comportamenti dell’attuale governo, sia sul modo di fare opposizione. Da una parte, sembra proprio che l’asse Salvini-Di Maio abbia fatto slittare il pedale nel proprio ormai tipico modo di far politica, tutto basato sull’annuncio e sulla costruzione mediatica di consenso. Mi spiego: non c’era nessuna necessità reale di mettere per iscritto il punto del 2,4% di deficit in un documento come il Def, che doveva solo indicare una stima. Per poi infatti ricorrere a un pietoso tira e molla (il 2,4% per tre anni, anzi no, per un anno e poi vedremo; 10 miliardi per le pensioni, anzi no di meno…). In sostanza, hanno scelto di amplificare l’effetto annuncio per porre una sfida di parole, che incassasse a breve un sostegno del proprio elettorato ansioso, ribollente e preoccupato per i vincoli europei. Occorreva insomma fissare un punto propagandistico, costruire la scena del balcone. Poi, si sarebbe visto… i fatti sono più complicati da gestire delle parole.
Intanto – forse hanno anche pensato – si poteva verificare la reazione europea e quella dei mercati. E qui è cascato mezzo asino, perché l’Europa è stata prudente e tutto sommato consapevole del contenuto modesto della sfida, senza offrire sponde a un innalzamento del conflitto verbale (qualcuno dice che non sarebbe spiaciuto soprattutto a Salvini inasprire lo scontro). I mercati, molto meno: lo spread salito a 300 significa una perdita secca di svariati miliardi in conto interessi sul debito (le stime variano per il solo 2019 a 4-6 miliardi, se si resta per un anno a questi livelli, cosa non garantita). Il che segna già da ora un autogol clamoroso del governo, quando di trippa per i gatti ancora non si è visto nemmeno il profumo. E poco serve dire che c’è il complotto degli speculatori, perché è ora che ci si accorga anche nel sospettoso popolo grillino che il meccanismo finanziario in cui siamo immersi e condizionati è talmente vasto e capillare, costituito di tanti molecolari interessi, che è assolutamente impossibile condizionarlo ad opera di un numero ristretto di operatori.
Altro si sarebbe potuto fare se la maggioranza fosse più seria e cioè non fautrice di una politica basata sugli annunci, ma capace di immaginare una correzione di rotta graduale e sensata della finanza pubblica. Tutti i governi passati hanno infatti sforato le cifre e cifrette indicate nel Def: ma senza dirlo prima con le grancasse (nel 2017 a cose fatte il deficit è stato del 2,3%). In quel modo un po’ surrettizio, la correzione attuale rispetto alle previsioni sarebbe stata molto più gestibile. Il problema è che questa classe di governo, nel suo palese dilettantismo, non sembra all’altezza della necessaria accorta gestione dei delicati equilibri della finanza pubblica.
Dicevo però che questo episodio rivela anche molto dell’opposizione attuale. E più in generale di come vengono criticate le scelte del nuovo governo da parte di una opinione pubblica mainstream come quella rappresentata da parte della grande stampa. Si è infatti aperto ampiamente da parte politica e mediatica il fronte della polemica sul rigore di bilancio, che ripete cose molto note sul fatto che non si può creare nuovo debito, dato che l’Italia è già al 130% del Pil, e che non si può fare assistenzialismo sulle pensioni e sul reddito di cittadinanza in deficit. Sì, ma… Il precedente ciclo di governi a trazione Pd non è che sul rientro del debito abbia costruito molto, anzi: la percentuale è sempre la stessa da sei anni. Semplicemente, si sono avvalsi in modo molto opportuno della difesa dell’euro compiuta da Draghi con la creazione enorme di liquidità monetaria, che ha sconfitto la speculazione sul debito pubblico dell’Italia e dei paesi più fragili che si era innescata nel 2011: cioè ha appunto abbattuto lo spread a livelli irrisori, facendo risparmiare al paese una cosa come 65 miliardi di euro in cinque-sei anni in interessi da pagare sullo stock di debito pregresso (lo 0,8 del Pil all’anno, mica noccioline). Al riparo del cospicuo scudo della Bce, tali governi hanno comunque ridotto di pochissimo il deficit, continuando a tagliare su alcuni capitoli come la pubblica amministrazione, riducendo di pochissimo la pressione fiscale e facendo la scommessa su modalità diverse di incentivo economico, rispetto a quelle oggi in discussione: dagli 80 euro erogati ai bassi redditi, fino ai molti miliardi messi nella riduzione contributiva del Jobs act. Con risultati discussi (e discutibili, non apriamo qui il capitolo): comunque non certo eclatanti, ci si concederà, in termini di occupazione e sviluppo. Siamo un paese in cui il Pil è ancora sotto del 5-6% rispetto al 2008.
Quindi, qual è il punto vero, a mio sommesso parere (non è farina del mio sacco, naturalmente, ma si basa su un dibattito non banale che su questi temi è avviato da tempo in Europa)? Il punto non è il mantra liberista del pareggio di bilancio o la discussione sulle percentuali del deficit, con il relativo braccio di ferro con l’Europa per sfangare un decimale in più. Nessuno è immune da critiche su queste dimensioni, e soprattutto non c’è nessun terreno sicuro in proposito. Paradossalmente, nemmeno un governo che avviasse veramente la riduzione della montagna di debito che attualmente abbiamo – cosa possibile solo a costi sociali drammatici, diciamocelo – sarebbe a rigore veramente al riparo dalla speculazione finanziaria: perché mai, infatti, il 110 o il 120% dovrebbe andare bene, invece del 130%? Se per qualche motivo gli investitori avessero sentore di una certa debolezza si appiglierebbero anche al 110 o al 120%. Il rischio speculazione rimarrebbe, soprattutto a causa del mero fatto che lo scudo della Bce si sta riducendo e ogni paese resterà progressivamente più esposto ai marosi.
Cosa significa questo discorso? Ovviamente non che siamo liberi di fare quello che vogliamo. È palese che ci siano compatibilità economiche sostanziali, cui nessuno sfugge a lungo andare. Chi parla di sospendere il pagamento del debito o di uscire dall’euro ciancia di cose insostenibili, o comunque a costi altissimi per la collettività. Ma è anche vero che le coerenze economiche non sono per definizione rigide, né assolute. Possono essere gestite nel tempo in modo diverso, a seconda della capacità strategica e della forza politica che ci sta dietro. La globalizzazione non ha spazzato via il ruolo degli Stati, come a volte si dice: ha però di certo molto ridimensionato il peso degli Stati piccoli e medi. Il punto quindi è che la sovranità vera sulla propria politica economica, oltre alla serietà necessaria su un discorso di strategia e di rapporto mezzi/obiettivi (che non guasta mai), richiede nel mondo attuale una dimensione tale da poter gestire (non del tutto eliminare) la sfida dei “mercati”, cioè dell’ansiosa ricerca di rendite da parte di masse di capitali finanziari enormi e potentissimi. L’Italia, diciamocelo chiaro, questa dimensione non ce l’ha.
Naturalmente oggi sono in pochissimi ad averla: gli Stati Uniti che si permettono di aumentare un debito accolto con indifferenza da tutti i mercati. La Cina, con il proprio sistema che (per ora efficacemente) combina dirigismo e liberismo. Il Giappone, che ha un debito al 250% del Pil e lo gestisce senza affanno alcuno (e non vale obiettare cose peraltro vere, cioè che per un terzo tale debito è in mano alla banca centrale o che molta parte è risparmio interno, perché questi elementi non mutano l’enormità della massa finanziaria coinvolta). L’unica altra alternativa sarebbe l’Europa. Già: qui si rivela il vero punto critico del sovranismo nostrano. Picconare l’Europa è segno di miopia assoluta, perché impedisce di costruire livelli di compartecipazione e corresponsabilità finanziaria che soli potrebbero essere in grado di sfidare gli altri soggetti globali e la forza generalizzata dei mercati. Certo, l’Europa attuale è del tutto inadempiente sul punto, data l’annosa polemica interna sull’austerity e l’interpretazione restrittiva della solidarietà causata dal peso del modello tedesco, che si crogiola nel proprio enorme surplus commerciale (ottenuto in buona parte anche grazie all’esistenza dell’euro) e lo gestisce pigramente senza utilizzarlo in chiave espansiva. Politicamente parlando, però, l’unico futuro immaginabile di una sovranità politica democratica che sfidi i vincoli dell’attuale sistema e allarghi le sue maglie si collocherebbe nella capacità di costruire un consenso in Europa su questo punto. Se c’è una battaglia vera da fare non è ottenere un decimale di deficit in più dai guardiani della commissione, ma cambiare pian piano questa logica perdente. Smuovendo la miope posizione tedesca, compito certo non semplice. Ma prima o poi anche a Berlino ci si renderà conto che da soli non vanno da nessuna parte nemmeno loro e che costruire un’Europa più solida politicamente e finanziariamente serve anche a loro.
Un soggetto europeo che cominci a mettere in comune non solo la moneta, ma anche la politica economica e finanziaria, con l’europeizzazione prudente e responsabile di una parte dei debiti nazionali, è cruciale per potere infatti porsi obiettivi di politica economica veramente incisivi. Solo l’Europa avrebbe infatti la forza di raccogliere risorse tali da avviare un nuovo ciclo di investimenti espansivi orientati dalla mano pubblica, che potrebbe essere all’altezza delle difficoltà attuali, contrastando gli effetti della grande stagnazione e bilanciando i limiti del sistema della globalizzazione. Solo un tipo di svolta epocale come questa sarebbe decisiva per potersi porre obiettivi non risibili e tutti solo apparenti, come quelli che si possono affannosamente gestire nel cortile di casa. Naturalmente poi occorrerebbe discutere della qualità di questa spesa: e potremmo tornare a ragionare se e come il reddito di cittadinanza sia meglio degli sgravi contributivi o di un grande piano di ristrutturazione delle città o delle infrastrutture. Laicamente e senza preconcetti, provando e magari sbagliando.
Non mi pare ci siano attualmente, né nella maggioranza né nell’opposizione (politica e intellettuale) molti ambienti disponibili a prendere sul serio questo ragionamento. E questo è il limite dell’attuale situazione. Se non facciamo fare al dibattito questo salto di qualità, non credo andremo lontano. Dopo i giorni dell’euforia del balcone, seguiranno le mezze promesse e le spese rimandate, i ritorni indietro e i contentini risibili, le riforme dilazionate e gli allarmi per i cattivi speculatori. Il tutto condito con un inarrestabile declino dell’apparato amministrativo e del nerbo pubblico del paese. Un balletto che nessuna società – tantomeno quella italiana così slabbrata e provata – può ancora reggere a lungo.







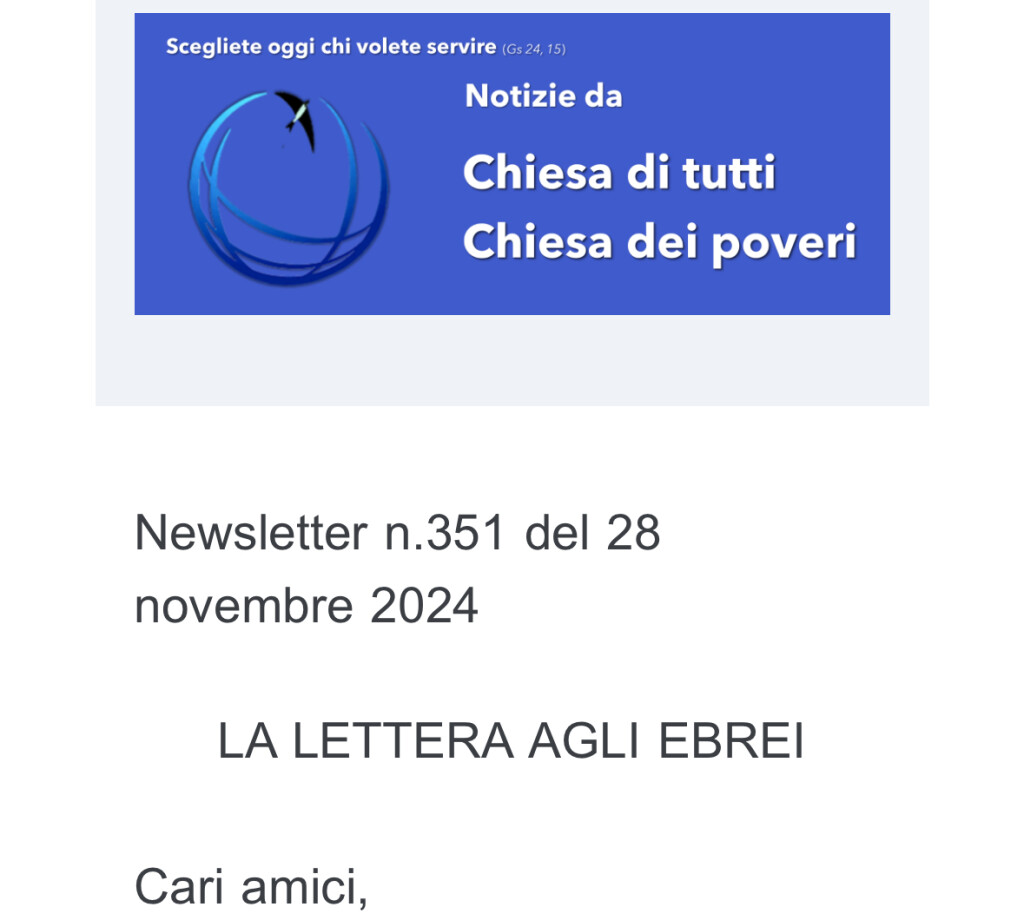






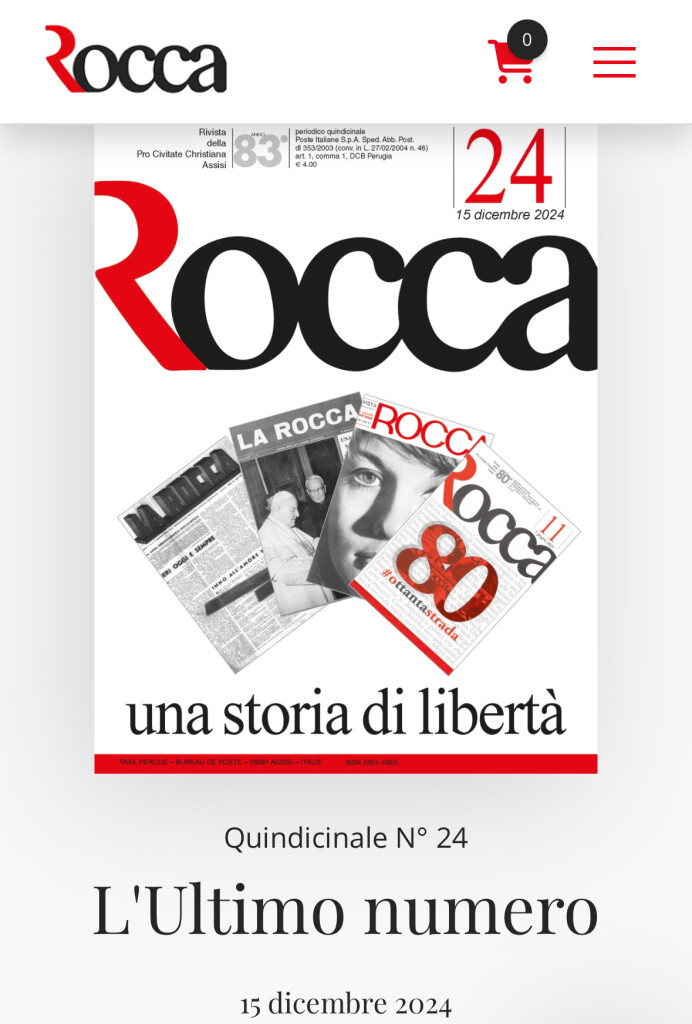




 AService Studio
AService Studio