Monthly Archives: aprile 2018
Governo vo’ cercando
 E’ giustificabile un “governo dei tecnici” in alternativa alla democrazia?
E’ giustificabile un “governo dei tecnici” in alternativa alla democrazia?
Gianfranco Sabattini*
Jeson Brennan, autore di “Contro la democrazia” (con Prefazione di Sabino Cassese e un saggio introduttivo di Raffaele De Mucci), sostiene che esiste “un insieme di convinzioni ampiamente condivise sul valore e la legittimazione della democrazia e della partecipazione democratica”, per lo più fondate sugli assunti secondo cui la democrazia e un’ampia partecipazione politica sarebbero importanti perché condurrebbero “a risultati giusti, efficienti o stabili”, e tenderebbero “a istruire, illuminare e nobilitare i cittadini”, essendo esse “un fine di per sé”. Secondo Brennan, le tre finalità (dell’istruzione, dell’illuminazione e della nobilitazione dei cittadini) esprimerebbero ciò che egli chiama “trionfalismo democratico”, contro il quale egli muove la sua critica, rifiutandone la fondatezza.
Il politologo americano ritiene che tali finalità non meriterebbero la considerazione della quale esse godono; innanzitutto, perché la partecipazione politica non apporterebbe beneficio alcuno, in quanto, a suo dire, trasformerebbe in nemici i cittadini nell’arena civile e darebbe loro motivo di odiarsi l’un l’altro; in secondo luogo, perché il diritto al voto non sarebbe come gli altri diritti posti a presidio delle altre libertà civili (come, ad esempio, la libertà di parola, di culto, di associazione, ecc.); infine, perché la democrazia non sarebbe l’unica forma di governo intrinsecamente giusta, in quanto il suffragio universale incentiverebbe “la maggior parte degli elettori a prendere le decisioni politiche in condizioni di ignoranza e irrazionalità [...]. Un suffragio illimitato, uguale e universale sarebbe giustificato soltanto se non potessimo concepire un sistema che funzioni meglio”.
Da dove derivano le finalità sulle quali sarebbero fondate, a parere di Brennan, le presunte virtù della democrazia? Per il politologo americano, le finalità deriverebbero dal liberalismo filosofico, ovvero da quella concezione secondo cui “ogni individuo possiede una sua dignità, fondata su ragioni di giustizia che gli garantisce tutta una serie di libertà e diritti, i quali non possono essere calpestati alla leggera, nemmeno per perseguire un bene sociale più grande”. L’analogia presunta dal liberalismo filosofico tra singoli individui e società non è però giustificata; ciò perché un elettorato è un insieme di individui “con scopi, comportamenti e credenziali intellettuali distinti”.
Un elettorato, perciò, non è un corpo unico in cui ogni singoli componente propugna le stesse cose; al contrario, in esso esistono individui che impongono le loro decisioni ad altri, per cui se la maggior parte degli elettori dovesse “agire con stupidità” non farebbe del male solo a se stessa, ma danneggerebbe anche le minoranze di elettori “meglio informati e più razionali”. In politica, afferma Brennan, il processo decisionale non si riduce mai a scelte per se stessi, ma implica sempre scelte per tutti. Per queste ragioni, insiste Brennan, volendo giustificare le finalità sulle quali è basata la legittimazione della democrazia, occorre dare conto del perché alcuni individui “hanno il diritto di imporre cattive decisioni agli altri”; in altre parole, occorre spiegare perché è legittimo e possibile che un gruppo di individui, anche se maggioranza, possa obbligare le minoranze a subire le “decisioni prese in modo incompetente”.
Nel chiedersi quale valore abbia la democrazia, la maggior parte dei filosofi del liberalismo individualista ritiene che essa abbia un “valore procedurale”, nel senso che si tratti di una “procedura decisionale di per sé giusta”, assumendo che qualsiasi decisione presa col metodo democratico sia una decisione razionale. Al contrario, secondo Jason Brennan, il valore della democrazia è unicamente “strumentale”, per cui “la sola ragione per preferire la democrazia a qualsiasi altro sistema politico è che è più efficiente nel produrre risultati giusti, secondo standard di giustizia che sono indipendenti dalle procedure”.
Poiché la democrazia assegna a ogni individuo una quota uguale di potere politico, uno dei problemi dell’organizzazione politica di una comunità democratica consiste nello stabilire chi deve “detenere il potere”; data la natura individualistica della società democratica è plausibile assumere, secondo Brennan, che esistano opinioni diverse su chi debba detenere il potere, così come è plausibile ipotizzare che esistano opinioni alternative riguardo alla scelta dei criteri in base ai quali decidere a chi assegnare il potere politico. La soluzione del problema non puà quindi essere determinata in modo univoco.
Con lo strumentalismo, sostiene Brennan, l’indeterminazione sarebbe rimossa, perché la distribuzione del potere politico sarebbe determinata in funzione della possibilità di ottenere “risultati di governo giusti, indipendentemente dalle procedure e quali che siano tali risultati”. Secondo lo strumentalismo – afferma Brennan –“esiste un modo (o dei modi) intrinsecamente buono, giusto o legittimo di distribuire il potere” e, nella sua versione più radicale, “non esistono standard morali indipendenti con cui valutare i risultati delle istituzioni decisionali”. In altre parole, per lo strumentalismo non esiste un metodo di distribuzione del potere politico intrinsecamente giusto o sbagliato attraverso il quale si possa “stabilire con certezza quali siano i giusti scopi di un governo, quali le forme di policy che dovrebbe implementare o quali i risultati che dovrebbe conseguire”; sarebbe questa, secondo Brennan, la ragione per cui una comunità che scegliesse di vivere all’interno di un regime democratico, nel risolvere la questione della distribuzione del poter politico, dovrebbe optare per qualsiasi forma di governo “risulti più affidabile” nel perseguire i risultati decisi in modo indipendente dal regime politico adottato.
Se la democrazia non è un valore in sé, o se essa non può essere giustificata su basi procedurali, ma solo strumentali, allora per una comunità democratica diventa ragionevole – afferma Brennan – dotarsi di un governo “epistocratico” (esercitato da chi è dotato di maggiore conoscenza e capacità incontrovertibili); cioè di un governo che sia espressione di un regime nel quale il potere politico è distribuito secondo le competenze e le capacità degli individui che compongono la comunità. In questo modo, conclude Brennan, diverrebbe possibile, innanzitutto, evitare che una partecipazione politica universale, senza alcuna selezione, tenda a “corrompere” le relazioni tra i componenti la comunità; in secondo luogo, sarebbero evitate le inutili attese degli effetti positivi connessi al presunto valore intrinseco attribuito alle libertà politiche; infine, diverrebbe possibile, attraverso l’attività svolta dai soggetti più competenti e capaci che compongono la comunità, perseguire risultati efficienti e socialmente giusti, sostituendo la democrazia comunemente intesa con qualche forma di epistocrazia.
Ha ragione Brennan? Non proprio; meglio, avrebbe ragione se la democrazia fosse priva, come egli suppone, di elementi intrinseci idonei a garantire che le decisioni siano assunte con competenza e capacità. Le critiche di Brennan alla democrazia rappresentativa non sono che una variante dei numerosi tentativi da sempre portati avanti dall’ideologia neoliberista di rimuovere i “lacci e laccioli” che, a dire dei suoi sostenitori, inceppano il libero funzionamento del marcato, a causa di una distribuzione inappropriata del potere politico, resa possibile dall’organizzazione democratica dello Stato sociale di diritto. La forma di democrazia realizzabile all’interno di tale tipo di Stato è però sufficientemente dotata di “anticorpi” contro i pericoli di una deriva del processo decisionale, che Brennan paventa; se gli “anticorpi” non funzionano, non dipende tanto dalla democrazia in sé, quanto dal fatto che essa è rimasta ancora incompiuta, oppure perché alcuni suoi capisaldi, come i partiti, hanno smarrito il ruolo e la funzione che avevano all’origine, rendendo plausibile, per i critici della democrazia, la presunzione di poter sostituire, nell’interesse di tutti, un governo democraticamente espresso, con il governo di una ristretta “élite di professionals”.
Già Cassese nella Prefazione al libro di Brennan traccia i motivi per cui le proposte sul tipo di quella avanzata da questo autore non sono accettabili. La democrazia rappresentativa – afferma Cassese – “è nata come forma epistocratica e tale è rimasta per lungo tempo, nell’antichità prima e poi per tutto il periodo del suffragio limitato”. Successivamente, con la progressiva costruzione dello Stato sociale di diritto, il suffragio è stato allargato a tutti indistintamente e indipendentemente da ogni considerazione riguardante il genere, il censo e il colare della pelle degli individui, sulla base dell’assunto che l’eguaglianza formale e quella sostanziale in materia politica procedessero congiuntamente. Non casualmente, infatti, le Costituzioni moderne stabiliscono che è compito dello Stato “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono l’effettiva partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
Quindi, le Costituzioni moderne, assumendo che possano esistere delle originarie disuguaglianze di diverso ordine e tali da ostacolare la partecipazione politica al funzionamento dello Stato, stabiliscono che il problema dei cittadini “non educati” e quello dei rappresentanti politici “non competenti” siano progressivamente risolti, pena il “cattivo” funzionamento della democrazia. Sin tanto, però, che tale problema resterà irrisolto, o solo parzialmente risolto, la democrazia compatibile con lo Stato sociale di diritto è destinata a rimanere incompiuta e a manifestare forme evidenti di “zoppia”, destinate ad alimentare le ragioni, non disinteressate, dei neoliberisti nel sostenere la convenienza che al governo della comunità accedano i “professionals”.
Nel tentativo di rimuovere i problemi dell’”incompetenza politica dei cittadini e dei loro rappresentanti”, un ruolo basilare è stato svolto dai partiti, i quali – afferma Cassese – “hanno supplito gli Stati in un compito essenziale, quello di portare persone capaci e con esperienza alla guida di quella macchina complessa che sono oggi i poteri pubblici”. Sennonché, a un certo punto, anche i partiti sono venuti meno al loro ruolo, come dimostra il loro modo d’essere attuale, per cui buona parte dei rappresentanti del popolo presenta un grado di mediocrità tale da suscitare reazioni antidemocratiche, rafforzando le tesi delle quali è portatrice l’ideologia neoliberista.
Di conseguenza, oggi, la persistenza dell’incompletezza dei presupposti della democrazia non fa dell’epistocrazia una valida alternativa alla democrazia rappresentativa; se ciò accadesse – afferma Raffaele Di Mucci nell’Introduzione al libro di Brennan – si finirebbe “per privilegiare ancora di più i già privilegiati”, ovvero coloro che hanno avuto, e continuano ad avere, le maggiori opportunità per acquisire capacità e competenze. Per sventare il pericolo che la critica dell’ideologia neoliberista alla democrazia rappresentativa possa ulteriormente diffondersi tra i cittadini, occorre aumentare l’impegno dello Stato ad eliminare le differenze che ancora permangono tra uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale in materia politica e ricuperare l’antico ruolo dei partiti politici; da un altro lato, occorre incrementare l’informazione tra i cittadini, soprattutto quella che origina dal dibattito attraverso un loro maggiore accesso ai mezzi d’informazione.
In questo modo sarebbe garantita la diffusione della cultura del discorso critico, la quale diverrebbe patrimonio di tutti, anziché essere appannaggio, come alcuni vorrebbero, di una ristretta “élite di professionals”, secondo l’affermazione di Karl Raimund Popper, in “La lezione di questo secolo”. Ciò avrebbe importanti conseguenze a livello politico, quali, esempio, quella di rifiutare qualsiasi decisione collettiva senza pubblico confronto, quella di mettere in discussione l’autorità costituita quando la sua azione mancasse di rispondere alle aspettative dei cittadini e quella del radicamento nel popolo delle fede nella necessità che sia sempre rispettato il diritto a partecipare ai processi decisionali politici.
Nel loro insieme queste conseguenze avrebbero l’effetto di rendere politicamente inappropriata, perché conservativa, per non dire reazionaria, qualsiasi proposta di natura epistocratica, in quanto la democrazia, già di per sé, è autosufficiente; basta realizzarla compiutamente, o impedire che alcune sue parti già portate a compimento siano ingiustificatamente soppresse.
* Anche su Avanti online.
Oggi venerdì 6 aprile 2018

![]()








![]() ——————–Dibattiti&Commenti———————–
——————–Dibattiti&Commenti———————–
 La Babele sale al Quirinale
La Babele sale al Quirinale
6 Aprile 2018
Norma Rangeri – Il Manifesto
Democraziaoggi pubblica come contributo alla riflessione sulla situazione attuale un editoriale della direttrice de Il manifesto, di cui, peraltro, precisa di non condividere molti giudizi.
————————–
Siamo realisti, cerchiamo l’impossibile

Dall’utopia a un programma di governo
di Roberta Carlini.
«Perché dovrebbe importarmene delle generazioni future? Cosa hanno fatto loro per me?». Inizia così, con una battuta di Groucho Marx, un libro sul quale è bene spostare l’attenzione, distraendola dal copione delle trattative preliminari alla formazione dei futuri equilibri di potere, e spostandola sui contenuti di un’azione di governo. Il libro si intitola «L’utopia sostenibile», l’autore è Enrico Giovannini (Laterza 2018).
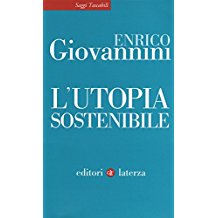
Economista, statistico, già presidente dell’Istat e già ministro del lavoro (nella breve parentesi del governo Letta, quella chiusa dallo scampanellio arrembante di Renzi: sembra un secolo fa), Giovannini ha legato gran parte della sua attività nell’ultimo quindicennio al tema della sostenibilità. Lavorando, dall’Istat e dall’Onu, sulla revisione degli indicatori, poiché sono i numeri che spesso ci indicano quel che dobbiamo fare oppure ci delimitano i sentieri per farlo: dall’Istat, ha posto le basi per il passaggio dalla misurazione del Pil (prodotto interno lordo) a quella del Bes (benessere equo e sostenibile). Ha fondato l’Alleanza italiana per lo sviluppo equo e sostenibile, che diffonde la cultura della sostenibilità, tra le altre cose con un festival annuale – che quest’anno si svolgerà dal 22 maggio al 7 giugno, con eventi sparsi in tutt’Italia.
L’utopia è un non luogo, un’aspirazione, una tendenza continua che, per definizione secolare, è destinata a non realizzarsi ma a seminare futuro. Eppure, il libro di Giovannini è un programma concreto per l’utopia. È difficile che gli economisti, alle prese con i vincoli legati alle risorse scarse, si occupino di utopie. Eppure necessario, visto che – ha spiegato Giovannini qualche giorno fa nel corso di una presentazione romana del suo libro, nella sede di una biblioteca comunale intitolata a Tullio De Mauro – «la vera utopia sarebbe pensare di poter restare nella situazione in cui siamo». A quarantasei anni dall’evento che introdusse lo sviluppo sostenibile nel dibattito pubblico e istituzionale, il Club di Roma del 1972 sui limiti ambientali allo sviluppo, molte cose sono cambiate. Vertici e trattati internazionali hanno via via fissato princìpi, individuato obiettivi, vincolato i governi su carte e trattati. Nei contenuti, il salto più importante è stato nel passaggio a una concezione ampia della sostenibilità: non ci si riferisce più al solo tema ambientale. L’insostenibilità del saccheggio del pianeta è scientificamente provata, il cambiamento climatico obbliga ad azioni immediate e concrete, dunque l’ambiente resta al primo posto nell’agenda della sostenibilità. Ma questa si arricchisce di altri pilastri necessari: quello sociale, quello economico e quello istituzionale. Non è insostenibile solo il fatto che – per stare solo ai numeri italiani – ogni anno muoiono 60mila persone a causa dell’inquinamento; ma anche il fatto che 4,7 milioni di persone vivono al di sotto della soglia della povertà, oltre 2 milioni di giovani non lavorano né studiano né fanno formazione, che il 5% delle famiglie più abbienti detiene la stessa ricchezza del 75% delle famiglie meno abbienti, che il 18% delle case esistenti è abusivo e che l’80% delle specie ittiche è in condizioni di sovrasfruttamento.
retroutopia
 Questi non sono giudizi morali o politici, ma scostamenti, statisticamente individuati e misurati, dagli obiettivi che noi stessi, come comunità, ci siamo dati: i Millennium Goals, gli obiettivi per il 2030 firmati nel 2015 nella conferenza di Parigi. Se le tendenze restano quel che sono, mancheremo la gran parte degli obiettivi. Siamo già adesso indietro quasi su tutti, in particolare per l’aggravamento della diseguaglianza sociale ereditata dalla crisi e per il nulla di fatto per la difesa dell’ecosistema e dell’acqua. Eppure, non se ne parla, come se quelle carte fossero solo un belletto messo in occasioni ufficiali, e la vera politica, i veri programmi, le cose davvero importanti si svolgessero altrove. La stessa Europa, che «è stata finora la campionessa mondiale dello sviluppo sostenibile» per gli impegni presi e scritti nelle sedi internazionali, al suo interno ha aggravato l’insostenibilità, e procede con grandissime differenze da Stato a Stato. Dando così ragione alla versione scettica e banalizzante della parola «utopia»: bei propositi, ma nel mondo dei sogni; la realtà è un’altra. E negando che, invece, proprio la realtà ci mostra la necessità e l’urgenza di muoversi. Anzi, ci siamo già mossi, però in direzione opposta a quella dell’utopia: quella che Bauman ha chiamato la «retrotopia», ossia la tendenza a cercare rifugio nel passato; di fronte all’aumento del disagio sociale, dell’incertezza sul futuro, della povertà materiale e dei dissesti ambientali, della tecnologia che crea disoccupazione e della globalizzazione che taglia le fabbriche, invocare e sognare il ritorno a un’età dell’oro che forse non è mai esistita. Un’età spesso collegata a un mondo più facile, più chiuso, nel quale si possono presidiare i confini da persone e merci, nel quale la propria Nazione era grande (l’America first di Trump e i sogni della grandezza imperiale della Brexit), e difendere un’identità rassicurante di fronte a cambiamenti tutti vissuti in modo negativo.
Questi non sono giudizi morali o politici, ma scostamenti, statisticamente individuati e misurati, dagli obiettivi che noi stessi, come comunità, ci siamo dati: i Millennium Goals, gli obiettivi per il 2030 firmati nel 2015 nella conferenza di Parigi. Se le tendenze restano quel che sono, mancheremo la gran parte degli obiettivi. Siamo già adesso indietro quasi su tutti, in particolare per l’aggravamento della diseguaglianza sociale ereditata dalla crisi e per il nulla di fatto per la difesa dell’ecosistema e dell’acqua. Eppure, non se ne parla, come se quelle carte fossero solo un belletto messo in occasioni ufficiali, e la vera politica, i veri programmi, le cose davvero importanti si svolgessero altrove. La stessa Europa, che «è stata finora la campionessa mondiale dello sviluppo sostenibile» per gli impegni presi e scritti nelle sedi internazionali, al suo interno ha aggravato l’insostenibilità, e procede con grandissime differenze da Stato a Stato. Dando così ragione alla versione scettica e banalizzante della parola «utopia»: bei propositi, ma nel mondo dei sogni; la realtà è un’altra. E negando che, invece, proprio la realtà ci mostra la necessità e l’urgenza di muoversi. Anzi, ci siamo già mossi, però in direzione opposta a quella dell’utopia: quella che Bauman ha chiamato la «retrotopia», ossia la tendenza a cercare rifugio nel passato; di fronte all’aumento del disagio sociale, dell’incertezza sul futuro, della povertà materiale e dei dissesti ambientali, della tecnologia che crea disoccupazione e della globalizzazione che taglia le fabbriche, invocare e sognare il ritorno a un’età dell’oro che forse non è mai esistita. Un’età spesso collegata a un mondo più facile, più chiuso, nel quale si possono presidiare i confini da persone e merci, nel quale la propria Nazione era grande (l’America first di Trump e i sogni della grandezza imperiale della Brexit), e difendere un’identità rassicurante di fronte a cambiamenti tutti vissuti in modo negativo.
l’appello alla ragione contro quello alla pancia
Qui arriva la parte più interessante del libro, che è politica. Dopo aver ripercorso le tappe istituzionali e storiche della evoluzione delle «utopie sostenibili», aver chiarito e raccontato il ruolo della statistica, del potere dei numeri nel tracciare le politiche, Giovannini entra nel mezzo della questione che sta invadendo e scuotendo le nostre democrazie, mettendone a rischio la tenuta anche dal punto di vista istituzionale. Succede ogni volta che, in nome di una «retrotopia», vince chi parla al cuore (alla pancia, si dice spesso) delle tante persone danneggiate, o solamente impaurite, dagli enormi cambiamenti che tutti insieme ci sono precipitati addosso. Non si vince contro queste tendenze difendendo lo status quo o continuando a proporre ricette basate su un modello economico-politico che non funziona più, dai punti di Pil che risalgono alle spinte vecchio stile all’economia. «Mi rendo perfettamente conto – scrive Giovannini – che non si vincono le campagne elettorali spaventando gli elettori con scenari catastrofici senza indicare le possibili soluzioni, ma credo sia altrettanto evidente che vincere una campagna elettorale con promesse mirabolanti basate sul ‘vecchio paradigma’ non seguite da un significativo e duraturo miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini renderebbe estremamente difficile non solo la rielezione, ma la stessa ‘tenuta’ delle società democratiche: infatti, la sfiducia nelle istituzioni e in chiunque abbia governato in passato, a tutto beneficio di ‘facce’ o ‘storie’ nuove, comprese quelle basate su messaggi cosiddetti ‘populismi’ o ‘antisistema’, non farebbe che aumentare, con significativi rischi per l’assetto faticosamente costruito in Europa negli ultimi sessant’anni».
trasformare l’utopia
in programma di governo
Difficile non vedere in queste parole, scritte prima delle elezioni italiane di marzo, una sceneggiatura di quel che poi è successo. L’appello alla «ragione» contro quello alla «pancia» non ha perso solo perché difficile, complesso, a suo modo elitario; ma perché ha invocato una ragione smentita dai fatti, un accompagnamento dell’esistente – che basterebbe solo raccontare e gestire meglio, nell’idea della ex-sinistra che ha perso il governo – che non ne ha compreso l’insostenibilità.
Quale l’alternativa allora, per chi non vuole limitarsi ad agitare catastrofi e cavalcare paure? Nel libro, scritto per la divulgazione e non come saggio scientifico, Giovannini si sforza di trasformare l’utopia in un programma di governo, individuare obiettivi raggiungibili e i percorsi per arrivarci, chiarire quello che si può fare in una singola nazione e quello che deve necessariamente essere fatto a livello sovranazionale, europeo per cominciare. Ci sono passi concreti, politiche specifiche e passaggi con valore simbolico – come nella proposta di introdurre il principio della sostenibilità in Costituzione. Ma soprattutto quello che ci serve, scrive Giovannini, è un cambiamento di mentalità, senza il quale «non potremo realizzare la trasformazione necessaria del nostro mondo al tempo dell’Antropocene. Essere diventati così potenti da determinare addirittura le caratteristiche di un’era geologica richiede a tutti noi di assumere una piena responsabilità per la gestione comune della nuova condizione in cui ci troviamo. D’altra parte – aggiunge – questo è esattamente ciò che papa Francesco intende quando si richiama alla necessità di una ‘ecologia integrale’ in grado di tenere insieme l’ecosistema e quello che ho chiamato ‘sociosistema’». Dunque, «sviluppare tecnologie ri- solutive, migliorare la governance delle nostre società, cambiare mentalità. Difficile, ma non impossibile».
Roberta Carlini
——–

———————–
Sullo stesso tema

Da Pandora: recensione di Giulio Andrea Del Boccio.
Oggi giovedì 5 aprile 2018

![]()








![]()
——————–Dibattiti&Commenti—————
 Oggi l’Italia è a un bivio fra democrazia e oligarchia
Oggi l’Italia è a un bivio fra democrazia e oligarchia
5 Aprile 2018
 Andrea Pubusa su Democraziaoggi.
Andrea Pubusa su Democraziaoggi.
————————————-
Cittàquartiere
 CITTÀ E TERRITORIO » TEMI E PROBLEMI » SPAZIO PUBBLICO
CITTÀ E TERRITORIO » TEMI E PROBLEMI » SPAZIO PUBBLICO
Gli standard urbanistici compiono cinquant’anni
di MAURO BAIONI su eddyburg, ripreso da aladinews.
Il 2 aprile 1968 è stato approvato il decreto interministeriale sugli standard urbanistici che sancisce l’obbligo di riservare, nei piani urbanistici, almeno 18 mq di suolo destinato a spazi pubblici e attività collettive per ogni abitante. Un obbligo posto a garanzia di un diritto sociale.
Dibattito. Oltre il 4 marzo
 Pd. Una disfatta annunciata
Pd. Una disfatta annunciata
di Francesco Casula
Il risultato elettorale del Pd del 4 marzo scorso era ampiamente previsto e annunciato in seguito alla debacle fragorosa nelle elezioni amministrative del 2016 (pensiamo solo a Roma e Torino) ma soprattutto al referendum istituzionale e costituzionale.
In modo insipiente il Pd, per giustificare quella disfatta parlò allora di “insufficiente comunicazione” e di eccessiva “personalizzazione”. Ma soprattutto, in modo ancor più stolto, Renzi e i suoi, forse per autoconsolarsi, si attribuirono il 40% dei Sì. Non comprendendo che almeno la metà di quei voti erano riconducibili all’elettorato berlusconiano e alle frattaglie più propriamente centriste. E’ pur vero infatti che il pregiudicato di Arcore, formalmente e ufficialmente, aveva dato ordine di votare No, ma in realtà la visione politica sua e del suo elettorato, era tutta all’interno delle motivazioni, del senso complessivo e delle finalità del sì.
Ricordo sinteticamente che gli ispiratori di quella Controriforma costituzionale (in senso centralistico e con tratti autoritari), e dunque i veri padri putativi e politici, erano fra gli altri, la P2 di Licio Gelli e la Banca JP Morgan.
Il Gelli che con il Piano di Rinascita democratica aveva disegnato e prospettato uno stato autoritario con un Parlamento che perde la sua centralità a favore di un premierato forte, con una enorme concentrazione di potere nelle mani dell’esecutivo e del suo capo. E che nel contempo voleva uno Stato antisociale, con il Sindacato ridotto a collaboratore del fenomeno produttivo, l’abolizione dell’art. 18 ecc.
Dal canto suo in un documento del 28 maggio 2013 la Banca Morgan, una delle grandi istituzioni della finanza speculativa mondiale, aveva scritto che le riforme liberiste nei paesi europei periferici, Italia, Spagna, Grecia, Portogallo, non si erano potute realizzare pienamente a causa degli ostacoli frapposti dalle relative costituzioni nazionali. Troppo democratiche. Troppo sociali, anzi, “socialiste”! Quattro i difetti fondamentali delle Costituzioni adottate in Europa nel dopoguerra: a) una debolezza degli esecutivi nei confronti dei Parlamenti; b) un’eccessiva capacità di decisione delle Regioni nei confronti dello Stato; c) la tutela costituzionale del diritto del lavoro; d) la libertà di protestare contro le scelte non gradite del potere.
Bene. Alcuni obiettivi proposti da Gelli-Morgan, Renzi li ha perseguiti e ottenuti (abolizione dell’art.18, Jobs act, Buona scuola). Cui occorre aggiungere la Legge Fornero e altre sciagurate e antisociali scelte: sempre con governi sostenuti principalmente dal Pd.
Di qui l’esito fallimentare nelle elezioni del 4 marzo scorso. Di qui l’epilogo di un processo e progetto che ha visto, nel corso degli anni, viepiù la mutazione genetica del Pd: una mutazione antropologica prima ancora che culturale e politica. Nella direzione di un Partito “governativo” (a prescindere dai contenuti, e non a caso sostenuto, organicamente anche da forze di centro-destra) e dell’establishement, dei poteri forti e delle banche, della tecnocrazia e della finanza europea . Che ha come referenti sociali Marchionne e non gli operai; guru della finanza come Davide Serra e non i risparmiatori truffati dalle banche.
La controprova? Al referendum votano Sì nei quartieri romani dell’Eur e dei Parioli. O al centro di Bologna o Milano. Gli stessi che votano il Pd il 4 marzo.
Dalle analisi de voto da parte degli Istituti di ricerca (in primo luogo il Censis) risulta infatti che nelle scorse elezioni i giovani e i disoccupati si astengono o votano 5 stelle; gli operai (e le casalinghe) votano ancora 5 stelle o Lega. La classe media, sempre più impoverita e, giustamente viepiù riottosa vota 5 stelle con gli impiegati pubblici e Lega con gli artigiani e i lavoratori autonomi. Votano Pd i pensionati “garantiti” ma soprattutto la classe medio-alta e alta e le élites socio-culturali con molte possibilità e opportunità.
Per spiegare il fallimento di un’ipotesi di partito come quello del Pd c’è di più: l’aver sposato la globalizzazione, considerata tout court, come “la modernità”, fonte e scaturigine di magnifiche sorti e progressive.
Una globalizzazione – in buona sostanza la forma e la traduzione attuale e moderna del liberismo e del capitalismo – che ha creato e continua a creare immani disuguaglianze, aumentando per moltissimi (per la moltitudine, direbbe Toni Negri – vedi Impero, Rizzoli, 2003) precariato, emarginazione, disoccupazione e povertà; e per pochissimi privilegiati immani ricchezze e potere.
Occorre inoltre ricordare che sull’altare del progresso globalizzante, segnato dall’orgia neoliberista e dunque dal furore del profitto, del produttivismo, del denaro e del consumo, scandito dalla semplice accumulazione di beni materiali e fondato sulla onnipotenza della tecnostruttura – di cui parla Jean Braudillard – ovvero sulla tecnologia e gli apparati di dominio politico, si è sconquassato il territorio, devastato l’ambiente, compromettendo forse in modo irreversibile gli equilibri dell’ecosistema.
Ma non solo. La globalizzazione infatti produce una società che si atomizza e si frammenta. E cerca di omologare destra, sinistra e centro; annullando progressivamente le specificità; ibernando nella bara della tecnica, del calcolo economico, dell’iperliberismo, della mercificazione, le identità politiche, sociali, etniche.
Cerca inoltre di ammutolire la politica, mettendo al bando l’idea stessa di cambiamento.
E sarebbe questa la modernità? Possibile che il Pd non capisca che la globalizzazione con la standardizzazione e l’omologazione, insomma con la reductio ad unum, rappresenta una catastrofe e una disfatta, economica e sociale ancor prima che culturale, per gli individui e per i popoli?
Eva canta
 Eva canta, romanzo di Maria Tiziana Putzolu Mura
Eva canta, romanzo di Maria Tiziana Putzolu Mura
di Raffaele Deidda
 Maria Tiziana Putzolu Mura muove la narrazione del suo romanzo su diversi piani temporali, alimentati da pezzi di storie e da frammenti di ricordi che riprendono vita attraverso il racconto di Elena. Un racconto affascinante che coinvolge il lettore e lo porta a calarsi nei contesti, negli eventi, nei luoghi dove si snoda la vita di una famiglia di imprenditori che dalla “città delle biciclette”, Ferrara, durante il periodo fascista muove l’esistenza di tutti i suoi membri verso la Libia, in particolare a Tripoli “Bel suol d’amore”, per realizzare le infrastrutture utili all’insediamento dei coloni italiani. [segue]
Maria Tiziana Putzolu Mura muove la narrazione del suo romanzo su diversi piani temporali, alimentati da pezzi di storie e da frammenti di ricordi che riprendono vita attraverso il racconto di Elena. Un racconto affascinante che coinvolge il lettore e lo porta a calarsi nei contesti, negli eventi, nei luoghi dove si snoda la vita di una famiglia di imprenditori che dalla “città delle biciclette”, Ferrara, durante il periodo fascista muove l’esistenza di tutti i suoi membri verso la Libia, in particolare a Tripoli “Bel suol d’amore”, per realizzare le infrastrutture utili all’insediamento dei coloni italiani. [segue]
Oggi mercoledì 4 aprile 2018
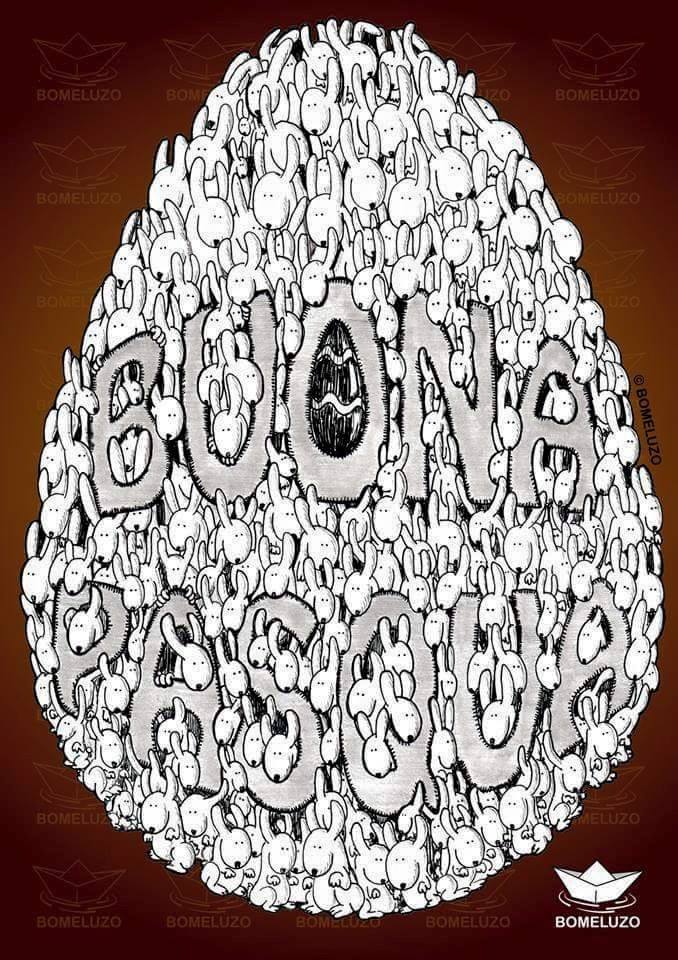 Fino a domani 5 aprile p.v. l’aggiornamento quotidiano della nostra News subirà un rallentamento per consentirci una pausa di riposo e anche di riflessione pasquale.
Fino a domani 5 aprile p.v. l’aggiornamento quotidiano della nostra News subirà un rallentamento per consentirci una pausa di riposo e anche di riflessione pasquale.
.

![]()








![]()
——————–Dibattiti&Commenti—————
 Nella Costituzione al centro c’è il lavoro
Nella Costituzione al centro c’è il lavoro
4 Aprile 2018
Tonino Dessì su Democraziaoggi.
—————————-
Oggi martedì 3 aprile 2018
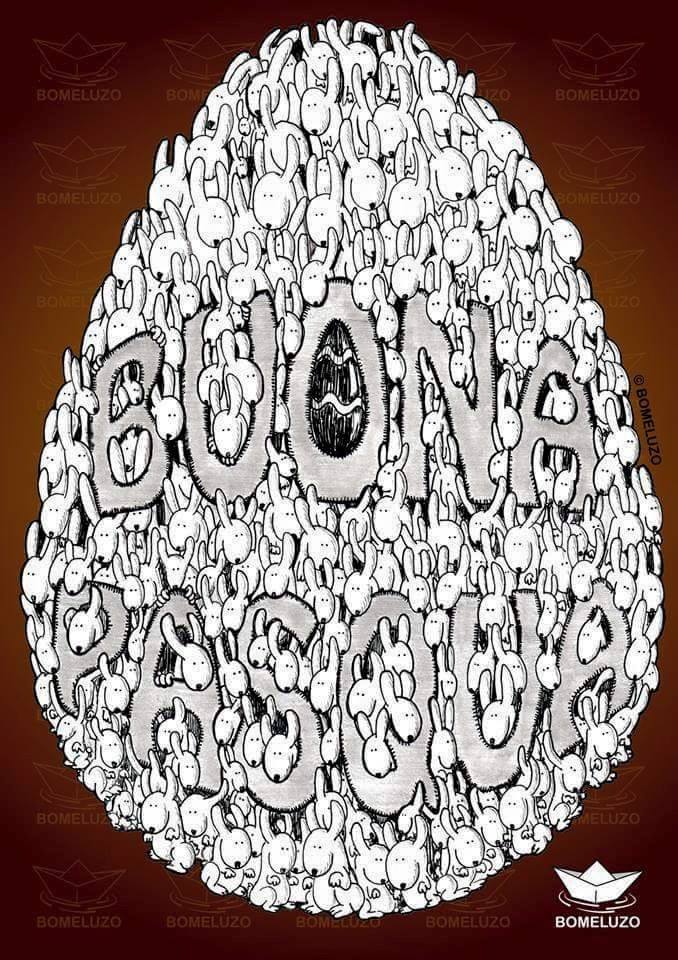 Fino al 5 aprile p.v. l’aggiornamento quotidiano della nostra News subirà un rallentamento per consentirci una pausa di riposo e anche di riflessione pasquale.
Fino al 5 aprile p.v. l’aggiornamento quotidiano della nostra News subirà un rallentamento per consentirci una pausa di riposo e anche di riflessione pasquale.
.

![]()








![]()
——————–Dibattiti&Commenti————–
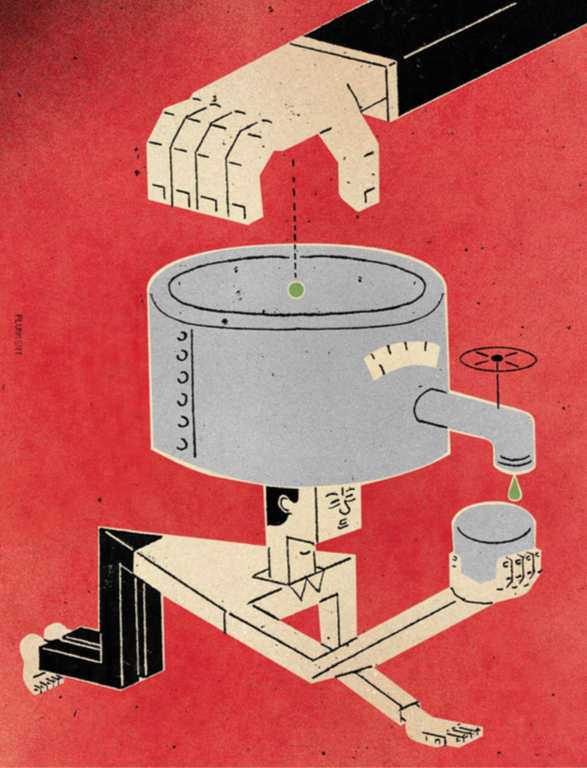 DUE MITI DA SFATARE PER EVITARE L’AGONIA PER PROGETTI DEL TERZO SETTORE
DUE MITI DA SFATARE PER EVITARE L’AGONIA PER PROGETTI DEL TERZO SETTORE
Pubblicato il: 22/03/2018
di Carola Carazzone su Il giornale delle Fondazioni.
Perché le fondazioni filantropiche italiane dovrebbero iniziare a finanziare obiettivi strategici e organizzazioni e non solo progetti? “Il meccanismo dei bandi ha prodotto organizzazioni deboli, in starvation cycle e in concorrenza vitale tra loro e un effetto di adattamento, di isomorfismo delle organizzazioni del terzo settore come progettifici”. Ne scrive Carola Carazzone, segretario generale di Assifero (Associazione italiana delle fondazioni ed enti della filantropia istituzionale) e membro dell’advisory board di Ariadne (European Funders for Social Change and Human rights) e di ECFI (European Community Foundations Initiative). “Il terzo settore italiano (…) che regge un sistema di welfare pubblico traballante, ma non riesce a fare il salto propositivo necessario per essere il motore di trasformazione sociale, il catalizzatore di innovazione e sviluppo umano e sostenibile che potrebbe essere”.
———————————————————-
Il PD, la sinistra e il che fare
3 Aprile 2018
Andrea Pubusa su Democraziaoggi.
—————————————
La crisi del Pd
Francesco Cancellato su Linkiesta.
——————————-
Le diseguaglianze riducono la vita
Misurato l’invecchiamento precoce dei poveri rispetto ai benestanti

I sessantenni che vivono in condizioni socioeconomiche svantaggiose perdono fino a 7 anni di vita trascorsi in buone condizioni fisiche.
L’effetto delle circostanze socioeconomiche sfavorevoli sulla qualità dell’invecchiamento è paragonabile a quello dell’obesità, del diabete e della scarsa attività fisica, ed è addirittura maggiore rispetto a ipertensione e consumo di tabacco.
Oggi lunedì 2 aprile 2018
Intellettuali alla ricerca di senso

Regressione: intellettuali a confronto
di Marco Gallizioli, su Rocca
Che il mondo stia attraversando uno snodo culturale estremamente complesso non è certo uno scoop, ma una semplice constatazione che non necessita di grandi analisti internazionali per essere autenticata. Molto più complesso, invece, è poter analizzare e decodificare i caratteri di questa straordinaria transizione per cercare di comprendere meglio i possibili sviluppi futuri delle nostre società.
una lettura imprescindibile
 Con questo intento, il filosofo ed economista tedesco Heinrich Geiselberger ha chiamato a raccolta alcune delle voci intellettualmente più autorevoli del nostro tempo, da Bauman ad Appadurai, da Latour a Zizek, da Fraser a della Porta, per tentare di districare la matassa intricata della nostra contemporaneità. Da questo sforzo è nato un bellissimo saggio a più mani, pubblicato in tutto il mondo nel 2017, la cui lettura è imprescindibile per chi voglia orientarsi in questo nebbioso e tumultuoso presente che ci è capitato da vivere. Il titolo del lavoro è programmatico e, apparentemente, pessimista: La grande regressione: quindici intellettuali di tutto il mondo spiegano la crisi del nostro tempo (1).
Con questo intento, il filosofo ed economista tedesco Heinrich Geiselberger ha chiamato a raccolta alcune delle voci intellettualmente più autorevoli del nostro tempo, da Bauman ad Appadurai, da Latour a Zizek, da Fraser a della Porta, per tentare di districare la matassa intricata della nostra contemporaneità. Da questo sforzo è nato un bellissimo saggio a più mani, pubblicato in tutto il mondo nel 2017, la cui lettura è imprescindibile per chi voglia orientarsi in questo nebbioso e tumultuoso presente che ci è capitato da vivere. Il titolo del lavoro è programmatico e, apparentemente, pessimista: La grande regressione: quindici intellettuali di tutto il mondo spiegano la crisi del nostro tempo (1).
Innanzitutto, occorre definire cosa si intenda con «regressione», definendone i caratteri. Ciò è fondamentale se non si vuole confondere questa bellissima raccolta di saggi con una geremiade fine a se stessa. Inquadrare in termini culturale il senso dell’attuale «regressione» è, paradossalmente, l’unico modo per avanzare verso nuovi sviluppi del pensiero. In termini generali, per Geiselberger, con «regressione» si deve intendere un abbassamento del livello di civilizzazione (2), una compromissione di ciò che nel passato recente e in occidente si era dato per acquisito in termini di diritti e benessere. In primo luogo, infatti, si deve sottolineare che il nostro universo culturale ha perso fiducia nel concetto di progresso. Anche se ciò pare un paradosso in società sospinte dall’ipertecnologia verso il perpetuo e ansiogeno cambiamento, in realtà, a ben vedere, la mancanza di fiducia nel futuro sembra essere una strisciante e implicita condizione del nostro humus culturale. In uno dei suoi ultimi lucidissimi contributi, posto in apertura dell’opera, Zygmunt Bauman sostiene che «mentre le generazioni precedenti vedevano nel futuro il luogo più sicuro e promettente verso cui rivolgere le proprie speranze, noi tendiamo a proiettare su di esso soprattutto le nostre paure e le nostre angosce» (3). Siamo diventati timorosi, quando non proprio pessimisti e spaventati. Le nostre apprensioni si declinano in un profondo senso di incertezza connesso alla precarizzazione del lavoro, o causato dalla diminuzione del tenore di vita e delle tutele sociali, dal senso di provvisorietà sottolineato dall’estrema fragilità delle relazioni interpersonali e da un sempre più pervasivo panico da immigrazione. Insomma, per dirla col sociologo polacco, si ha l’impressione di non riuscire più a controllare in modo pacato e razionale le proprie esistenze.
sovranità economica compromessa
A livello più ampio questo senso di regresso sociale, si connette con l’inconsistenza delle leadership politiche mondiali, sempre più balbuzienti in termini di proposte e di prospettive, e sempre più pericolosamente populiste e autoritarie. In altre parole, la politica avverte l’erosione della sovranità economica di ciascuno stato e cerca di sostituire questa avvenuta erosione dell’indipendenza produttiva e finanziaria con una neo-sovranità culturale di stampo più o meno larvatamente nazionalistica. Ma cosa si intende per sovranità economica compromessa? Risponde a questo interrogativo un’altra voce autorevole dell’antropologia culturale contemporanea, Arjun Appadurai, quando sottolinea che nessuno stato, oggi, si mostra di fatto autosufficiente, anzi, al contrario ogni economia è tenuta sotto scacco di un’altra in una sorta di inestricabile interrelazione. Così, il motore economico americano dipende dalla Cina, che, a sua volta, è legata alle materie prime africane o asiatiche e ai paesi produttori di petrolio che, a loro volta, sono connessi al funzionamento del mercato occidentale e globale. Per questo «la sovranità economica, come base della sovranità nazionale (…) oggi diventa sempre più irrilevante» (4) e la politica, per acquisire combustibile ideologico, devia la propria attenzione sul tema culturale, rispolverando e riattualizzando una forma di pensiero nazionalistico. Vladimir Putin, in Russia, cerca di fondare il suo successo politico usando una retorica antieuropeista che ponga in rilievo i valori russi tradizionali, e, fatte le debite proporzioni, in maniera analoga si comportano in Turchia, Erdogan, in India, Narendra Modi e, negli Usa, Donald Trump. Questi leader, usando linguaggi specifici, cercano di mascherare l’affanno economico con una revanche di tipo nazionalistico, condita di retorica destrorsa, capace di mescolare tra loro populismo, virilismo misogino, xenofobia, neoliberismo e una certa insana dose di megalomania.
Lo scivolamento verso destra del pensiero politico globale, dunque, costituisce un altro aspetto della regressione, non tanto perché sia antitetico rispetto ad una concezione progressista, intesa come bene assoluto, ma, più semplicemente, perché la risposta culturale che queste forme di leadership politiche offrono è debole e incentrata solo sul creare e ricreare un senso diffuso di risentimento. Un ulteriore aspetto di quello che U. Beck chiamava «il dramma cosmopolitico» (5) sta proprio nel fatto che, da un lato, il mondo vive una realtà sempre più interconnessa e interdipendente e, dall’altro, non produce alcun pensiero realmente cosmopolita, anzi, si sforza di alimentare una cultura della paura, del timore e del sospetto. Il «panico da immigrazione» (6), come lo definisce Bauman, si rinforza via via sempre più, per la ragione che non esiste alcuna rete di riflessione internazionale capace di «pensare» il fenomeno globale. Più specificatamente, poi, il sociologo definisce tale panico ancora più angosciante, perché in realtà non coincide con un reale timore verso l’immigrato, ma con un panico rivolto alla condizione esposta e debole del migrante. Se l’immigrato è colui che viene da un posto e cerca di inserirsi in un altro luogo, attribuendo un senso al suo vagare, il «migrante», invece, è parte di un flusso umano che fugge verso qualcosa di indefinito e, per questa ragione, il suo vagare è drammaticamente inarrestabile.
creare una logica globale del «noi»
Se, dunque, il fenomeno della diaspora migrante è, per sua stessa natura inarrestabile e, in sé, in grado di generare paura e senso del rischio, giocoforza la questione dell’assimilazione non può più essere rinviata, né culturalmente demonizzata, come, invece, sembrano voler fare i leader mondiali più apertamente populisti. Al contrario, è sempre più imperativo creare una logica globale del «noi» che lentamente si imponga sulla mentalità contrastiva del «loro», secondo la quale lo straniero è l’estraneo che minaccia la mia visione culturale. Questa logica del «noi» o, per dirla con Francesco Remotti (7), del «noialtri», rispetto a quella del «voi» o del «voialtri», non è più rimandabile, né può essere coperta con la benzina ideologica rappresentata da una concezione xenofoba semplificatoria. Ovviamente, la logica del «noi» comporta molti problemi e infinite questioni, chiamando in causa le differenze culturali, filosofiche e religiose, alcune delle quali paiono sulla carta inconciliabili e davanti alla cui complessità nessuno si deve illudere di trovare facili soluzioni, ma la rinuncia apriori di tentare mediazioni per la creazione di una visione davvero cosmopolita e, insieme rispettosa delle diversità, non è una alternativa. Occorre anche pensare, con l’antropologo norvegese Frederick Barth (8), se e quanto la sottolineatura delle differenze culturali preesista o sia successiva alla creazione delle frontiere, ossia se in qualche modo non siamo culturalmente portati ad evidenziare il differente dell’altro per salvaguardare il proprio isolamento piuttosto che individuarne le analogie. Senza diventare drastici, cancellando evidenti inconciliabilità tra le culture, appare altresì evidente che è la violazione della frontiera che attiva un discorso della differenza e del disprezzo per la diversità. In altre parole, ci sentiamo più diversi dagli altri, quando ce ne sentiamo minacciati.
La logica del «noi», ossia lo sforzo di pensare davvero una politica globale e globalizzata in cui le questioni di tutte le comunità umane possano essere affrontate in maniera integrata, se forse appare ad alcuni un’utopia, rappresenta una via molto più concreta e pragmatica delle pseudo risposte finora elaborate dalla politica. La nostalgia di un mondo pre-globale, oppure l’adesione a movimenti identitari che si alimentino di xenofobia e islamofobia, la retorica di demagoghi identitari, secondo Geiselberger (9), sono modalità per non arginare e, addirittura, per acuire l’aspetto regressivo della cultura. Secondo Appadurai, poi, non solo non si è generata alcuna valida riflessione capace di generare una nuova logica inclusiva mondiale, ma si è sviluppato anche uno strisciante pensiero antidemocratico sempre più diffuso proprio all’interno delle grandi democrazie occidentali. Quasi tutte le consultazioni elettorali dei grandi paesi liberi del mondo portano in superficie, attraverso lo strumento democratico del voto, una sorta di insofferenza verso il sistema democratico in quanto tale, premiando generosamente chi si fa portabandiera di un programma anti-inclusivo.
una nota di speranza
Una prima parziale via d’uscita a questa condizione regressiva viene indicata proprio dall’anziano Bauman che, a un passo dalla morte, ha mantenuto lucidi i risvolti pessimistici della crisi e, insieme, ha saputo elaborare anche una nota di speranza. Il sociologo polacco trova nell’invito alla cultura del dialogo, formulato da papa Francesco, forse l’unico vero appiglio per uscire da una impasse negativa e angosciante del pensiero. Nella visione del papa, la cultura del dialogo implica «(…) un autentico apprendistato, un’ascesi che ci aiuti a riconoscere l’altro come un interlocutore valido; che ci permetta di guardare lo straniero, il migrante, l’appartenente a un’altra cultura come un soggetto da ascoltare, considerare e apprezzare» (10). Per il pontefice, la pace si realizza, paradossalmente, solo armandosi con le armi del dialogo, dell’incontro e della negoziazione, ossia armi che producano vita e non morte. La cultura del dialogo dovrebbe diventare, così, una prassi educativa, capace di formare le nuove generazioni a modalità inedite per la gestione dei con- flitti. A conclusione della sua riflessione, Bauman, convinto dalle parole di papa Francesco, sostiene che solo educandosi a una cultura del dialogo si può sperare di trovare una soluzione ai problemi del nostro tempo, sapendo che tale soluzione non sarà affatto dietro l’angolo, ma anzi pretenderà «una riflessione e una pianificazione sul lungo periodo, due arti purtroppo dimenticate e raramente messe in pratica in questi tempi affrettati vissuti sotto la tirannia del momento» (11). Solo ponendosi alla ricerca di soluzioni sovrannazionali e cosmopolite si potrà uscire dallo stallo regressivo attuale, sapendo che l’unica soluzione auspicabile è quella di individuare menti lucide che desiderino veramente cominciare a pensare un mondo nuovo. Quella che, forse, può sembrare una risposta inconcludente o fumosa, in realtà si dimostra essere l’unica vera possibile soluzione: per abitare il nostro tempo dobbiamo compiere lo sforzo lento di elaborare nuove strategie che comportino un approccio integrato dei problemi e questo pensiero costa in termini di fatica e di messa in gioco di sé. Forse, dunque, la vera regressione sta nel contemplare che, in realtà, questa messa in discussione di sé non è un’opzione valida per i più. Così come, forse, non credere in questa lettura pessimistica è l’unico modo per invertire la regressione culturale stessa.
Marco Gallizioli
—————–
Note
(1) H. Geiselberger (a cura di), La grande regressione. Quindici intellettuali da tutto il mondo spiegano la crisi del nostro tempo, Feltrinelli, Milano 2017.
(2) H. Geiselberger, Introduzione, in cit. p. 11. (3) Z. Bauman, Sintomi alla ricerca di un oggetto e di un nome,incit.p.32.
(4) A. Appadurai, L’insofferenza verso la democrazia, in cit. p. 18.
(5) Cfr. U. Beck, Lo sguardo cosmopolita, Carocci, Roma 2005.
(6) Cfr. Z. Bauman, op. cit., p. 33.
(7) Cfr., F. Remotti, L’ossessione identitaria, Laterza, Roma-Bari 2010, pp. 24-50.
(8) Cfr. F. Barth, Ethnic Groups and Boundaries. The Social Organization of Culture Difference, Waveland Press, Long Grove – Illinois 1998.
(9) H. Geiselberger, op. cit., p. 10.
(10) Dal Discorso del Santo Padre Francesco, 6 maggio 2016: http://vatican.va/content/france- sco/it/speeches/2016/may/documents/papa- francesco_20160506_premio-carlo-magno.html.
(11) Z. Bauman, op. cit., p. 43.
—————————-





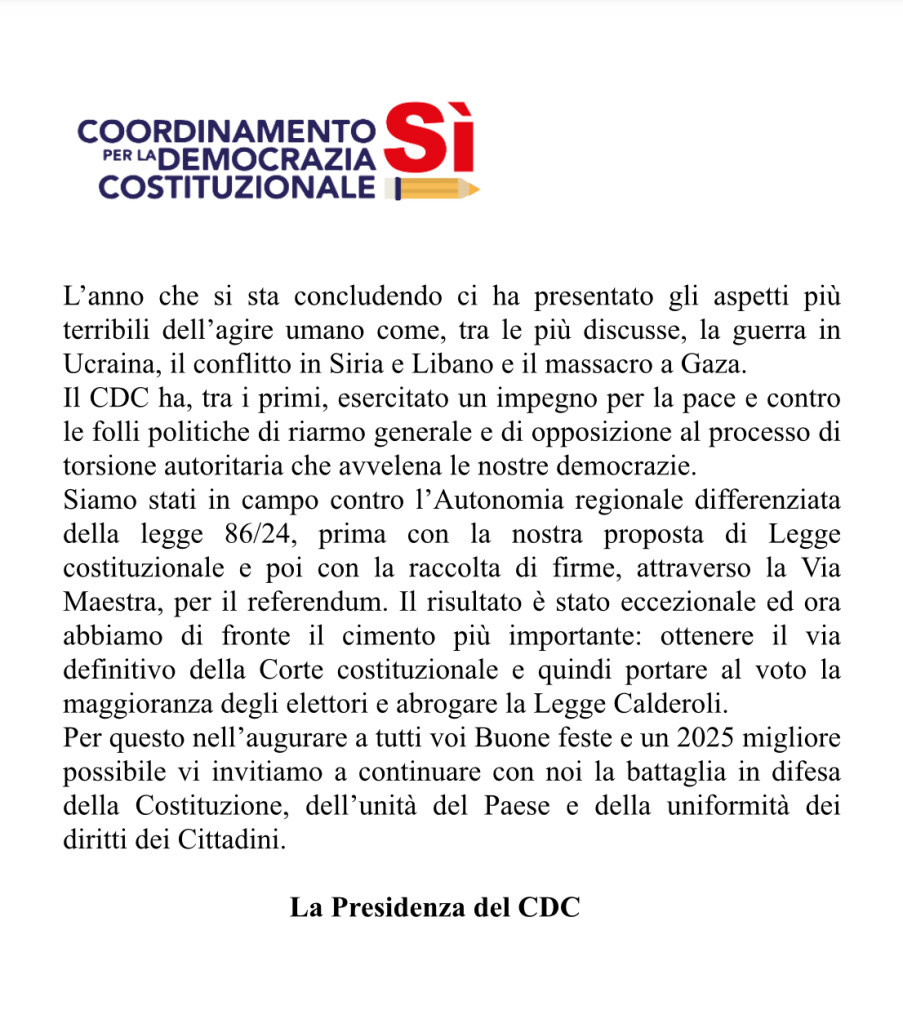



 AService Studio
AService Studio