Monthly Archives: aprile 2018
Oggi martedì 24 aprile 2018

![]()








![]() ——————–Dibattiti&Commenti—————————
——————–Dibattiti&Commenti—————————
 Il “reddito di cittadinanza” secondo Ferrajoli
Il “reddito di cittadinanza” secondo Ferrajoli
24 Aprile 2018
Gianfranco Sabattini su Democraziaoggi.
————————————————————
L’importanza dei “beni comuni”

![]() di Franco Meloni
di Franco Meloni
Premesso che io mi ritengo fondamentalmente un “pratico”, con un approccio sostanzialmente “giornalistico”, rispetto agli esperti e agli accademici (i chierici), che hanno studiato e studiano la questione dei “beni comuni”, mi permetto di proporre in argomento alcune sintetiche riflessioni, che avevamo condiviso con alcuni amici nella fase di costituzione di un “Osservatorio sui beni comuni della Sardegna”, progetto che è rimasto sulla carta oltre che nelle buone intenzioni, ma che non disperiamo di riprendere quando i tempi saranno propizi e le risorse sufficienti.
L’argomento nella sua complessità è veramente importante e per me decisamente intrigante. E pertanto ne propongo opportuni approfondimenti a tutti i livelli, non solo a quelli accademici e propri dei centri studi e documentazione (recentemente il sottoscritto ha proposto che l’argomento “beni comuni” venga inserito nella programmazione delle attività dell’Istituto Gramsci per la Sardegna, trovando, mi pare, favorevole accoglienza dei soci), ma a tutti i centri di iniziativa politica e culturale presenti nella realtà sarda. Credo di essere in buona compagnia per sostenere questo impegno culturale, con importanti implicazioni politiche. Al riguardo, tra tutti gli esperti che giustamente enfatizzano l’importanza dell’argomento, voglio citare l’economista Giulio Sapelli che in un suo recente libro (Oltre il capitalismo, Guerini e Associati Editore) sostiene: “(…) La soluzione rivoluzionaria (…) è rilanciare su larga scala la filosofia e la pratica del common goods. Di questo esistono i presupposti teorici (…) In questo filone analitico risiede la concezione di una possibile alternativa all’odierno capitalismo“.[segue]
Dibattito su reddito di cittadinanza e dintorni

I fondamenti etico-politico, giuridico-costituzionale ed economico-sociale del “reddito di cittadinanza”
di Gianfranco Sabattini
Il volume “Manifesto sull’uguaglianza” di Luigi Ferrajoli, professore emerito di Filosofia del diritto nell’Università di “Roma Tre”, rappresenta un contributo, oltre che all’approfondimento del “principio di uguaglianza”, anche alla corretta definizione del tanto discusso “reddito di cittadinanza”; Ferrajoli differenzia quest’ultimo da altre forme di reddito di sostegno, per l’impatto che esso, se attuato, potrebbe avere sul piano politico, sociale, economico, nonché su quello costituzionale.
E’ interessante seguire l’analisi svolta in questo “Manifesto”, con particolare riferimento al difficile problema del finanziamento del reddito di cittadinanza; le considerazioni dell’autore sul “costituzionalismo dei beni” suggeriscono una soluzione appropriata, che potrebbe valere a “tranquillizzare” tutti coloro che si dimostrano preoccupati degli esiti economici negativi che potrebbero verificarsi se il finanziamento del reddito di cittadinanza fosse realizzato attraverso l’inasprimento della tassazione.
Quello di uguaglianza – afferma Ferrajoli – “è il principio politico dal quale, direttamente o indirettamente, sono derivabili tutti gli altri principi e valori politici. Esso equivale all’uguale valore associato a tutte le differenze di identità e al disvalore associato alle disuguaglianze nelle condizioni materiali di vita”. Tale principio è il presupposto della solidarietà sociale e, per questo, “è il termine di mediazione delle tre classiche parole della Rivoluzione francese”. La sua mancata attuazione (o, se si vuole, il parziale smantellamento di quanto è stato sinora attuato al riguardo con la costruzione, a partire soprattutto dalla fine del secondo conflitto mondiale, del welfare State) e l’approfondimento delle disuguaglianze già esistenti, causato dall’aumentata globalizzazione delle economie nazionali, anche in quelle ad economia avanzata, sono all’origine “di tutti i problemi che stanno oggi minacciando le nostre democrazie e la convivenza pacifica”.
La crescita delle discriminazioni personali e delle disuguaglianze materiali è dovuta, secondo Ferrajoli, al crollo della politica, per avere “abdicato al suo ruolo di tutela degli interessi generali e di governo dell’economia” e per essersi assoggettata alle leggi del mercato non regolato. Perché, egli si chiede, il principio di uguaglianza è cosi importante da risultare sancito da tutti gli ordinamenti costituzionali avanzati? La risposta del filosofo del diritto è che la ragione è duplice: innanzitutto, perché gli uomini sono “differenti”, nel senso che hanno identità personali diverse; in secondo luogo, perché gli uomini che “vivono insieme” presentano condizioni di vita materiale differenti. Quindi, l’uguaglianza sancita dagli ordinamenti costituzionali è giustificata dal fatto che “siamo differenti e disuguali”, per cui essa corrisponde alla necessità che siano tutelate le differenze personali e contrastate le disuguaglianze materiali.
Infatti, a parere di Ferrajoli, quello di uguaglianza include due principi diversi: da un lato, il principio dell’uguale valore associato a tutte le “differenze che formano l’identità di ciascuna persona”; dall’altro lato, il principio di disvalore associato “alle eccessive disuguaglianze economiche e materiali, dalle quali anche l’uguale valore delle differenze risulta di fatto limitato, o peggio negato”. In entrambi i casi, sostiene il filosofo del diritto, è una ”égalité en droit“, cioè un’uguaglianza stabilita in “punto di diritto”, perché è tramite il diritto che essa viene garantita. Dei due principi di uguaglianza, il più violato allo stato attuale è il secondo (quello dell’uguaglianza sociale e materiale), non solo tra i diversi gruppi sociali all’interno dei singoli Paesi, ma anche tra i diversi Paesi, a livello internazionale.
Le attuali dimensioni della disuguaglianza materiale, che non hanno precedenti nella storia, sono di solito giustificate dall’ideologia neoliberista sulla base di diverse assunzioni prive di fondamento: innanzitutto – si afferma – esse sarebbero una conseguenza delle differenze di merito, per cui la loro conservazione favorirebbe un aumento complessivo dei livelli di benessere e agirebbero come stimolo della crescita economica; infine, non esisterebbero altre politiche alternative a quelle attuali, compatibili con le ferree leggi del marcato. Si tratta di giustificazioni “false”, perché smentite dall’esperienza. Al contrario, quest’ultima evidenzia l’esistenza di una stretta correlazione positiva tra il “grado di uguaglianza sostanziale”, da un lato, e dall’altro, rispettivamente, il “grado di uguaglianza delle differenze personali”, il “grado di democrazia”, il “grado di benessere collettivo” e il “grado di sviluppo dell’economia”.
La prima correlazione (tra il grado di uguaglianza sostanziale e quello di effettiva uguaglianza delle differenze personali) evidenzia, per un verso, che la riduzione della disuguaglianza sostanziale costituisce la condizione necessaria per la salvaguardia del pari valore attribuito a tutte le differenze personali; per un altro verso, che il livello di uguaglianza sostanziale realizzato dipende dal grado di effettiva salvaguardia delle differenze personali, strumentali al perseguimento dei differenti progetti di vita. Tra i diritti sanciti a garanzia dell’uguaglianza sostanziale e quelli posti a garanzia delle differenze personali esiste, pertanto – sostiene Ferrajoli – un rapporto di sinergia, nel senso che l’uguaglianza sostanziale forma il necessario presupposto dell’uguaglianza dei diritti personali; i quali, a loro volta, costituiscono “la necessaria condizione dell’esercizio consapevole dei diritti civili e dei diritti politici”.
La seconda correlazione (tra il grado di uguaglianza sostanziale e quello di democrazia) mostra che l’uguaglianza sostanziale costituisce il presupposto della democrazia, oggi compromessa dalla subalternità della politica alle leggi del mercato senza regole. L’assenza di una sfera pubblica autonoma, capace di regolare gli esiti negativi del libero mercato e delle leggi dell’economia, causa inevitabilmente una concentrazione della ricchezza in chi è già titolare di cospicui patrimoni, cui corrisponde un aumento della povertà di tutti gli altri.
La terza correlazione (tra il grado di uguaglianza sostanziale e quello del benessere collettivo) evidenzia che l’uguaglianza sostanziale costituisce la base per la crescita del benessere collettivo, inteso questo, non solo in termini quantitativi (in termini cioè di crescita della disponibilità pro-capite dei beni prodotti), ma anche in termini qualitativi, di progresso civile generato, oltre che “dalla sicurezza della sopravvivenza, dal senso di appartenenza a una comunità di uguali nei diritti [...] che, grazie al senso e alla percezione dell’uguaglianza, formano il necessario sostegno di qualunque democrazia”.
Infine, la quarta correlazione (tra il grado di uguaglianza sostanziale e quello di sviluppo dell’economia) è la più importante; essa contraddice “in toto” gli assunti dell’ideologia neoliberista, in merito ai vincoli che l’uguaglianza materiale imporrebbe alla crescita economica. La spesa pubblica per finalità sociali non è “solo un costo – dice Ferrajoli -, ma anche una condizione esenziale dello sviluppo, cioè [dell’aumento] della produttività individuale e collettiva”. La spesa pubblica finalizzata alla riduzione della disuguaglianza materiale è infatti “un fattore decisivo della crescita economica”, perché, elevando le condizioni di vita, cresce anche la produttività del lavoro. In assenza della spesa pubblica, crescerebbe la disuguaglianza e con essa la povertà. La condizione per contrastare queste due crescite (della disuguaglianza e della povertà), per Ferraioli, è l’abbandono della tesi ideologica neoliberista, secondo cui al contenimento della spesa pubblica, attuato in funzione dello sviluppo quantitativo e qualitativo, non esisterebbero alternative. Occorre, al contrario, contrastare la disuguaglianza materiale, rimuovendo la povertà attraverso l’introduzione di un “reddito di base”.
Al riguardo – afferma Ferrajoli – si possono distinguere due tipi di reddito idonei a sconfiggere la povertà: il “reddito minimo garantito” e il “reddito di cittadinanza”. Il primo è previsto a favore dei soli bisognosi, previo accertamento della mancata disponibilità dei mezzi, e viene erogato in ossequio al diritto alla vita che, dal punto di vista economico, non elimina per il beneficiario lo stigma dello stato di povertà e della costrizione a sottoporsi a procedure umilianti per acquisire la possibilità di ricevere l’”obolo caritatevole”, sia pure di natura pubblica; inoltre, dal punto di vista sociale, esso non esclude la possibilità del rischio del permanere della povertà, diventando la conservazione di questa, a causa dell’”effetto ricchezza sul reddito”, motivo che può indurre il beneficiario a preferire il reddito minimo garantito, anziché un possibile reddito da lavoro.
La seconda ipotesi di reddito è, secondo Ferrajoli, “ben più radicale e ambiziosa”. Essa comporta l’attribuzione di un reddito di base a tutti (perciò, universale), in modo incondizionato, sganciato da ogni obbligo da parte del beneficiario, nel senso che chi lo riceve non è tenuto ad accettare alcuna condizione o l’obbligo di controprestazioni, perché corrisposto a “garanzia della dignità personale”. Ferrajoli ritiene che la rimozione, attraverso l’erogazione del reddito di cittadinanza, dello stigma dell’essere povero all’interno della società, soprattutto se si tratta di una società economicamente avanzata, abbia un triplice fondamento: etico-politico, giuridico-costituzionale ed economico-sociale.
Sotto l’aspetto etico-politico, il reddito di cittadinanza rappresenta la garanzia della vita contro gli esiti negativi della irrazionalità delle leggi che sottostanno al libero funzionamento del mercato; la “disoccupazione crescente e strutturale” dei moderni sistemi economici non può essere contrastata dalle politiche tradizionali del lavoro.
Sotto l’aspetto giuridico-costituzionale, il reddito di base universale e incondizionato è prescritto dalle Costituzioni moderne, inclusa quella italiana, che prevedono il diritto al mantenimento, per chiunque sia inabile al lavoro e non disponga dei mezzi necessari per vivere.
Infine, sotto l’aspetto economico-sociale, il reddito di base è lo strumento col quale è possibile ridurre la disuguaglianza, come condizione dell’inclusione sociale del beneficiario e dello stabile funzionamento del sistema economico.
I tre fondamenti illustrati, che stanno alla base dell’istituzionalizzazione dell’erogazione di un reddito di cittadinanza universale e incondizionato, a parere di Ferrajoli, sono giustificati da diverse ragioni. In primo luogo, l’erogazione di un reddito di base, o di dignità personale, si “accorda con il costituzionalismo” delle democrazie avanzate; in secondo luogo, tale erogazione è affrancata da ogni “connotato caritatevole ed assistenziale”, presente invece nelle prestazioni erogate dall’attuale welfare State; in terzo luogo, l’assegnazione di un reddito di garanzia personale, operando “ope legis”, elimina la mediazione burocratica, partitica e sindacale; infine, l’istituzionalizzazione di un reddito di base universale e incondizionato, determina la necessità di una profonda revisione del welfare State, “sviluppatosi fino ad oggi in forme prevalentemente burocratiche e assistenziali, all’insegna della trasparenza, dell’uguaglianza, dell’universalismo dei diritti e della loro garanzia automatica ex lege”.
Sinora, l’introduzione in Italia del reddito di cittadinanza è stata contrastata anche dai sindacati e dalle forze di sinistra per due ordini di motivi, espressi da una superata ideologia lavorista e dalla presunta indisponibilità delle risorse necessarie a garantirne l’erogazione. Le tesi dell’ideologia lavorista devono essere superate, non solo perché non più rispondenti alle modalità di funzionamento dei moderni sistemi economici ad economia di mercato, ma anche perché il reddito di base non è affatto in contrasto – osserva Ferrajoli – con il valore associato al lavoro, così come indicato all’articolo uno della Costituzione; il reddito di base è infatti lo strumento – egli dice – posto a presidio del “principio che fa del lavoro un fondamento della Repubblica. [...] Non certo sul lavoro come merce, bensì sul lavoro come autodeterminazione e sviluppo della persona, e perciò come espressione delle sue capacità e fattore di realizzazione personale e sociale”.
L’importanza del “Manifesto” di Ferrajoli sta anche nella dimostrazione di quanto sia fuorviante la tesi secondo cui l’istituzionalizzazione del reddito di base sarebbe impossibile a causa dell’insufficienza delle risorse disponibili, in quanto sarebbe impensabile poterle reperite attraverso una maggiore tassazione. A parte l’autofinanziamento, realizzabile attraverso una necessaria riforma dei meccanismi ridistributivi del prodotto sociale e del welfare State tradizionale, è rilevante ciò che Ferrajoli indica come possibile fonte di risorse la necessità di un riordino giuridico dei beni pubblici, fondato sulla distinzione al loro interno della funzione e del ruolo di quelli “fondamentali” e di quelli “patrimoniali”: i primi (i beni comuni) destinati al soddisfacimento dei diritti fondamentali delle persone e, in quanto tali, da sottrarre alle logiche di mercato; i secondi, in quanto di proprietà pubblica (e, dunque, acquisiti dallo Stato con il contributo di tutti) esitabili, ma non trasferibili, sul mercato, non per destinare le rendite alla copertura delle “esigenze di cassa” delle maggioranze politiche di turno, ma per la costituzione di un “fondo” da utilizzare come ulteriore finanziamento del reddito di cittadinanza universale e incondizionato.
Il discorso di Ferrajoli merita attenzione, perché spesso, nel dibattito politico corrente, le critiche portate contro la fattibilità del reddito di cittadinanza sono fuorvianti, in quanto riferibili, quasi sempre, a un reddito di sostegno alla vita che non ha i caratteri dell’universalità e dell’incondizionalità; gli unici, questi caratteri, che assegnano al reddito di cittadinanza il triplice fondamento etico-politico, giuridico-costituzionale ed economico-sociale, come chiaramente emerge dalle puntuali considerazioni formulate da Ferrajoli.
—–
Anche su Democraziaoggi.
La natura dei beni comuni


a cura di Gianfranco Sabattini
.
1. Posizione del problema
Un inquadramento dei problemi concernenti il governo dei beni comuni non è possibile realizzarlo sulla base dei soli assiomi analitici della teoria economica tradizionale; occorre un approccio che integri gli assiomi della teoria economica tradizionale dei cosiddetti beni pubblici con quelli propri di altri approcci all’analisi di specifici aspetti della realtà sociale, quali quelli della teoria giuridica dei diritti, della teoria sociologica, della teoria istituzionale.
Punto centrale dell’inquadramento unitario dei problemi riguardanti i beni comuni e la loro definizione; a tal fine, conviene partire da una loro considerazione come beni sociali, nel senso di beni il cui consumo arreca un beneficio indistintamente a tutti i membri del sistema sociale (A.Nicita, 2003; S.Civitarese Matteucci, 2008). Il maggiore problema concernente tali beni riguarda il fatto d’essere stati sinora governati attraverso procedure che la teoria economica tradizionale ha elaborato con riferimento alla classe onnicomprensiva dei cosiddetti beni pubblici. Conviene, perciò, partire preliminarmente dalla sistematizzazione teorica di questi ultimi, fornita dai contributi di P.A.Samuelson (1993), J.M.Buchanan (1969), R.A.Musgrave (1995) e J.Head (1974).
Secondo questa sistematizzazione, i beni pubblici sono quei beni il cui consumo a livello individuale si riferisce al totale consumato da un’intera comunità di individui secondo una condizione di parità e non di somma, come avverrebbe nel caso di beni di consumo privati.
Un noto teorema di economia del benessere, recita che quando in un sistema economico a decisioni decentrate coesistono beni di consumo privati e beni di consumo pubblici, è possibile una configurazione di equilibrio ottimale del mercato in senso paretiano solo se tutti i soggetti economici, dal lato del consumo, rivelano le loro preferenze (le loro funzioni di domanda individuali e quindi le disponibilità a pagare per le diverse quantità possibili dei beni stessi) e quando, dal lato dell’offerta, i produttori, in funzione delle preferenze rivelate, producono ed offrono i beni pubblici domandati.
[segue]
L’importanza dei “beni comuni”

![]()
di Franco Meloni
Premesso che io mi ritengo fondamentalmente un “pratico”, con un approccio sostanzialmente “giornalistico” nei confronti degli esperti e degli accademici (i chierici), che hanno studiato e studiano la questione dei “beni comuni”, mi permetto di proporre in argomento alcune sintetiche riflessioni, che avevamo condiviso con alcuni amici nella fase di costituzione di un “Osservatorio sui beni comuni della Sardegna”, progetto che è rimasto sulla carta oltre che nelle buone intenzioni, ma che non disperiamo di riprendere quando i tempi saranno propizi e le risorse sufficienti.
L’argomento nella sua complessità è veramente importante e per me decisamente intrigante. E pertanto ne propongo opportuni approfondimenti a tutti i livelli, non solo a quelli accademici e propri dei centri studi e documentazione (recentemente il sottoscritto ha proposto che l’argomento “beni comuni” venga inserito nella programmazione culturale dell’Istituto Gramsci per la Sardegna, trovando, mi pare, favorevole accoglienza dei soci), ma a tutti i centri di iniziativa politica e culturale presenti nella realtà sarda. Credo di essere in buona compagnia per sostenere questo impegno culturale, con importanti implicazioni politiche. Al riguardo, tra tutti gli esperti che giustamente enfatizzano l’importanza dell’argomento, voglio citare l’economista Giulio Sapelli che in un suo recente libro (Oltre il capitalismo, Guerini e Associati Editore) sostiene: “(…) La soluzione rivoluzionaria (…) è rilanciare su larga scala la filosofia e la pratica del common goods. Di questo esistono i presupposti teorici (…) In questo filone analitico risiede la concezione di una possibile alternativa all’odierno capitalismo“.
———–
Di seguito alcuni APPUNTI pertinenti.
Il concetto di “beni comuni” è da individuare concretamente nelle “cose che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona (…) che devono essere tutelati e salvaguardati dall’ordinamento giuridico, anche a beneficio delle generazioni future” (1) e dei quali favorire la fruibilità e la gestione da parte dei cittadini attivi e organizzati in accordo con le Pubbliche amministrazioni. La categoria dei “beni comuni” è immensa. Il primo bene comune universale è la terra, nella sua generalità (superficie e sottosuolo), da utilizzare a beneficio di tutti, nel rispetto dei limiti imposti dall’ordinamento giuridico. E possiamo continuare in un’elencazione di dettaglio, non certo esauriente, traendola dalle elaborazioni della Commissione Rodotà (1):
“i fiumi, i torrenti e le loro sorgenti; i laghi e le altre acque; l’aria; i parchi come definiti dalla legge, le foreste e le zone boschive; le zone montane di alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni; i lidi e i tratti di costa dichiarati riserva ambientale; la fauna selvatica e la flora tutelata; i beni archeologici, culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate” (1).
—————————–
I “beni comuni urbani”, particolare categoria dei “beni comuni”.
A noi interessa che nella gestione di questi “beni comuni” intervengano direttamente i cittadini, nella pratica attuazione del principio costituzionale della sussidiarietà orizzontale, di cui all’art. 118, ultimo comma della Costituzione: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”. Detta norma, allo stato attuale largamente disattesa, riconosce ai cittadini – e dunque alle loro organizzazioni/associazioni nelle più diverse espressioni – la capacità di attivarsi autonomamente nell’interesse generale e dispone che le istituzioni debbano sostenerne le coerenti iniziative.
Unendo il generale al particolare possiamo individuare gli strumenti per praticare con tutta la possibile urgenza tali obbiettivi. Per esempio aiutando il Comune di Cagliari (così pure gli altri Comuni sardi) a dotarsi di un buon “Regolamento per l’amministrazione condivisa dei beni comuni”, magari da copiare, adattandolo, dai migliori regolamenti tra quelli attualmente vigenti in più di 100 Comuni italiani (vedasi www.labsus.it).
———————————————
(1). Proposta di articolato Commissione Rodotà – elaborazione dei principi e criteri direttivi di uno schema di disegno di legge delega al Governo per la novellazione del Capo II del Titolo I del Libro III del Codice Civile nonché di altre parti dello stesso Libro ad esso collegate per le quali si presentino simili necessità di recupero della funzione ordinante del diritto della proprietà e dei beni (14 giugno 2007).
——–
Approfondimenti su Aladinews: https://www.aladinpensiero.it/?p=64813.
——————————————————————————
Per quanto riguarda una essenziale bibliografia sull’argomento, abbiamo chiesto la collaborazione del prof. Gianfranco Sabattini, che cortesemente ce l’ha fornita e che puntualmente riportiamo in altra parte della News. Tra i testi fondamentali c’è, ovviamente, “Governare i beni collettivi” di Elinor Ostrom (Marsilio Editore), premio Premio Nobel 2009 per l’economia, insieme a Oliver Williamson, per l’analisi della governance e, in particolare, delle risorse comuni (vedasi: https://it.wikipedia.org/wiki/Elinor_Ostrom).
Oggi lunedì 23 aprile 2018

![]()








![]() ———————Dibattiti&Commenti—————————
———————Dibattiti&Commenti—————————
 Priorità regionale: non la legge elettorale, ma quella urbanistica!
Priorità regionale: non la legge elettorale, ma quella urbanistica!
23 Aprile 2018
Red su Democraziaoggi.
————————————–
DIBATTITO. Jeremy Rifkin: È necessario costruire e estendere una nuova infrastruttura intelligente di Terza Rivoluzione Industriale
 È necessario costruire una nuova infrastruttura intelligente di Terza Rivoluzione Industriale. Se su questo si creasse consenso trasversale, avremmo una nuova visione capace di ispirare le prossime tre generazioni in Italia. L’opinione dell’economista americano
È necessario costruire una nuova infrastruttura intelligente di Terza Rivoluzione Industriale. Se su questo si creasse consenso trasversale, avremmo una nuova visione capace di ispirare le prossime tre generazioni in Italia. L’opinione dell’economista americano
 di JEREMY RIFKIN
di JEREMY RIFKIN
19 aprile 2018 su L’Espresso
Le elezioni del 4 marzo hanno scosso la politica italiana e l’onda sismica si è fatta sentire in tutta Europa. La maggioranza degli elettori italiani si è espressa contro la vecchia casta politica più vicina agli interessi delle lobby che a quelli dei cittadini. Il disincanto populista ormai accomuna elettori di destra e di sinistra in un acceso dibattito che riguarda non solo l’Italia, ma l’Unione europea e il mondo intero, e si aggiunge a problemi come stagnazione economica, produttività declinante, disoccupazione, diseguaglianze crescenti, e perdita di speranza per i giovani. Mentre il cambiamento climatico continua a minacciare la sopravvivenza della vita sulla Terra.
Queste elezioni impongono dunque un radicale cambiamento, ma in che senso?
———-
In un mio recente articolo su L’Espresso, osservavo che il rallentamento del Pil e l’aumento di disoccupazione e disuguaglianza sono il risultato del declino della seconda rivoluzione industriale, basata su telecomunicazioni ed energia centralizzate e sul motore a scoppio. Questa infrastruttura antiquata è ormai entrata in fase terminale in tutto il mondo. È necessario costruire e estendere una nuova infrastruttura intelligente di Terza Rivoluzione Industriale (Tri) ad alto tasso di integrazione digitale, che dovrà comprendere anche una rete Internet 5G, un’Internet dell’energia rinnovabile digitalizzata, un’Internet della mobilità automatizzata basata su veicoli elettrici e a idrogeno, circolanti in tessuti urbani intelligenti collegati interattivamente nell’Internet delle cose (IdC). Se su questo si creasse consenso trasversale, avremmo una nuova visione capace di ispirare le prossime tre generazioni in Italia per affrontare efficacemente i problemi posti da disoccupazione, immigrazione e deficit di protagonismo delle comunità locali nei processi decisionali. Serve una radicale transizione dell’Italia verso un’economia Tri digitalizzata, intelligente.
OLTRE IL REDDITO MINIMO
Altro tema caldo è il reddito minimo condizionato all’accettazione di almeno una su tre proposte di lavoro dei Centri per l’impiego. Ma dove le si va a prendere le tre proposte di lavoro se non si creano nuove dinamiche occupazionali e professionali? Nella costruzione di un’infrastruttura Tri, che richiede decine di migliaia di posti di lavoro semi-qualificati, qualificati, e altamente qualificati per le prossime due generazioni, che non potranno essere coperti né da robot né dall’Intelligenza artificiale. Sono figure professionali nuove per settori quali l’ammodernamento della rete di comunicazione e la cablatura della banda larga universale 5G e del Wi-Fi gratuito; l’efficienza energetica di milioni di edifici pubblici e privati con l’installazione di infissi ad alta tenuta termica; una nuova infrastruttura energetica basata non più su fossili o nucleare ma sulle fonti rinnovabili (sole, vento etc) con installazione delle tecnologie di accumulo energetico; la riconfigurazione di tutta la rete elettrica in una vera e propria Internet dell’energia con contatori di nuova generazione e altre tecnologie digitali per collegare fra di loro milioni di microcentrali; la realizzazione di un’Internet della logistica e della mobilità senza conducente a guida satellitare, con milioni di sensori su “smart roads” che forniranno informazioni in tempo reale su flussi di traffico e movimenti di merci, la sostituzione del parco veicoli tradizionali con quelli elettrici e a idrogeno su strada, ferrovia e mare, con decine di migliaia di stazioni di ricarica e rifornimento di idrogeno. La creazione di questa infrastruttura dell’Internet delle Cose per una “Smart Italy” darà lavoro a centinaia di migliaia di lavoratori per i prossimi trent’anni e la riqualificazione delle figure professionali necessarie non dovrebbe richiedere più di 6-9 mesi, secondo esperienze già in corso in altre regioni d’Europa. Altrettanto bisognerebbe fare per i programmi delle scuole superiori e delle università.
QUALE LAVORO DOPO IL LAVORO
Per i prossimi trent’anni vi sarà dunque un’ultima ondata di occupazione di massa prima che la nuova infrastruttura economica digitale intelligente riduca il lavoro al lumicino perché sarà governata da algoritmi e robot. Cosa faranno allora gli esseri umani? L’occupazione migrerà verso l’economia sociale e della condivisione, e il settore “No profit” (che non significa necessariamente “No jobs”). Nell’economia no profit e della condivisione il lavoro dell’uomo rimarrà importante perché l’impegno sociale e la creazione di capitale sociale sono un’impresa intrinsecamente umana. Neanche i più ardenti tecnofili osano sostenere l’idea che le macchine possano creare capitale sociale. La gestione di ambiente, educazione, salute, attività culturali e una moltitudine di altre attività sociali, richiede l’intervento umano e non quello delle macchine. Un robot potrà portare il pranzo al bambino, ma non potrà mai insegnargli a diventare un essere umano. La sfera del no profit è già il settore a più rapida crescita in tutto il mondo. Non è solo volontariato. Uno studio su 42 paesi della Johns Hopkins University rivela che 56 milioni di persone lavorano a tempo pieno nel settore no profit. Il 15,9 per cento del lavoro retribuito nei Paesi Bassi è no profit. Il 13,1 per cento in Belgio, l’11 per cento nel Regno Unito, il 10,9 per cento in Irlanda, il 10 per cento negli Stati Uniti, il 12,3 per cento in Canada. Queste percentuali sono in costante aumento. È prevedibile che entro il 2050 la maggioranza degli occupati nel mondo sarà in comunità senza scopo di lucro, impegnate nell’economia sociale e della condivisione. Il saggio di John Maynard Keynes “Economic possibilities for our grand-children” scritto più di 80 anni fa, immaginava un mondo in cui le macchine liberano l’uomo dalla fatica del lavoro, permettendogli di impegnarsi nella ricerca del senso più profondo della vita. Questa potrebbe rivelarsi la previsione economica più azzeccata di Keynes. Ma per cogliere questa opportunità dobbiamo riqualificare la forza lavoro esistente verso il mercato dell’Internet delle Cose, e formare le persone alle nuove figure professionali che si aprono nel no profit.
MODERNIZZAZIONE, DEMOGRAFIA E IMMIGRAZIONE
È vero, serve uno sforzo erculeo, ma l’umanità ha già affrontato sfide simili in passato, come nel passaggio da uno stile di vita agricolo a uno industriale tra il 1890 e il 1940. Per affrontare questa sfida l’Italia dovrà però risolvere un problema supplementare: secondo la Banca Mondiale infatti, l’Italia è 187ma su 200 paesi come tasso di natalità. Dove reperirà le centinaia di migliaia di lavoratori per realizzare l’infrastruttura intelligente Tri nei prossimi quarant’anni se c’è questo impressionante declino demografico? Qui tocchiamo il tema caldo dell’immigrazione: per far fronte alle sue esigenze di modernizzazione, l’Italia dovrà dunque fronteggiare il declino demografico con politiche intelligenti e impedire lo spopolamento del paese. C’è poi il tema della crisi di fiducia verso la classe politica tradizionale, troppo condizionata dagli interessi di ben precise lobby economiche. Il rapporto fra l’economia e la politica deve ispirarsi a logiche nuove, sviluppate intorno alla riorganizzazione del Sogno europeo verso un’economia sostenibile e una società ecologica. Si comincia a discutere su come mettere in pratica il “principio di sussidiarietà”, punto centrale del Trattato di Lisbona, che presuppone che rimangano a livello regionale o nazionale, tutte le decisioni che non siano state devolute all’Ue.
“POWER TO THE PEOPLE”
La piattaforma digitale Tri mira a valorizzare le comunità locali in tutta Europa e a dare loro maggiore potere, perché le collega in uno spazio digitale continentale intelligente distribuito, aperto, trasparente e crea economie di scala laterali e non centralizzate, in un”effetto rete” più produttivo e creativo per l’Italia e per l’Europa, e quindi è in perfetta sinergia col principio di sussidiarietà. Questo è “power to the people”, letteralmente nel senso di energia per tutti, e anche figurativamente nel senso di potere alle persone.
Come finanziamo il passaggio all’infrastruttura digitale Tri? Le rigidità dovute ai parametri di stabilità finanziaria (rapporto debito-Pil, etc) sconsigliano l’uso di fondi pubblici ma nulla vieta di utilizzare capitali privati attraverso il nuovo strumento dei contratti Esco, che permettono alla P.A. di pagare gradualmente il finanziamento delle infrastrutture pubbliche con i risparmi di spesa determinati dalla maggiore efficienza energetica e dalle maggiori economie di scala, mantenendo il possesso delle infrastrutture in mani pubbliche anche se pagate con fondi privati.
Le recenti elezioni politiche offrono l’occasione di ripensare il futuro dell’Italia in quest’Europa rivitalizzata. L’Italia è stata a lungo la fucina delle idee per la politica europea e l’innovazione economica. Negli ultimi anni, questo ruolo guida si è un po’ offuscato. È venuto il momento del risveglio.
Traduzione di Angelo Consoli
Articoli correlati
OPINIONE
«L’Italia non sta facendo abbastanza per innovare»: parla Jeremy Rifkin
———————————————-
«È necessario costruire ed estendere una nuova infrastruttura intelligente di Terza Rivoluzione industriale, come stanno facendo in Olanda, Lussemburgo e in alcune regioni della Francia». L’opinione dell’economista e saggista americano
di JEREMY RIFKIN
29 gennaio 2018
Il governo italiano ha intrapreso una serie di iniziative per stimolare innovazioni con l’obiettivo di accelerare la produttività e la crescita economica, agevolando la creazione di occupazione nell’economia.
Sebbene queste iniziative siano essenziali, esse non sono sufficienti finché la piattaforma dominante per la gestione, l’alimentazione, e la movimentazione dell’attività economica italiana rimarrà basata sulla infrastruttura della Seconda rivoluzione industriale, con le sue telecomunicazioni centralizzate, le sue energie fossili e fissili e trasporti stradali, marittimi e aerei basati sul motore a scoppio.
È vero, l’infrastruttura della Seconda rivoluzione industriale ha fornito la base per uno straordinario aumento della crescita nel XX secolo, ma quel modello ha ormai raggiunto il limite massimo della sua produttività in tutte le nazioni industriali negli ultimi 15-20 anni, e oggi determina il costante calo del Pil e un corrispondente aumento della disoccupazione.
Anche se dovessimo rimodernare l’infrastruttura della Seconda rivoluzione industriale, l’effetto sull’efficienza aggregata sarebbe estremamente limitato, e così anche sulla produttività, sulle nuove opportunità di business, sull’occupazione e sulla crescita. I combustibili fossili e l’energia nucleare sono ormai superati. E le tecnologie progettate e realizzate per funzionare con queste energie, come le reti di telecomunicazione, la rete elettrica centralizzata e le forme di trasporto basate sul motore a scoppio hanno esaurito quasi del tutto la loro produttività.
Quindi è adesso necessario costruire ed estendere una nuova infrastruttura intelligente di Terza Rivoluzione Industriale, ad alto tasso di integrazione digitale, che dovrà comprendere anche una rete, Internet 5G, un’Internet dell’energia rinnovabile digitalizzata, un’Internet della mobilità automatizzata e digitalizzata basata su veicoli elettrici e a idrogeno, circolanti fra gruppi di edifici intelligenti collegati individualmente nell’Internet delle cose (Idc).
A tutt’oggi però l’Italia rimane fanalino di coda al 25° posto sui 28 Paesi dell’Ue nel Rapporto Desi (Digital Economy and Society Index) della Commissione Europea, che misura lo stato di avanzamento nell’economia e società digitali di ciascuno Stato membro dell’Ue. Eppure questa nuova infrastruttura intelligente diventa una priorità fondamentale nel riposizionamento dell’Italia per la transizione verso la nuova dimensione di spazio commerciale, sociale e politico pienamente integrato.
Se l’Italia riuscirà a allestire ed estendere al massimo questa nuova infrastruttura digitale verde e intelligente, riuscirà a scatenare una nuova ondata di produttività che, questa sì, continuerà a crescere nella prima metà di questo secolo.
La costruzione di questa infrastruttura coinvolgerà praticamente ogni settore per i prossimi 40 anni: le società di distribuzione di energia e elettricità, il settore delle telecomunicazioni tradizionali e via cavo, il settore dell’informazione e della comunicazione, il settore dell’elettronica, l’edilizia e l’industria immobiliare, i trasporti e la logistica, il settore manifatturiero, l’agricoltura, etc. E impiegherà milioni di lavoratori specializzati, semi specializzati e di professionisti. La nuova infrastruttura digitale italiana, a sua volta, renderebbe possibili nuovi modelli di business e nuovi tipi di figure professionali proprie del paradigma economico intelligente della nuova economia a basse emissioni di carbonio e rispettosa del clima. Il governo italiano si è impegnato a investire nella distribuzione di infrastrutture pubbliche per stimolare nuove innovazioni di business e opportunità di lavoro. Questi fondi infrastrutturali dovrebbero essere utilizzati, in parte, per erigere l’infrastruttura digitale del XXI secolo e accompagnare la transizione verso le energie rinnovabili e la mobilità verde per un’Italia intelligente.
Tre poteri pubblici nell’Unione Europea hanno sviluppato piani di Terza Rivoluzione Industriale completamente integrati e iniziative di sviluppo per accompagnare la transizione delle loro economie: la regione Hauts-de-France, il Lussemburgo e soprattutto la regione metropolitana di Rotterdam e L’Aia.
Queste tre regioni hanno stabilito una nuova pietra miliare nella governance dello sviluppo economico e sociale che riflette la natura della nuova infrastruttura della Terza Rivoluzione Industriale in corso di preparazione.
Mentre la Prima e la Seconda rivoluzione industriale sono state progettate per essere centralizzate, verticistiche, proprietarie e verticalmente integrate, la Terza rivoluzione industriale è tendenzialmente distribuita, collaborativa, aperta e crea economie di scala in modo laterale, e questo richiede una governance di tipo nuovo.
In considerazione delle nuove opportunità e delle nuove sfide lanciate da questa nuova rivoluzione tecnologica, i governi di Hauts-de-France, il Granducato di Lussemburgo e la regione metropolitana di Rotterdam e L’Aia hanno adottato strategie che hanno cambiato il ruolo tradizionale di sorvegliante e pianificatore centralizzato di un potere pubblico, facendolo evolvere in quello di un facilitatore laterale per una rete regionale di centinaia di parti interessate e impegnate in questa nuova governance, parti che vanno dai poteri pubblici alla comunità imprenditoriale, al mondo accademico e alla società civile che hanno partecipato attivamente alla preparazione di ciascuno dei progetti di sviluppo e relative tabelle di marcia.
Mentre la Prima e la Seconda Rivoluzione Industriale hanno generalmente creato una forma di globalizzazione verticalmente integrata, la Terza Rivoluzione Industriale porta la famiglia umana in un ambito più “glocal” di reti laterali distribuite – con città, regioni, stati nazionali e unioni continentali che collaborano fianco a fianco in più vaste reti globali digitali dove condividono comunicazioni a banda larga, energie rinnovabili e autonomi veicoli elettrici e a idrogeno creando una qualità di vita più ecologicamente sostenibile ed equa.
Il primo passo verso la progettazione di questa Smart Italy di Terza Rivoluzione Industriale consiste nella elaborazione di una apposita tabella di marcia per la sincronizzazione e integrazione della nuova infrastruttura digitale a livello di governo nazionale. Questo documento, a sua volta, può fornire ispirazione, incentivi, e il riferimento normativo-quadro per dare impulso alle regioni italiane affinché procedano con appositi piani locali per creare un’infrastruttura regionale smart di Terza Rivoluzione Industriale.
Lo scorso anno la Commissione Europea ha annunciato l’iniziativa “Smart Europe” progettata per creare un’infrastruttura digitale trasparente nonché la relativa transizione energetica rinnovabili in tutta l’Unione europea per aumentare la produttività, creare nuove imprese e occupazione e far progredire l’economia a basse emissioni di carbonio. La Commissione Europea ha creato un fondo di sviluppo economico di 630 miliardi di euro – il cosiddetto fondo Juncker – che sarà in parte dedicato alla costruzione e alla massima estensione possibile della nuova infrastruttura Smart Europe di Terza Rivoluzione I ndustriale.
L’Italia ha adesso l’opportunità di assumere un ruolo di guida nell’Unione europea verso la prossima tappa del suo percorso per creare una Smart Europe e un unico spazio economico integrato nei 28 Paesi membri.
Traduzione di Angelo Consoli
——————————-
Articoli correlati
L’INTERVISTA
Jeremy Rifkin commenta l’enciclica Laudato si’
“Com’è sharing questo Papa Francesco”
INTERVISTA
Jeremy Rifkin: “La sharing economy è la terza rivoluzione industriale”
Che succede? Migheli: Viviamo un tempo di democrazia assediata. Saraceno: I professori umiliati e il rispetto da insegnare

I professori umiliati e il rispetto da insegnare
di Chiara Saraceno su Repubblica 19.4.18
————————-
Il ritorno degli ottimati
di Nicolò Migheli su SardegnaSoprattutto.
————————
[segue]
Oggi domenica 22 aprile 2018

![]()








![]() ——————–Dibattiti&Commenti—————————
——————–Dibattiti&Commenti—————————
Domenica 29 a Nuxis si inaugura il “Cammino della Libertà” nei luoghi della latitanza del capo della Rivolta di Palabanda
22 Aprile 2018
Andrea Pubusa su Democraziaoggi.

(Murale di F. Del Casino a Nuxis sulla latitanza dell’Avv. Salvatore Cadeddu -1812/13)
Per Nuxis, nel Sulcis, domenica 29 aprile sarà una giornata importante. Su iniziativa dell’Associazione culturale “Le Sorgenti”, alle 10 dalla piazza Satta, vicina al Municipio, partirà la carovanna per l’inaugurazione del “Cammino della Libertà” lungo il percorso che dal centro del Paese […]
—————————————————–
Oggi 22 aprile Giornata Mondiale della Terra
 Giornata Mondiale della Terra
Giornata Mondiale della Terra
L’Earth Day (Giornata della Terra) è la più grande manifestazione ambientale del pianeta, l’unico momento in cui tutti i cittadini del mondo si uniscono per celebrare la Terra e promuoverne la salvaguardia. La Giornata della Terra, momento fortemente voluto dal senatore statunitense Gaylord Nelson e promosso ancor prima dal presidente John Fitzgerald Kennedy, coinvolge ogni anno fino a un miliardo di persone in ben 192 paesi del mondo.
Le Nazioni Unite celebrano l’Earth Day ogni anno, un mese e due giorni dopo l’equinozio di primavera, il 22 aprile.
Approfondimenti
——————————————————
La crisi della scuola riflesso della crisi della società
SOCIETÀ E POLITICA » TEMI E PRINCIPI » DE HOMINE
Scuola e bullismo
 articoli ripresi da eddyburg
articoli ripresi da eddyburg
il manifesto, Corriere della sera, eddyburg, 20 aprile 2018. La crisi della scuola è il riflesso della crisi di una società nella quale il “titolo” vale mille, mentre i contenuti dell’apprendimento valgono zero. Articoli di Alessandra Pigliaru, Alba Sasso e Antonio Polito.
—————————————————
Oggi sabato 21 aprile 2018

![]()








![]() ——————–Dibattiti&Commenti—————————
——————–Dibattiti&Commenti—————————
 Il sindacato nell’alternanza scuola-lavoro
Il sindacato nell’alternanza scuola-lavoro
21 Aprile 2018
Marco Mereu, segr. prov. Fiom, su Democraziaoggi.
Democraziaoggi pubblica la seconda parte dell’intervento di Marco Mereu al Convegno del 13 marzo scorso “Prima di tutto il lavoro e la scuola”, indetto dall’Anpi, dal Cidi e dal Costat.
————————-
Non colpa ma gloria
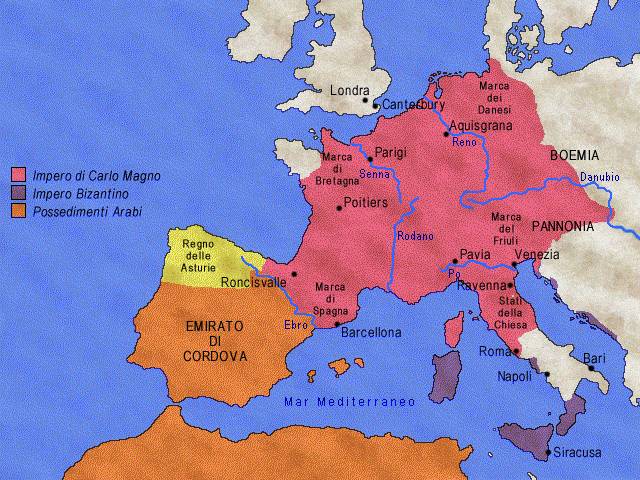
 L’accusa al papa
L’accusa al papa
NON COLPA MA GLORIA
Sotto il titolo “Fine del cattolicesimo romano?” lo storico Roberto Pertici interpreta il pontificato di Francesco come risposta alla crisi di quella determinazione storica del cristianesimo che è stato il regime di cristianità quale negli ultimi secoli si è costruito in Occidente e che sarebbe oggi al tramonto. Analisi che il partito antipapista agita come accusa al papa
di Roberto Pertici
1. A questo punto del pontificato di Francesco, credo che si possa ragionevolmente sostenere che esso segna il tramonto di quell’imponente realtà storica definibile come “cattolicesimo romano”.
Questo non significa, beninteso, che la Chiesa cattolica sia alla fine, ma che sta tramontando il modo in cui si è storicamente strutturata e autorappresentata negli ultimi secoli.
Mi pare evidente, infatti, che sia questo il progetto consapevolmente perseguito dal “brain trust” che si stringe attorno a Francesco: un progetto inteso sia come risposta estrema alla crisi dei rapporti fra la Chiesa e il mondo moderno, sia come premessa per un rinnovato percorso ecumenico in comune con le altre confessioni cristiane, specie quelle protestanti.
*
2. Per “cattolicesimo romano” intendo quella grande costruzione storica, teologica e giuridica che prende l’avvio dall’ellenizzazione (per l’aspetto filosofico) e dalla romanizzazione (per l’aspetto politico-giuridico) del cristianesimo primitivo e che si basa sul primato dei successori di Pietro, quale emerge dalla crisi del mondo tardo-antico e dalla sistemazione teorica dell’età gregoriana (“Dictatus Papae”).
Nei secoli successivi, la Chiesa si è data inoltre un proprio diritto interno, il diritto canonico, guardando al diritto romano come modello. E questo elemento giuridico ha contribuito a plasmare gradualmente una complessa organizzazione gerarchica con precise norme interne, che regolano la vita sia della “burocrazia di celibi” (l’espressione è di Carl Schmitt) che la gestisce, sia dei laici che ne sono parte.
L’altro decisivo momento di formazione del “cattolicesimo romano” è infine l’ecclesiologia elaborata dal concilio di Trento, che ribadisce la centralità della mediazione ecclesiastica in vista della salvezza, in contrasto con le tesi luterane del “sacerdozio universale”, e quindi fissa il carattere gerarchico, unito e accentrato della Chiesa; il suo diritto di controllare e, se occorra, condannare le posizioni che contrastino con la formulazione ortodossa delle verità di fede; il suo ruolo nell’amministrazione dei sacramenti.
Tale ecclesiologia trova il suo suggello nel dogma dell’infallibilità pontificia proclamato dal concilio Vaticano I, messo alla prova ottant’anni dopo nell’affermazione dogmatica dell’Assunzione in cielo di Maria (1950), che assieme alla precedente proclamazione dogmatica della sua Immacolata Concezione (1854) ribadisce anche la centralità del culto mariano.
Sarebbe riduttivo, tuttavia, se ci limitassimo a quanto detto ora. Perché esiste, o meglio esisteva, anche un diffuso “sentire cattolico”, così fatto:
– un atteggiamento culturale che si basa su un realismo, a proposito della natura umana, talora disincantato e disposto a “tutto comprendere” come premessa del “tutto perdonare”;
– una spiritualità non ascetica, comprensiva di certi aspetti materiali della vita, né disposta a disprezzarli;
– impegnato nella carità quotidiana verso umili e bisognosi, senza il bisogno di idealizzarli o di farne quasi novelli idoli;
– disposto a rappresentarsi anche nella propria magnificenza, quindi non sordo alle ragioni della bellezza e delle arti, come testimonianza di una Bellezza suprema a cui il cristiano deve tendere;
– sottile indagatore dei più riposti moti del cuore, della lotta interiore fra il bene e il male, della dialettica fra “tentazioni” e risposta della coscienza.
Si potrebbe quindi dire che in quello che chiamo “cattolicesimo romano” si intrecciano tre aspetti, oltre ovviamente a quello religioso: l’estetico, il giuridico, il politico. Si tratta di una visione razionale del mondo che si fa istituzione visibile e compatta e che entra fatalmente in conflitto con l’idea di rappresentanza emersa nella modernità, basata sull’individualismo e su una concezione del potere che, salendo dal basso, finisce per mettere in discussione il principio di autorità.
*
3. Questo conflitto è stato considerato in modi diversi, spesso opposti, da coloro che l’hanno analizzato. Carl Schmitt guardava con ammirazione alla “resistenza” del “cattolicesimo romano”, considerato come l’ultima forza in grado di frenare le forze dissolvitrici della modernità. Altri lo hanno duramente criticato: in questa lotta, la Chiesa cattolica avrebbe rovinosamente enfatizzato i suoi tratti giuridico-gerarchici, autoritari, esteriori.
Al di là di queste opposte valutazioni, è certo che negli ultimi secoli il “cattolicesimo romano” sia stato costretto alla difensiva. A mettere progressivamente in discussione la sua presenza sociale è stata soprattutto la nascita della società industriale e il conseguente processo di modernizzazione, che ha avviato una serie di mutamenti antropologici tuttora in atto. Quasi che il “cattolicesimo romano” fosse “organico” (per dirla con linguaggio vetero-marxista) a una società agraria, gerarchica, statica, basata sulla penuria e sulla paura e non trovasse invece una rilevanza in una società “affluente”, dinamica, caratterizzata dalla mobilità sociale.
Una prima risposta a questa situazione di crisi fu data dal concilio ecumenico Vaticano II (1962-1965), che nelle intenzioni di papa Giovanni XXIII che lo aveva convocato doveva operare un “aggiornamento pastorale”, guardare cioè con nuovo ottimismo al mondo moderno, insomma abbassare finalmente la guardia: non si trattava più di portare avanti un secolare duello, ma di aprire un dialogo e operare un incontro.
Il mondo era percorso in quegli anni da cambiamenti straordinari e da un inedito sviluppo economico: probabilmente la più sensazionale, rapida e profonda rivoluzione nella condizione umana di cui ci sia traccia nella storia (Eric J. Hobsbawm). L’evento concilio contribuì a questo mutamento, ma ne fu a sua volta travolto: il ritmo degli “aggiornamenti” – favorito anche dalla vorticosa trasformazione ambientale e dalla convinzione generale, cantata da Bob Dylan, che “the times they are a-changin’” – sfuggì di mano alla gerarchia, o almeno a quella sua parte che voleva operare una riforma, non una rivoluzione.
Così fra il 1967 e il 1968 si assistette alla “svolta” di Paolo VI, che si espresse nell’analisi preoccupata delle turbolenze sessantottine e poi della “rivoluzione sessuale” contenuta nell’enciclica “Humanae vitae” del luglio 1968. Tanto era il pessimismo a cui giunse negli anni Settanta quel grande pontefice che, conversando col filosofo Jean Guitton, si domandava e gli domandava, riecheggiando un inquietante passo del vangelo di Luca: “Quando il Figlio dell’Uomo ritornerà, troverà ancora la fede sulla terra?”. E aggiungeva: “Ciò che mi colpisce, quando considero il mondo cattolico, è che all’interno del cattolicesimo sembra talvolta predominare un pensiero di tipo non cattolico, e può avvenire che questo pensiero non cattolico all’interno del cattolicesimo diventi domani il più forte”.
*
4. È noto quale sia stata la risposta dei successori di Paolo VI a questa situazione: coniugare cambiamento e continuità; operare – su alcune questioni – le opportune correzioni (memorabile, da questo punto di vista, la condanna della “teologia della liberazione”); cercare un dialogo con la modernità che fosse al tempo stesso una sfida: sui temi della vita, della razionalità dell’uomo, della libertà religiosa.
Benedetto XVI, in quello che fu il vero testo programmatico del suo pontificato (il discorso alla curia pontificia del 22 dicembre 2005), ribadì poi un punto fermo: che le grandi scelte del Vaticano II andavano lette e interpretate alla luce della tradizione precedente della Chiesa, quindi anche dell’ecclesiologia emersa dal concilio di Trento e dal Vaticano I. Anche per la semplice ragione che non si può operare una smentita formale della fede creduta e vissuta da generazioni e generazioni, senza introdurre un “vulnus” irreparabile nell’autorappresentazione e nella percezione diffusa di un’istituzione come la Chiesa cattolica.
È noto anche come questa linea abbia causato un diffuso rigetto non solo “extra ecclesiam”, dove si manifestò in un’aggressione mediatica e intellettuale contro papa Benedetto assolutamente inedita, ma – nel modo nicodemitico e nella mormorazione congeniti nel mondo clericale – anche nel corpo ecclesiastico, che sostanzialmente lasciò solo quel papa nei momenti più critici del suo pontificato. Da qui, credo, la sua rinuncia del febbraio 2013, che – al di là di interpretazioni rassicuranti – appare come un evento epocale, del quale le ragioni e le implicazioni di lungo periodo restano ancora tutte da approfondire.
*
5. Questa fu la situazione ereditata da papa Francesco. Mi limito solo ad accennare agli aspetti biografici e culturali che rendevano “ab initio” Jorge Mario Bergoglio in parte estraneo a quello che ho chiamato il “cattolicesimo romano”:
– il carattere periferico della sua formazione, profondamente radicata nel mondo latino-americano, che gli rende difficile incarnare l’universalità della Chiesa, o almeno lo spinge a viverla in modo nuovo, accantonando la civiltà europea e quella nordamericana;
– l’appartenenza a un ordine, come la Compagnia di Gesù, che nell’ultimo mezzo secolo ha operato uno dei più clamorosi riposizionamenti politico-culturali di cui si abbia notizia nella storia recente, passando da una posizione “reazionaria” a una variamente “rivoluzionaria” e quindi dando prova di un pragmatismo per molti aspetti degno di riflessione;
– l’estraneità all’elemento estetico che è proprio del “cattolicesimo romano”, la sua ostentata rinuncia a ogni rappresentazione di dignità di carica (gli appartamenti pontifici, la mozzetta rossa e il consueto apparato pontificale, le automobili di rappresentanza, la residenza di Castel Gandolfo) e a quelle che chiama “abitudini da principe rinascimentale” (a cominciare dal ritardo e poi assenza a un concerto di musica classica in suo onore agli inizi del pontificato).
Cercherei piuttosto di sottolineare quello che può essere a mio parere l’elemento unificante dei molteplici mutamenti che papa Francesco sta introducendo nella tradizione cattolica.
Lo faccio basandomi su un piccolo libro di un eminente uomo di Chiesa, che viene generalmente considerato il teologo di riferimento dell’attuale pontificato, citato eloquentemente da Francesco già nel suo primo Angelus, quello del 17 marzo 2013, quando disse: “In questi giorni ho potuto leggere un libro di un cardinale – il cardinale Kasper, un teologo in gamba, un buon teologo – sulla misericordia. E mi ha fatto tanto bene quel libro, ma non crediate che faccia pubblicità ai libri dei miei cardinali. Non è così. Ma mi ha fatto tanto bene, tanto bene”.
Il libro di Walter Kasper a cui qui mi riferisco ha per titolo: “Martin Lutero. Una prospettiva ecumenica”, ed è la versione rielaborata e ampliata di una conferenza tenuta dal cardinale il 18 gennaio 2016 a Berlino. Il capitolo sul quale voglio richiamare l’attenzione è il sesto: “Attualità ecumenica di Martin Lutero”.
Tutto il capitolo è costruito su un’argomentazione binaria, secondo cui Lutero fu indotto ad approfondire la rottura con Roma principalmente dal rifiuto del papa e dei vescovi di procedere a una riforma. Fu solo di fronte alla sordità di Roma – scrive Kasper – che il riformatore tedesco, “sulla base della sua comprensione del sacerdozio universale, dovette accontentarsi di un ordinamento d’emergenza. Egli ha però continuato a confidare nel fatto che la verità del Vangelo si sarebbe imposta da sé e ha così lasciato la porta fondamentalmente aperta per una possibile futura intesa”.
Ma anche da parte cattolica, all’inizio del Cinquecento, restavano molte porte aperte, c’era insomma una situazione fluida. Scrive Kasper: “Non c’era una ecclesiologia cattolica armonicamente strutturata, ma unicamente degli approcci, che erano più una dottrina sulla gerarchia che una ecclesiologia vera e propria. L’elaborazione sistematica dell’ecclesiologia si avrà solamente nella teologia controversistica, come antitesi alla polemica della Riforma contro il papato. Il papato divenne così, in un modo fino ad allora sconosciuto, il contrassegno di identità del cattolicesimo. Le rispettive tesi e antitesi confessionali si condizionarono e bloccarono a vicenda”.
Bisogna dunque procedere oggi – stando al senso complessivo dell’argomentazione di Kasper – a una “deconfessionalizzazione” sia delle confessioni riformate sia della Chiesa cattolica, nonostante questa non si sia mai avvertita come una “confessione”, ma come la Chiesa universale. Si deve tornare a qualcosa di simile alla situazione che precedeva il divampare dei conflitti religiosi del Cinquecento.
Mentre però in campo luterano questa “deconfessionalizzazione” si è oggi già ampiamente compiuta (con la secolarizzazione spinta di quelle società, per cui i problemi che erano alla base delle controversie confessionali sono diventati irrilevanti per la stragrande maggioranza dei cristiani “riformati”), in campo cattolico invece molto ancora si deve fare, appunto per la sopravvivenza di aspetti e strutture di quello che ho chiamato il “cattolicesimo romano”. È quindi soprattutto al mondo cattolico che è rivolto l’invito alla “deconfessionalizzazione”. Kasper la invoca come una “riscoperta della cattolicità originaria, non ristretta ad un punto di vista confessionale”.
A tal fine sarebbe quindi necessario portare fino in fondo il superamento dell’ecclesiologia tridentina e di quella del Vaticano I. Secondo Kasper il concilio Vaticano II ha aperto la strada, ma la sua ricezione è stata controversa e tutt’altro che lineare. Da qui il ruolo dell’attuale pontefice: “Papa Francesco ha inaugurato una nuova fase in tale processo di ricezione. Egli sottolinea l’ecclesiologia del popolo di Dio, il popolo di Dio in cammino, il senso della fede del popolo di Dio, la struttura sinodale della Chiesa, e per la comprensione dell’unità mette in gioco un interessante nuovo approccio. Descrive l’unità ecumenica non più con l’immagine dei cerchi concentrici attorno al centro, ma con l’immagine del poliedro, cioè di una realtà a molte facce, non un ‘puzzle’ messo insieme dall’esterno, ma un tutto e, come trattandosi di una pietra preziosa, un tutto che riflette la luce che lo colpisce in modo meravigliosamente molteplice. Ricollegandosi a Oscar Cullmann, papa Francesco riprende il concetto della diversità riconciliata”.
*
6. Se riconsideriamo brevemente sotto questa luce i comportamenti di Francesco che hanno suscitato più scalpore, ne comprendiamo meglio la logica unitaria:
– la sua sottolineatura, fin dal giorno dell’elezione, della sua carica di vescovo di Roma, più che di pontefice della Chiesa universale;
– la sua destrutturazione della figura canonica del pontefice romano (il celeberrimo “chi sono io per giudicare?”), alla base della quale – dunque – non vi sono solo i moventi caratteriali prima accennati, ma una ragione più profonda, di carattere teologico;
– il pratico depotenziamento di alcuni sacramenti fra i più caratteristici del “sentire cattolico” (la confessione auricolare, il matrimonio indissolubile, l’eucaristia), realizzato per ragioni pastorali di “misericordia” e “accoglienza”;
– l’esaltazione della “parrhesìa” all’interno della Chiesa, della confusione presunta creatrice, a cui si lega una visione della Chiesa quasi come una federazione di Chiese locali, dotate di ampi poteri disciplinari, liturgici e anche dottrinali.
C’è chi prova scandalo per il fatto che in Polonia finirà per avere vigore un’interpretazione di “Amoris laetitia” diversa da quella che si realizzerà in Germania o in Argentina, riguardo alla comunione ai divorziati risposati. Ma Francesco potrebbe rispondere che si tratta di facce diverse di quel poliedro che è la Chiesa cattolica, al quale quindi si potranno aggiungere prima o poi – perché no? – anche le Chiese riformate post-luterane, in uno spirito appunto di “diversità riconciliata”.
Su questa strada, è facile prevedere che i prossimi passi saranno un ripensamento della catechesi e della liturgia in senso ecumenico, anche qui con il cammino che spetta alla parte cattolica molto più impegnativo di quello della parte “protestante”, considerati i diversi punti di partenza, come pure un depotenziamento dell’ordine sacro nel suo aspetto più “cattolico”, cioè nel celibato ecclesiastico, con il che la gerarchia cattolica cesserà anche di essere la schmittiana “burocrazia di celibi”.
Si comprende meglio, allora, la vera e propria esaltazione della figura e dell’opera di Lutero che si è prodotta ai vertici della Chiesa cattolica in occasione del cinquecentesimo anniversario del 1517, fino al discusso francobollo commemorativo dedicatogli dalle poste vaticane, con lui e Melantone ai piedi di Gesù in croce.
Personalmente non ho dubbi che Lutero sia uno dei giganti della “storia universale”, come si amava dire una volta, ma “est modus in rebus”: soprattutto le istituzioni devono avere una sorta di pudore nell’operare rovesciamenti di queste dimensioni, pena il ridicolo: lo stesso da cui eravamo assaliti nel Novecento, quando vedevamo i comunisti di allora riabilitare all’unisono e a comando gli “eretici” condannati e combattuti strenuamente fino al giorno prima: il “Contrordine, compagni!” delle vignette di Giovannino Guareschi.
*
7. Se dunque ieri il “cattolicesimo romano” era avvertito come un corpo estraneo dalla modernità, estraneità che non gli era perdonata, è naturale che il suo tramonto venga oggi salutato con gioia dal “mondo moderno” nelle sue istituzioni politiche, mediatiche e culturali e che quindi l’attuale pontefice sia visto come colui che sana quella frattura fra i vertici ecclesiastici e il mondo dell’informazione, delle organizzazioni e dei “think tank” internazionali, che – apertasi nel 1968 con la “Humanae vitae” – si era fatta più profonda nei pontificati successivi.
Ed è anche naturale che gruppi ed ambienti ecclesiastici che già negli anni Sessanta auspicavano il superamento della Chiesa tridentina e che in questa prospettiva hanno letto il Vaticano II, dopo aver vissuto sotto traccia nell’ultimo quarantennio, siano oggi usciti allo scoperto e con i loro eredi laici ed ecclesiastici figurino fra le componenti di quel “brain trust” cui si accennava all’inizio.
Restano aperti però alcuni interrogativi, che imporrebbero ulteriori e non facili riflessioni.
L’operazione portata avanti da papa Francesco e dal suo “entourage” conoscerà un successo duraturo o finirà per incontrare resistenze, all’interno della gerarchia e di ciò che resta del popolo cattolico, maggiori di quelle in definitiva marginali finora emerse?
A quale tipo di nuova realtà “cattolica” nella società occidentale essa darà vita?



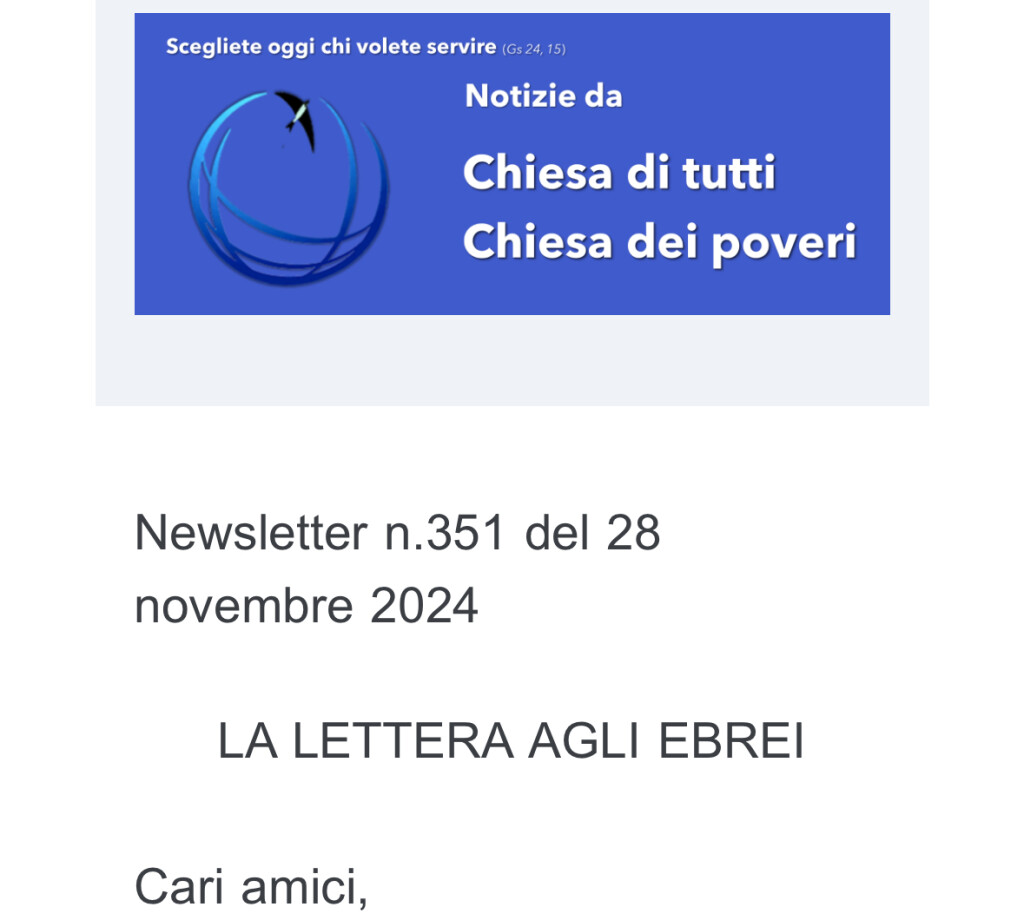






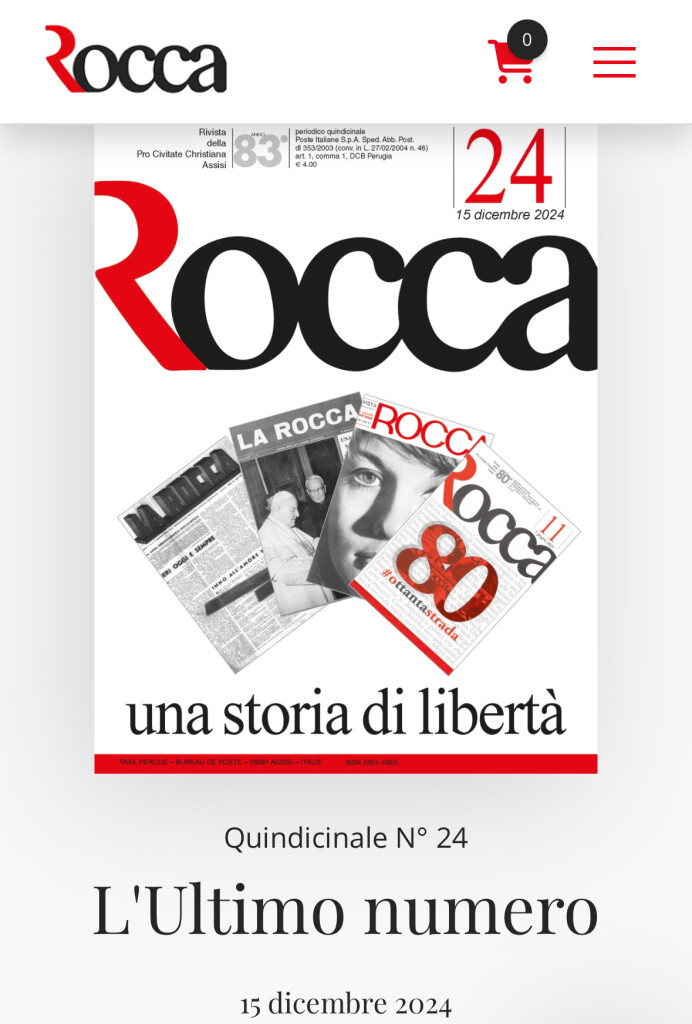




 AService Studio
AService Studio