Monthly Archives: ottobre 2017
Ripensare la Sardegna. Un Nuovo Piano di Rinascita della Sardegna Possibile e Auspicabile
Ultimamente gli impegni politici mi portano spesso fuori Cagliari consentendomi un riscontro sempre più preciso delle ripercussioni nel territorio che ha avuto l’istituzione della città metropolitana con l’approvazione della Legge Regionale 2/2016 con la quale si è proceduto al riordino del sistema delle autonomie locali in Sardegna. La città metropolitana di Cagliari ha un senso se riuscirà a svolgere un ruolo guida al servizio dell’isola, se riuscirà ad essere motore per lo sviluppo economico di tutti, se riuscirà a redistribuire nel territorio le molte risorse che riceve sia dall’U.E. sia dal governo centrale. Questo del resto era previsto nella relazione introduttiva alla legge.
Il timore è che invece tutto sia incentrato nella sola città madre ovvero Cagliari. Queste stesse preoccupazioni hanno fatto si che durante il percorso legislativo che l’ha istituita si creassero polemiche dannose che hanno trovato il culmine nella localizzazione della sede dell’Ats a Sassari. Riforme di questo genere devono essere quanto mai condivise e devono unire e non dividere.
Il problema se vogliamo non riguarda la sola novità della città metropolitana ma l’intera riforma degli enti locali. Riforma incentrata sull’esigenza minima di razionalizzare la spesa senza preoccuparsi di dare un’adeguata risposta alle esigenze dei territori, perché non si è voluto tener conto delle differenze. Pensate alla provincia del Sud Sardegna con capoluogo a Carbonia ma che si estende fino all’Ogliastra (fagocitata dalla provincia di Nuoro). Si è pensato di aumentare gli enti senza curarsi delle conseguenze, con il rischio di un ulteriore spopolamento delle zone interne a vantaggio delle aree urbane più sviluppate e verso i centri costieri. Rischio rafforzato e purtroppo confermato dalla Legge sull’urbanistica.
Le riforme istituzionali dovrebbero essere incentrate in un’ottica di sviluppo locale oggi totalmente assente. L’altro giorno ho osservato con grande attenzione i dati sulla disoccupazione in Sardegna che ha ricavato Salvatore Multinu dalla lettura dei dati ISTAT. Così mentre il Sistema Informativo del Lavoro sostiene che l’occupazione su base annua aumenta del 3% i dati ricavati dall’Istat ci dicono che i disoccupati sono aumentati dal 2006 al 2016 del 6,6%. Certo lo stesso Sistema Informativo spiega che l’analisi di questi dati può indurre in errore travisando la realtà. A questo punto noi spostiamo la nostra visuale e chiediamoci come mai tra il 2007 e il 2016 ben 21.746 sardi sono emigrati all’estero e nel solo 2016 le persone che hanno lasciato l’isola sono ben 3.370. Se consideriamo che partono generalmente i laureati e i diplomati allora ci dobbiamo chiedere quale futuro può avere questa terra se molti tra i suoi figli migliori vanno via.
Dico queste cose perché i temi istituzionali e quelli dello sviluppo sono strettamente connessi e quando parliamo di sviluppo dobbiamo chiederci se è il caso di continuare con un sistema industriale completamente estraneo al contesto Sardo basato sulle importazioni più che sulle esportazioni, con industrie come la chimica, la petrolchimica, la produzione dell’alluminio che hanno portato disoccupazione e miseria lasciando tra l’altro l’ambiente circostante fortemente compromesso avendolo inquinato, oppure voltare pagina e puntare sulle energie rinnovabili, l’agroalimentare, l’economia del mare, il turismo e il rilancio della nostra agricoltura.
Concludo con una riflessione. Noi abbiamo bisogno di una Regione snella capace di decentrare funzioni alla periferia per stimolare la capacità a risolvere i problemi locali, che le consenta di concentrarsi maggiormente in un rapporto alla pari con lo Stato Centrale, perché non è pensabile che da una parte lo Stato declini le sue responsabilità e faccia sparire dalla Costituzione il tema delle isole e del mezzogiorno e dall’altra faccia onore all’impegno previsto dallo Statuto sardo che all’art.13 recita: lo Stato col concorso della Regione dispone un piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell’isola. Forse è proprio dalla rivendicazione di un Nuovo Piano di Rinascita che occorre ripartire, unificando su questo grande obbiettivo i movimenti e i partiti che li sostengono e rappresentano.

———–
![]() Recente dibattito su ipotesi di Nuovo Piano di Rinascita della Sardegna: Vanni Tola su Aladinews.
Recente dibattito su ipotesi di Nuovo Piano di Rinascita della Sardegna: Vanni Tola su Aladinews.
Oggi sabato 14 ottobre 2017
![]()





——————————————————————
Se i guardiani della Carta sono distratti
14 Ottobre 2017
Massimo Villone Il Manifesto, 11 ottobre 2017, ripreso da Democraziaoggi.
—————————–oggi—————–

Su Democraziaoggi.
————————–Oggi&domani—————-

Programma.
——————————
Riflessioni ripartendo da Gramsci. “Un nuovo umanesimo sociale, una nuova antropologia in grado di federare le fragilità, di riscattare in forma collettiva la solitudine e la disperazione trasformando in forza la debolezza: solo da qui è possibile ripartire”
 6 OTTOBRE, 2017 IN SINISTRA
6 OTTOBRE, 2017 IN SINISTRA
Considerazioni inattuali su Gramsci: il disastro della sinistra e le prospettive.
di PIERO BEVILACQUA
da “Reblab.it“, 4 ottobre 2017*, ripreso da
![]()
Esiste un indicatore infallibile dello stato di salute della sinistra italiana: è la discrepanza tra la complessità dei problemi storici che stiamo attraversando, dentro una transizione che pone l’umanità di fronte a interrogativi che toccano e trasformano il nostro destino (il rapporto con la tecnologia e la robotizzazione del lavoro, il rapporto tra sviluppo e ambiente, la demografia, le grandi migrazioni, lo sfruttamento, le nuove guerre) e la mediocrità della nostra iniziativa politica quotidiana.
Mediocrità e pigrizia intellettuale, direttamente proporzionale all’ansia da tweet, all’ossessione compulsiva per il commento inutile e comprensibile soltanto agli addetti ai lavori.
Ma così si perde di vista il senso della politica e della storia, la consapevolezza che si è in campo, si milita, per difendere e affermare le ragioni della nostra parte, in un conflitto progressivo verso equilibri più avanzati e più giusti.
Questo è il punto di vista autonomo sul mondo che oggi manca alla parte prevalente e più visibile dei gruppi dirigenti della sinistra nel nostro Paese: la consapevolezza di un progetto, di una strategia dentro cui collocare anche la battaglia quotidiana, le iniziative, le dichiarazioni alla stampa, persino i tweet.
In questa autonomia dovrebbe invece vivere sempre la curiosità di porre domande alla nostra storia, alla nostra tradizione, alla nostra cultura politica. Mi pare che più ci impastiamo di mediocrità, più ci disconnettiamo dal sentimento dei settori popolari che dovremmo difendere, rappresentare e coinvolgere, e più mostriamo debolezza e reticenza rispetto alle nostre radici.
Abbiamo paura di nominarle. Nel Paese che ha visto nascere e crescere il più grande e forte partito comunista d’Occidente. Non propongo certo il comunismo come soluzione univoca ai problemi dell’Italia. Non avrebbe senso, non sarebbe comprensibile per spiegare la nostra idea per l’oggi e per il domani. Né penso che quella radice debba essere l’unica. Tutte le grandi tradizioni politiche democratiche del nostro Paese sono ricche di semi e fertili: dal personalismo cattolico-democratico alle diverse forme di socialismo liberale, fino all’azionismo.
Però quella radice esiste, va vissuta senza imbarazzo, va nominata. A questa altezza si colloca Antonio Gramsci: non come un feticcio, ma come l’arnese migliore di una cassetta degli attrezzi che va conosciuta, utilizzata, rinnovata se avremo le forze e le qualità per farlo.
Gramsci, a ottant’anni dalla morte, ci consegna un mare di spunti, di idee e persino alcune prescrizioni.
Provo a elencare quattro di queste suggestioni che a mio avviso sono utili nell’impresa di ricostruire un pensiero della sinistra adeguato ai tempi e un soggetto politico degno di questo pensiero.
La prima riguarda l’idea di partito. Alla fine del 1925 Gramsci scrive le tesi di quello che sarà – a Lione, nel gennaio dell’anno successivo – il III congresso del Pcd’I. E’ un passaggio fondamentale: il partito è in clandestinità, il fascismo si sta consolidando nella forma della dittatura dopo le leggi fascistissime. Quel congresso segna una svolta e la fine dell’egemonia sul partito di Amedeo Bordiga. Le tesi sono un atto di accusa raffinatissimo e spietato del settarismo.
Ciò che serve è un partito interno e non esterno alla classe, strutturato nei luoghi di lavoro e della produzione, non in comitati d’avanguardia sconnessi dalla vita quotidiana delle masse. Ciò che serve è un partito in cui l’elaborazione politico-intellettuale sale dal basso verso l’alto e la responsabilità della direzione viene condivisa. Non un nucleo inossidabile di rivoluzionari talmente convinti della propria infallibilità da guardare con diffidenza – come Bordiga, nelle tesi di Roma del II congresso del PCd’I – persino all’impegno nelle vertenze dei lavoratori.
Del resto, è l’idea che Gramsci sviluppa già nella stagione dell’Ordine Nuovo, quella dei Consigli, dell’autogoverno, dell’autonomia dei produttori, connettendo l’urgenza di una rivoluzione progressiva del sistema economico a partire dal protagonismo dei lavoratori dentro il processo produttivo con la necessità di radicare un partito di uomini e donne consapevoli, liberi, capaci di pensare e dunque di dirigere collettivamente.
La seconda è a questa strettamente legata. Un partito di questa natura, in cui si annulla (si tende ad annullare) la distanza tra dirigenti e diretti, in cui – per usare le sue stesse parole – “ogni membro del partito è un elemento politico attivo, è un dirigente”; un partito che può e vuole fare a meno del capo carismatico cui affidare fortune e attese, nel quale le masse non sono considerate masse di manovra (“esercito” passivo) perché sono soggetto protagonista e cosciente, è così non per una scelta morale o arbitraria. E’ così, vive della mobilitazione e del protagonismo cosciente dei suoi militanti, perché sa interpretare il contesto nel quale agisce. Sa che economicamente, socialmente, culturalmente, storicamente la politica democratica ha bisogno del protagonismo delle masse.
E’ un’idea che attraversa la storia dei comunisti italiani in mille forme, dalla democrazia progressiva di Eugenio Curiel sino a Pietro Ingrao. Ma in ogni frangente essa ha poggiato sulla disamina precisissima e rigorosa della società italiana. Nel caso di Gramsci, in quelle tesi di Lione, c’è il cuore della questione politica: il compromesso tra agrari e industriali, che è all’origine della questione meridionale, cioè dell’arresto dello sviluppo economico di intere regioni del Paese, del deficit del bilancio economico e di un rapporto coloniale con il Sud che fa dei lavoratori meridionali una forza potenzialmente sovversiva dello Stato nazionale (“forza continuamente mobilitata contro lo Stato”). Da qui il ruolo della classe operaia che svolge “una funzione unificatrice e coordinatrice di tutta la società, il cui programma è unitario” nella costruzione di alleanze sociali più larghe. E da qui, ancora, il giudizio sul fascismo, che ha unificato le forze reazionarie non più attraverso un compromesso ma in una unità organica, in un unico organismo politico, accentrando e monopolizzando nel partito fascista, nel governo e nello Stato le funzioni di controllo e direzione.
Si chiede Gramsci: cosa fece il Pcd’I per frenare l’avanzata del fascismo? La sua risposta è precisa: non tutto quello che avrebbe dovuto. Non capendo fino in fondo il pericolo, la pervasività antidemocratica del fascismo, non cogliendo – di esso – la capacità di sfondamento a livello sociale e popolare e non riuscendo, di conseguenza, ad opporsi alla sua ascesa al potere incuneandosi (come avrebbe dovuto fare con gli arditi del popolo) nelle pieghe del suo consenso popolare.
Quindi l’analisi, storica e sociale, sempre. Che impedisce errori tattici e favorisce la connessione sentimentale con le classi popolari. Perché non c’è partito in grado di svolgere una funzione rivoluzionaria se non aderisce plasticamente al “territorio”, alla struttura produttiva, alla complessità delle sue articolazioni intermedie e se – sulla base di questa analisi – non si fa carico di una funzione generale.
In questo Gramsci c’è ovviamente – a partire dal ruolo della classe operaia industriale – molto marxismo puro: l’idea di un punto di vista di parte muovendo dal quale si possono leggere le dinamiche sociali per individuare non un interesse parziale ma un interesse generale dentro la costruzione di un blocco storico alternativo. Così come, a partire da qui, ci sarà molto Gramsci in Togliatti, nella idea di costruire un partito nuovo, di massa, in dialogo con le forze storiche della società italiana (a partire dalle masse cattoliche) e con le forze innovative (a partire dai ceti medi) sulla strada della via italiana al socialismo.
La terza suggestione è ancora un passo più in là, dentro questo stesso milieu. Un partito così, non settario, che lavora dentro la società e la storia italiana per abolire la distanza tra dirigenti e diretti dentro di sé e al di fuori di sé, quale idea di rivoluzione può propugnare? Non certo la conquista del palazzo di Inverno, non certo l’ora x della presa militare del comando. Ma una rivoluzione molecolare, come processo permanente e progressivo di accumulazione di forze, di massa critica, di idee, di consenso. È il tema della rivoluzione nell’Occidente, patria di una società civile articolata e complessa, luogo di elaborazione di un apparato ideologico formidabile, raffinatissimo. Che va smontato, decostruito, ricostruito, conquistato pezzo per pezzo. Sostituendo, attraverso l’esercizio dell’egemonia, al dominio e alla forza il consenso e la capacità di direzione ideale e morale della società. Così si fanno proprie le casematte, così ci si incammina nella direzione di cambiare il segno al potere, alle strutture, alle sovrastrutture, al rapporto tra esse.
L’ultimo spunto, infine. E’ il cuore di quel Quaderno 22 dedicato all’americanismo e al fordismo. A me pare contenga elementi profetici. Analizza agli albori lo sviluppo capitalistico statunitense, la razionalizzazione dei processi produttivi, Ford e Taylor, tanto sul piano economico e sociale quanto sul piano culturale, persino antropologico. Inizia l’era dell’operaio deprofessionalizzato e alienato, non più padrone della propria prestazione, non più consapevole del prodotto del proprio lavoro, non più artigiano, non più creativo, non più specializzato. Ben oltre i primi processi di industrializzazione che Marx aveva studiato, cogliendone il senso e, in prospettiva, il valore genetico.
Comincia il Novecento e Gramsci ne intuisce il cuore: non si tratta di essere contrari alla tecnologia, al lavoro ordinato razionalmente. Non bisogna essere luddisti, reazionari, anti-moderni. Si tratta invece di difendere la dimensione dello “umanesimo del lavoro” dentro una fase più alta di sviluppo produttivo. Si tratta di impedire che questo sviluppo produca “gorilla ammaestrati” ridotti a numero e a merce, privi di coscienza, di pensiero, di strumenti contro-egemonici. Perché è evidente che si tratti – nel caso dell’americanismo – di una vera e propria “rivoluzione passiva” (imposta dall’alto verso il basso, con la complicità passiva dei subalterni) del capitale volta a conquistare corpo e anima della classe operaia: mani e fatica, testa e intelletto.
Come si reagisce, quindi, alla rivoluzione passiva che annulla l’uomo, la persona, la capacità di esprimere coscienza di sé e valore sociale? Soltanto ponendo l’obiettivo di una nuova antropologia alternativa al “tipo umano” indotto dalla rivoluzione passiva americanista. Siamo ancora a questo punto, alla fine del ciclo lunghissimo del fordismo e in questa nuova transizione segnata dalla seconda rivoluzione passiva del capitale nel Novecento (quella principiata alla fine degli anni Settanta, con la frammentazione del processo produttivo, la finanziarizzazione spinta dell’economia e la fine del ciclo lungo delle lotte operaie del trentennio glorioso) e – ora – dalla più grande crisi economica dell’ultimo secolo che apre a scenari nuovi. Scenari nei quali, proprio sul terreno antropologico e sul terreno del “nesso psico-fisico” (per dirla ancora con Gramsci) i caratteri di spersonalizzazione, alienazione, solitudine e frantumazione sono esplosi a livello parossistico costringendo le classi subalterne (estese in nuove e inedite articolazioni sociali e simboliche) a una vera e propria lotta per la sopravvivenza contro il dominio della tecnica e della finanza.
Un nuovo umanesimo sociale, una nuova antropologia in grado di federare le fragilità, di riscattare in forma collettiva la solitudine e la disperazione trasformando in forza la debolezza: solo da qui è possibile ripartire.
Ed è ancora Antonio Gramsci a farci intravedere la prospettiva. Con dolcezza. In una lettera del 1928 indirizzata a Giulia, in cui Gramsci ricorda un operaio che diversi anni prima, dopo l’uscita dal lavoro, passava ogni sera nel suo ufficio. Spesso gli diceva: “Non ho potuto dormire, oppresso dal pensiero: cosa farà il Giappone?”. Era ossessionato dal Giappone, di cui – continua Gramsci – “nei giornali italiani si parla solo quando muore il Mikado o un terremoto uccide almeno 10.000 persone”. Anche il Giappone di Gramsci, la sua ossessione, era il mondo, “il quadro sistematico delle forze del mondo”. La capacità di guardare oltre, di guardare lontano, potremmo dire. Ma allo stesso tempo Gramsci coltivava una seconda ossessione: la vita reale e quotidiana dei suoi figli, che ovviamente la reclusione in carcere gli impediva di vedere crescere.
Ma non soltanto quella dei suoi figli. Anche quella di chiunque altro, nell’insieme. Perché tutto si teneva, tutto si doveva tenere: “i libri e le riviste danno solo idee generali […] ma non possono dare l’impressione immediata, diretta, viva, della vita di Pietro, di Paolo, di Giovanni, di singole persone reali, senza capire i quali non si può neanche capire ciò che è universalizzato e generalizzato”.
Ecco: il Giappone, il quadro sistemico delle forze del mondo e la vita reale di Giulia, di Pietro, di Paolo, di Giovanni. Abbiamo bisogno di un partito così, all’intersezione tra il Giappone e la vita reale. E di un gruppo dirigente a proprio agio a queste latitudini.
Antonio Gramsci è così. Necessario e inattuale, proprio perché lontano dalla politica di oggi, abbandonato dalla sinistra italiana anche quando lo ricorda e lo commemora. Questa è la riflessione che Gramsci ci ha consegnato, dentro una storia che continua. Spetta un po’ anche a noi non interromperla, rinnovarla in questo mondo “grande e terribile” in cui siamo chiamati a camminare.
* Note scritte in occasione di un’iniziativa su Gramsci organizzata presso il Centro Anziani di Torrespaccata a Roma con Antonio Bassolino, Giulia Urso e Giuseppe Manna, tenutasi lo scorso 26 settembre. Nella foto: opera dello street artist Solo, in via Affogalasino, Roma
—————
Oggi venerdì 13 ottobre 2017
![]()





——————commenti—————————————-
![]() Rosatellum: bene l’opposizione e vademecum.
Rosatellum: bene l’opposizione e vademecum.
13 Ottobre 2017
A.P. Su Democraziaoggi.
————————————-
Saviano: “La fiducia sul Rosatellum-bis è un agguato alla democrazia”.
di SILVIA TRUZZI
Saviano: “La fiducia sul Rosatellum-bis è un agguato alla democrazia”. il Fatto Quotidiano, 13 ottobre 2017, ripreso da eddyburg e da aladinews. «“Cambiare sistema alla vigilia del voto è da Paese malato: chi usa parole forti fa benissimo”». (p.d.)
———————————————————————————–
 Vincono i comitati: a Torino l’acqua torna pubblica
Vincono i comitati: a Torino l’acqua torna pubblica
di MAURIZIO PAGLIASSOTTI
Vincono i comitati: a Torino l’acqua torna pubblica il manifesto, 12 ottobre 2017 Torino, ripreso da eddyburg e da aladinews. Via libera del consiglio comunale alla delibera che toglie ai privati le gestione del servizio idrico. Contrari Pd, Forza Italia e Lega (c.m.c.)
————————————————————————————-

 Gli Editoriali di Aladinews. Materiali per il Dibattito su Lavoro e Reddito di Cittadinanza
Gli Editoriali di Aladinews. Materiali per il Dibattito su Lavoro e Reddito di Cittadinanza
La solidarietà: dato naturale o concetto ideologico?
di Gianfranco Sabattini su Aladinews e su Democraziaoggi.
————————————————————————————————-
Lo sviluppo locale in Sardegna: un flop?
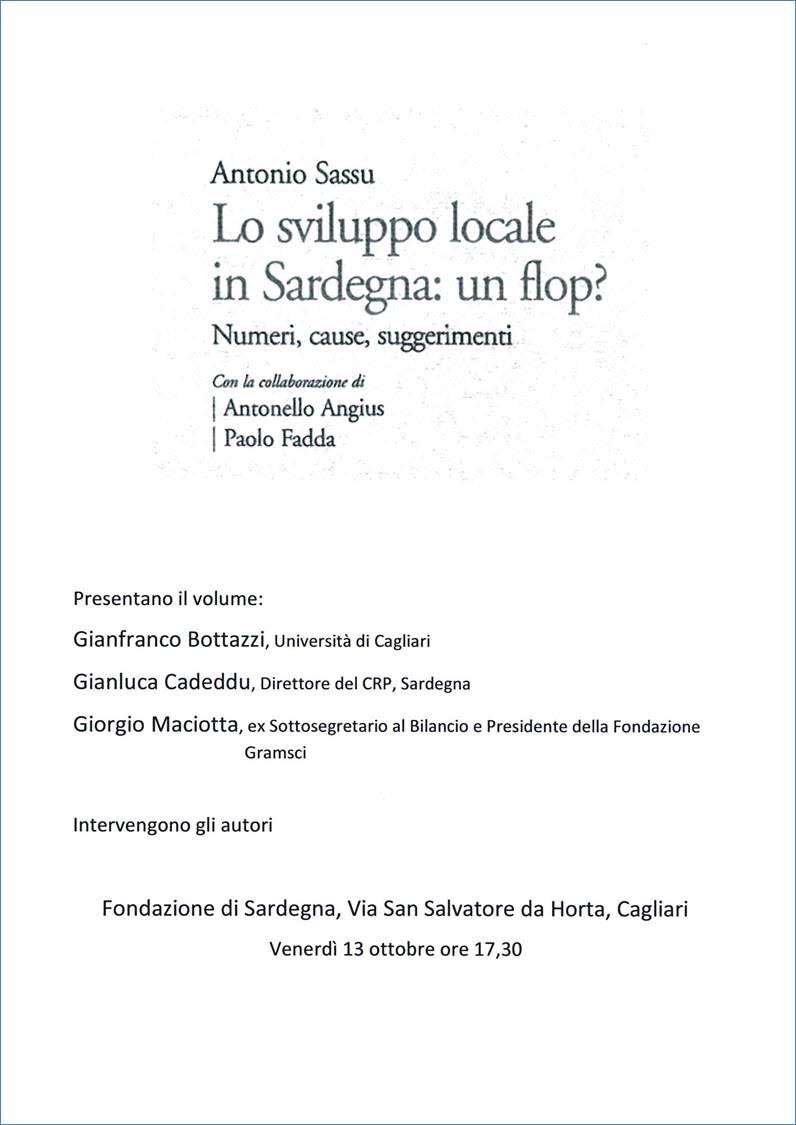 Lo sviluppo locale in Sardegna: un flop? Uno studio appena pubblicato da Antonio Sassu, economista di lungo corso dell’università di Cagliari, cerca di rispondere a questo interrogativo, che è anche il titolo del volume.
Lo sviluppo locale in Sardegna: un flop? Uno studio appena pubblicato da Antonio Sassu, economista di lungo corso dell’università di Cagliari, cerca di rispondere a questo interrogativo, che è anche il titolo del volume.
Lo studio sarà presentato a Cagliari venerdi 13 ottobre alle 17,30 presso la Fondazione di Sardegna (via San Salvatore da Horta) da Gianfranco Bottazzi (sociologo dell’Università di Cagliari), Gianluca Cadeddu (direttore del Centro regionale di programmazione) e Giorgio Macciotta (già Sottosegretario al Bilancio e attualmente Presidente della Fondazione Gramsci).
Il sottotitolo del volume, a cui hanno collaborato con specifici capitoli Antonello Angius e Paolo Fadda, promette “Numeri, cause, suggerimenti”: si tratta forse della più documentata e completa analisi sui risultati dei programmi e progetti che per circa quindici anni hanno monopolizzato l’attenzione e le risorse pubbliche in gran parte d’Italia (la Programmazione negoziata), con una particolare attenzione a quelli della Sardegna (Patti territoriali, Piani integrati d’area, Leader, PIT …).
Programmi e progetti che, tuttavia, improvvisamente, come spesso accade nel nostro Paese, sono finiti nel dimenticatoio senza bilanci e resoconti oggettivi sui risultati ottenuti. Esperti e autori cercheranno di riaccendere la luce su alcune stanze abbandonate della programmazione pubblica, in cui è transitato un fiume di denaro per lo sviluppo locale, per capire quali lezioni è possibile trarre dall’esperienza.
Aumento delle disuguaglianze e Reddito di cittadinanza: il Fondo monetario internazionale ipotizza perfino qualcosa (moderatamente) di sinistra!


L’aumento della disuguaglianza e la lenta crescita economica di molti paesi hanno concentrato l’attenzione sulle politiche a sostegno della crescita inclusiva. Mentre una disuguaglianza è inevitabile in un sistema economico basato sul mercato, la disuguaglianza eccessiva può erodere la coesione sociale, portare alla polarizzazione politica e infine ridurre la crescita economica. Questo Fiscal monitor esamina come le politiche fiscali possono contribuire a raggiungere obiettivi ridistributivi. Essa si concentra su tre discussioni politiche salienti: tassi di imposta in cima alla distribuzione del reddito, introduzione di un reddito base universale e ruolo della spesa pubblica per l’istruzione e la salute.
(Sommario del “FISCAL MONITOR IMF Fiscal Monitor: Tackling Inequality, October 2017″ del Fmi)

ITI IS MIRRIONIS. Si muove… lentamente!
 ITI Is Mirrionis: pubblicato sul sito del Comune di Cagliari il bando per l’affidamento del Servizio di assistenza per la gestione del processo di accompagnamento inclusivo: http://www.comune.cagliari.it/portale/it/at20_notizie_dett.page?contentId=NWS204414
ITI Is Mirrionis: pubblicato sul sito del Comune di Cagliari il bando per l’affidamento del Servizio di assistenza per la gestione del processo di accompagnamento inclusivo: http://www.comune.cagliari.it/portale/it/at20_notizie_dett.page?contentId=NWS204414
Materiali per il Dibattito su Lavoro e Reddito di Cittadinanza

 La solidarietà: dato naturale o concetto ideologico?
La solidarietà: dato naturale o concetto ideologico?
di Gianfranco Sabattini
Nel libro “Solidarietà. Un’utopia necessaria”, di cui si è già parlato su Aladinews e su Democraziaoggi, Stefano Rodotà sottolinea come la parola usata come titolo del libro fosse divenuta “proscritta”; di essa – afferma l’autore – “ci si voleva liberare o se ne cancellava ogni senso positivo”, in quanto si considerava la solidarietà, “non più tratto che lega benevolmente le persone, ma delitto: delitto appunto di solidarietà, quando i comportamenti di accettazione dell’altro […] vengono considerati illegittimi e si prevedono addirittura sanzioni penali per chi vuol garantirgli diritti fondamentali”.
Le vicende storiche della solidarietà sono state, a parere di Rodotà, caratterizzate da alti e bassi, che però hanno consentito al concetto “di conservare nei diversi sistemi una benefica tensione”, servita a ribadire l’”irriducibilità del mondo alla sola dimensione del mercato”; ma anche a ricordare che principi, come appunto quello di solidarietà, prima affidati “alla forza della morale o all’azione politica”, sono stati trasformati in norme giuridiche; fatto, questo, che impone che quei principi siano oggi “presi sul serio”. A tal fine, diventa perciò necessario capire come sia avvenuta l’evoluzione della solidarietà da precetto morale a vincolo giuridico, e come ciò si sia congiunto al problema della funzionalità della democrazia e della possibilità della sua conservazione.
In questo modo, secondo Rodotà, collegando l’evoluzione del principio di solidarietà e la sua trasformazione in uno dei capisaldi della democrazia, diviene possibile, da un lato, ”dilatare” i confini del significato della solidarietà, “sottraendola in qualche modo alle letture riduttive suggerite dalla crisi dello Stato sociale e individuandone un più largo campo di operatività”; dall’altro lato, capire come siano divenute stringenti le connessioni tra democrazia e solidarietà, “rendendo plausibile la conclusione secondo la quale solo la presenza effettiva dei segni della solidarietà consente di definire ‘democratico’ un sistema politico”; come dire che, se si affievolisce il principio di solidarietà, si affievolisce anche la possibilità di sopravvivenza della democrazia.
Considerando il particolare interesse che nei momenti di crisi la solidarietà riesce a promuovere, si deve forse concludere – si chiede Rodotà – “che essa è virtù di tempi difficili, e non un ‘sentimento repubblicano’ che deve accompagnarci in ogni momento?” Dal punto di vista storico, il concetto di solidarietà è comparso in tempi diversi, non ha conosciuto un’evoluzione lineare, ma ha sempre mostrato una capacità di “forzare le barriere” entro le quali si è cercato di rinchiuderlo, sino a convertirsi in una “potente forza positiva”, diventando sinonimo di fraternità, per costituire, come già si è detto, con i concetti di libertà e di uguaglianza, i principi che hanno presieduto alla nascita del mondo moderno.
Rodotà esclude che la solidarietà sia un “dato naturale” e sia invece un “dato costruito”, cioè un’ideologia nata alla fine del XIX secolo, implicante una “nuova rappresentazione del legame sociale e politico”, che ha portato a una “profonda trasformazione dei modi di gestione del sociale e delle forme di intervento pubblico”. Si tratta di una tesi, questa, che richiama, sempre secondo Rodotà, un altro dato “tutt’altro che naturalistico”, che considera la solidarietà “nel suo separasi dalla fraternità”, perché della “triade rivoluzionaria”, proprio la fraternità si è rivelata la componente più debole, o quella più difficilmente accettabile, per via del rilievo che l’affermazione dell’ideologia liberale ha assegnato al diritto di proprietà.
La fraternità è stata infatti oscurata dal primato del diritto di proprietà; diritto, questo, implicante l’esclusione degli altri “dal godimento di un bene, dunque destinato a spezzare quel legame tra gli uomini”, che attraverso la fraternità si era inteso stabilire. In tal modo, la fraternità ha cessato di esprimere un diritto fraterno, imbattendosi “nella durezza del nudo potere proprietario”, che ha separato e non unito, rendendo impossibile il vero compito affidato alla fraternità/solidarietà. La scomparsa della fraternità è valsa ad affievolire anche l’efficacia dei principi di libertà ed uguaglianza, in quanto anch’essi subordinati a una logica che ha indicato nella proprietà “la misura prima dei rapporti tra le persone”. Ma è proprio per salvaguardare l’efficacia di questi ultimi due principi che, nel corso del Novecento, è stato costruito un contesto costituzionale che ha individuato nel diritto di proprietà il fattore limitante il principio di solidarietà.
Così, è stato possibile ricuperare il principio di fraternità/solidarietà, essendo stato concepito tale ricupero come precondizione perché si potesse ridare la loro piena importanza ai principi di libertà ed uguaglianza. Per comprendere come sia stato possibile la costruzione di un contesto costituzionale all’interno del quale venisse riaffermato il principio di fraternità/solidarietà, diventa cruciale – afferma Rodotà – la considerazione del “modo in cui nel corso dell’Ottocento si sono sempre più fortemente intrecciate le lotte operaie, l’organizzazione di massa dei lavoratori, il progressivo riconoscimento dei diritti sociali […]. Da qui sono provenute le idee-forza che prima hanno indicato e poi hanno spianato il cammino verso il riconoscimento istituzionale della solidarietà, “come principio e riferimento necessario per l’agire pubblico e privato”.
Il processo col quale è stato ricuperato il principio di fraternità/solidarietà consente anche di capire, a parere di Rodotà, quanto sia debole l’idea che si possa avere solidarietà “senza lotta di classe” e sia invece cruciale l’idea che non possa aversi solidarietà sino a quando sulla scena sociale manchi un soggetto in grado di assicurarne il ricupero e la conservazione; individuando, nella solidarietà stessa, il mezzo per contrastare la “lotta di classe dopo la lotta di classe”, intesa nel modo in cui la concepiva Luciano Gallino, come mezzo per “contrastare una possibile “lotta condotta da una classe imprenditoriale proprio per ridimensionare i diritti sociali”.
Rodotà ritiene che il ricupero del principio di fratellanza/solidarietà, inteso come risultato costruito attraverso un processo storico, consentirebbe anche di “sfuggire a suggestioni comunitarie che […] fanno correre il rischio di passare dalla frammentazione individualistica, che si vuole contrastare, a una scomposizione della società in gruppi custodi della propria individualità più che interessati a una ricostruzione complessiva dei legami sociali”. Per Rodotà, la solidarietà non deve subire confini limitanti, in quanto, sebbene si inveri all’interno dei diversi contesti sociali secondo le loro tradizioni, essa però non deve mai perdere la “sua capacità d’essere principio unificante”.
Nella completa affermazione del principio di solidarietà, i grandi soggetti collettivi della modernità hanno quindi giocato un ruolo essenziale; la loro scomparsa, particolarmente evidente in Italia, è stata aggravata, secondo Rodotà, dall’erosione dello Stato sociale, attraverso politiche corruttive e clientelari; tutto ciò “ha aperto un vuoto, ha lasciato spazi liberi per l’iniziativa di altri soggetti, che sono così divenuti protagonisti di politiche della solidarietà”. Si è infatti consolidata la presenza di un “terzo settore”, caratterizzato dal “no profit”; per quanto meritevole di attenzione sia questo terzo settore, non si dovrà tuttavia trascurare che il principio solidaristico sia esposto al pericolo di possibili frammentazioni, che possono condurre ad inasprire il fenomeno negativo della disuguaglianza.
La costruzione sociale con la quale si è dato corpo al principio di solidarietà è stato il Welfare State, “variamente declinato nelle lingue e nei diversi contesti”; la sua costruzione e il suo mantenimento non sono avvenuti però a “costo zero”, in quanto hanno richiesto la disponibilità di “capitale sociale e risorse finanziarie”; se tali risorse diminuiscono – afferma Rodotà – “si determinano condizioni propizie per dinamiche politiche e culturali che negli ultimi tempi hanno messo in discussione lo stesso modello dello Stato sociale e riproposto una solidarietà venata di irresponsabilità pubblica e ingannevole responsabilità privata”, che ha fatto rinascere una concezione caritatevole dello stesso Stato sociale, nella quale l’”economico” ha prevalso sul “giuridico e sullo stesso politico”.
Ciò non è stato privo di conseguenze, in quanto la messa in discussione del modello dello Stato sociale ha comportato una “decostituzionalizzazione accompagnata da una ricostituzionalizzazione [della solidarietà] in termini economici”; così è stata riproposta la “centralità della proprietà”, che ha determinato una subordinazione dei diritti sociali a “una discrezionalità politica” concepita come “insindacabile potere proprietario sulle risorse disponibili; e una dipendenza della persona dalle risorse proprie, necessarie per acquistare sul mercato quel che dovrebbe essere riconosciuto come diritto e che, invece, si presenta come merce, con un evidente ritorno alla cittadinanza censitaria”.
Ma se si ricupera l’idea di fraternità/solidarietà, intesa come concetto costruito costituzionalmente, occorre affrontare due questioni dirimenti che riguardano, da un lato, l’introduzione di un reddito garantito universalmente (o reddito di cittadinanza, correttamente inteso) e, dall’altro lato, la “discrezionalità politica in tempi di risorse scarse”.
La prima questione, che può essere definita come “questione del diritto all’esistenza”, può essere risolta statuendo per lo Stato un “dovere di assicurarne la garanzia”, nel senso che le risorse disponibili, anche se scarse, devono essere utilizzate in modo da rispondere a una gerarchia che consideri prioritari gli impieghi per la soddisfazione dei diritti fondamentali, tra i quali appunto il “diritto all’esistenza”. La seconda questione, quella concernente la discrezionalità politica sull’uso delle risorse, può essere risolta consequenzialmente alla prima, stabilendo destinazioni delle risorse “costituzionalmente consentite” e “destinazioni vietate”, fondando la distinzione in relazione alla soddisfazione dei diritti fondamentali; invertendo così la prassi politica tradizionale che considera prioritarie le destinazioni finalizzate alla crescita e residuali quelle destinate alle soddisfazione dei diritti fondamentali.
Le due “questioni” indicate sollevano un problema che la definizione della solidarietà intesa da Rodotà, come “concetto costruito” o come ideologia, e non già come “dato naturale”, non consente di risolvere, subordinando la soluzione al ricatto delle politica. L’accoglimento della definizione della solidarietà come fatto naturale (sottostante al diritto di esistere di ogni individuo) implica però che tale fatto sia costituzionalizzato con un’affermazione diretta e non ricavato indirettamente attraverso altre statuizioni relative ad altri diritti sociali. Se la fratellanza/solidarietà fosse costituzionalmente istituzionalizzata sarebbe possibile, come osserva John Rawls, realizzare, tra l’altro, anche una più compiuta democrazia. Infatti, la mancata istituzionalizzazione dei principi del 1789 come principi naturali dimostra, secondo Rawls, che una democrazia che non risulti fondata sulla costituzionalizzazione congiunta e diretta dei tre principi è una democrazia incompleta e “zoppa”, dominata da un eccesso di individualismo o da un eccesso di comunitarismo.
In conclusione, solo all’interno di una comunità nella quale siano eliminate, in termini pre-politici, le disuguaglianze nella distribuzione delle opportunità è possibile correlare una vera democrazia, fondata su un vero “sentimento repubblicano”, ad un processo di crescita e sviluppo stabile e socialmente condiviso. La qualità dell’evoluzione sociale ed economica verrebbe così a dipendere da un’organizzazione della comunità che sia il riflesso della costituzionalizzazione esplicita di tre condizioni: il governo democratico dei rapporti sociali della comunità; la parificazione ex ante delle opportunità di tutti i componenti la comunità come conseguenza dell’accoglimento congiunto sul piano costituzionale dei principi sanciti dalla rivoluzione del 1789; l’affrancamento del lavoro e di tutti i rapporti sociali da ogni forma di condizionamento del capitale. Fuori da queste condizioni, il diritto all’esistenza degli individui continuerà sempre a dipendere dal “ricatto politico”, esercitato in funzione della prevalente contingenza.
————-

—————————-
Per correlazione. Fmi: ‘Disuguaglianze di reddito in aumento nei Paesi avanzati. Reddito di cittadinanza? Costa fino al 6,5% del pil’ Su il fatto quotidiano.
Oggi giovedì 12 ottobre 2017
![]()





——————————————————————
SOCIETÀ E POLITICA » TEMI E PRINCIPI » DE HOMINE
La rabbia non ci salverà
di SIMONETTA FIORI
La Repubblica, 8 ottobre 2017, ripreso da eddyburg e da aladinews. «È un sentimento distruttivo: può servire per reagire alle ingiustizie, ma va subito purificato”. Martha Nussbaum parla del suo ultimo libro. E spiega perché critica anche il perdono»
———————————————-domani—————————————-
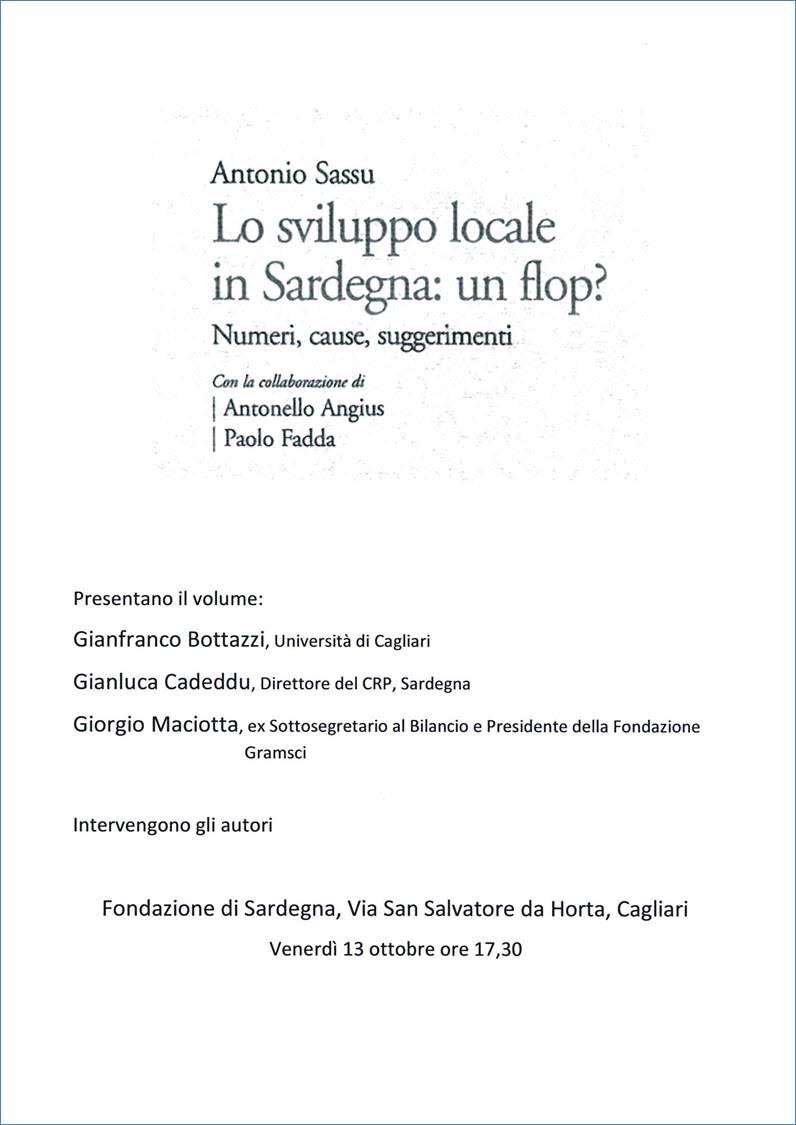
————————————————————
 Sardegna: lo sviluppo locale un flop? Parola di Antonio Sassu
Sardegna: lo sviluppo locale un flop? Parola di Antonio Sassu
12 Ottobre 2017, su Democraziaoggi.
——————————————————————————–
![]() La solidarietà: dato naturale o concetto ideologico?
La solidarietà: dato naturale o concetto ideologico?
12 Ottobre 2017
Gianfranco Sabattini su Democraziaoggi.
—————————————————
 Gli Editoriali di Aladinews.
Gli Editoriali di Aladinews.
Il Reddito di Cittadinanza non è un provvedimento-tampone contro la povertà
di Gianfranco Sabattini
————————————–
Appello del Comitato per la democrazia costituzionale
Oggi mercoledì 11 ottobre 2017
![]()





——————————————————————
Il Comitato si mobilita: No al voto di fiducia
Fateci scegliere i nostri parlamentari
NO AL VOTO DI FIDUCIA
 La scelta di mettere il voto di fiducia sul Testo della Legge elettorale evidenzia un ulteriore atto di disprezzo degli esiti del Referendum del 4 Dicembre e configura una grave lesione democratica.
La scelta di mettere il voto di fiducia sul Testo della Legge elettorale evidenzia un ulteriore atto di disprezzo degli esiti del Referendum del 4 Dicembre e configura una grave lesione democratica.
Il Coordinamento per la Democrazia Costituzionale invita tutti i propri aderenti a manifestare, a partire dalle ore 13 di mercoledì 11 ottobre, sostenendo, con la propria autonomia e le proprie impostazioni, le iniziative programmate in P.zza Montecitorio e al Pantheon.
Il CDC vuole così condividere l’impegno di tutti coloro che si stanno battendo per la difesa dei valori costituzionali e per una legge elettorale che rispetti i cittadini senza imposizioni dall’alto e senza distorsioni della loro volontà.
A Roma il concentramento sarà alle ore 13 in P.za Montecitorio e la nostra protesta si trasferirà successivamente alle 17.30 al Pantheon.
Appello del Comitato per la democrazia costituzionale
——————————Informazioni Costat———————
 Ieri presso la sede del CSS si è svolta la riunione del Comitato d’iniziativa costituzionale e statutaria di Cagliari.
Ieri presso la sede del CSS si è svolta la riunione del Comitato d’iniziativa costituzionale e statutaria di Cagliari.
Il Comitato ha espresso soddisfazione per il successo del Convegno sul Lavoro, a cui un gruppo di compagni ed amici ha lavorato fin dal mese di febbraio. Gli interventi hanno sottolineato la novità dell’iniziativa fondata non sulla lamentazione o gli slogans, ma – col supporto di autorevoli relatori e di soggetti che stanno sul campo – sull’analisi economica e sociologica e sulla proposta.
Si è deciso così di approfondire alcune indicazioni emerse dal Convegno come scuola-lavoro; dividendo sociale o reddito di cittadinanza; lavoro-ambiente; economia sociale e solidale; beni comuni… Sul punto il gruppo di lavoro riferirà e farà una proposta nella prossima riunione.
Si è anche deciso di riprendere la mobilitazione sulla legge elettorale anche alla luce dei gravi sviluppi del dibattito parlamentare sulla legge elettorale. Il Comitato nazionale ha lanciato un appello alla mobilitazione, che si può leggere nelle news Democraziaoggi http://www.democraziaoggi.it/?p=5125 e aladinews (https://www.aladinpensiero.it/?p=73576).
Anche su questo il Comitato locale sta predisponendo un programma di iniziative che comprende la battaglia per una nuova legge elettorale regionale. Sul tema una prima iniziativa, insieme all’ANPI, si svolgerà all’Hostel Marina il prossimo 16 ott. alle 17, con un dibattito introdotto dalla costituzionalista Silvia Niccolai sui tempi della sovranità popolare, della rappresentanza e dei sistemi elettorali. E’ importante essere numerosi.
Data la neccessità di una forte ripresa dell’azione del Comitato e l’urgenza di intervenire in modo organico sulla questione elettorale si lancia un appello a tutti i compagni e amici alla partecipazione alle riunioni e alle iniziative. La prossima riunione è fissata per mercoledì prossimo. Seguirà avviso.
———————————————————-
Legge elettorale. Tre fiducie, poi altre tre
11 Ottobre 2017
Su Democraziaoggi.
—————————————–Dibattito——————————————-
CATALOGNA ![]()
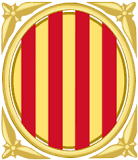 Catalogna. E’ eversiva l’azione della Generalitat?
Catalogna. E’ eversiva l’azione della Generalitat?
11 Ottobre 2017
Emanuele Pes su Democraziaoggi.
————————————————————————————
Materiali per il Dibattito su Lavoro e Reddito di Cittadinanza

 Facendo seguito all’anticipazione fattane in questa stessa rubrica, e ad altri precedenti contributi, pubblichiamo un saggio breve del prof. Gianfranco Sabattini sul “Reddito di Cittadinanza”, o meglio sul “Dividendo Sociale”, come lui preferisce denominare lo strumento che costituirebbe una fonte alternativa alle sempre più improbabili nuove opportunità di lavoro. Stiamo parlando di una tematica complessa, non riconducibile alle semplificazioni proprie di molte trattazioni giornalistiche o, peggio ancora, a molte improvvisate e superficiali proposte presenti nel recente dibattito politico. Al contrario, le teorie serie e fondate, se non altro perché avanzate da illustri economisti, tra i quali James Edward Meade, premio Nobel per l’Economia del 1977, fanno fare a Gianfranco Sabattini una scelta di campo precisa a favore del RdC-Dividendo Sociale nel dibattito sui sistemi più efficaci per perseguire il benessere collettivo. Tale scelta netta a nostro avviso favorisce il confronto tra posizioni e indubbiamente contribuisce a illuminare la strada ai decisori politici. Non spetta a noi, giornalisti e operatori della comunicazione, fare scelte altrettanto chiare e definite. A noi spetta fornire un terreno fertile per il dibattito. Come abbiamo fatto e stiamo facendo con il sostegno all’attività del Comitato d’Iniziativa Costituzionale e Statutaria a partire dalla preparazione, organizzazione e, ora, disseminazione dei contenuti, del recente Convegno sul Lavoro (4-5 ottobre u.s.). Proprio in tale sede sono emersi i termini del dibattito e l’attuale (diciamo attuale perché forse il dibattito potrebbe anche fornire soluzioni intermedie o diverse) contrapposizione tra teorie e posizioni politiche; la più netta tra quelle contrarie (o fortemente critiche rispetto) al RdC sembra essere quella di cui si è fatto autorevole sostenitore Papa Francesco, nella più aggiornata versione della Dottrina sociale della Chiesa cattolica (espressa con massima chiarezza nel discorso fatto a Genova ai lavoratori dell’Ilva il 27 maggio u.s.), che Giacomo Meloni, Segretario nazionale della CSS, ha ripreso, condividendola, nel suo intervento al nostro Convegno. Nel ringraziare il prof. Sabattini per il suo tenace lavoro di ricercatore accademico e di eccellente divulgatore, non possiamo che rinnovare la richiesta, o, meglio, la giusta pretesa, perché le Università sarde al riguardo si impegnino seriamente sul versante dell’approfondimento scientifico, mettendosi a maggiore disposizione della società, in primis quella sarda di loro primo riferimento.
Facendo seguito all’anticipazione fattane in questa stessa rubrica, e ad altri precedenti contributi, pubblichiamo un saggio breve del prof. Gianfranco Sabattini sul “Reddito di Cittadinanza”, o meglio sul “Dividendo Sociale”, come lui preferisce denominare lo strumento che costituirebbe una fonte alternativa alle sempre più improbabili nuove opportunità di lavoro. Stiamo parlando di una tematica complessa, non riconducibile alle semplificazioni proprie di molte trattazioni giornalistiche o, peggio ancora, a molte improvvisate e superficiali proposte presenti nel recente dibattito politico. Al contrario, le teorie serie e fondate, se non altro perché avanzate da illustri economisti, tra i quali James Edward Meade, premio Nobel per l’Economia del 1977, fanno fare a Gianfranco Sabattini una scelta di campo precisa a favore del RdC-Dividendo Sociale nel dibattito sui sistemi più efficaci per perseguire il benessere collettivo. Tale scelta netta a nostro avviso favorisce il confronto tra posizioni e indubbiamente contribuisce a illuminare la strada ai decisori politici. Non spetta a noi, giornalisti e operatori della comunicazione, fare scelte altrettanto chiare e definite. A noi spetta fornire un terreno fertile per il dibattito. Come abbiamo fatto e stiamo facendo con il sostegno all’attività del Comitato d’Iniziativa Costituzionale e Statutaria a partire dalla preparazione, organizzazione e, ora, disseminazione dei contenuti, del recente Convegno sul Lavoro (4-5 ottobre u.s.). Proprio in tale sede sono emersi i termini del dibattito e l’attuale (diciamo attuale perché forse il dibattito potrebbe anche fornire soluzioni intermedie o diverse) contrapposizione tra teorie e posizioni politiche; la più netta tra quelle contrarie (o fortemente critiche rispetto) al RdC sembra essere quella di cui si è fatto autorevole sostenitore Papa Francesco, nella più aggiornata versione della Dottrina sociale della Chiesa cattolica (espressa con massima chiarezza nel discorso fatto a Genova ai lavoratori dell’Ilva il 27 maggio u.s.), che Giacomo Meloni, Segretario nazionale della CSS, ha ripreso, condividendola, nel suo intervento al nostro Convegno. Nel ringraziare il prof. Sabattini per il suo tenace lavoro di ricercatore accademico e di eccellente divulgatore, non possiamo che rinnovare la richiesta, o, meglio, la giusta pretesa, perché le Università sarde al riguardo si impegnino seriamente sul versante dell’approfondimento scientifico, mettendosi a maggiore disposizione della società, in primis quella sarda di loro primo riferimento.
—————————————
Il Reddito di Cittadinanza non è un provvedimento-tampone contro la povertà
di Gianfranco Sabattini
1. Premessa
Il dibattito politico che ha preceduto l’introduzione in Italia del “Reddito d’inclusione”, inteso come provvedimento utile per assicurare il sostegno economico in modo progressivo a tutte le famiglie che si trovino al di sotto della soglia di povertà assoluta, ha rilanciato la “campagna di disinformazione” sul Reddito di Cittadinanza (RdC), spargendo su quest’ultima forma di reddito valutazioni e giudizi che sono del tutto estranei al discorso degli economisti che ne hanno definito e formalizzato in termini compiuti il concetto, collocandolo all’interno di un’analisi coerente con i principi della teoria economica. Esempi di disinformazione recente sono offerti da un articolo di Raoul Kirchmayer, apparso su L’Espresso del 30 aprile scorso, dal titolo “Una trappola contro i poveri. Non fidatevi del reddito di cittadinanza: è la vittoria culturale del neoliberismo”, e dall’intervista concessa dal tedesco Henning Meyer, docente alla London School of Economics, a Carlo Bordoni, il cui testo è apparso sul periodico domenicale del Corriere delle Sera, “La Lettura”, col titolo “Il reddito garantito umilia le persone”.
Kirchmayer afferma d’aver sentito parlare per la prima volta del “RdC” dal filosofo Jean-Mark Ferry, uno degli studiosi che, a partire dalla fine degli anni Ottanta, ha contribuito a diffonderne la conoscenza e l’attuazione. Il nesso che si sosteneva esistesse tra la cittadinanza e una base economica garantita dall’introduzione del “RdC” è sembrata a Kirchmayer “una forma di protezione sociale capace di mettere al riparo dalle incertezze di quella che, di lì a poco, sarebbe stata chiamata ‘società del rischio’”.
Il nesso, perciò, non evocava nessuna correlazione del “RdC” con la povertà, della quale, tra l’altro, non si parlava; questo nesso, secondo Kirchmayer, è cominciato a comparire dopo il 2007/2008. Con la crisi, sarebbe mutato il senso e il significato originario come utopia o come proposta di politica del “RdC”. Questo avrebbe cessato di rappresentare un progetto d’inclusione della democrazia e di ampliamento dei diritti democratici materiali dei cittadini, per diventare “un intervento-tampone per limitare la sofferenza dei ceti più attaccati dalla crisi”. La crisi, secondo Kirchmayer, avrebbe comportato, in merito al senso del “RdC”, uno suo spostamento “nella produzione discorsiva pubblica”, che sarebbe valsa ad attribuirgli un carattere non più utopico e progettuale; uno spostamento, cioè, che lo avrebbe “fatto entrare da qualche anno a questa parte e con denominazioni diverse, nell’agenda politica nazionale di movimenti e partiti”.
Il discorso critico di Kirchmayer è condivisibile; ciò che non è condivisibile è la sua implicita affermazione secondo la quale, a causa dell’”incompetenza” dei movimenti e dei partiti politici, il concetto di Reddito di Cittadinanza possa aver perso il senso e il significato che gli sono stati attribuiti originariamente. Quando, però, il “RdC” sia correttamente inserito nella “cornice teorica” grazie alla quale coloro che l’hanno costruita hanno dotato il concetto di senso e di significato univoci, nessun movimento o partito politico può stravolgere il concetto stesso in funzione di esigenze politiche contingenti.
Più grave è la disinformazione sul “RdC” che origina dalle considerazioni svolte da Henning Meyer nell’intervista concessa a Bordoni. Egli mette addirittura in dubbio l’efficacia del “RdC” contro la disoccupazione, facendo pensare che la sua introduzione possa portare allo “smantellamento del sistema previdenziale, sostituito da misure minime generalizzate”, destinate a ridursi “ad una falsa democratizzazione”, in quanto il Reddito di Cittadinanza “si risolverebbe in una falsa democratizzazione, privilegiando le classi che non hanno bisogno di sostegno”. Inoltre, Meyer nutre dubbi sull’efficacia del “RdC” come strumento utile a contrastare la disoccupazione tecnologica. Ciò si verificherebbe per diversi motivi: intanto, perché il “RdC” ridurrebbe il lavoro a semplice fonte di introiti, con la conseguenza di radicare l’ignoranza circa la sua natura di fattore di autostima; inoltre, perché il ricevimento di un salario sociale indurrebbe la forza lavoro a non riuscire più ad inserirsi nel mondo del lavoro, a causa della rapida obsolescenza delle competenze professionali provocata dalle trasformazioni tecnologiche dei moderni sistemi economici.
In luogo di erogare un Reddito di Cittadinanza, i governi dovrebbero combattere la disoccupazione comportandosi keynesianamente come “datori di lavori di ultima istanza”; in questo modo, a parere di Meyer, “i governi avrebbero uno strumento aggiuntivo per incrementare le attività socialmente utili”; ma anche “per finanziare lo sport e altre attività culturali a livello locale, rafforzando la coesione sociale delle comunità”. Si potrebbe anche aggiungere, sebbene Meyer manchi ricordarlo, il possibile ampliamento del servizio civile secondo le forme e le modalità indicate dall’attuale Ministro della difesa italiano.
Concludendo la sua critica riguardo al “RdC”, Meyr, contraddittoriamente, dopo aver escluso che le risorse necessarie per combattere la disoccupazione attraverso lo Stato datore di lavoro di “ultima istanza” possano essere recuperate attraverso un “ripensamento” del sistema fiscale, non ha avuto altro di meglio che proporre, per il futuro, la “democratizzazione” del capitale accumulato, per estendere al maggior numero possibile di cittadini le quote di partecipazione alla sua proprietà.
Le osservazioni critiche di Meyer sorprendono, non solo per la sua rinnovata fiducia nel sistema del welfare State, che egli considera ancora come strumento efficace per risolvere il problema della disoccupazione tecnologica originata dai moderni sistemi industriali; ma anche, e soprattutto, perché mostra di ignorare il contributo di un suo illustre predecessore alla London School of Economics, James Edward Meade, il cui contributo pionieristico alla definizione e giustificazione del Reddito di Cittadinanza resta un punto di riferimento ineludibile, come si cercherà di evidenziare nelle pagine che seguono, per capirne il senso sul piano sociale, oltre che su quello economica.
2. Reddito di cittadina e disoccupazione strutturale
Allo stato attuale, una cosa è certa; una schiera sempre più espansa di analisti di sinistra, di centro e di destra va sostenendo da tempo, che la logica capitalistica di funzionamento dei moderni sistemi produttivi non è più in grado di “creare” posti di lavoro, né di “conservare” i livelli occupazionali acquisiti. Quindi, gli attuali sistemi industrializzati, anziché soddisfare gli stati di bisogno delle rispettive società civili (funzione, questa, che dovrebbe valere a giustificarli e a legittimarli socialmente) riversano su di esse l’”inconveniente” di produrre crescenti livelli di disoccupazione strutturale irreversibile. Di fronte a questa situazione sopraggiunge l’incombente e fatidica domanda: che fare allora?
Proprio per dare una risposta all’interrogativo, è maturata l’idea che occorresse creare all’interno dei sistemi sociali che soffrono della crescente disoccupazione strutturale irreversibile condizioni (fuori dalle logiche rivoluzionarie del passato) tali da consentire, non solo il sostentamento del nuovo “esercito industriale di riserva” senza lavoro, ma anche l’autoproduzione, resa possibile dall’erogazione del “RdC”, considerato come fonte alternativa di nuove opportunità di lavoro.
Affrontando la soluzione del problema della disoccupazione, insistendo sul valore psicologico del lavoro e trascurando la natura strutturale irreversibile della disoccupazione, si manca di considerare il crescente e continuo affievolimento, se non della totale estinzione, dell’etica del lavoro; in tal modo, ci si preclude di comprendere come gli esiti negativi della disoccupazione strutturale possono essere rimossi ricorrendo ad una forma di reddito incondizionato, qual è il Reddito di Cittadinanza, alternativo al reddito di mercato. Sin tanto che non sarà rimosso il rapporto che si presume esista tra il lavoro e la stima di sé, che porta a considerare il lavoro stesso come un valore esistenziale dal quale non si può prescindere (perché: “il lavoro è vita”, “il lavoro è partecipazione”, “il lavoro è autonomia”, ecc.), la necessità di creare posti di lavoro continuerà a costituire una priorità sociale ineludibile, ma irrisolvibile in presenza delle attuali regole di funzionamento delle economie di mercato integrate nell’economia mondiale.
Perché il lavoro possa portare la stima di sé occorre che esso produca beni e servizi che possano essere “apprezzati” dai potenziali consumatori e dai contribuenti, quando sono questi a doverlo finanziare; ne consegue, perciò, che il lavoro creato attraverso contribuzioni pubbliche solo perché si ritiene costituisca un valore in sé potrebbe non servire allo scopo. Ciò può accadere se il lavoro fosse avvertito come controproducente, sia da chi fruisce del prodotto finale (consumatore), sia da chi ne finanzia la produzione (contribuente).
La stima di sé del lavoratore non è un valore che possa essere presidiato con il convincimento che esso esista o, peggio, che esso debba esistere. Se il lavoro svolto da un lavoratore è “apprezzato” dagli altri, esso sarà richiesto e, necessariamente, assicurerà a chi lo svolge stima di sé; d’altra parte, se il lavoro non è richiesto, esso non potrà assicurare a chi lo esercita nessuna stima, ma solo uno stato di indigenza insostenibile e di grave frustrazione psicologica.
Inoltre, dal punto di vista dei rapporti sociali, la stima di sé, che può essere tratta da chi svolge un lavoro, dipende anche dal “tipo” di lavoro svolto. Un lavoro temporaneo, ad esempio, non può assicurare alcuna stima, in quanto coloro che lo eseguono sono occupati solo per un tempo limitato. Se, ad esempio, lo scopo del lavoro temporaneo, nelle condizioni attuali, fosse quello di impedire l’autoafflizione dei disoccupati strutturali, occorrerebbe che il lavoro fosse stabile e non precario. In conclusione, il lavoro supposto dotato di valore in sé nella attuali economie industriali avanzate non è assunzione utile alla rimozione della disoccupazione strutturale e con questa dell’indigenza; il lavoro inteso come “vita”, “dignità”, “partecipazione” e “libertà” è un residuo biblico, che si è tradotto in un principio comportamentale individualistico ed arcaico dell’uomo “condannato” a produrre ciò di cui ha bisogno per sopravvivere, non più idoneo, nei moderni sistemi industriali, a garantire stabilità economica e sociale in presenza di una giustizia distributiva condivisa. Il problema allora della giustificazione dell’erogazione di un reddito svincolato dallo svolgimento di un lavoro deve essere spostato sul piano sociale.
3. Giustificazione economico-sociale del Reddito di Cittadinanza
3.1. L’esperienza del modo di funzionare dei moderni sistemi industriali ha da tempo evidenziato che, quando la gestione del sistema economico è lasciata all’azione discrezionale della politica per il perseguimento di scopi nobili come, ad esempio, l’incremento o il mantenimento dei livelli occupativi, in assenza di un qualche automatismo autoregolatore, è resa possibile una manipolazione dei flussi di reddito, tale da creare uno stock di capitale sociale negativo (somma dei disavanzi correnti del settore pubblico) a spese dei cittadini; è questa la ragione del perché si impone oggi, all’interno delle società industriali avanzate, ed in particolare all’interno di sistemi come quello italiano che da tempo ha visto deteriorarsi i propri “fondamentali” economici, la necessità di una riforma radicale del welfare esistente.
Prima del secondo conflitto mondiale John Maynard Keynes affermava che gli Stati autoritari dell’epoca risolvevano il problema della disoccupazione a spese dell’efficienza e della libertà. Keynes, tuttavia, era certo che il mondo non avrebbe tollerato a lungo la mancanza di libertà, ma anche che non avrebbe sopportato la “piaga” della disoccupazione, imputabile alle ingiustificabili modalità di funzionamento delle economie capitalistiche. L’economista di Cambridge era anche certo che, abbattute le dittature, una corretta soluzione del problema della disoccupazione sarebbe stato possibile trovarla, ricuperando, sia l’efficienza, che la libertà.
Dopo il secondo conflitto mondiale, però, il mercato del lavoro ha subito un cambiamento nelle forme d’uso della forza lavoro, originando una diffusa disoccupazione sempre più difficile da “governare”, sino a diventare disoccupazione strutturale, che ha messo progressivamente in crisi il sistema di sicurezza sociale basato sul modello elaborato nel Regno Unito, nel 1942, da William Henry Beveridge. Questo sistema aveva tre funzioni: assicurare alla forza lavoro disoccupata la garanzia di un reddito corrisposto sotto forma di sussidi a fronte di contribuzioni assicurative; assicurare un reddito alle categorie sociali che, per qualsiasi motivo, avessero avuto bisogno di un’assistenza temporanea, nel caso in cui esse non avessero avuto il diritto ad alcun sussidio; assicurare al sistema economico servizi regolativi e di supporto all’occupazione ed al risparmio, attraverso la realizzazione delle condizioni che davano titolo a ricevere i sussidi. L’obiettivo fondamentale del welfare State realizzato è stato, sin dal suo inizio, univocamente determinato; il sistema è però “fallito”, a causa delle perdita della flessibilità del mercato del lavoro.
Il sistema di sicurezza sociale realizzato era basato sulla premessa che l’economia operasse in corrispondenza del pieno impiego, o ad un livello molto prossimo ad esso, cosicché le contribuzioni della forza lavoro bilanciassero le erogazioni previste in suo favore. Ma il sistema così come era stato concepito all’origine è divenuto largamente insufficiente rispetto all’evoluzione successiva della realtà economica e sociale. Ciò perché il welfare State è stato progressivamente esteso per coprire le emergenze conseguenti all’aumentata complessità dei sistemi economici; in tal modo, esso è divenuto costoso ed inefficiente a seguito dell’espandersi delle varie forme di sussidio che è stato necessario corrispondere e dei costi burocratici per le “prove dei mezzi” (le prove cioè di trovarsi realmente in stato di bisogno) alle quali i beneficiari dei sussidi dovevano sottoporsi.
3.2. Il fallimento delle riforme e delle integrazioni cui il sistema di sicurezza sociale è stato sottoposto, dopo la sua realizzazione, ha orientato l’analisi economica ad assumere che la sicurezza sociale dovesse avere principalmente lo scopo di assicurare una costante flessibilità del mercato del lavoro e non quello di compensare la crescente insicurezza reddituale delle forza lavoro. Il modo per rendere tra loro compatibili la flessibilità del mercato del lavoro e la sicurezza reddituale individuale nella libertà, da un lato, e l’efficienza del sistema economico, dall’altro, è stato individuato nell’istituzionalizzazione del Reddito di Cittadinanza.
Si tratta di una forma di reddito erogato incondizionatamente a favore di tutti e finanziato con le medesime risorse impegnate nel funzionamento del sistema di sicurezza sociale, l’attuale welfare; oppure mediante la distribuzione di un Dividendo Sociale, finanziato con le risorse derivanti dalla vendita sul mercato dei servizi di tutti i fattori produttivi di proprietà collettiva, gestiti dallo Stato, mediante la costituzione di un “Fondo-capitale nazionale”, per conto e nell’interesse di tutti i cittadini. Era questa l’idea originaria con cui James Edward Meade, docente alla London School of Economics e alla Cambridge University e insignito nel 1977 del premio Nobel per l’economia, parlando di Dividendo Sociale, ha introdotto nell’analisi economica il problema dell’istituzionalizzazione del Reddito di Cittadinanza.
Il Dividendo Sociale, doveva essere corrisposto di diritto a ciascun cittadino sotto forma di trasferimento, indipendentemente da ogni considerazione riguardo ad età, sesso, stato lavorativo, stato coniugale, prova dei mezzi e funzionamento stabile del sistema economico. Il suo fine ultimo doveva essere quello di realizzare un sistema di sicurezza sociale che avesse riconosciuto ad ogni singolo soggetto, in quanto cittadino, il diritto ad uno standard minimo di vita, in presenza di una giustizia sociale più condivisa; un sistema di sicurezza, cioè, che avesse consentito di raggiungere, sia pure indirettamente, tale fine in termini più efficienti ed ugualitari di quanto non fosse stato possibile conseguirlo con qualsiasi altro sistema alternativo.
3.3. Meade ha sempre preferito parlare di Dividendo Sociale, anziché di Reddito di Cittadinanza; quest’ultima espressione sarà introdotta successivamente, verso la fine degli anni Ottanta del secolo scorso; ma il suo significato e le sue implicazioni saranno quelle indicare da Meade nel suo concetto di Dividendo Sociale, che il premio Nobel aveva mutuato dal lavoro di Lady Juliet Rhys-Williams, autrice nel 1943 di un libro dal titolo “Something to Look Forward Too” (Non vedere l’ora di fare qualcosa di nuovo), in cui veniva proposto un “Nuovo Contratto Sociale”, implicante la corresponsione incondizionata e universale di un reddito sociale alternativo a quello previsto dal Rapporto-Beveridge sulla sicurezza sociale. James Meade, nel 1948, in un suo lavoro, “Planning and the Price Mechanism”, ha presentato l’idea di Lady Rhys-Williams come una stimolante proposta per una riforma strutturale del modello di sicurezza sociale istituzionalizzato nel Regno Unito alcuni anni prima.
Meade ha riassunto come segue la proposta di Lady Juliet Rhys-Williams: ella – ha affermato il Nobel inglese – ha suggerito la corresponsione di un pagamento in moneta (o Dividendo Sociale) ad ogni singolo cittadino, uomo, donna o bambino. La somma pagata deve sostituire tutti i benefici sociali corrisposti sulla base del sistema di sicurezza sociale esistente, quali i sussidi ai disoccupati, il pagamento delle pensioni ai lavoratori collocati a riposo per raggiunti limiti di età, i sussidi per malattia e quelli corrisposti ai minori di età. Ogni uomo, donna o minore deve percepite il Dividendo Sociale, qualunque sia il loro stato di salute, sia nel caso di malattia che nel caso si trovino in perfetto stato di salute, sia in caso di occupazione che di disoccupazione, e indipendentemente dall’età. Non deve essere prevista nessuna prova dei mezzi, né devono esistere dei test per provare che i soggetti destinatari del Dividendo Sociale sono impegnati nella ricerca di lavoro; né essi sono obbligati a dimostrare di essere realmente ammalati. I medici possono cessare di rilasciare certificati di malattia e procedere, quindi, a tempo pieno nella cura dei loro ammalati. Gli uffici per l’occupazione possono cessare di preoccuparsi dei disoccupati e impegnarsi maggiormente nell’avviare verso nuove opportunità occupazionali chi si trova involontariamente ad essere disoccupato. Conclusivamente, il Ministero della Sicurezza Sociale può addirittura essere chiuso. I sussidi personali universali concessi incondizionatamente a tutti i cittadini possono prendere il posto dell’intero apparato del sistema di sicurezza sociale esistente.
3.4. La proposta di Lady Juliet Rhys-Williams, secondo Meade, era da condividersi e da preferirsi al sistema di sicurezza sociale costruito sulla base del Rapporto-Beveridge, perché presentava quattro grandi vantaggi: 1. realizzava una semplificazione burocratica nel governo del sistema economico; 2. garantiva una maggiore libertà personale; 3. realizzava una “equalizzazione” dei redditi personali; 4. garantiva un’efficace strumentazione per un più razionale controllo della spesa pubblica. Per tutti questi motivi, secondo Meade, la proposta meritava un’attenta e seria considerazione, in quanto rendeva possibile una razionalizzazione dei metodi correnti di distribuzione del costo della sicurezza sociale.
Negli anni successivi alla sua formulazione, la proposta sarà abbandonata, per via dell’inizio dei “Gloriosi trent’anni” (1945-1975), nell’arco dei quali le economie capitalistiche, rette da sistemi politici democratici, vivranno un periodo di crescita sostenuta che consentirà la realizzazione di welfare State sempre più universali; dopo la crisi monetaria ed energetica e l’instabilità di funzionamento dei sistemi economici degli anni Settanta è insorto il problema della sostenibilità del costo dei sistemi di sicurezza sociale realizzati, anche per via del fatto che le politiche pubbliche finalizzate a regolare il mercato del lavoro, sono diventate sempre meno efficaci per il mantenimento dei livelli occupazionali.
L’occasione per riproporre il dibattito sull’istituzionalizzazione di un reddito incondizionato da corrispondersi a tutti i cittadini (o residenti) sarà offerta dall’evento che nel 1985 ha visto la formazione del Basic Income European Network (BIEN), movimento fondato alla fine della First International Conference on Basic Income, svoltasi all’Università Cattolica di Lovanio. La conferenza ha inaugurato la prima fase di riflessione sull’uso dell’espressione Reddito di Cittadinanza, ma ha anche concorso a consolidarne l’uso nell’analisi economica. La letteratura sull’argomento evidenzia che, nell’anno in cui si è svolta la conferenza, molti economisti inglesi erano ancora propensi ad usare, in luogo dell’espressione Reddito di Cittadinanza, quella di Dividendo Sociale. Alla fine della conferenza del 1986, i suggerimenti per stabilire definitivamente il nome del Network è stato, tra i molti avanzati, quello che, in considerazione della natura bilingue del Paese che ospitava la conferenza, proponeva di associare all’acronimo “BIEN” (che in lingua francese significa anche “bene”) la sua traduzione olandese in “GOED”, corrispondente all’espressione inglese “Great Order for European Dividend”. Tutti così hanno trovato la “pace dei sensi” sul come denominare il movimento a supporto dell’uso del “RdC”, inteso come strumento di politica economica attraverso il quale realizzare un sistema di sicurezza sociale alternativo a quello realizzato.
3.5. Le carenze del sistema di sicurezza sociale esistente erano la conseguenza della premessa originariamente assunta che l’economia operasse in corrispondenza del pieno impiego, o ad un livello molto prossimo al pieno impiego, cosicché una parte delle contribuzioni assicurative della forza lavoro potesse bilanciare le erogazioni previste in suo favore nelle fasi negative del ciclo economico.
Ma il sistema così come era stato concepito è divenuto largamente insufficiente rispetto alla nuova natura della realtà economica e sociale. Il welfare State è stato necessario estenderlo progressivamente per coprire le emergenze conseguenti alla crescente complessità del funzionamento dei sistemi economici; in tal modo, esso è divenuto costoso ed inefficiente a seguito dell’espandersi delle varie forme di sostegno che è stato necessario erogare e dei costi burocratici originati dal suo funzionamento.
Il fallimento delle riforme e delle integrazioni, cui il sistema di sicurezza sociale è stato sottoposto dopo la sua realizzazione, ha orientato l’analisi economica ad assumere, come già si detto, che la sicurezza sociale dovesse avere principalmente lo scopo di assicurare una costante flessibilità del mercato del lavoro attraverso la liberazione dal bisogno della forza lavoro, e non quella di compensare la sua crescente insicurezza reddituale. Il modo per rendere tra loro compatibili, la flessibilità del mercato del lavoro e la sicurezza reddituale individuale nella libertà, da un lato, e l’efficienza del sistema economico, dall’altro, è stato individuato nell’adozione di un nuovo sistema di sicurezza sociale fondato sull’istituzionalizzazione del Reddito di Cittadinanza, sotto il vincolo di poter creare un sistema di sicurezza sociale più efficiente ed ugualitario di quanto non fosse possibile realizzare con il sistema del welfare State esistente.
All’interno del nuovo sistema di sicurezza sociale, lo scopo perseguibile con l’istituzionalizzazione del “RdC” sarebbe consistito, in sostanza, nell’assicurare a tutta la forza lavoro disponibile la possibilità di scegliere tra un più alto reddito/maggior lavoro e un più basso reddito/più tempo libero; ciò nella prospettiva che l’effettuazione di questa scelta avrebbe consentito il cambiamento in positivo della percezione negativa che tradizionalmente la disoccupazione ha sempre avuto sul piano individuale, ma anche su quello sociale. Le conseguenze dell’istituzionalizzazione di un sistema di sicurezza sociale fondato sull’istituzionalizzazione del Reddito di Cittadinanza, secondo chi lo proponeva, sarebbero state diverse e tutte positive sul piano individuale e su quello sociale.
In primo luogo sarebbe stato possibile ridurre il bisogno di attuare programmi pubblici volti ad avviare “attività di cantiere”, al solo fine di creare un alto numero di posti di lavoro fittizi; ciò perché la corresponsione di un reddito incondizionato, alternativo a quello ottenibile attraverso lo svolgimento di attività precarie, avrebbe reso più responsabile, per coloro che lo avessero percepito, la decisione del come impiegare il loro tempo libero.
In secondo luogo, l’erogazione del Reddito di Cittadinanza avrebbe contribuito ad incoraggiare la propensione a svolgere un’attività lavorativa per l’autosostentamento; questa propensione, comportando per la forza lavoro un suo minore inserimento nel mercato del lavoro, avrebbe reso possibile l’innalzamento della qualità del lavoro e quella del risultato di chi lo avesse svolto.
4. Il superamento dell’etica del lavoro.
Nel dibattito sul Reddito di Cittadinanza, coloro che affrontano criticamente il superamento della disoccupazione strutturale e la dissociazione del reddito individuale dal rapporto di lavoro attraverso l’istituzionalizzazione del Reddito di Cittadinanza, tendono a trascurare il problema della necessità di pervenire al superamento dell’etica del lavoro, intesa questa come valore in sé. Per tale motivo, essi finiscono anche col trascurare i limiti sul piano degli effetti delle loro stesse proposte. Così, sin tanto che non sarà rimosso il rapporto che si presume esista tra il lavoro e la stima di sé che porta a considerare il lavoro stesso come diritto (il lavoro è un diritto, perché: “il lavoro è vita”, “il lavoro è partecipazione”, “il lavoro è autonomia”, ecc.), ne consegue che la necessità di creare posti di lavoro continui a costituire una priorità sociale ineludibile; priorità che, come si è detto, nei moderni sistemi economici si sta rivelando quasi impossibile da soddisfare.
Perché il lavoro porti la stima di sé occorre anche che esso produca beni e servizi che possano essere apprezzati dai potenziali consumatori e dai contribuenti; ne consegue, perciò, che il lavoro creato attraverso contribuzioni pubbliche solo perché si ritiene costituisca un diritto potrebbe non servire allo scopo, in quanto avvertito come controproducente. La stima di sé non è un valore che possa essere assicurato con la creazione di un diritto; se il lavoro svolto da un dato soggetto è apprezzato dagli altri, esso, necessariamente, assicurerà stima per chi lo svolge. D’altra parte, se il lavoro non è richiesto, ed è garantito solo perché considerato un diritto, il lavoro stesso non potrà assicurare necessariamente stima per chi lo svolge.
Inoltre, dal punto di vista dei rapporti sociali, la stima di sé connessa al lavoro dipende dal “tipo” di lavoro svolto. Un lavoro temporaneo, ad esempio, non può portare alcuna stima duratura per chi lo svolge; né il lavoro ha implicazioni positive per chi lo esegue allorché i disoccupati sono destinati alla produzione di “servizi socialmente utili”, cioè quando i disoccupati sono impiegati nella produzione di beni e servizi che in un momento particolare sono ritenuti necessari. Infatti, se lo scopo dei “lavori socialmente utili” è quello di impedire il disagio sociale dei disoccupati mediante l’inserimento di questi ultimi nel mercato del lavoro, occorrerebbe che i lavori socialmente utili fossero lavori stabili.
In conclusione, il lavoro come diritto non sembra “strumento” proponibile per rimuovere la disoccupazione strutturale; il lavoro come diritto, inteso come “vita”, “partecipazione” e “libertà” è un residuo ideologico proprio dei sistemi sociali ad economia di mercato afflitti da disoccupazione strutturale irreversibile e da difficoltà di crescita. Occorre, pertanto, flessibilizzare il mercato del lavoro, dissociando il lavoro dal reddito che deve essere corrisposto anche a coloro che non siano inseriti nel mercato del lavoro; ciò consentirà ai soggetti che percepiranno il Reddito di Cittadinanza di ricuperare l’autostima di sé, svolgendo attività lavorative che potranno essere intraprese grazie all’impiego del reddito ricevuto, secondo le scelte che ognuno potrà compiere tra un più alto reddito/maggior lavoro e un più basso reddito/più tempo libero. Il ricevimento di un reddito svincolato da un rapporto di lavoro costituirà, perciò, il ricupero da parte dell’intera forza lavoro della piena stima di sé, rinvenendo la sua “fonte” nella funzione economica, individuale e sociale svolta dal reddito universale e incondizionato ricevuto.
Il ruolo e la funzione del Reddito di Cittadinanza “sganciato” dagli automatismi del mercato saranno, come ripetutamente è stato affermato, strumentali al rilancio che, nel breve periodo, è possibile imprimere alle tre “istituzioni portanti” del processo di crescita e di sviluppo del sistema produttivo: settore delle famiglie, mercato e settore pubblico. Il settore delle famiglie, fruendo dell’opportunità garantita a tutti i membri di ogni famiglia dal Reddito di Cittadinanza indipendentemente dal loro status rispetto al lavoro, potrà concorrere a rendere più flessibile il mercato del levoro; con il sistema economico in espansione, sarà possibile finanziare il progresso tecnologico, aumentare la produzione e la distribuzione dei servizi sostituitivi di quelli tradizionali prodotti e consumati direttamente dalle famiglie. D’altra parte, con l’attuazione di una politica riformatrice dello Stato sociale tradizionale, il mercato del lavoro, dotato di una maggiore flessibilità, sarà anche caratterizzato da una maggiore instabilità, per cui il settore pubblico, con il Reddito di Cittadinanza, potrà garantire alle famiglie un’adeguata protezione sul piano economico e su quello sociale, contro la possibile perdita temporanea di ogni capacità di reddito da lavoro e contro molti altri rischi sociali, quali, ad esempio, la perdita di professionalità, la perdita della capacità di reinserimento nel mercato del lavoro, ecc.
5. Finanziamento del Reddito di Cittadinanza
Un problema assai dibattuto riguardo all’istituzionalizzazione del Reddito di Cittadinanza concerne il suo finanziamento. Un dei meriti di Meade è stata la dimostrazione della possibilità di istituzionalizzare l’introduzione del “RdC” attraverso il suo finanziamento con l’impiego delle risorse utilizzate per il funzionamento del sistema di sicurezza sociale esistente, oppure mediante la distribuzione di un Dividendo Sociale finanziato con le rimunerazioni derivanti dalla vendita sul mercato dei servizi di tutti i fattori produttivi di proprietà collettiva, gestiti dallo Stato mediante la costituzione di un “Fondo Capitale Nazionale”, per conto e nell’interesse di tutti i cittadini.
Al riguardo, è plausibile pensare che, in Paesi come Italia, la “via” del finanziamento del “RdC” tramite la riforma ab imis dell’attuale sistema di sicurezza sociale sia destinata ad essere percepita in assoluto come impercorribile, dati i tempi che sarebbero richiesi e le criticità inevitabili che sarebbe necessario affrontare durante la transizione dall’attuale sistema di sicurezza sociale a quello nuovo, imperniato sull’introduzione del “RdC”. Più facile sembra la “via” della costituzione del Fondo Capitale Nazionale, dal quale derivare le risorse da assegnare sino alla concorrenza delle disponibilità, variabili nel tempo, del “Fondo” ai singoli cittadini. In questo caso, come reperire le risorse necessarie?
Meade ipotizzava che lo stock di capitale costituivo del “Fondo” potesse essere finanziato dai surplus della bilancia internazionale dei pagamenti dei singoli Paesi; si potrebbe però ipotizzare che il finanziamento sia realizzato coi proventi derivanti dalla vendita di determinati beni, come ad esempio avviene in Norvegia, dove la costituzione del “Fondo” è alimentato dai proventi della vendita del petrolio. In Paesi come l’Italia, dove mancano le risorse petrolifere e dove è problematico pensare di trovare risorse alternative per introdurre il Reddito di Cittadinanza attraverso uno dei due possibili modi suggerii da Meade, la soluzione del problema potrebbe essere inserito nella prospettiva delle finalità del cosiddetto “movimento benecomunista”, ovvero del movimento che si prefigge di riordinare i diritti di proprietà all’interno dei moderni sistemi industriali, senza “tagliare la gola” ai capitalisti.
L’idea di riordinare l’istituto della proprietà in funzione dello stato presente del sistema sociale ed economico nazionale può essere derivata dalla teoria economica dei diritti di proprietà, secondo la quale l’esistenza dei diritti di proprietà e la disponibilità di una loro definizione più rispondente alle modalità di funzionamento dei moderni sistemi economici costituirebbero i fattori che consentirebbero di massimizzare la convenienza della persone a “vivere insieme”, per svolgere l’attività utile al perseguimento dei loro progetti di vita, attraverso il meccanismo di produzione, di scambio o di fruizione della ricchezza accumulata.
In questa prospettiva, l’elemento che giustificherebbe la proprietà non sarebbe tanto il valore dei beni in sé e la possibilità di una loro illimitata ed arbitraria utilizzazione, quanto l’insieme delle regole che ne dovessero sottendere la loro fruizione; i beni, perciò, sarebbero svuotati del loro mero significato di oggetti, per dare rilievo alle modalità con cui i costi ed i benefici connessi alle decisioni del loro uso sono suddivisi. In questo contesto, la proprietà privata sarebbe distinta da quella comune, proprio per il diverso grado di disponibilità a titolo individuale dei beni che costituiscono il contenuto sia dell’una forma di proprietà che dell’altra.
Sono gli stravolgimenti della vita sociale imputabili alle modalità di funzionamento dei moderni sistemi economici che giustificherebbero una migliore ridefinizione dei diritti di proprietà; su questa nuova base, diverrebbe possibile costituire un patrimonio collettivo per il finanziamento del “Fondo” da utilizzare per finanziare il “RdC”.
6. Conclusioni
Da quanto sin qui esposto risulta chiaro come il Reddito di Cittadinanza (o Dividendo Sociale), all’origine concepito come forma di reddito sul quale fondare la costruzione di un sistema di sicurezza sociale più efficiente di quello realizzato sulle base del “Rapporto-Beveridge”, esso, successivamente, dopo la First International Conference on Basic Income, svoltasi all’Università Cattolica di Lovanio nel 1985, è stato riferito ad una sfera di applicazione molto più allargata, sino a comprendere la soluzione del problema della disoccupazione tecnologica irreversibile originata dalle modalità di funzionamento dei moderni sistemi industriali capitalistici.
Al Reddito di Cittadinanza, o Dividendo Sociale, o Reddito di Base, oltre che un significato economico, è stata assegnata la funzione di risolvere sul piano sociale i problemi che la sperimentazione del welfare State ha mostrato di non poter risolvere, quali, in particolare, quello di conservare ai lavoratori che hanno perso la stabilità occupazionale la stima di sé e quello di poter garantire una maggiore flessibilità al mercato del lavoro.
Tali obiettivi, con il Reddito di Cittadinanza diventano perseguibili, senza la necessità di realizzare rivoluzioni sociali, ma solo attraverso una responsabile politica riformista, idonea a riproporre, su basi nuove, l’organizzazione dello stato di sicurezza sociale vigente, a porre definitivamente fine all’uso di provvedimenti-tampone per rimediare alle situazioni sociali negative causate dall’insorgenza di possibili crisi economiche, ma anche di promuovere lo svolgimento, da parte dei percettori del Reddito di Cittadinanza, l’avvio di possibili attività produttive autonome gratificanti, perché la fruizione del loro risultato è affrancato dalla natura di “prestazione caritatevole” dei sussidi di sopravvivenza corrisposti dall’assistenza statale.
—————————-
Riferimenti bibliografici
Elster J. (1987), La democrazia possibile. Principi per un nuovo dibattito politico, Feltrinelli, Milano.
Ferry J.M. (1996), L’allocation universelle. Pour un revenu de citoyemmeté, Les Éditioms du Cerf, Paris.
George H. (1963), Progresso e libertà, Robert Schalkenbach Foundation, New York.
Jordan B. (1992), “Basic incombe and Common Good”, in Van Parijs P. (1992).
Mantegna A., Tiddi A. (2000), Reddito di cittadinanza. Verso la società del non lavoro, Castelvecchi, Roma.
Meade J.E. (1972), “Poverty in the Welfare State”, in Oxford Economic Papers”, vol. XXIV.
Meade J.E. (1948), Planning and the Price Mechanism: The Liberal-Socialist Solution, Routledge, London.
Morley-Fletcher E. (1998), “Opening Adress”, Discorso di apertura al VII Congresso internazionale sul reddito di cittadinanza, 10-12 settembre, Amsterdam.
Offe C. (1999), “Il reddito di cittadinanza: una strategia inevitabile per contrastare la disoccupazione”, in Stato e Mercato, n. 56.
Purdy D. (1990), “La fattibilità politica di una società a reddito di base”, in Democrazia e Diritto, vol. XXX.
Purdy D. (1994), “Citizenship, Basic Incombe and the State”, in The New Left Review, n. 208.
Rhys-Williams J.E. (1943), Something to Look Forward to; a Suggestion for a New Social Contract, Macdonald, London.
Standing G. (1986), Unemployment and Labour Market Flexibility: the United Kingdom, International Labour Office, Geneva.
Toso S. (2016), Reddito di cittadinanza o reddito minimo?, Il Mulino, Bologna.
Van Donselar G. (2009), The Right to Exploit. Parasitism, Scarsity, Basic Incombe, Oxford University Press, Oxford.
Van Parijs P. (1992), A cura di, Arguing for Basic Incombe. Ethical Fondations for a Radical Reform, Verso, Lomdon.
Van Parijs (1997), Real Freedom for All; What (if Anything) Can Justify Capitalism, Oxford University Press, Oxford.
Van Parijs P., Vanderborght Y. (2006), Il reddito Minimo universale, Università Bocconi Editrice, Milano.
C’era una volta il Piano di Rinascita
 Qualcuno crede ancora nelle favole? C’era una volta il Piano di Rinascita, ventitré anni fa.
Qualcuno crede ancora nelle favole? C’era una volta il Piano di Rinascita, ventitré anni fa.
Questo racconto potrebbe iniziare come nella migliore tradizione favolistica. “C’era una volta, in una antica terra lontana circondata dal mare…” e via dicendo. Il nostro “C’era una volta” parte dalla fine del secolo scorso, più precisamente dal 1999. In quegli anni si concludeva la vicenda del Piano di Rinascita della Sardegna. Cosa è accaduto? Leggendo la narrazione dei fatti così come viene riportata dalla stampa regionale, nello specifico dal quotidiano “La Nuova Sardegna”, si apprende che lo Stato pagherà alla Regione 90 milioni di lire “scordati” nel 1999. L’ultima rata del Piano di Rinascita. Il titolo nelle pagine interne recita: “La Regione trova un tesoretto, 90 milioni dimenticati dal 1999”. L’autore della scoperta viene individuato nella persona dell’Assessore Raffaele Paci al quale si riconosce il merito di avere frugato sapientemente tra le pieghe dei bilanci e di avere trovato il tesoretto. La notizia è intrigante, curiosa, direi quasi sbalorditiva, merita una attenta lettura. Dalla puntuale ricostruzione giornalistica emerge che lo Stato doveva dei soldi alla Regione fin dal 1994, per l’esattezza ben 910 miliardi di lire (pari a 460 milioni di euro) da impiegare in interventi urgenti per sviluppo delle infrastrutture. I contributi statali erano erogati con rate annuali. Dell’ultima rata, quella del 1999 di 90 milioni di lire, non si aveva traccia. Nel 2015, cioè dopo 16 anni di “ritardo”, l’Assessorato al bilancio della regione Sardegna si è reso conto della mancata riscossione dell’ultima rata del finanziamento statale e del fatto che la vicenda Piano di Rinascita, dopo 23 anni, non si era ancora formalmente conclusa. Risparmiamo al lettore la ricostruzione dei diversi passaggi burocratici che si sono resi necessari per arrivare alla conclusione della vicenda. Si arriva così all’anno 2016 per registrare la presa d’atto del Cipe della avvenuta chiusura del Piano di Rinascita e il riconoscimento alla Regione Sardegna del credito dell’ultima rata del Piano, i 90 milioni di lire. Tali risorse, assicura l’Assessore competente, appena riscosse saranno impiegate per saldare i debiti con i Comuni e le imprese. E vissero a lungo felici e contenti. Ci si pone una domanda intrigante che suggerisce qualche riflessione. Quanto sono capienti e vaste le citate “pieghe di bilancio”? Ricordo soltanto, per restare in tempi recenti, che nel mese di luglio del corrente anno si è tenuto in Regione un incontro tra autorevoli rappresentanti della Giunta e le Organizzazioni professionali agricole e della cooperazione. In quella occasione emerse che per fronteggiare la crisi dell’agricoltura e il dramma della siccità la Giunta avrebbe erogato con urgenza 15 milioni di euro. Apparve a tutti come una grande vittoria del mondo contadino, il massimo che si potesse concedere per l’emergenza del comparto. Poche settimane dopo, con una grandiosa manifestazione del Movimento Pastori Sardi, scende in piazza la rabbia e la determinazione dei pastori che incontrono il Presidente Pigliaru e riescono a ottenere l’impegno della Giunta per reperire un ulteriore finanziamento di 30- 35 milioni di euro. In meno di un mese la Giunta riesce nel suo intento, trova e mette sul tavolo altri 30 milioni per la pastorizia. E dove li va a trovare? Naturalmente nelle pieghe del bilancio. Alcune considerazioni si impongono. Quanto sono estese e capienti queste pieghe del bilancio? E’ mai possibile che gli amministratori di una regione con gravi problemi occupazionali e la crisi in atto nei principali comparti produttivi non abbiano conoscenza, fin dall’inizio del loro mandato, di un quadro preciso e dettagliato delle risorse disponibili? La Giunta regionale, il Consiglio, gli apparati burocratici, sono organismi di programmazione e direzione di processi politici ed economici della regione. Tali istituzioni sono nelle mani di individui competenti o, come sembrerebbe, ci si avvale della abilità di improvvisati gestori delle emergenze? Fino a quando si continuerà a fare affidamento sulle pieghe del bilancio?











 AService Studio
AService Studio