Monthly Archives: marzo 2017
Marianna Bussalai, “Signorina Mariannedda de sos Battor Moros”
 L’Otto marzo? Con Marianna Bussalai.
L’Otto marzo? Con Marianna Bussalai.
di Francesco Casula
1. la vita
Marianna Bussalai, “Signorina Mariannedda de sos Battor Moros”, così veniva chiamata dagli oranesi, è i una straordinaria figura di femminista, di sardista e di antifascista. Una poetessa, traduttrice e intellettuale di valore, morta nel 1947, a soli 43 anni. Frequenta solo fino alla quarta elementare, poi abbandona a causa di una malattia che non le permette di potersi recare a Nuoro per proseguire gli studi. Autodidatta – legge gli autori sardi (Sebastiano Satta, Montanaru, – con cui ha un fitto carteggio epistolare – e Giovanni Maria Angioy, di cui vanta una remota ascendenza), gli italiani (Dante, Manzoni, Monti, Pindemonte) ma anche i russi. Di Montanaru traduce le poesie in italiano. Di Dante avrebbe voluto tradurre la Divina Commedia in Limba per poter dare al popolo sardo – scriveva – la possibilità di leggere e comprendere l’opera.
2. Il sardismo di Bussalai
“II mio sardismo – scriverà in una lettera all’avvocato Luigi Oggiano – è nato da prima che il Partito sardo sorgesse, cioè da quando, sui banchi delle scuole elementari, mi chiedevo umiliata perché nella storia d’Italia non si parlasse mai della Sardegna. Giunsi alla conclusione che la Sardegna non era Italia e doveva avere una storia a parte”.
Quello della Bussalai è dunque un Sardismo ante litteram, nasce inizialmente come sentimento o, più precisamente, come ri-sentimento contro uno Stato patrigno. Di qui la sua militanza nel Partito sardo d’azione e la sua “devozione” nei confronti di Lussu, che periodicamente le scriveva dall’esilio a Parigi.
“Ho bisogno di seguirlo devotamente in qualunque modificazione, in qualunque innovamento dal più ampio e moderno respiro – scriverà in una lettera all’amica Mariangela Maccioni – ma ad una condizione: purché sia nel Partito nostro, nel Partito sardo, come «sardisti» non in un Partito italiano «nazionale», dove saremmo forse ancora «autonomisti» ma non saremmo più «sardisti». Perché militare in un Partito «sardo» significava che v’era (oltre alla necessità di riforme autonomiste dell’intero stato italiano) anche una «questione sarda», di fronte alla Penisola; una passione Sarda, una coscienza Sarda da formare, sia pure per un lontano futuro.
E a chi obiettava che rinchiudersi nella Sardegna e in un Partito come il PSd’Az sarebbe provinciale e limitativo, in una lettera all’amica Graziella Sechi Giacobbe scrive: “Mi spieghi perché ci voglia un cuore più capace per militare nel Partito italiano d’azione e un cuore più limitato per militare nel Partito sardo d’Azione. Indubbiamente l’Italia ha una superficie maggiore della Sardegna; ma la vastità e la grettezza dello spirito non si misurano a metri o a chilometri quadrati”.
3. Le sue poesie
Famose sono rimaste quelle che mettono alla berlina i fascisti, ad iniziare dai ras locali. Il sardismo e l’antifascismo, cui dedicò tutta la sua vita, – ovvero l’amore smisurato per l’Autonomia e per la libertà – li vedeva incarnati meravigliosamente in Lussu, verso cui nutriva ammirazione e persino devozione. Marianna Bussalai infatti durante tutto il ventennio fascista diventa a Orani – ma non solo – punto di riferimento dell’antifascismo, la sua casa è il circolo antifascista, composto di ragazzi e ragazze, di uomini e donne.
È altresì punto di riferimento dei Sardisti: ai Congressi del PSd’Az viene sempre delegata per portare le istanze dei minatori di Orani, dei pastori e del mondo delle campagne.
Da parte mia ritengo che gli scritti più validi e, ancora oggi più che mai attuali, siano i suoi Mutos e Mutetus, in lingua sarda. Soprattutto quelli ironici e satirici con cui ridicolizzava i gerarchi e gli scherani del fascismo e Mussolini stesso (nel cui nome allungava il mussi-mussi, l’appellativo con cui si chiamano in Sardo i gatti e la cui espressione deriva dal latino mus (topo) e dunque a fronte di mussi-mussi il (gatto si avvicina).
Eccone alcuni:
“Farinacci est bragosu/ca l’ana saludau/sos fascistas de Orane/tene’ pius valentia/de su ras de Cremona/su Farinacci nostru.”
“Ite bella Nugòro / tottu mudada a frores / in colore ‘e fiama. / Ite bella Nugòro / solu a tie est s’amore / ca ses sa sola mama / Sardigna de su coro/ Saludan’ sos sardistas / chin sa manu in su coro / de sas iras fascistas / si nde ride’ Nugòro.”
4. Le amiche e gli amici di Marianna Bussalai
Aveva due grandi amiche e compagne di lotta: Mariangela Maccioni e Graziella Sechi-Giacobbe, che considera “dolci ed eroiche amiche”. La prima è maestra elementare e moglie di Raffaello Marchi (verrà sospesa dall’insegnamento perché ostile al Fascismo), la seconda ugualmente antifascista è moglie di Dino Giacobbe, il mitico combattente e comandante nella Guerra civile in Spagna contro Franco. Formano la cosiddetta triade sardista e antifascista.
Ma aveva anche molti amici: Lussu, Dino Giacobbe, i fratelli Melis, Oggiano, Mastino, Sebastiano Satta, Montanaru. Ma aveva amici, in modo particolare fra i giovani: per cui era un punto di riferimento intellettuale e culturale oltre che politico.
Così la ricorda con affetto e ammirazione Gonario Usala, uno dei suoi “allievi” più cari e fedeli: “Era enciclopedica nella sua formazione culturale nonostante si fosse formata da perfetta autodidatta. Su tutto dava risposte appropriate. Nel suo cuore aveva tuttavia la Sardegna e proprio ai libri sardi, ne possedeva tantissimi, riservava un’attenzione particolare”.
—————————

RAS. Online il nuovo sito dedicato all’Osservatorio del Paesaggio
 DOCUMENTAZIONE. Regione Autonoma della Sardegna. È online il sito dell’Osservatorio della pianificazione urbanistica e della qualità del paesaggio, di recente istituito per la promozione di studi, analisi e proposte utili a fornire strumenti agli Enti Locali per l’attuazione degli interventi di trasformazione territoriale in armonia con il contesto paesaggistico di riferimento.
DOCUMENTAZIONE. Regione Autonoma della Sardegna. È online il sito dell’Osservatorio della pianificazione urbanistica e della qualità del paesaggio, di recente istituito per la promozione di studi, analisi e proposte utili a fornire strumenti agli Enti Locali per l’attuazione degli interventi di trasformazione territoriale in armonia con il contesto paesaggistico di riferimento.
- Il sito è realizzato con una struttura di navigazione progettata per rispondere in maniera semplice e diretta a cittadini e amministratori locali sulle tematiche inerenti al paesaggio ed alla sua gestione.
Attraverso i tre canali principali
- osservare e interpretare
- programmare e cooperare
- sensibilizzare e comunicare
sarà infatti possibile a chiunque accedere a differenti e specifici livelli di informazione.
- Il sito rappresenta anche l’occasione per rendere pubbliche le tante iniziative, gli studi e le ricerche coordinate dall’Osservatorio nel corso degli ultimi anni. È possibile visualizzare i risultati delle cinque edizioni del Premio del paesaggio e del Premio Architetture per i litorali, i prodotti e i dati dei progetti comunitari, così come sono resi disponibili in formato digitale i volumi e le linee guida riferite ai molteplici aspetti legati al paesaggio.
Visita il sito
I care, il segreto del successo. Intervista a Jennifer Nedelsky
 I care, il segreto del successo
I care, il segreto del successo
a cura di Luigino Bruni, 4 ottobre 2014 su L’Avvenire
La filosofa della politica Jennifer Nedelsky, canadese, docente all’Università di Toronto, è una delle voci più innovative nel dibattito sui temi della cura, dei diritti e delle relazioni sociali, ed è convinta che nella nostra epoca ci sia una grande priorità che, invece e purtroppo, resta molto sullo sfondo della vita delle democrazie: il profondo ripensamento del rapporto tra lavoro e cura, e quindi tra uomini e donne, giovani e anziani, ricchi e poveri. Un tema essenziale in un mondo con sempre più vecchi e con vecchi che, grazie a Dio, vivono sempre di più.
Senza una svolta collettiva e seria nella cultura della cura in rapporto alla cultura del lavoro, è la democrazia e l’uguaglianza tra le persone che vengono sostanzialmente negate. La conosco da qualche anno (per questo nel colloquio che segue ho tradotto l’inglese “you” con “tu”) e l’ho incontrata in Italia all’Istituto Internazionale Sophia di Loppiano (Firenze). Le ho fatto alcune domande su temi che credo dovrebbero essere posti, oggi, al centro dell’agenda politica e civile del nostro Paese.
Perché, secondo te, c’è qualcosa di sbagliato nell’acquistare servizi di cura sul mercato, nell’usare la moneta perché persone più ricche possano “comprare” assistenza da persone più povere? In fondo il positivo del mercato è proprio l’incontro tra persone diverse con “beni” diversi che possono scambiare per un mutuo vantaggio.
«Io non sono contraria in assoluto al “mercato della cura”. Il mio sistema permetterebbe di comprare una certa quota di cura, perché nella mia visione le persone, per esempio le donne, avrebbero più tempo libero per i loro figli e anche per lavorare. La mia proposta è che ogni persona debba donare tempo per la cura di se stessi e degli altri. Ciò che differenzia il mio approccio da altri (penso a chi propone un salario per le casalinghe) è che vorrei che tutti i cittadini adulti (uomini e donne, di ogni ceto e classe sociale) si dedicassero ad attività di cura gratuite (cioè non retribuite), vorrei che si occupassero della cura di se stessi invece di “comprare” sul mercato qualcuno che lo faccia per loro, e vorrei che si occupassero anche della cura della propria famiglia, dei propri genitori, e anche delle proprie comunità di appartenenza. Almeno per 12 ore alla settimana».
- segue –
Oggi martedì 7 marzo 2017





——————————————————————————————————

![]() Attualità del pensiero gramsciano
Attualità del pensiero gramsciano
Francesco Cocco su Democraziaoggi.
————————————————————————————————————–-
 Scuola Popolare
Scuola Popolare
Il principio di sussidiarietà.
Cara Università della Sardegna: da te vogliamo di più

![]() . Maria Del Zompo, Rettore, vive il suo impegno universitario con totale dedizione, da sempre: da quando era studentessa, da docente e ricercatrice poi, fino ad oggi, negli ultimi due anni al massimo livello politico-amministrativo dell’Ateneo, che interpreta con grande capacità professionale e politica. Di più non le si potrebbe chiedere e pertanto qualsiasi critica del suo operato sembra ingiusta. In più lei aggiunge una grande carica di passione che stempera con il sorriso e spesso con una risata contagiosa. E tutto ciò è bene ed importante comunque e perfino maggiormente nella conduzione della più importante Istituzione culturale della Sardegna, nella misura in cui ispira fiducia e ottimismo (della volontà) nei suoi interlocutori. Ma noi, impertinenti, con tutto l’affetto e l’amicizia che le vogliamo, osiamo criticare alcune sue scelte di gestione politica. Ovviamente ci limitiamo a criticare per quanto riteniamo di esserne legittimati da specifiche informazioni in nostro possesso e per la pretesa di avere precise impostazioni da contrapporre. Nel senso che non entriamo in campi nei quali non abbiamo informazioni e competenze. In questo contesto ci limitiamo allora ad alcune tematiche (neppure tutte) trattate da Maria nell’intervista di domenica su L’Unione Sarda.
. Maria Del Zompo, Rettore, vive il suo impegno universitario con totale dedizione, da sempre: da quando era studentessa, da docente e ricercatrice poi, fino ad oggi, negli ultimi due anni al massimo livello politico-amministrativo dell’Ateneo, che interpreta con grande capacità professionale e politica. Di più non le si potrebbe chiedere e pertanto qualsiasi critica del suo operato sembra ingiusta. In più lei aggiunge una grande carica di passione che stempera con il sorriso e spesso con una risata contagiosa. E tutto ciò è bene ed importante comunque e perfino maggiormente nella conduzione della più importante Istituzione culturale della Sardegna, nella misura in cui ispira fiducia e ottimismo (della volontà) nei suoi interlocutori. Ma noi, impertinenti, con tutto l’affetto e l’amicizia che le vogliamo, osiamo criticare alcune sue scelte di gestione politica. Ovviamente ci limitiamo a criticare per quanto riteniamo di esserne legittimati da specifiche informazioni in nostro possesso e per la pretesa di avere precise impostazioni da contrapporre. Nel senso che non entriamo in campi nei quali non abbiamo informazioni e competenze. In questo contesto ci limitiamo allora ad alcune tematiche (neppure tutte) trattate da Maria nell’intervista di domenica su L’Unione Sarda.
1) CAMPUS e VUOTI URBANI
Ha ragione il Rettore a sostenere che si trova a gestire scelte non sue, come quella della Cittadella di Monserrato e del suo ampliamento, che vengono da lontano e che sono state sostanzialmente confermate (sia pur ridimensionate rispetto ai progetti originari) dalle ultime gestioni rettorali. Sicuramente il suo predecessore avrebbe potuto invertire la rotta anzicché proseguire nell’investimento in nuove costruzioni, a tal fine riconsiderando l’uso dei vecchi edifici universitari (e non), che vanno oggi in rovina (inesorabilmente?). Per stare nell’ambito delle proprietà universitarie parliamo della (ormai ex) Clinica Macciotta, del palazzo delle Scienze e, per estenderci verso altre proprietà, dell’Ospedale San Giovanni di Dio, dell’ex Ospedale militare, alle quali aggiungere altre strutture pubbliche in dismissione, di possibile cambio d’uso rispetto a quello originario (Carcere Buoncammino, ex servitù militari, etc.). Sono questi i “vuoti urbani” di cui parla Pasquale Mistretta? Crediamo di si, anche se noi che non siamo urbanisti, preferiamo classificarli come “beni comuni”, ossia delle cose che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona, che vorremmo pertanto restituiti a funzioni civili in favore della popolazione. Ma, si dirà, altre scelte sono state fatte anche perché i soldi non bastavano e sempre meno bastano. Invece, noi non accettiamo tale liquidazione. Al contrario vorremmo che si sviluppasse un diverso ragionamento e che si impostassero scelte politiche in direzione radicalmente opposta a quella attualmente dominante. Lo abbiamo suggerito altre volte e sarà necessario ritornarci in un dibattito aperto. C’è ancora tempo per evitare ulteriori disastri.
2) UNIVERSITA’ DELLA SARDEGNA
Fa bene il Rettore a difendere l’identità e la storia dell’Università di Cagliari, come pure fa bene il suo collega per l’Università di Sassari. Fanno male entrambi a non impegnarsi per costruire realmente l’Università della Sardegna, attraverso una vera Federazione dei due Atenei, sotto l’egida appunto dell’“Università della Sardegna – Universidade de Sardigna – University of Sardinia”. Anche per questa tematica rimandiamo a quanto più volte abbiamo scritto, nella consapevolezza che i processi storici che non si sanno gestire ci vedono soccombenti. E questo è esattamente quanto già accade per le Università sarde, costrette a continui ridimensionamenti perché incapaci di misurarsi su una necessaria più grande dimensione almeno regionale.
3) IL RUOLO DELL’UNIVERSITA’ SUL TERRITORIO (impegno per la Terza Missione)
Il rapporto con la città è fondamentale, ma solo se Cagliari saprà rappresentare l’intera Sardegna, cosa che non solo non le riesce, ma che non la vede in cambiamento in tale direzione. E in questo l’Università di Cagliari non sembra di grande aiuto alla città. Complessivamente si ha l’impressione (e non solo) di un declino complessivo della nostra Isola, che singole realtà in controtendenza non possono arrestare. Cagliari e la sua Università non si salvano se non insieme alla Sardegna e alla sua Università Sarda. Riflettiamoci e se ci riusciamo usciamo da impostazioni provinciali. Ci riusciamo ad osare di più? Detto questo, mentre riconosciamo il grande sforzo fatto dall’Università per porsi al servizio del territorio, nell’impegno per la “terza missione” (le politiche di promozione dell’innovazione, con Contamination Lab e altre iniziative, ne sono una prova), riteniamo al riguardo tuttora inadeguata la propria iniziativa, se solo pensiamo alla ridottissima offerta formativa post lauream e allo scarso impegno nella formazione professionale (longlifelearning). O, ancora, all’insufficiente investimento di studio e ricerca nelle tematiche della “nuova economia”, quella che può valorizzare le significative esperienze in atto anche in Sardegna e dare prospettive consistenti di occupazione rispetto alle vecchie e superate impostazioni socio-economiche, che si sostengono solo con interventi assistenziali a carico dei fondi pubblici. E poi: balza all’occhio come l’Università tenda ad esaurire il rapporto con il territorio nel rapporto con le Istituzioni. Molto importante, ma l’Università è un entità autonoma, qualità costituzionalmente garantita, che deve essere al servizio di tutti, includendo, tra questi “tutti” e in aggiunta alle Istituzioni, altri soggetti: le imprese, le entità del terzo settore, i cittadini associati e singoli. Insomma vorremo al riguardo una Università che praticasse la sussidiarietà, secondo il principio costituzionale (art.118), cioè una Università che sappia riconoscere come interlocutori anche i cittadini e le loro associazioni.
4) PICCOLO PISTOLOTTO CONCLUSIVO
“Ask not what your country can do for you; ask what you can do for your country”. “Non chiederti cosa può fare il tuo paese per te, chiediti cosa puoi fare tu per il tuo paese”. E’ questa una delle frasi più famose tra quelle pronunciate da John Fitzgerald Kennedy; esattamente risale al 20 gennaio 1961, giorno del suo insediamento alla Casa Bianca come 35° presidente degli Stati Uniti d’America. Riscrivendola “a nostro uso e consumo” suona così: cara Università “non chiederti cosa può fare il tuo paese per te, chiediti cosa puoi fare tu per il tuo paese”, mettendo concretamente da parte la tua autoreferenzialità.
Forse troverai più gente e più organizzazioni convintamente al tuo fianco per salvarti insieme al paese!
———————————————————————–
 “DEL ZOMPO, UNA MAGNIFICA SFIDA”
“DEL ZOMPO, UNA MAGNIFICA SFIDA”
Sergio Nuvoli, Unica
Cagliari, 6 marzo 2017 – E’ stata pubblicata ieri su L’Unione Sarda un’intervista di Paolo Paolini con il Rettore Maria Del Zompo. Il colloquio è il primo di una serie che il giornalista realizzerà con le figure più autorevoli nella città di Cagliari. Nella conversazione pubblicata ieri dal quotidiano, la prof.ssa Del Zompo fa il punto della situazione e risponde puntualmente ad alcuni rilievi, senza sottrarsi ad alcuna domanda.
- L’UNIONE SARDA - segue –
DIBATTITO. Questa Europa è in crisi e la Sinistra non riesce a trovare proposte convincenti per un’altra Europa

 SOCIETÀ E POLITICA
SOCIETÀ E POLITICA
Europa, la minaccia della disintegrazione
«Dalla Brexit alla divisione tra Nord e Sud alle politica in materia di migrazioni. La crisi del processo di integrazione europeo nel rapporto Euromemorandum 2017 che verrà presentato a Roma il 16 marzo».
Sbilanciamoci info, 2 marzo 2017 (c.m.c.)
La crisi del processo di integrazione europeo ha molte sfaccettature e si è aggravata negli ultimi anni. Il sintomo più visibile è stato il referendum britannico sull’uscita dalla Ue, ma questo non è certo l’unico indicatore del diffondersi delle tendenze disgregatrici e delle crescenti contestazioni alle politiche europee.
Brexit
La disintegrazione dell’Unione è stata introdotta esplicitamente nell’agenda politica dal referendum britannico. Si può inquadrare il risultato del referendum nel contesto globale delle rivolte contro le élite politiche. La crescita delle diseguaglianze, l’insicurezza economica, la stagnazione o diminuzione del reddito subita da larghi strati di popolazione, insieme alla riduzione dei servizi pubblici, sono i fattori alla base di questo malcontento, le cui espressioni politiche variano enormemente.
In Gran Bretagna, come in molte altre nazioni, gli immigrati sono diventati i capri espiatori, accusati di aver causato problemi economici, quando in realtà la mobilità dei capitali, non del lavoro, è stata una delle principali cause della riduzione degli standard di vita medi e dell’erosione dei diritti dei lavoratori e della protezione sociale. In Gran Bretagna un altro capro espiatorio è stato trovato nei più bisognosi e sia i conservatori che i laburisti, prima del cambio nella leadership del partito, hanno invocato un’ulteriore riduzione dei già inadeguati livelli di protezione sociale.
Durante la coalizione tra conservatori e liberal-democratici, nel 2010-2015, i demagoghi dell’Independence Party britannico (Ukip), sono riusciti a indirizzare il malcontento popolare contro la Ue e a fomentare un nazionalismo xenofobo, che individua i nemici nei lavoratori provenienti dagli altri Paesi dell’Unione. La crescente forza dell’Ukip ha allarmato i partiti tradizionali. Ciò che ne è seguito è stato, almeno in parte, guidato dal caso.
Per cercare di fermare l’avanzata politica dell’Ukip, il primo ministro britannico David Cameron ha promesso un referendum sulla permanenza del Regno Unito nell’Unione, in un momento nel quale la coalizione al governo sembrava destinata a continuare a governare il Paese; poiché i liberal-democratici non avrebbero mai potuto condividere la decisione di tenere il referendum, i conservatori erano sicuri che tale promessa non avrebbe potuto realizzarsi nella pratica. Tuttavia, l’inaspettata vittoria di una maggioranza conservatrice alle elezioni ha costretto Cameron a rispettare l’impegno preso.
Il trionfo della campagna del leave (uscire dalla Ue) ha coinvolto due grandi correnti politiche: da una parte il nazionalismo xenofobo promosso dall’Ukip; dall’altra la corrente ultra-liberale interna ai conservatori. Michael Gove e John Redwood, due conservatori membri del parlamento britannico, hanno visto l’Europa come un ostacolo al capitalismo globale deregolamentato di cui sono promotori. Nigel Lawson, ministro dell’economia britannico negli anni ottanta, sostenitore di questa corrente scrisse “la Brexit completerà la rivoluzione economica iniziata da Margaret Thatcher”.
Queste due correnti sono potenzialmente in conflitto, poiché la radicale deregolamentazione proposta dai conservatori porterebbe, con molta probabilità, ad accrescere la precarietà economica della maggior parte della popolazione. Sino a oggi tale conflitto è, tuttavia, rimasto sopito. D’altra parte, però, è già scoppiato un aperto conflitto all’interno del governo post-Brexit di Theresa May. Alcuni ministri, influenzati da potenti gruppi di interesse – quelli finanziari innanzitutto – sono preoccupati per le possibili conseguenze dell’uscita del Regno Unito dal Mercato Unico e dai rischi di instabilità economica, che hanno portato a un forte deprezzamento della sterlina. Essi stanno adoperandosi per una ligth-Brexit, una interpretazione minimalista dell’uscita dall’Unione, che preservi il più possibile lo status quo. Altri, invece, sono determinati nel dare seguito alle richieste populiste di controlli sull’immigrazione, anche a costo di distruggere i rapporti con la Ue. Non è ancora chiaro quale delle due strade verrà seguita.
Le posizioni e le argomentazioni del movimento laburista sono state quasi ininfluenti nel dibattito referendario. La posizione accettata quasi unanimemente dal partito è stata che l’Europa, per come è adesso, non fa gli interessi dei lavoratori, ma un’uscita dall’Unione associata a un programma politico xenofobo e a un’agenda che punta alla deregolamentazione non può certo migliorare la situazione. Nonostante questa posizione fosse più che ragionevole, la debolezza del partito laburista, unita alla posizione pro-Brexit della stampa di destra, ha fatto sì che essa risultasse marginale nel dibattito.
La Brexit ha reso concreta la minaccia che forze centrifughe possano erodere, o forse addirittura distruggere, il progetto europeo. In particolare, il trionfo, con la Brexit, di due portati della destra radicale – liberismo economico estremo e nazionalismo xenofobo – rafforzano le tendenze disgregatrici in tutta Europa. Il fallimento dei leader europei nel rispondere al malessere sociale, che trova invece una distorta espressione in queste forze distruttrici, aumenta certamente le minacce per l’Unione. La passività con cui essa sta affrontando l’avanzata delle forze nazionaliste in tutta Europa è in evidentemente contrasto con la durezza e determinazione con le quali è stata schiacciata la proposta, razionale e pro-europea, di superamento dell’austerità in Grecia.
La divisione Nord e Sud nell’area euro
Non è stato solo il primo ministro britannico Cameron a spargere il seme della discordia in Europa. A suo modo, il ministro delle finanze tedesco, Wolfgang Schäuble, ha fatto lo stesso quando, a luglio dello scorso anno, confrontandosi con il governo greco, non ha dato alternative se non accettare l’austerità e le riforme strutturali richieste o lasciare l’area euro. Schäuble, che già nel 1994 aveva proposto un’Europa caratterizzata da un nucleo centrale, ha chiarito che l’appartenenza all’Unione dei Paesi (quelli periferici!) è reversibile, se questi non si adeguano ai cambiamenti strutturali e all’austerità fiscale e salariale.
Il governo guidato da Syriza non era pronto ad affrontare l’uscita dall’euro e, sotto fortissima pressione, ha accettato le condizioni imposte dagli altri Stati membri dell’area euro, guidati dalla Germania. A causa della continua contrazione della domanda interna, nel 2015 il Pil greco è diminuito ancora dello 0.2%, mentre il tasso di disoccupazione è rimasto attorno al 25%. Se le politiche restrittive hanno abbassato il deficit della bilancia commerciale, senza peraltro affrontarne le cause, hanno però peggiorato i problemi legati al debito greco. Negli ultimi mesi, il conflitto tra Europa e Fondo Monetario Internazionale sulla sostenibilità del debito pubblico greco e la necessità di un suo taglio si è intensificato. I Paesi dell’Europa centrale, tra cui la Germania, sono particolarmente riluttanti all’idea di tagliare il debito greco, nonostante i loro governi siano pienamente coscienti del fatto che ciò sarà inevitabile.
I programmi di adeguamento strutturale sostenuti dalla Commissione Europea e dai governi del nucleo centrale europeo, non hanno affrontato la profonda divisione che corre tra Nord e Sud, né il problema della debolezza delle strutture produttive e della deindustrializzazione nella periferia Ue. Il deprezzamento dell’euro, unito al trasferimento del turismo di massa da Egitto, Turchia e Tunisia ai Paesi dell’ovest del Mediterraneo, ha alleviato la situazione di Spagna e Portogallo.
Analogamente, la riduzione del grado di restrittività delle politiche macro deciso sia dal governo provvisorio della destra in Spagna, sia dal neo eletto governo progressista portoghese, con la sua aperta politica anti austerità, hanno contribuito a una qualche, lieve ripresa economica. Nonostante i due governi non abbiano rispettato le regole di bilancio imposte dalla Commissione Europea, in autunno 2016 non sono stati sanzionati. Anche il governo tedesco ha sostenuto questa decisione, il che ha lasciato margine di manovra al partito popolare spagnolo, importante alleato del tedesco Cdu/Csu, in uno scenario politico particolarmente incerto. Tuttavia la flessibilità concessa non deve essere interpretata come un cambio di direzione generale.
Sebbene i Paesi del nord Europa godano di un tasso di disoccupazione più basso rispetto a quelli del sud, sono anche loro esposti ai pericoli causati dagli squilibri presenti nell’economia europea. Ad esempio, essi sono, data la loro apertura economica e commerciale, particolarmente vulnerabili all’eventualità di una recessione indotta dalla Brexit in Gran Bretagna e nei maggiori Paesi europei. La crescita delle esportazioni (misurate in valore per includere il petrolio norvegese), dopo una lieve ripresa successiva alla crisi, è stata bassa in tutti i Paesi del nord (con l’eccezione dell’Islanda).
La situazione in Svezia e Norvegia è stata in qualche modo alleggerita grazie alla variabilità del tasso di cambio delle rispettive monete, mentre la Finlandia, facendo parte anche dell’Unione Monetaria, non ha potuto far fronte con il deprezzamento della moneta agli specifici shock che l’hanno colpita – i problemi della Nokia e le sanzioni alla Russia in particolare –, la qual cosa sarebbe stata particolarmente necessaria per sostenere l’industria del legno e dell’acciaio.
Analogamente, in Danimarca l’ancoraggio della moneta all’euro ha contribuito alla stagnazione delle esportazioni, sin dal 2010. Sebbene il flusso dei migranti abbia causato una crescita della spesa pubblica in Svezia, tale politica attiva discrezionale non è stata usata per aumentare l’occupazione; in Finlandia, invece, la crisi è stata ulteriormente aggravata dalle politiche di correzione fiscale mirate a soddisfare le richieste europee. In generale, l’ortodossia economica non ha permesso politiche di bilancio attive e solo la politica monetaria fortemente espansiva della Bce e delle banche centrali svedesi e norvegesi, con il loro pericoloso impatto sui prezzi delle case, ha permesso alla spesa interna di compensare, almeno parzialmente, la bassa domanda di esportazioni.
I rifugiati e la rottura dell’area Shengen
L’arrivo di un gran numero di rifugiati dal Medio Oriente e dai Paesi africani nel 2015 e a inizio 2016 ha evidenziato le spaccature interne alla Ue. Mentre le procedure non formalizzate utilizzate per gestire la crisi hanno portato a scaricare il peso sui Paesi periferici, la regolamentazione Ue sui rifugiati – derivante dalla Convenzione di Dublino – indica esplicitamente che a farsi carico dei migranti devono essere i Paesi di primo ingresso nell’Unione, tipicamente i più poveri. Nel 2015 questa scelta ha messo particolarmente in difficoltà la Grecia. Nell’estate del 2015 è apparso evidente che il governo greco – già affamato dalle politiche di austerità – era ormai sopraffatto dall’emergenza.
La decisione del governo tedesco di accogliere i rifugiati di guerra, particolarmente siriani, ha aiutato la Grecia, ma ha comportato problemi con altri governi, dall’Ungheria alla Svezia. Essa, assunta senza previa consultazione degli altri Paesi, ha riconosciuto implicitamente il fallimento degli accordi di Dublino. Da settembre 2015 a marzo 2016 sono state adottate soluzioni temporanee, non previste dalla normativa in vigore, come quella dei corridoi umanitari tra Germania e Croazia, attraverso i quali ai rifugiati è stato consentito di raggiungere l’Europa centrale.
Queste misure sono state, però, fortemente avversate da forze nazionaliste conservatrici come il governo di Fidesz in Ungheria. Esse si sono fortemente mobilitate per chiudere le frontiere agli immigrati e costruire muri. Queste istanze hanno trovato risonanza nei partiti cristiano-democratici e, addirittura, in alcuni partiti social-democratici. Rappresentanti di alto rango di governi come quello ungherese e austriaco sono andati in visita in Macedonia – Paese candidato a entrare nell’Unione – elogiando come questa stesse difendendo i confini “europei”. Implicitamente, hanno così mostrato come ci sia un Paese considerato “ridondante” nell’area Shengen – ancora una volta la Grecia.
I Paesi Ue si sono dimostrati incapaci di trovare una nuova formula per distribuire gli oneri associati alla crisi dei migranti. Invece di un più che giustificato approccio umanitario associato a circostanze eccezionali, hanno optato per esternalizzare la gestione del problema. A tal fine, il 10 marzo 2016 è stato siglato un accordo con la Turchia, che prevede che essa accetti i rifugiati in cambio di soldi, mentre la Ue si impegna a ricevere un numero limitato di rifugiati siriani provenienti dalla Turchia; inoltre, è prevista l’accelerazione dei negoziati di accesso della Turchia all’Unione e l’abolizione del visto per l’ingresso nella Ue dei cittadini turchi. In pratica, il governo turco ha bloccato i rifugiati in Turchia, impedendogli di raggiungere la Ue, in cambio dell’acquiescenza europea rispetto al carattere sempre più repressivo del regime che governa quel Paese.
L’imposizione del Comprehensive Trade and Economic Agreement col Canada (Ceta)
Alla fine di ottobre 2016 la Commissione e, più in generale, tutte le forze liberiste hanno utilizzato tutti gli strumenti a loro disposizione per far sottoscrivere a tutti gli Stati membri il trattato Ceta con il Canada. Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha elogiato questo accordo di libero scambio come “il più progressivo” mai siglato dall’Unione. Forti correnti interne ai partiti di sinistra, ai sindacati e ai movimenti sociali hanno, però, visto in questo accordo molti elementi regressivi dal punto di vista della democrazia e dello stato di diritto.
Una delle clausole più controverse riguarda la creazione di un tribunale che permetterebbe agli “investitori” (le grandi multinazionali) di citare in giudizio i governi per ottenere compensazioni economiche nei casi in cui ritengano che la regolamentazione nazionale leda i loro diritti, così precostituendo un privilegio legale per le imprese multinazionali. Altri elementi di preoccupazione riguardano, fra gli altri, i servizi pubblici e gli standard sanitari. Accordi commerciali come il Ceta scolpiscono nella roccia le regole liberiste, riducendo grandemente lo spazio per una ri-regolamentazione democratica. Le negoziazioni per il Ceta sono rimaste riservate a lungo, nascoste all’ombra delle trattative per la Transatlantic Trade and Investment Partnership (il Ttip), basata sulla stessa filosofia.
Quando le negoziazioni per il Ttip sono saltate, viste le forti resistenze, le forze del libero mercato hanno messo l’approvazione del Ceta fra le loro priorità. Di fatto, molte società americane hanno sedi in Canada e possono, perciò, comunque avvalersi del Ceta. In un certo senso, il Ceta è un sotterfugio per imporre comunque le regole del Ttip. Sebbene in Germania le proteste contro il Ttip e il Ceta siano state particolarmente accese, i social-democratici hanno ceduto alle pressioni dei conservatori loro alleati, del mondo degli affari e di Bruxelles.
Il partito social-democratico austriaco ha negoziato una dichiarazione interpretativa di alcuni punti critici, che verrà allegata al trattato. L’ultimo ostacolo alla firma è venuto dalle regioni belghe della Vallonia e di Bruxelles. La Vallonia, in particolare, aveva evidenziato già un anno prima le sue obiezioni alla Commissione ma, ciononostante, quest’ultima ha scelto di fissare comunque la data della cerimonia per la firma. Ciò si è rivelato in parte un errore di calcolo, in quanto il governo regionale ha fatto slittare la data prevista, cedendo, infine, solo dopo aver negoziato una dichiarazione speciale.
Il commissario europeo Günther Oettinger ha reagito alle controversie sul Ceta chiedendo che i governi nazionali non interferiscano con le politiche commerciali europee. L’intento di questa dichiarazione è, evidentemente, quello di contrastare l’opposizione al trattato tramite la centralizzazione. Il percorso di ratifica del Ceta da parte dei parlamenti nazionali si preannuncia, tuttavia, accidentato. Di fatto, il modo in cui l’Europa ha insistito per l’approvazione del Ceta aggrava la crisi di legittimità europea e fomenta le tendenze disgregatrici.
Le relazioni Ue-Usa dopo l’elezione di Trump
L’ascesa dei partiti nazionalisti di estrema destra non è rimasta confinata all’Europa. Negli Usa, l’oligarca Donald Trump ha vinto con un margine ristrettissimo le elezioni presidenziali, grazie al supporto di varie forze di destra. Gli elementi chiave della sua campagna sono stati un’aggressiva retorica anti-immigrati, la promessa di abbassare le tasse e la fine di trattati commerciali come il Ttip. Se realizzate, le promesse di interrompere le negoziazioni per il Ttip e di ridurre le spese americane a sostegno della Nato cambieranno significativamente le relazioni tra Usa e Ue.
Dopo l’elezione di Trump, si è riacceso il dibattito sulla formazione di una “difesa comune”. In un contesto di “cooperazione strutturale permanente”, la cooperazione militare tra gli Stati membri non può che aumentare. In effetti, sia i deputati europei cristiano-democratici che quelli social-democratici hanno chiesto un aumento della spesa militare da parte dei singoli Paesi: in un contesto dove molteplici sono gli elementi di crisi, emerge dunque un ampio consenso, che va dai social-democratici alle destre nazionaliste, per una maggiore militarizzazione dell’Unione e una politica estera più aggressiva. Questa spinta militarista deve essere contrastata con decisione dalle forze di sinistra e dai movimenti per la pace.
Idee e strategie per leggere le tendenze disgregative
L’ampio consenso tra i cristiano-democratici, i social-democratici e i nazionalisti di destra non va oltre la militarizzazione della politica estera. Le élite europee hanno intrapreso percorsi differenziati per fronteggiare le molteplici crisi e le tendenze disgregative. Queste strategie sono strettamente legate ai differenti scenari futuri considerati e ai diversi modi di guardare all’Europa. Come nel caso della Brexit in Gran Bretagna, anche in Europa sono le forze di destra che dominano il dibattito sul futuro dell’Unione.
Cercare di sopravvivere in qualche modo: questo è il modo prevalente di gestione delle molte crisi che affliggono l’Europa. È l’approccio privilegiato dalla maggior parte dei cristiano-democratici, come dei social-democratici e dei liberali. Si tratta di una strategia che punta a proseguire nell’attuazione del modello neoliberista di integrazione e a preservare l’attuale configurazione geografica dell’Unione Monetaria e dell’area Shengen. È un approccio che ottiene il supporto delle maggiori multinazionali, ma che non fa in alcun modo i conti né con le divisioni tra centro e periferia dell’Unione, né con la sua perdita di legittimazione agli occhi delle classi popolari. Nonostante questa strategia abbia la pretesa di preservare il processo di integrazione europeo e i suoi confini geografici, la mancanza di elementi di promozione della coesione non potrà che accelerare il processo di disgregazione europeo.
Vanno anche evidenziate due sotto-varianti di questa strategia.
Cercare di sopravvivere con un po’ più di flessibilità fiscale e maggiori investimenti pubblici. È la strategia perseguita principalmente dai social-democratici e, in parte, dalle forze di sinistra in Francia e nei Paesi mediterranei. Essa punta a integrare l’approccio sopra descritto con una combinazione di flessibilità fiscale e investimenti pubblici. Si cerca di ampliare lo spazio per gli interventi di politica economica alleggerendo le regole fiscali. Questa strategia è caratterizzata da una qualche maggiore attenzione ai problemi di coesione dell’Unione rispetto alla variante principale.
Cercare di sopravvivere restringendo e rendendo più rigida l’area Schengen. Questa variante invoca il ritorno temporaneo dei controlli alle frontiere nell’area Schengen e vuole escludere dall’area i Paesi che non sono disposti a tenere rifugiati e migranti “indesiderati” fuori dai confini nazionali. Quest’approccio è perseguito soprattutto dalle correnti nazionaliste interne ai partiti cristiano-democratici dei Paesi del nucleo centrale europeo e dei Paesi più orientali dell’Europa centrale, ma esso gode del sostegno anche di alcuni partiti social-democratici. De facto questa strategia sta già prendendo piede, come dimostrato, ad esempio, dalla reintroduzione di controlli temporanei alle frontiere e dalla costruzione di barriere fisiche di confine all’interno della stessa area Schengen.
Core Europe: la costruzione di un nucleo centrale europeo. L’Europa è già caratterizzata da differenti gradi di integrazione. Tradizionalmente, il concetto di Europa core è stato finalizzato a intensificare l’integrazione neoliberista tra i Paesi che ne dovrebbero farne parte. Per questo come area di riferimento si guarda a un insieme di Paesi più ristretto e omogeneo all’interno dell’area euro. Questa visione è stata ampiamente dibattuta all’interno dei circoli cristiano-democratici dei Paesi interessati. I partiti della destra nazionalista che propongono questa visione, come Freiheitliche Partei Osterreichs (Fpö) o Alternative fur Deutschland (AfD), puntano soprattutto a rendere l’Unione più piccola e omogenea, vogliono liberarsi dei Paesi periferici che ritengono un peso. Le proposte delle forze di destra dei Paesi periferici, come in Italia la Lega Nord o, in modo più lieve, il Movimento 5 Stelle, puntano ad abbandonare l’eurozona e sono dunque complementari a quelle che mirano alla costruzione del nucleo centrale.
L’Europa delle nazioni. Alcuni partiti della destra nazionalista sostengono che il processo di integrazione europeo debba focalizzarsi sul Mercato Unico e la relativa regolazione economica. I partiti della destra nazionalista nell’Europa dell’est, come Fidesz in Ungheria o Prawo i Sprawiedliwość (PiS), in Polonia ritengono, invece, fondamentali anche gli apporti dei fondi europei per lo sviluppo regionale. Tuttavia, essi invocano negli altri campi più libertà per gli Stati nazionali, in parte per realizzare strategie competitive, in parte per promuovere un’agenda politica nazionalista e conservatrice (ad esempio, in ambiti quali l’identità sessuale o le politiche sociali). Alcune forze della destra nazionalista, come il Front National in Francia, hanno formulato vaghe idee di “un’altra Europa”, tanto poco definite da non apparire sostanzialmente distinte da quelle che mirano alla completa dissoluzione dell’Unione.
Idee e strategie per la sinistra
Un’altra Europa: un federalismo europeo di sinistra: il concetto di un’altra Europa è stato usato anche da alcune forze di sinistra, ma con un significato completamente diverso. Il fine è quello di rifondare democraticamente la Ue, gettando le basi per un federalismo democratico europeo e per un’integrazione più equilibrata. Il punto è che i presupposti politici per l’attuazione di questa agenda sono particolarmente difficili da realizzare, sarebbe necessario un largo consenso generale e tra gli Stati membri, un contesto, insomma, opposto a quello che sembra prevalere attualmente.
A fronte del manifestarsi di forti disequilibri di potere fra i Paesi Ue e dopo l’esperienza greca, un crescente numero di forze di sinistra chiede ora l’attuazione di esplicite politiche di promozione sociale, che contemplino il non rispetto delle regole europee e, laddove necessario per intraprendere politiche progressiste, anche l’abbandono della moneta unica.
I due differenti approcci della sinistra differiscono principalmente nel giudizio su cosa sia politicamente realizzabile all’interno dell’Unione e su cosa potrebbe essere realizzato attraverso le singole politiche economiche nazionali.
Entrambe le prospettive appaiono di difficile realizzazione senza una maggiore unità politica e un maggiore incidenza elettorale della sinistra rispetto all’attuale. Malgrado contestazioni radicate negli specifici contesti nazionali costituiscano la più immediata forma di sfida alle politiche attuali, EuroMemo continua a ritenere indispensabile una prospettiva internazionale e a sostenere la necessità di un approccio coordinato a livello europeo per promuovere la ripresa economica e la giustizia sociale.
Oggi lunedì 6 marzo 2017
Oggi, lunedì 6 marzo alle ore 17.30 la Fondazione Sardinia, organizza presso la propria sede di piazza San Sepolcro a Cagliari la prima riunione per la Festa de Sa die de Sa Sardignia 2017.
———————–
 ————————————-
————————————-
Dipinto di Filippo Figari, Sardegna Industre, 1925, olio su tela, aula magna dell’Università di Cagliari (Università della Sardegna).
———————–





—————————————————————————————————–

 DIBATTITO/DEBATE. Jesús Timoteo Álvarez: i pericoli della deriva populista. Ci può salvare l’Utopia? Forse… Si, crediamoci.
DIBATTITO/DEBATE. Jesús Timoteo Álvarez: i pericoli della deriva populista. Ci può salvare l’Utopia? Forse… Si, crediamoci.
Editoriale di Aladinews.
———————————————————————————————-
![]() Tra presidenziale e proporzionale c’è una terza via?.
Tra presidenziale e proporzionale c’è una terza via?.
Andrea Pubusa su Democraziaoggi.
———————————————————————————————–
 Riflessioni pertinenti
Riflessioni pertinenti
Tonino Dessì su fb
Tutto il gruppo L’Espresso sta mollando Renzi.
Su La Repubblica, sintomatica della sindrome dei topi che saltano dalla nave che affonda, la rubrica di Michele Serra: veramente un pezzo domenicale da Maramaldo.
Il numero del settimanale allegato a La Repubblica di oggi, poi, titola in copertina: “Il giglio nero”.
Ho letto la prima. Non leggerò il secondo.
È vero infatti che l’indagine Consip sta facendo emergere fatti (presunti) gravi.
Ma che il milieu renziano (e ancor prima boschiano) fosse quello era emerso nettamente anche in precedenza.
Perché allora questi media hanno sostenuto Renzi nell’operazione referendum?
Che interessi c’erano, dietro quello che oggi più che mai appare esser stato un tentativo di golpe bianco?
Cosa davvero rappresenta, attualmente, il gruppo economico-editoriale Debenedetti?
Secondo me è un quesito assai più rilevante di questa fase terminale del renzismo.
La parabola di una leadership di preminente creazione mediatica sta travolgendo il PD. Dubito che qualcuno pensi davvero che una figura del tutto priva di carisma e di spessore come il ministro Orlando possa fungere, se vincesse le primarie, più che da liquidatore del partito.
Chi poi abbia visto e sentito Emiliano dalla pur compiacente Annunziata non può che averne constatato la pomposa vacuità.
La crisi del sistema politico italiano, tolto dai piedi il tappeto (e il diversivo) delle invocate riforme costituzionali ed elettorali, sta deflagrando in una misura persino imprevista.
È anche vero che il voto popolare ha messo al sicuro le istituzioni repubblicane.
Ma gli interessi eversivi, ora, come si muoveranno?
Elogio della sostenibilità dello sviluppo
 Presentazione del volume
Presentazione del volume
Elogio della sostenibilità dello sviluppo
Critica della teoria della decrescita di Serge Latouche
di Gianfranco Sabattini
Cagliari, martedì 7 marzo ore 17.30 – Società degli Operai (via XX Settembre 80)
In alternativa alla prospettiva latouchiana della decrescita felice e partendo dalla distinzione tra crescita e sviluppo il volume di Gianfranco Sabattini, titolare della cattedra di Politica Economica all’Università di Cagliari, propone un’ organizzazione del sistema economico secondo una idea di sviluppo sostenibile. Questo il tema sviluppato nel nuovissimo libro “Elogio della sostenibilità dello sviluppo”, edito da Tema edizioni e scritto da Gianfranco Sabattini che verrà presentato martedì 7 marzo con inizio alle ore 17.30, nella sala conferenze della Società degli Operai, in via XX Settembre a Cagliari.
La presentazione sarà coordinata da Antonello Angioni, direttore dell’Istituto Gramsci. Oltre all’autore, interverranno Vittorio Dettori, e Pietro Maurandi, rispettivamente docenti di Economia Politica e Storia delle Dottrine Economiche all’Università di Cagliari.
DIBATTITO/DEBATE. Jesús Timoteo Álvarez: i pericoli della deriva populista. Ci può salvare l’Utopia? Forse… Si, crediamoci



Vientos del 2017: Intuiciones sobre lo que nos viene
.
.
Por la ventana sólo se ve niebla. Iluminada por augures de diferentes colores. Hace dos años ese color era la economía (Stiglitz, Piketty, Mazzucato, Spence, Naim…). Ahora es el populismo (Crouch, Todt, Diamati, Duhamel, Bauman/Bordoni, Rosanvallon…). Lo que se vislumbra es tormenta y pesimismo: el año entrante vira hacia la democracia directa, paso previo de las “democracias iliberales”, a lo Putin, a lo Erdogan, a lo Trump, a lo LePen… con inevitable deriva hacia gobiernos prepotentes y a dictaduras. Seguramente tienen razón pero esos gruesos ensayos son demasiado académicos, algo alejados del hacer diario. En el trajín del momento los comportamientos de las gentes se mueven por hilos más elementales. El primero de estos hilos tiene que ver con el nivel de manipulación que en todas sus actividades esas gentes soportan, es decir, la eficacia del marketing (de consumo, social, político) que han interiorizado. El segundo hilo tiene que ver con la percepción que las mismas gentes tienen de su propio poder, la sensación personal de su propia capacidad de decisión e influencia. El tercero, más subterráneo, es el rastro que el eterno flujo de la evolución humana, los comportamientos primarios, continúa teniendo en las actitudes, costumbres y decisiones de la sociedad y de las gentes.
——————————
Jesús Timoteo Álvarez
Catedrático de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid
Vientos del 2017: Intuiciones sobre lo que nos viene
La sociedad del 2017 es en una primera instancia producto del Marketing
La sociedad del 2017 es en una segunda instancia producto de la reorganización del sentido y de la estructura del poder
La sociedad del 2017 significa en una tercera instancia, el renacer de lo primigenio contra una “era confesional” e ideologizada.
¿Qué se ve en el horizonte?
La sociedad del 2017 es en una primera instancia producto del Marketing
El común comportamiento de los ciudadanos responde a programadas “provocaciones” o entradas que provienen de agentes de todo tipo. Los más clásicos son los comerciales que orientan el consumo y los comportamientos pero también los políticos y todo tipo de “influenciadores” que hacen lo posible para establecer actitudes y decisiones. El nivel de manipulación que las personas son capaces de adecuar son por tanto el primer elemento de organización social. Un ejemplo lo tenemos en las últimas elecciones USA, un flash inesperado, deslumbrante.
La victoria de Trump es el éxito de sus equipos de Estrategia y Marketing Político. Un par de “Spin Doctors”, Stephen Bannon y Kellyanne Conway, una empresa de Big Data, “Cambridge Analityca” de Alexander Nix, que había acumulado el perfil y la huella digital de los votantes, las Redes Sociales (Facebook y Twitter sobre todo), gestionadas aquí por Matthew Oczkowsk, que permitían llegar individualmente a cada votante y una gestión de contenidos con técnicas de desinformación (con mentiras programadas) ganaron la partida.
Arrollaron a los “Spin Doctors” demócratas: John Podesta, Olivia Pope y Zac Petkanas. Fundamentalmente porque estos padecieron de arrogancia.
Cameron convocando el referéndum o Hillary con su estrategia de campaña son clara muestra de ese pecado. Son tres las razones de esa soberbia. La primera es de identidad: el votante demócrata se identifica desde siempre con un gran segmento de mercado autodefinido como “progresista”, convencido de ser moralmente superior, jaleado por elites intelectuales y caracterizado por factores identitarios del tipo de igualitarismo, pacifismo, alianza de las civilizaciones, “buenismo”, culpabilidad occidental,…etc. La segunda es de discurso, de relato: estar seguros de que la gente vota por razones económicas; y así, su lenguaje y argumentos dominantes en la estrategia del poder demócrata y progresista gira en torno a conceptos económicos como PIB, salario social para todos, crecimiento, inflación, déficit público, economía sostenible y conceptos parecidos, todos ellos agregados estadísticos que se han consagrado como los únicos referentes del discurso político oficial y que tienden a concentrar el mundo en una máscara de objetividad, marcada por indicadores manipulables. Existe, sin embargo, una esencial diferencia entre el marketing comercial y el político: el primero, una vez logrado su objetivo de persuasión, se encuentra con un último contradictor que es el precio. El precio corrige excentricidades. El segundo, el marketing político, no cuenta con ese valor último de ajuste: votar sale gratis. La tercera es estratégica: creer, como sucede en el consumo de marcas y productos, que lo diferente, lo minoritario, define el progreso y atrae al comprador (al votante): para la izquierda intelectual todo lo minoritario es progresista y el desarrollo viene definido por la novedad, mejor mientras más radical; es así cómo dietistas, ciclistas, corredores, feministas, animalistas, tribus musicales, cursis del “vosotros vosotras”… etc., siempre que sean radicales y fanatizados se sienten con derecho a marcar el futuro de toda la sociedad. Resultó que una campaña orientada a elitistas, economicistas y extravagantes, que sólo puede alcanzar mayorías por acumulación de grupos radicales, fue un fracaso para los spin demócratas.
La sociedad del 2017 es en una segunda instancia producto de la reorganización del sentido y de la estructura del poder
En un doble sentido. Desde una perspectiva micro, y bajo influencia del consumo, las personas están convencidas de elegir autónomamente y de que sus decisiones influyen. Desde el punto de vista macro, la estructura del poder mundial ha saltado más allá de los Estados.
El Poder se ha entendiendo, desde donde alcanza nuestro recuerdo, como aquello que permite imponer las decisiones del soberano (de quien manda) a la libertad del subordinado.
Esta estructura lineal es eficaz en sociedades teocráticas o estatal-piramidales, pero es difícil de aplicar en un mundo complejo como el actual. El clásico modelo de causalidad no explica la evolución compleja de los acontecimientos, como sucede por ejemplo con la justificación del actual terrorismo. Sucede así con el poder: los votantes y consumidores están convencidos de que son libres y con capacidad de tomar sus propias decisiones. Cualquier poder por tanto es básicamente persuasivo, está obligado a “vender” antes que nada el convencimiento de que las decisiones son opciones libres y personales de los súbditos, tanto en el mercado de la política como en el de bienes y consumo.
Paralelamente ha sucedido una reorganización del orden geopolítico mundial. El viejo orden, basado en el sumando Estado, Territorio, Impuestos, Propaganda, Identidad, controlado todo ello dentro de las fronteras nacionales por el intervencionismo estatal, ya casi no existe. La globalización sobrepone a ese viejo orden un orden internacional distinto que es circular, caótico y sin referentes fijos. Son las poderosas “Repúblicas Digitales” (Google, Amazon, Facebook, Twitter, Yahoo, Apple, etc..) que violan las leyes fiscales de los territorios donde operan y sin complejos exigen radicales cambios de las mismas a su favor.
La sociedad del 2017 significa en una tercera instancia, el renacer de lo primigenio contra una “era confesional” e ideologizada.
Otro afianzado apriorismo del pensamiento dominante occidental identifica evolución y progreso con el definitivo triunfo de la razón sobre todo lo que tenga que ver con el mito, las creencias o la religión, la victoria definitiva de la razón sobre la supuesta ignorancia del pasado digno sólo de entierro y olvido. La palabra llave en este discurso dominante es el término “laicismo”. Nuestro mundo occidental ha eliminado del consciente colectivo el dilema profano-sagrado. Por innecesario. Pero tal vez las cosas no sean tan sencillas porque, como enunciaba Tocqueville, “las revoluciones, que fueron políticas, fueron siempre precedidas de revoluciones religiosas” En modo diverso.
La Revolución Americana la podemos relacionar preferentemente con Montesquieu, donde Dios es garantía metapolítica de la Constitución y de las leyes y no entra en las guerras por el poder. Los Estados Unidos de Norteamérica nacen de la religión y no se establece allí la religión al servicio de la política. El equilibrio de poderes presupone la existencia de diversas fuentes normativas en competencia entre ellas, unas de origen estatal (civil), otras de origen religioso (tradicional). La Revolución Francesa, sin embargo, nace preferentemente de Rousseau, heredando el Iluminismo, y tiene como fin la salvación del hombre a través del Estado y de la “voluntad general”. La autoridad es un cuerpo único que es político, donde la conciencia individual queda sometida a la conciencia colectiva de la nación, los sistemas de derecho y de ética quedan unificados en una única realidad. Nace ahí y para Europa la “religión política”, la ideología religiosa del Estado Nación al que el individuo queda religiosamente consagrado como súbdito y como ciudadano por el hecho de su nacimiento (que equivale al bautismo).
Un rápido proceso, sin embargo, ha puesto fin en menos de 30 años a esa era confesional, ideológica y de la religión laica. Porque esa estructura se montó sobre el Estado nacional que la globalización ha roto. Globalización aquí significa además de la ruptura del Estado Nación, la desaparición de la centralidad occidental y del modelo europeo, significa además la pérdida de soberanía a cualquier nivel que se licúa en redes y repúblicas “digitales” y la desaparición por desconocimiento o estupidez de referentes legales (“potestas”) y morales (“auctoritas”).
¿Qué se ve en el horizonte?
Evolucionamos hacia un futuro no controlable. Necesitamos entender la actual realidad y ser capaces de predecir su evolución hacia un modelo intramundano, terrenal, que, una vez prefigurado con uno o varios escenarios permita ser utilizado como referente y atracción de la acción política a seguir. Eso se llama Utopía, apertura a lo no localizado (u-topos), al no lugar, a lo universal. Ni Moro, ni Bacon ni Maquiavelo quisieron nunca crear una ciudad sino un paradigma, una referencia, un “lugar” de atracción y referente del camino a lo perfecto, a la “ciudad de Dios”. Desde nuestra perspectiva, en este horizonte se entrelazan dos hilos complementarios: la evolución darwiniana de lo humano con la ciencia y tecnología.
Nadie pone en duda la bondad de los progresos sociales y científicos que el mundo moderno ha alcanzado. Es probable que estos adelantos puedan, con el desarrollo científico, hacer frente a grandes retos de la humanidad tales como la minusvalía, el sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento, el dolor… y puedan cambiar la especie humana con la aplicación de lo que se conoce como “tecnologías exponenciales” o “NBIC” [nanotecnologías, biotecnologías, informática (Big Data e Internet) y ciencias cognitivas como inteligencia artificial y robótica]. Es probable que la tecnología cambie el mundo hasta el punto de que nuestros descendientes ya no serán en muchos aspectos “humanos” sino “transhumanos” o “posthumanos” o “postdarwinianos”, formando parte de una raza robotizada o cibernética. Será inútil sin embargo querer descartar de esta utopía cibernética lo primigenio, el rastro genético, el poso de comportamientos seculares, las virtudes y los vicios capitales, en definitiva, lo sagrado. Mientras quede algo de “humano”. Einstein, en su autobiográfico Out of My Later Years llega a acuñar la conocida fórmula: «La ciencia sin la religión es coja. La religión sin la ciencia es ciega». Y al final de su existencia, en 1955, en una especie de testamento, dejaba en su Mensaje a la humanidad una llamada (…): «Nosotros, los científicos, dirigimos una llamada como seres humanos que se dirigen a seres humanos. Recordad vuestra humanidad y olvidad el resto».
Porque al final y siempre esa humanidad es más grande que el cielo:
“La Mente – es más grande que el cielo –
“The Brain – is wider than the sky -
porque – puestos uno junto a otro -
For – put them side by side -
el primero contiene al segundo
The one the other will contain
con facilidad – y a ti – también”
With Ease – and You – beside”
(“The Brain”. Emily Dickinson: 1830-86)
———————————————
Jesús Timoteo Álvarez
Mis libros
- Los Intangibles en el valor de las empresas
- Neurocomunicación
- Manejo de la comunicación organizacional
- Historia y modelos de la comunicación en el s. XX
- Muchas voces un mercado
- Gestión del poder diluido
- Del viejo orden informativo
Datos de contacto
eMails
brimberal@gmail.com – jtalvare@ucm.es – jesus.timoteo@cqlp.es
Teléfono +34 917 818 090
Oficina
Calle Velázquez 31
5ª derecha
Madrid 28001, España
—————-
Privacidad
© 2017 – Jesús Timoteo Álvarez, Catedrático de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid
Powered by Science and Marketing
Oggi, domenica
 OGGI, alle 15,30, in via Piccioni 21 Cagliari, chiacchieriamo di architetture della salute, dove si racconta di abitudini greche, romane, medievali ecc., fino ad arrivare ai giorni nostri con Veronesi, Renzo Piano e alcune vicende locali che sono, guarda caso, in Cima. C’è posto per tutti, venite numerosi! (Aldo Lino)
OGGI, alle 15,30, in via Piccioni 21 Cagliari, chiacchieriamo di architetture della salute, dove si racconta di abitudini greche, romane, medievali ecc., fino ad arrivare ai giorni nostri con Veronesi, Renzo Piano e alcune vicende locali che sono, guarda caso, in Cima. C’è posto per tutti, venite numerosi! (Aldo Lino)
——————————————————————

![]() DIBATTITO. I limiti dello «sviluppo». Intervento di Serge Latouche: “La via della decrescita come risposta all’inganno dello sviluppo sostenibile”.
DIBATTITO. I limiti dello «sviluppo». Intervento di Serge Latouche: “La via della decrescita come risposta all’inganno dello sviluppo sostenibile”.
Editoriale di Aladinews.
Oggi domenica 5 marzo 2017





—————————————————————————————————-
Punta de billete: arregordarì. Save the date La pagina fb dell’evento.

UN ESERCIZIO GIAPPONESE. Città di Cagliari. REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI

 Abbiamo preso il Regolamento di Torino e l’abbiamo letteralmente ricopiato sostituendo a Città di Torino Città di Cagliari. E’ solo un esercizio alla “giapponese”, come si diceva un tempo perché erano i giapponesi i maestri del ricopiare/imitare. Oggi, invece, sono considerati tali soprattutto i cinesi. A prescindere, in questo caso vogliamo solo sostenere che a redigere un regolamento sui beni comuni urbani, di cui la Città di Cagliari è priva, basta poco: basta appunto copiare intelligentemente dalle migliori regolamentazioni (a cui corrispondano buone pratiche) conosciute. Noi vorremmo però arrivare all’approvazione formale di un regolamento (da parte del Consiglio comunale) attraverso un percorso di condivisione con i cittadini attivi e le loro organizzazioni associative. Spetta al Comune e, in particolare ai consiglieri comunali (tutti: di maggioranza e di minoranza) e, ovviamente, al Sindaco e alla Giunta, di avviare questo percorso partecipativo per arrivare rapidamente alla meta. Al riguardo il Laboratorio sulla Sussidiarietà (www.labsus.org) guidato dal prof. Gregorio Arena fornisce ogni necessario e qualificato supporto. Spetta poi all’Amministrazione comunale di dotarsi di un’adeguata organizzazione di carattere gestionale perché tutto venga concretamente attuato nel migliore dei modi. (Franco Meloni direttore di Aladinews e componente dell’Osservatorio Beni Comuni della Sardegna).
Abbiamo preso il Regolamento di Torino e l’abbiamo letteralmente ricopiato sostituendo a Città di Torino Città di Cagliari. E’ solo un esercizio alla “giapponese”, come si diceva un tempo perché erano i giapponesi i maestri del ricopiare/imitare. Oggi, invece, sono considerati tali soprattutto i cinesi. A prescindere, in questo caso vogliamo solo sostenere che a redigere un regolamento sui beni comuni urbani, di cui la Città di Cagliari è priva, basta poco: basta appunto copiare intelligentemente dalle migliori regolamentazioni (a cui corrispondano buone pratiche) conosciute. Noi vorremmo però arrivare all’approvazione formale di un regolamento (da parte del Consiglio comunale) attraverso un percorso di condivisione con i cittadini attivi e le loro organizzazioni associative. Spetta al Comune e, in particolare ai consiglieri comunali (tutti: di maggioranza e di minoranza) e, ovviamente, al Sindaco e alla Giunta, di avviare questo percorso partecipativo per arrivare rapidamente alla meta. Al riguardo il Laboratorio sulla Sussidiarietà (www.labsus.org) guidato dal prof. Gregorio Arena fornisce ogni necessario e qualificato supporto. Spetta poi all’Amministrazione comunale di dotarsi di un’adeguata organizzazione di carattere gestionale perché tutto venga concretamente attuato nel migliore dei modi. (Franco Meloni direttore di Aladinews e componente dell’Osservatorio Beni Comuni della Sardegna).
REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI.
.
.
- RIADATTAMENTO PER CAGLIARI.
Da approvare con deliberazione del Consiglio Comunale…
- segue -
Oggi sabato 4 marzo 2017





————————————————————————————————

——————————————————————————-
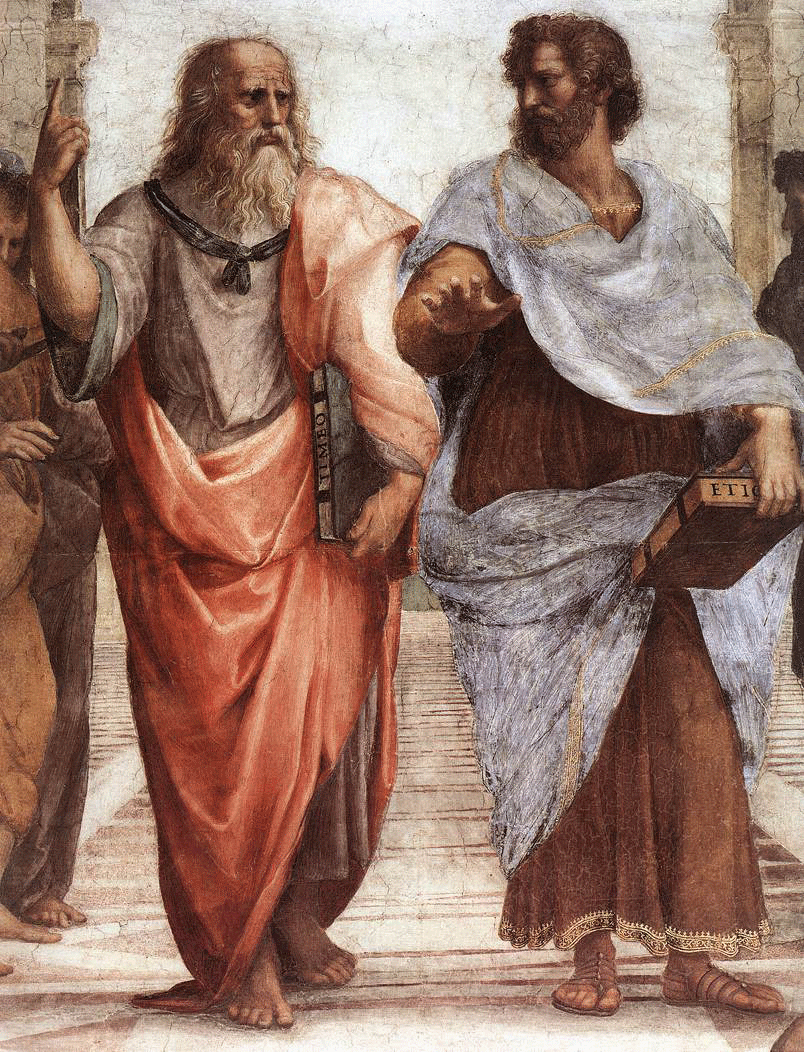
![]() Caro Pigliaru, col rimpasto la giunta dei sapientoni?
Caro Pigliaru, col rimpasto la giunta dei sapientoni?
Amsicora su Democraziaoggi.
DIBATTITO. I limiti dello «sviluppo» . Intervento di Serge Latouche: “La via della decrescita come risposta all’inganno dello sviluppo sostenibile”

 SOCIETÀ E POLITICA
SOCIETÀ E POLITICA
Il mondo non è una merce
di Serge Latouche
«Intervento di Serge Latouche preparato per un incontro promosso a Dublino (il 24 e 25 febbraio 2017) dal titolo “La via della decrescita come risposta all’inganno dello sviluppo sostenibile”». comune-info, 28 febbraio 2017 (c.m.c.), ripreso da eddyburg.
Fare della decrescita, come hanno fatto certi autori, una variante dello sviluppo sostenibile, costituisce un controsenso storico, teorico e politico sul significato e sulla portata del progetto. La necessità, provata da tutta una corrente dell’ecologia politica e dei critici dello sviluppo, di rompere con il linguaggio fasullo dello sviluppo sostenibile, ha portato a lanciare, quasi per caso, la parola d’ordine della decrescita.
All’inizio, quindi, non si trattava di un concetto, e in ogni caso di una idea simmetrica a quella della crescita, ma di uno slogan politico di provocazione, il cui contenuto era soprattutto diretto a far ritrovare il senso dei limiti; in particolare, la decrescita non è una recessione e neppure una crescita negativa. La parola quindi non deve essere presa in considerazione alla lettera: decrescere solo per decrescere sarebbe altrettanto assurdo di crescere soltanto per crescere. Tuttavia, i decrescenti volevano far crescere la qualità della vita, dell’aria, dell’acqua e di una pluralità di cose che la crescita per la crescita ha distrutto.
Per parlare in modo più rigoroso, si dovrebbe indubbiamente usare il termine a-crescita, con l’ «a» privativo greco, come si parla di ateismo. In quanto si tratta, d’altronde, esattamente di abbandonare una fede e una religione. È necessario diventare degli atei della crescita e dell’economia, degli agnostici del progresso e dello sviluppo. La rottura della decrescita incide quindi insieme sulle parole e sulle cose, implica una decolonizzazione dell’immaginario e la realizzazione di un altro mondo possibile.
La rottura con il produttivismo e la truffa dello sviluppo sostenibile
Seppure esiste un certo margine di incertezza nel concatenersi degli avvenimenti, l’emergere di un movimento radicale che propone una alternativa reale alla società dei consumi e al dogma della crescita, rispondeva sicuramente a una necessità che non è certo esagerato definire storica. Di fronte al trionfo dell’ultra liberalismo e all’arrogante affermazione della famosa Tina (acronimo di There is non alternative, non vi sono alternative) da parte della Margaret Thatcher, le piccole massonerie che si opponevano allo sviluppo e che auspicavano il rispetto dell’ecologia non potevano più accontentarsi di una critica teorica quasi confidenziale usata solo dai sostenitori del terzomondismo.
Inoltre l’altra faccia del trionfo dell’ideologia del pensiero unico non era altro che lo slogan consensuale dello «sviluppo sostenibile», un bell’ossimoro lanciato dal Pnue (Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente) per tentare di salvare la religione della crescita che doveva fronteggiare la crisi ecologica, e visione nella quale il movimento antiglobalizzazione sembrava essere perfettamente a suo agio. Diventava urgente contrapporre al capitalismo di mercato globalizzato un altro progetto di civilizzazione, o, più esattamente, di dare visibilità ad un disegno, da tempo in gestazione, ma che si evolveva in modo molto nascosto, quasi sotterraneo. Il movimento che prende il nome della decrescita trova il suo atto di nascita durante il colloquio «Disfare lo sviluppo, rifare il mondo», che si è tenuto all’Unesco nel marzo del 2002, una avventura culturale confermata dalla nascita, qualche mese più tardi, del giornale La décroissance che le ha procurato un eco più diffuso.
Diventato rapidamente la bandiera sotto la quale raccogliersi di tutti coloro che aspirano a costruire una reale alternativa a una società di consumo ecologicamente e socialmente insostenibile, la decrescita costituisce ormai uno spettacolo significativo per rendere evidente la necessità di una rottura rispetto alla società della crescita e per far emergere una civilizzazione basata su una abbondanza frugale. La rottura con lo sviluppismo, forma di produttivismo da offrire in uso ai Paesi cosiddetti in via di sviluppo, è stata quindi la base fondante di questo progetto alternativo. Ciò si è dapprima manifestato sotto forma di denuncia dell’etnocentrismo del concetto di sviluppo, prima ancora della rottura nei confronti del produttivismo come logica distruttiva dell’ambiente. Su questo punto, il contributo degli antropologi (Marcel Mauss, Karl Polanyi, Marshall Salhins, ad esempio), ignorato dagli economisti, è stato fondamentale.
Si tratta allora, con la decrescita di un altro paradigma economico, che contesta l’ortodossia neoclassica confrontabile con ciò che è stato il keynesismo a suo tempo? Questo è il significato che tentano di attribuirgli certe persone sulla scia del progetto di Bioeconomia di Nicholas Georgescu-Roegen. È chiaro che esistono altre politiche economiche possibili diverse dall’austerità imposta da Bruxelles all’interno di una società della crescita. Il periodo chiamato «i trenta gloriosi», (1945-1975) che ha visto il trionfo della regolamentazione keyneso-fordita ne costituisce la prova. Tuttavia, in una società della crescita senza una crescita, cioè la situazione in cui si trovano attualmente i paesi industrializzati, le politiche economiche alternative a quelle di ispirazione neo-liberista, sembrano impossibili da realizzare senza rimettere in causa il sistema economico e/o aggravare la crisi ecologica.
La denuncia della truffa dello sviluppo sostenibile è fondamentale per comprendere la necessità della rottura che la decrescita comporta e comprenderne tuta la portata. Questa, in effetti, è insieme un ossimoro e un pleonasma. Un ossimoro perché in realtà ne la crescita ne lo sviluppo sono in alcun modo sostenibili o durevoli. Questo è ciò che dimostra l’ecologia ed è il contributo di Nicholas Georgescu- Roegen: «Una crescita infinità è incompatibile con un pianeta finito». Un pleonasma, perché Walt Whitman Rostow ne Le tappe della crescita economica definisce lo sviluppo come una «crescita che si autosostiene», che sarebbe come dire che una crescita sostenibile o durevole, è una crescita durevole che dura.
Contrariamente a quanto sostengono alcuni dei suoi difensori, lo sviluppo sostenibile non si è allontanato dal suo significato e dalla sua funzione originali. Inventata, secondo la leggenda, da alcuni sinceri ecologisti, il progetto sarebbe stato deviato da alcune cattive imprese transnazionali preoccupate per il green washing, la spinta a mostrare un aspetto ecologico, e da responsabili politici senza scrupoli. Questo mito, che è duro a morire, non resiste all’analisi dei fatti. Lo sviluppo sostenibile fu lanciato esattamente come una marca di detersivo e con una accurata sceneggiatura, alla Conferenza di Rio del giugno 1992, da un buono, Maurice Strong segretario del Pnud. Poiché l’operazione seduttiva è pienamente riuscita al di la delle aspettative, le folle sono cadute nella trappola, inclusi gli intellettuali critici di Attac e gli ecologisti.
Verso la fine degli anni Settanta, lo sviluppo sostenibile si è imposto contro l’espressione più neutra di «ecosviluppo» , adottata nel 1972 alla Coferenza di Stoccolma, sotto la pressione della lobby industriale statunitense e grazie all’intervento personale di Henry kissinger. L’ecosviluppo sembrava troppo «ecologico» e poco «sviluppo» , soprattutto dopo che il paesi del Sud del Mondo se ne sono impadroniti alla conferenza di Cocoyoc del 1974, con lo scopo di rivendicare un nuovo ordine economico internazionale.
Lo sviluppo sostenibile del quale si ritrova l’invocazione in tutti i programmi politici, «ha solo la funzione – precisa Hervè Kempf – di mantenere i profitti e di evitare il cambiamento delle abitudini, modificando appena la superficie». Il fatto che il principale promotore dello sviluppo sostenibile, Stephan Schmidheiny, si sia rivelato un assassino seriale è quasi troppo bello per coloro che da anni si scagliano violentemente contro questo pseudo concetto per denunciare l’intera truffa. Questo miliardario svizzero, fondatore del World Business Council for Sustainable Development, eroe di Rio 1992, e che si presenta sul suo sito come filantropo, non è altro che l’ex-proprietario dell’impresa Eternit, chiamata in causa durante il processo per l’amianto di Casale Monferrato. L’industriale condannato dal tribunale di Milano a sedici anni di prigione e il paladino dell’ecologia industriale e della responsabilità sociale di impresa si sono scoperti essere la stessa identica persona.
Il progetto della decrescita non è ne quello di un’altra crescita, né quello di un altro sviluppo (sostenibile, sociale, solidale, ecc.). Esige di uscire dalla religione della crescita, ma questo aspetto merita di essere spiegato meglio. La crescita è un fenomeno naturale e in quanto tale è indiscutibile. Il ciclo biologico della nascita, dello sviluppo, della maturazione, del declino e della morte degli esseri viventi e la loro riproduzione sono anche la condizione della sopravvivenza della specie umana, che che deve metabolizzarsi con il suo contesto vegetale e animale. Gli uomini con molta naturalezza hanno celebrato le forze cosmiche che garantivano il loro benessere nella forma simbolica del riconoscimento di questa interdipendenza e del loro debito verso la natura per tutti questi aspetti.
Il problema nasce quando la distanza tra il simbolico e il reale scompare. Mentre tutte le società umane hanno dedicato un culto giustificato alla crescita, solo l’Occidente moderno ne ha fatto la sua religione. Il prodotto del capitale, risultato di una astuzia o di una frode commerciale, e quasi sempre di uno sfruttamento della forza dei lavoratori, è considerato simile all’accrescimento di una pianta. Con il capitalismo l’organismo economico, cioè l’organizzazione della sopravvivenza della società, non più in simbiosi con la natura, ma attraverso un suo sfruttamento senza pietà, deve crescere in modo infinito, come deve crescere il suo feticcio, il capitale. La riproduzione del capitale/economia mettono insieme, confondendoli, la fecondità e l’accrescimento, il tasso di interesse e il tasso di crescita.
Questa apoteosi dell’economia/capitale si trasforma nel fantasma dell’immortalità della società dei consumi. È in questo modo che noi viviamo nella società della crescita. La società della crescita può essere definita come una società dominata da una economia della crescita e che tende a lasciarsene assorbire. La crescita per la crescita diventa così l’obiettivo primordiale se non addirittura l’unico dell’economia e della vita. Non si tratta più di crescere per soddisfare dei bisogni riconosciuti, cosa che sarebbe ancora positiva, ma di crescere per crescere.
La società dei consumi è l’approdo normale di una società della crescita. Ciò si basa su una triplice mancanza di limiti: una produzione senza limiti e quindi sono illimitati anche i prelievi delle risorse, rinnovabili e non rinnovabili; assenza di limiti nei consumi, e quindi anche nella produzione di bisogni e di prodotti superflui; mancanza di limiti nella produzione di rifiuti e quindi nelle emissioni di scarichi e di inquinanti (dell’aria, della terra e dell’acqua).
Per essere sostenibile e durevole, qualunque società deve porsi dei limiti. Ora, la nostra, si vanta di essersi liberata da qualunque vincolo e ha optato per la dismisura. Certo, nella natura umana esiste qualche elemento che spinge l’uomo a superarsi continuamente. Ciò costituisce insieme la sua grandezza e una minaccia. Così tutte le società, eccetto la nostra, hanno cercato di canalizzare questa capacità e di farla lavorare per il bene comune. In effetti, quando la si spende nello sport non commercializzato, questa aspirazione può non essere nociva. Viceversa, essa diviene distruttiva quando si lascia libero corso alla pulsione dell’avidità («ricercare sempre qualcosa in più») nell’accumulazione di merci e di denaro. Si deve quindi ritrovare il senso del limite per garantire la sopravvivenza dell’umanità e del pianeta. Con la decrescita, si intende uscire da una società fagocitata dal feticismo della crescita. E per questo la decolonizzazione dell’immaginario è indispensabile.
Il progetto di una società dell’abbondanza frugale
La parola decrescita indica ormai un progetto alternativo complesso e che possiede una portata analitica e politica che non può essere contestata. Si tratta di costruire un’altra società, una società dell’abbondanza frugale, una società post-crescita (Niko Paech), cioè della prosperità senza crescita (Tim Jackson). In altre parole, non si tratta di creare all’improvviso un progetto economico, fosse pure di un’altra economia, ma un progetto societario che comporta di uscire dall’economia come realtà e come logica imperialista. Ciò che viene prima è dunque la decolonizzazione dell’immaginario.
L’idea e il progetto della decolonizzazione dell’immaginario hanno due fonti principali: la filosofia di Cornelius Castoriadis da una parte e la critica antropologica dell’imperialismo dall’altra. Queste due fonti si trovano in modo molto naturale, a fianco della critica ecologica, alle origine della decrescita. In Castoriadis l’accento è posto naturalmente sull’immaginario, mentre negli antropologi dell’imperialismo riguarda la decolonizzazione. Per cercare di pensare ad una uscita dall’immaginario dominante, si deve in primo luogo riandare al modo con il quale ci siamo entrati, vale a dire al processo di economicizzazione degli spiriti che si è verificato nello stesso momento della mercificazione del mondo. Per Castoriadis, come per noi, l’incredibile resilienza ideologica dello sviluppo si fonda su una non meno stupefacente resilienza del progresso. Come lo esprime mirabilmente:
«Nessuno più crede veramente nel progresso. Tutti vogliono avere qualcosa in più nell’anno successivo, ma nessuno crede che la felicità dell’umanità consista veramente nella crescita del 3 per cento all’anno del livello dei consumi. L’immaginario della crescita è certamente sempre lì: è sicuramente il solo che resiste nel mondo occidentale. L’uomo occidentale non crede più a nulla, se non nel fatto che potrà avere presto un televisore ad alta definizione» .
D’altra parte, nell’analisi dei rapporti Nord/Sud, la forma di sradicamento di una credenza si formula volentieri attraverso la metafora della decolonizzazione. Il termine colonizzazione, utilizzato correntemente dall’antropologia antimperialista per quanto riguarda le mentalità, si ritrova nel titolo di numerose opere. Ad esempio, Serge Gruzinski pubblica, nel 1988, La colonizzazione dell’immaginario, il cui sottotitolo evoca anche il processo di occidentalizzazione.
Con la crescita e lo sviluppo, si tratta proprio di avviare un processo di conversione delle mentalità, quindi di natura ideologica e quasi religiosa, diretto a fondare l’immaginario del progresso e dell’economia, ma la violazione dell’immaginario, per riprendere la bella espressione di Aminata Traorè, rimane simbolica. Con la colonizzazione dell’immaginario in Occidente, noi abbiamo a che fare con una invasione mentale di cui noi siamo le vittime ma anche gli agenti. Si tratta ampiamente di una autocolonizzazione, di una servitù in parte volontaria.
La decolonizzazione dell’immaginario comporta quindi all’inizio, ma non soltanto, un cambiamento della logica o del paradigma, o, ancora, una vera e propria rivoluzione culturale. Si tratta di uscire dall’economia, di cambiare i valori, e quindi, in qualche modo, di disoccidentarsi. E precisamente il programma sviluppato nel progetto sul dopo sviluppo dei «partigiani» della decrescita. Il problema dell’uscita dall’immaginario dominante o coloniale, per gli antropologi antimperialisti, come per noi, è una questione centrale, ma molto difficile, perché non si può decidere di cambiare il proprio immaginario, e ancora meno quello degli altri, soprattutto se essi sono «dipendenti» dalla droga della crescita. La cura di disintossicazione non è completamente possibile fino a quando la società della decrescita non è stata realizzata. Si dovrebbe preliminarmente essere usciti dalla società dei consumi e dal suo regime di «cretinizzazione civica», cosa che ci blocca dentro un cerchio che occorre rompere.
Denunciare l’aggressione pubblicitaria, oggi veicolo dell’ideologia, costituisce certamente il punto di partenza della controffensiva diretta a uscire da ciò che Castoriadis chiama «l’onanismo consumistico e televisivo». Il fatto che il giornale La décroissance sia edito dall’associazione Casseurs de pub , distruttori della pubblicità, non è certamente dovuto al caso poiché la pubblicità costituisce una forza essenziale nella società della crescita, e il movimento degli obiettori della crescita è largamente e naturalmente connesso con la resistenza all’aggressione pubblicitaria.
Infine, la decrescita non è l’alternativa, ma una matrice di alternative che riapre l’avventura umana a una pluralità di destini e lo spazio della creatività sollevando la cappa di piombo del totalitarismo economico. Si tratta di uscire dal paradigma dell’homo oeconomicus o dell’uomo a una dimensione di Marcuse, principale fonte dell’uniformatizzazione planetaria e del suicidio delle culture. Ne consegue che la società della a-crescita non si affermerà nello stesso modo in Europa, nell’Africa a sud del Sahara, oppure in America Latina, nel Texas e nel Chiapas, nel Senegal e nel Portogallo. Ciò che importa è favorire o ritrovare la diversità e il pluralismo. Non si può dunque proporre un modello chiavi in mano di una società della decrescita, ma solamente un abbozzo degli elementi fondamentali di qualunque società non produttivista sostenibile e degli esempi concreti di programmi di transizione.
Di sicuro, come in tutte le società umane, una società della decrescita dovrà organizzare la produzione necessaria per la sua vita e a questo scopo dovrà utilizzare in modo ragionevole le risorse offerte dal proprio ambiente e consumarle attraverso la realizzazione di beni materiali e di servizi, ma un pò come le società dell’abbondanza dell’età della pietra, descritte da Marshall Salhins, che non sono mai entrate nell’epoca dell’economia. Essa non lo farà costretta nel busto di ferro della rarità, dei bisogni, del calcolo economico e dell’homo oeconomicus. Queste basi immaginarie dell’istituzione dell’economia devono anche essere rimesse in discussione. Come aveva ben visto ai suoi tempi il sociologo Jean Baudrillard, il consumerismo genera «una pauperizzazione psicologica», uno stato di insoddisfazione generalizzato, che, egli dice, «definisce la società della crescita come il contrario di una società dell’abbondanza».
La frugalità ritrovata permette di ricostruire una società dell’abbondanza sulla base di quella che Ivan Illich definiva la «sussistenza moderna». Vale a dire »un modo di vivere in una economia post-industriale all’interno della quale le persone possono ridurre la loro dipendenza rispetto al mercato , e dove sono pervenuti proteggendo – con dei mezzi politici – una infrastruttura nella quale le tecniche e gli strumenti servono, in primo luogo, a creare dei valori d’uso non quantificati e non quantificabili dai fabbricanti professionisti di bisogni». Su questa base si è imposta l’idea che una società senza crescita che sia sostenibile, giusta e prospera non può essere che frugale.
L’abbondanza frugale quindi non è più un ossimoro ma una necessità logica. «La scelta (…), nota intelligentemente Jacques Ellul, è tra una austerità subita, ingiusta, imposta dalle circostanze sfavorevoli, e una frugalità comune, generale, volontaria e organizzata, che deriva da una scelta più di libertà e meno di consumo di beni materiali. Essa sarà legata ad un consumo diffuso di beni di base (…) una abbondanza frugale».
Se l’orizzonte di senso così definito e sintetizzato nella forma dei cerchi virtuosi delle 8R (Rivalutare, Riconcettualizzare, Ristrutturare, Ridistribuire, Rilocaliazzare, Ridurre, Riutilizzare, Riciclare) presuppone una rottura veramente rivoluzionaria, i programmi di transizione saranno necessariamente riformisti. Di conseguenza, molte delle proposte «alternative» che non rivendicano esplicitamente la decrescita possono trovare un loro spazio. La decrescita offre così un quadro generale che da un senso a numerose lotte settoriali o locali favorendo dei compromessi strategici e delle alleanze tattiche.
Uscire dall’immaginario economico implica tuttavia delle rotture molto concrete. Si tratterà di fissare delle regole che inquadrino e limitino lo scatenarsi delle avidità degli operatori (ricerca del profitto, del sempre di più): protezionismo ecologico e sociale, legislazione del lavoro, limitazioni delle dimensioni delle imprese,ecc. E in primo luogo, la «demercificazione» di quelle tre merci fittizie (nel senso di Polanyi) che sono il lavoro, la terra e la moneta.
Il loro ritiro dal mercato globalizzato segnerebbe il punto di inizio di una reincorporazione/reincastramento dell’economico nel sociale, nello stesso tempo di una lotta contro lo spirito del capitalismo. La ridefinizione della felicità come «abbondanza frugale in una società solidale» corrispondente alla rottura creata dal progetto della decrescita presuppone di uscire dal cerchio infernale della creazione illimitata dei bisogni e dei consumi e dalla frustrazione crescente che esso comporta. L’autolimitazione è la condizione per conseguire una prosperità senza crescita ed evitare in questo modo l’annientamento della civilizzazione umana.
Conclusione
I recenti dibattiti sulla significatività degli indicatori di ricchezza, hanno avuto il merito di ricordare l’inconsistenza del prodotto interno lordo, il Pil, come indice che possa permettere di misurare il benessere, mentre costituisce il simbolo feticcio indissolubilmente funzionale alla società della crescita. Non ci si è abbastanza accorti in quell’occasione che è la stessa inconsistenza ontologica dell’economia che è messa in evidenza nello stesso momento.
Criticando il Pil, sono le fondamenta stesse della fede nell’economia o dell’eonomia come religione che vengono ridotte in pezzi. L’economia come discorso presuppone il suo oggetto, la vita economica che non esiste come tale soltanto in grazia ad essa. In effetti, quale che sia la definizione di economia politica che si è scelta, quella dei classici (produzione, distribuzione, consumo) o quella dei neoclassici (allocazione ottimale delle risorse rare di uso alternativo), l’economia esiste solo a condizione di presupporre se stessa.
Il campo specifico della pratica e della teoria perseguite non può essere delimitato se la ricchezza come l’allocazione delle risorse concernono soltanto l’economia. Garry Becker è più coerente quando afferma che tutto ciò che costituisce l’oggetto di un desiderio umano fa di diritto parte dell’economia, salvo che se tutto è economico, niente lo è. In questo caso, la quantificazione totale del sociale e l’ossessione calcolatrice che egli descrive non sono che il risultato di un colpo di mano, quello della istituzione del capitalismo come mercificazione totale del mondo. È proprio contro questo progetto di trasformazione del mondo in merci che la globalizzazione ha largamente contribuito a realizzare che intende reagire il movimento della decrescita.
Traduzione per Comune-info di Alberto Castagnola.








 AService Studio
AService Studio