Internazionale
Il carcere Palestina
 «Dentro e fuori dalla cella, la Palestina è un carcere» CISGIORDANIA/GAZA. Intervista alla Relatrice speciale dell’Onu per i diritti umani nei Territori palestinesi occupati che ha presentato il suo ultimo rapporto al Palazzo di Vetro
«Dentro e fuori dalla cella, la Palestina è un carcere» CISGIORDANIA/GAZA. Intervista alla Relatrice speciale dell’Onu per i diritti umani nei Territori palestinesi occupati che ha presentato il suo ultimo rapporto al Palazzo di Vetro 
https://ilmanifesto.it/dentro-e-fuori-dalla-cella-la-palestina-e-un-carcere
——————————————————-
[Pierpaolo Loi] Questo è solo un aspetto dello stato di profonda ingiustizia che dura da più di 70 anni nei confronti del popolo palestinese. La comunità internazionale se ne lava le mani.
—————————————————————————
Che succede?

 Costituente Terra Newsletter n. 116 del 10 maggio 2023 – Chiesadituttichiesadeipoveri Newsletter n. 297 del 10 maggio 2023
Costituente Terra Newsletter n. 116 del 10 maggio 2023 – Chiesadituttichiesadeipoveri Newsletter n. 297 del 10 maggio 2023
SAGGEZZA DI UN AMBASCIATORE
Cari amici,
ci sono alcune importanti notizie da raccogliere.
Il “Corriere della Sera” dell’8 maggio, forse con qualche imbarazzo, ha pubblicato un clamoroso articolo dell’ex ambasciatore a Mosca Sergio Romano in cui si chiede lo scioglimento della NATO, oggi priva delle ragioni per cui è nata. L’articolo dell’autorevole esperto di politica internazionale dice infatti così: “L’Alleanza atlantica ha avuto una parte utile e rispettabile. Ma la Guerra fredda è finita, il comunismo è sepolto, gli Stati Uniti hanno avuto un presidente come Trump e sarebbe giunto il momento di fare a meno di un’istituzione, la Nato, che ha ormai perduto le ragioni della sua esistenza”. L’accenno a Trump sembra dire che gli Stati Uniti non sono più affidabili, Per giungere a tale conclusione l’articolo richiama l’accordo “fondatore” Nato-Russia del 27 maggio 1997 in cui era scritto che “Nato e Russia non si considerano nemiche e intendono lavorare insieme per contribuire a instaurare in Europa una sicurezza comune e globale in conformità ai principi dell’ONU” . Invece è accaduto il contrario: facendo proprie le parole dello storico Giovanni Buccianti, l’ambasciatore ricorda che “in seguito all’implosione dell’URSS (e non alla vittoria degli Usa nella Guerra Fredda) la NATO prese a svolgere una costosa campagna acquisti di tanti Paesi portandoli tutti a giocare contro la Russia e arrivando ai confini del suo territorio. Possibile che nessuno abbia ancora detto che così facendo si stava favorendo lo scoppio della Terza guerra mondiale?”. Così Sergio Romano e il “Corriere della sera”. Ma allora chi ha aggredito chi?
La Siria è stata riammessa nella Lega Araba. Ciò, insieme alla rappacificazione tra Iran e Arabia Saudita mediata dalla diplomazia cinese, sta cambiando gli equilibri mondiali. Gli Stati Uniti che perseguono altri progetti , e l’Unione Europea, “continuano ad opporsi – scrive lo stesso “Corriere della Sera” – a qualsiasi regolarizzazione dei rapporti”. L’idea sembra essere che alla guerra non si può rinunziare.
In Texas ci sono state altre due stragi, che hanno provocato in tutto 16 morti. Dall’inizio dell’anno ce ne sono state più di 200, cioè più di una al giorno, mentre nel Paese in mani private ci sono più armi (393,3 milioni) che Americani. Questi corpi del reato in mano a tutti i cittadini sono protetti dal secondo emendamento della Costituzione americana. Biden ha detto: “perché continuare con questa carneficina?”. Già, perché continuare? Il problema è che a garantire che dalla “Libera Impresa” – uno dei tre cardini del modello di società che gli Stati Uniti vogliono installare in tutto il mondo – non sia escluso il business delle armi, non c’è solo la Costituzione, ma soprattutto la cultura del Paese. Questa è ancora quella del West, del “chi spara per primo”, ma è anche la cultura che discende dal potere, e che lo stesso Biden e i governi degli Stati Uniti adottano nei rapporti col resto del mondo. È in forza di questa cultura che, riguardo al nucleare, gli Stati Uniti hanno deciso di passare alla dottrina del “first use”: la vecchia concezione basata sulla deterrenza e sulla risposta a un eventuale attacco altrui, non funziona più. Questa opzione non si può più fare, sta scritto, perché non si può lasciare che i nemici colpiscano per primi. La miglior difesa è l’offesa. Quindi è prevista, di fronte a una minaccia, l’azione preventiva.
Sono partite con una fittizia consultazione delle opposizioni le riforme costituzionali. Giorgia Meloni, benché affermi di voler instaurare un sistema che dia più stabilità ed efficienza al sistema, si dice indifferente alla scelta tra presidenzialismo e premierato elettivo, anche se c’è una grande differenza tra le due ipotesi: le basta che ci sia qualcuno eletto al comando. Ciò rivela la ragione personalissima per cui la presidente del Consiglio intraprenda con tale urgenza la via delle riforme costituzionali. Il suo governo è scaturito da un’elezione estiva, con la complicità di una cattiva legge elettorale, di un forte astensionismo e della sbadataggine dei partiti oggi all’opposizione. È molto difficile, se non impossibile, che queste condizioni abbiano a ripetersi. Volendo perpetuare il suo potere oltre gli anni di questa legislatura, l’unica strada per lei è l’elezione popolare diretta, non importa a quale delle due cariche, nell’idea che il favore degli attuali sondaggi ad personam si traducano in un voto plebiscitario a suo favore. Si tratta di un’illusione, quando il Paese, a parte l’establishment, non è affatto di destra. Né si fida di una “destra costituente”, anche per le prove che su questo versante la destra sta dando di sé.
I riformatori costituzionali, di ieri e di oggi, non capiscono che il Paese ama le sue istituzioni; il meno amato è proprio il governo. Da quando Mussolini ha detto che voleva fare della Camera un bivacco di manipoli, il Parlamento è il bene da difendere, non si può profanare. Ora, su regia del suo presidente La Russa, l’aula del Senato è stata trasformata, come scrive “Critica liberale”, in un “bivacco pop”, per far «cantare a Gianni Morandi “Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte” e altre canzonette da discoteca di paese». La Russa si è anche fatto dare dall’Archivio di Stato l’originale della Costituzione che è inserito negli atti ufficiali delle leggi della Repubblica. Tomaso Montanari se ne indigna, ma nota che una profanazione ben maggiore della Costituzione si sta preparando “con la manovra a tenaglia del presidenzialismo e dell’autonomia differenziata, due armi letali che se sommate diventano una bomba nucleare capace di annichilire la Repubblica disegnata dai costituenti”.
Nel sito pubblichiamo l’articolo dell’ambasciatore Romano e un articolo in lode dell’artigiano di Beppe Manni. Vi segnaliamo, nel sito Costituente Terra, il testo del discorso di Putin sulla Piazza Rossa nella ricorrenza del 9 maggio, che non è stato fruibile sulla stampa d’informazione. Se è un nemico, perché non sapere quello che dice? Come sostiene il papa: “ Credo che la pace si faccia sempre aprendo canali, mai si può fare una pace con la chiusura. Invito tutti ad aprire rapporti, canali di amicizia”.
Ricordiamo che si può firmare scrivendo a Ripudio della Guerra l’appello “Per un’alternativa all’impero”.
Con i più cordiali saluti,
Raniero La Valle
Chiesa di Tutti Chiesa dei Poveri
Costituente Terra
————————————
PER UN’ALTERNATIVA ALL’IMPERO
3 MAGGIO 2023 / COSTITUENTE TERRA / LA CONVERSIONE DEL PENSIERO /
Gli ultimi avvenimenti hanno aperto due visioni del mondo: un dominio universale o una pace nelle differenze. Un appello
La guerra in Ucraina è giunta ormai ad essere una guerra suicida: il Regno Unito combatte contro se stesso e la propria stessa immagine annunciando apertamente l’invio di proiettili anticarro ad uranio impoverito, l’Ucraina vuole riconquistare il Donbass grazie a queste armi con componenti nucleari capaci di contaminare l’ambiente per migliaia di anni e di intossicare chi lo inala o chi lo ingerisce: “si sospetta – spiega il pur simpatizzante Corriere della Sera – che arrivi a modificare il DNA, causando linfomi, leucemie e malformazioni dei feti”, tutto ciò a danno delle stesse popolazioni di cui si rivendica l’appartenenza all’Ucraina; la Russia sfida l’esecrazione universale minacciando per tutta risposta di schierare atomiche tattiche in Bielorussia.
A sua volta, dopo una debole tergiversazione, e con la spinta determinante del presidente Biden, il cancelliere tedesco Sholz ha dato il via libera alla distribuzione di carri armati tedeschi a tutti i fornitori di armamenti a Zelenski che insistentemente li chiede. In tal modo settant’anni dopo l’”Operazione Barbarossa” vediamo di nuovo i Panzer tedeschi avanzare nella pianura d’Ucraina per sconfiggere la Russia non più sovietica.
Questa volta però la regia è americana, gli attori ucraini, mentre ogni negoziato è escluso per legge dallo stesso Zelensky.
È difficile ignorare l’impatto emotivo di questa svolta. Si può avere la memoria corta e il cuore indurito, ma nelle viscere della terra corre un sussulto dinanzi al ritorno dei carri tedeschi proiettati a combattere contro i russi nel cuore dell’Europa, quando quell’evento fu al centro della seconda guerra mondiale e ne precedette di poco l’esito con la tragedia della bomba atomica, l’ingresso dell’umanità tutta nell’età del nucleare genocida, l’adozione di un rapporto internazionale postbellico temerariamente fondato sulla “reciproca distruzione assicurata”, fino alle attuali strategie di guerre preventive e di minacciato ricorso all’arma assoluta.
In tal modo va in scena il sempre esorcizzato e incombente conflitto tra la NATO e la Russia in Europa. E dopo? Potrà ancora sussistere l’ONU, quando gli alleati di ieri, diventati i nemici di oggi, dovrebbero stare insieme come Membri Permanenti del Consiglio di Sicurezza per salvaguardare la pace e la sicurezza del mondo, e invece sono intenti a distruggerle? Non a caso l’Ucraina contesta già oggi la presidenza russa pro-tempore del Consiglio di Sicurezza. E siamo sicuri che questa volta, per non scomparire, la Russia invece di versare nell’olocausto 26 milioni e 600.000 morti, non sarà indotta alla scelta disperata di difendersi col “primo uso” dell’arma nucleare?
E tutto ciò accade quando il mondo ha distolto lo sguardo dalla vera priorità, che è salvare la Terra dal disastro ecologico, e anzi va allo scontro proprio sul gas, l’energia. I beni vitali e la reciproca deterrenza nucleare.
È chiaro che la priorità è cercare le vie d’uscita dalla crisi in Ucraina. Se ne sarebbe potuto trovare la soluzione, se non fosse stata sacrificata a interessi estranei all’Europa, fino al 24 febbraio 2022, quando l’assalto militare russo ha gettato tutto nella fornace dello scontro armato; e forse all’inizio un negoziato sarebbe stato risolutivo. E ora ci sono di mezzo centinaia di migliaia di caduti, orfani, vedove, città distrutte, odi implacabili e l’accecamento, nella perdita di ogni verità, della maggior parte dei protagonisti, degli ispiratori, osservatori e narratori del conflitto. Però non possiamo non dire che giunti a questo livello di rischio, i protagonisti palesi od occulti della guerra la devono immediatamente fermare, anche contro ogni irredentismo territoriale: il negoziato è necessario e possibile, la ragione e il cuore hanno sempre la possibilità di risorgere.
Quale visione del mondo?
Qui però vogliamo interrogarci soprattutto sulle due visioni del mondo che gli ultimi avvenimenti hanno aperto davanti a noi, e che ci pongono davanti a scelte da cui dipende un lungo futuro, e forse la possibilità stessa di un futuro. Non si tratta infatti di dettagli, ma di un crinale a cui siamo giunti, da cui si potrebbe cadere in un precipizio senza rimedio, quel crinale che il vecchio La Pira, negli anni più paurosi della guerra fredda, chiamava il “crinale apocalittico della storia”, intendendo col termine “apocalittico” non la fine stessa della storia, ma lo svelamento dell’alternativa radicale cui essa era pervenuta mettendo la guerra come principio e signore di tutte le cose, e nello stesso tempo invitava i sindaci delle città opposte a Firenze.
Qual è la nostra visione del mondo, stando noi su questo crinale?
La visione del mondo che ci viene proposta con grande insistenza, e che ci viene attribuita come connaturale alla nostra civiltà e alla nostra storia, è la visione del mondo propria dell’Occidente, anzi dell’“Occidente allargato”, che ha oggi il suo centro in America, la sua potenza militare negli Stati Uniti e nella Nato, la vocazione a estendersi fino agli estremi confini della terra.
È in nome dei suoi valori che siamo chiamati alle armi, per “mettere il nostro mondo saldamente sulla strada di un domani più luminoso e pieno di speranza”, come promette oggi il presidente Biden nell’illustrare la “Strategia della sicurezza nazionale degli Stati Uniti”.
Di fronte a noi abbiamo però, gravemente inquietanti, due documenti fondativi che propugnano e illustrano questa visione del mondo e la assumono come normativa. Si tratta dei due documenti programmatici in cui, in piena guerra d’Ucraina, il 12 e 27 ottobre 2022, la leadership americana ha enunciato le due strategie fondamentali degli Stati Uniti: il primo è per l’appunto la “National Security Strategy” (october 2022 – The White House Washington) del Presidente Biden (in sigla NSS), il secondo ne è la pianificazione operativa sul piano militare, ed è la “National Defense Strategy of The United States of America 2022” (in sigla NDS) del capo del Pentagono Lloyd Austin, corredata da un dettagliato aggiornamento della “postura” o visione nucleare americana. Questa visione o “postura” ribadisce la decisione di non adottare la politica del “Non Primo Uso” dell’arma nucleare perché essa “comporterebbe un livello di rischio inaccettabile alla luce della gamma di capacità anche non-nucleari degli avversari che potrebbero infliggere danni di natura strategica agli Stati Uniti e ai loro alleati e partners”. È la conferma di quanto era già stato deciso dopo l’attacco alle Torri gemelle: la vecchia concezione basata sulla deterrenza e sulla risposta a un eventuale attacco altrui, non funziona più. Questa opzione non si può più fare perché non si può lasciare che i nemici colpiscano per primi. La miglior difesa è l’offesa. Quindi è prevista, di fronte a una minaccia, l’azione preventiva; la nuova strategia è di ricorrere se necessario per primi all’arma nucleare. scudo al cui riparo si possono condurre senza rischi per gli Stati Uniti le guerre convenzionali necessarie. E questa nuova dottrina, adottata ormai anche dalla Russia, fa sì che dietro questo scudo si pensa che si possnoa combattere tutte le guerre convenzionali, come si è sempre fatto in tutto il corso della storia.
Due documenti programmatici
Per quanto strettamente americani, questi due documenti, di fatto ignorati in Occidente, riguardano tutti, perchè investono non solo l’una o l’altra regione del globo, ma il destino del mondo come tale. E ciò è dimostrato dal fatto che di questo mondo gli Stati Uniti rivendicano globalmente la leadership, che vi installano le loro basi militari da per tutto, e che intendono disporne con l’affermazione che “non c’è nulla che vada oltre le nostre capacità: possiamo farcela, per il nostro futuro e per il mondo”; la posta in gioco sarebbe “di rispondere alle sfide comuni e affrontare le questioni che hanno un impatto diretto sulla vita di miliardi di persone. Se i genitori non possono nutrire i propri figli – specifica Biden – nient’altro conta. Quando i Paesi sono ripetutamente devastati da disastri climatici, interi futuri vengono spazzati via. E come tutti abbiamo sperimentato, quando le malattie pandemiche proliferano e si diffondono, possono aggravare le disuguaglianze e portare il mondo intero al collasso”. Sarebbe questa la preoccupazione degli Stati Uniti, la giusta ragione del loro intervento ma anche il motivo per cui il raggio d’azione entro cui la loro impresa, politica e militare, si deve esercitare è senza limiti territoriali: “Abbiamo approfondito le nostre alleanze principali in Europa e nell’Indo-Pacifico. La NATO è più forte e unita che mai, stiamo facendo di più per collegare i nostri partner e le nostre strategie nelle varie regioni attraverso iniziative come il nostro partenariato di sicurezza con l’Australia e il Regno Unito (AUKUS). E stiamo forgiando nuovi modi creativi per lavorare in comune con i partner su questioni di interesse condiviso, come con l’Unione Europea, il Quadrilatero Indo-Pacifico, il Quadro economico Indo-Pacifico e il Partenariato per la prosperità economica delle Americhe”; e da lì lo sguardo si spinge fino all’Artico.
Si postula dunque un unico potere che si protende alla totalità del mondo, nella presunzione che questo debba avere un unico ordinamento politico, economico e sociale, corrispondere a un unico modello di convivenza umana; e questo è un presupposto che da tempo gli Stati Uniti avevano posto a base della loro relazione col mondo, da quando, dopo l’11 settembre 2001 e lo shock dell’attacco alle Due Torri, avevano enunciato l’ideologia a cui doveva essere conformato l’assetto del mondo, perché questo corrispondesse agli interessi e alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti d’America. Secondo quella ideologia il solo modello valido per ogni nazione sarebbe riassumibile in tre termini: Libertà, Democrazia e Libera Impresa; dunque un modello che mette insieme una definizione antropologica, una indicazione di regime politico ed una forma obbligatoria di organizzazione economico-sociale, e questo composto era dichiarato come normativo per tutti, sulla scia del “progetto”, pubblicato nell’ottobre del 2000, del “nuovo secolo americano”. Dunque non venivano contemplati tanti possibili regimi politici, economici e sociali, corrispondenti eventualmente a diverse teorie. Ce ne sarebbe uno solo che comporta un modello umano, quello dell’individualismo liberale, un modello politico, quello della democrazia occidentale, ed un modello economico, quello del capitalismo d’impresa. Altri modelli non sono ammessi e compito degli Stati Uniti sarebbe di diffondere questo modello in tutto il mondo.
Si potrebbe dire, fin qui, che non possiamo fare obiezioni: ognuno può avere la propria visione del mondo e auspicare e operare perché si realizzi.
Una chiamata alle armi anche per noi
Il problema è però che gli Stati Uniti vogliono fare tutto questo non per conto loro, ma coinvolgendo “l’impareggiabile rete di alleanze e partnership dell’America”. Questi partners nello stabilire l’ordine del mondo sono chiamati in causa 167 volte nei due documenti del presidente Biden e del Pentagono e attraverso la NATO in questa chiamata alle armi siamo coinvolti anche noi.
Dunque la cosa ci riguarda; e da partners e alleati, e non da sudditi o “vassalli”, come ha detto Macron, dobbiamo decidere se questa è la visione del mondo che abbiamo anche noi, se questo è il mondo che vogliamo costruire e qual è la nostra idea dello “stato del mondo” in cui ci troviamo ad operare.
La supremazia americana
La premessa da cui parte Biden e su cui tutta la strategia americana è fondata, “la nostra visione nel tempo”, come egli la definisce, è che “l’era post-Guerra Fredda è definitivamente finita”. Sarebbe una buona notizia se annunziasse la fine della guerra come tale. Purtroppo invece non è così: essa sancisce solo la fine della sua modalità come “guerra fredda”, cioè come una guerra sempre minacciata e mai combattuta, con armi sempre pronte all’uso ma accumulate e tenute ferme negli arsenali. Paradossalmente invece quella che ne deriva è una guerra liberata, non più trattenuta dai rischi di uno scontro nucleare, tornata ad essere libera all’esercizio, come non lo era stata all’epoca della competizione tra I blocchi, fino alla rimozione del muro di Berlino, e poi subito era stata recuperata come necessaria, buona e giusta e persino umanitaria con la prima guerra del Golfo, già nel 1991.
La seconda premessa è che liberato dai vincoli della guerra fredda, l’ovvio modo degli Stati, anzi delle maggiori Potenze, di relazionarsi tra loro, debba essere e sia quello di “una competizione strategica per plasmare il futuro dell’ordine internazionale” e, per gli Stati Uniti, quello di “far avanzare gli interessi vitali dell’America, posizionare gli Stati Uniti per superare i concorrenti geopolitici, affrontare le sfide comuni. Non lasceremo il nostro futuro vulnerabile ai capricci di chi non condivide la nostra visione di un mondo libero, aperto, prospero e sicuro”, dice Biden. Dovranno essere pertanto gli Stati Uniti a vincere in questa competizione: “Essi guideranno con i nostri valori”, “nessuna nazione è meglio posizionata degli Stati Uniti per avere successo”, naturalmente col corteo dei loro seguaci, di “tutti coloro che condividono i nostri interessi”: dunque si parte vincenti e lo spazio di tempo in cui ciò deve avvenire è “il prossimo decennio”, che il documento programmatico del presidente Biden definisce come “decisivo” e che poi nella programmazione della Difesa di Lloyd Austin si estende a comprendere “due decenni” destinati peraltro a prolungarsi nei decenni successivi. Dunque è un testo sul futuro del mondo.
La sfida culminante: la Cina
Questo è il mondo come è visto nel tempo, ma come è visto nello spazio, come viene proposto al nostro sguardo (e alle nostre decisioni) di oggi? Esso è un mondo di cui una parte (peraltro minore) si identifica con la democrazia, ed è contro l’altra, quella delle autocrazie, considerate costitutivamente minacciose e aggressive.
Nel documento del ministro della Difesa Lloyd Austin, esso è considerato come “l’ambito di sicurezza” in cui deve operare l’insieme delle Forze Armate americane (Joint Force), ovvero è il mondo come gli Stati Uniti se lo immaginano e vogliono che sia. È un mondo diviso tra quattro grandi soggetti considerati come contrapposti e in lotta fra loro: 1) Gli Stati Uniti e i loro alleati e partners; 2); la Cina; 3) la Russia, la Corea del Nord e le organizzazioni violente e estremiste, cioè il terrorismo; 4) la “zona grigia” che non è integrata in nessuno dei tre campi suddetti. L’Europa è aggregata al primo mondo, attraverso la NATO.
E subito, sia nel documento della Casa Bianca, sia in quello del Pentagono, vengono designati I due “competitori strategici”, quelli con cui dovrebbe disputarsi il dominio del mondo: e il maggiore non è, a sorpresa, il nemico tradizionale degli Stati Uniti, l’altra grande Potenza della seconda Guerra mondiale, la Russia, i cui “limiti strategici – sostiene Biden – sono stati messi in luce dopo la sua guerra di aggressione contro l’Ucraina”; ora il vero nemico è la Cina. “La Russia – dice Biden – rappresenta una minaccia immediata e continua all’ordine di sicurezza regionale in Europa ed è una fonte di disturbo e instabilità a livello globale, ma non ha le capacità trasversali della Repubblica Popolare Cinese”.
Pertanto è la Cina a rappresentare la “sfida culminante” (pacing challenge) nel prossimo decennio e nei decenni successivi, a causa della sua intenzione e capacità di “rimodellare l’ordine internazionale a favore di un ordine che inclini il campo di gioco globale a suo vantaggio”. È questa la ragione per cui il piano di pace presentato da Xi Jinping per l’Ucraina, non è stato preso in considerazione.
È singolare che mentre per la Russia Biden abbia buon gioco nell’attribuirle “una minaccia immediata al sistema internazionale libero e aperto come ha dimostrato la sua brutale guerra di aggressione contro l’Ucraina”, ragione per cui essa doveva essere ridotta per punizione alla condizione di “paria” (che nel sistema indiano delle caste significa essere gettati fuori dall’umanità e dalla storia) per la Cina non c’è alcuna motivazione che sia addotta per doverla combattere, se non il fatto che essa sarebbe “l’unico concorrente che ha l’intenzione di rimodellare l’ordine internazionale e, sempre più spesso, ha il potere economico, diplomatico, militare e tecnologico per perseguire tale obiettivo”.
Sulla scia di questa “damnatio” pronunciata da Biden, pochi giorni dopo, il 27 ottobre, il documento operativo sulla “Strategia della Difesa Nazionale degli Stati Uniti” pubblicato dal Segretario alla Difesa Lloyd Austin, illustrava in che modo l’immenso potenziale americano sarebbe stato predisposto a sostenere con la deterrenza questa sfida con la Repubblica Popolare Cinese e a “scoraggiare l’aggressione”; esso sosteneva bensì che il conflitto con la Cina non è “né inevitabile né auspicabile” ma anche che gli Stati Uniti sono pronti, se la deterrenza fallisce, “a prevalere nel conflitto”, come del resto in ogni altro conflitto che si trovino a combattere.
Che succede in Israele e Palestina? La situazione volge al peggio. Tuttavia s’intravede qualche segnale positivo.
 Israele e Palestina
Israele e Palestina di Franco Meloni
«Per il popolo palestinese non c’è fine al dolore, all’oppressione, al sacrificio, alla negazione della libertà e dell’indipendenza, ma solo muri, divieti, repressione e segregazione che dura dal 1967. #FreePalestine». Non sono certo un fan di Beppe Grillo e neppure appartengo al Movimento 5 Stelle da lui fondato, ma devo dire che condivido totalmente questo tweet da lui scritto il 7 aprile scorso e riportato sul suo blog, a commento di un articolo, che pure ho apprezzato, scritto da Torquato Cardilli, dal titolo “Sacrilegio e orrore in Terrasanta”, sugli episodi di violenza perpetuati dalla polizia e dall’esercito israeliano nei confronti di fedeli musulmani che pregavano nella “spianata delle moschee”.
Il tweet è stato pubblicato poche ore prima dell’attentato terroristico di Tel Aviv in cui ha perso la vita il giovane avvocato italiano Alessandro Parini. Fino a quel momento i commenti al tweet di Grillo erano stati del tutto positivi, a sostegno della causa palestinese. Dopo hanno prevalso commenti di dileggio e insulto nei confronti di Grillo.
Noi non abbiamo avuto nessuna esitazione a condannare duramente l’atto di terrorismo che ha ucciso Alessandro Parini, sempre che di questo si sia trattato (come nella versione delle autorità israeliane). Ma questo esecrabile episodio, come pure i lanci dei razzi da Gaza, non cancellano le pesanti responsabilità del Governo israeliano che alimenta un clima di violenza, prima causa degli episodi di terrorismo destinati a ripetersi, come prevede la gran parte dei commentatori politici internazionali.
————————-
In questo quadro di disperazione, spunta tuttavia qualche segno positivo, a cui vogliamo aggrapparci. Ci riferiamo alla notizia del calo di consensi del capo del governo israeliano Netanyahu e, ancor più al
Sondaggio Gallup a favore dei palestinesi – La prima volta nella storia!
Un blog di un movimento internazionale pro Palestina ci informa che ai primi di marzo, Gallup, una delle più grandi organizzazioni di sondaggi di opinione pubblica al mondo, ha reso noto un’indagine sulle “simpatie in Medio Oriente”, secondo cui il 49% dei democratici statunitensi ha espresso le proprie simpatie per i palestinesi, a fronte dell’oltre 38% per gli israeliani [la prima volta nella storia del sondaggio con un risultato a favore dei palestinesi]: “Guardando a tutti gli adulti statunitensi, indipendentemente dall’affiliazione partitica, il divario tra la preferenza verso Israele e la Palestina è il più stretto da quando sono iniziati i sondaggi sulla questione”. Al sondaggio Gallup nello stesso periodo se n’ è aggiunto un altro del Pew Research Center che ha mostrato che “più americani condividevano opinioni favorevoli che sfavorevoli sugli ebrei”. Come ha sottolineato lo scrittore e analista politico palestinese-americano Yousef Munayyer in un recente Tweet.
Scorrendo i dati degli ultimi dieci anni, Munayyer ci avverte che gli atteggiamenti democratici nei confronti degli ebrei sono rimasti relativamente fermi, mentre le loro simpatie per i palestinesi sono aumentate. Questi due sondaggi (Gallup e Pew) presi insieme sono significativi perché offrono prove concrete che “simpatizzare con la situazione palestinese sotto l’oppressione delle sistematiche violazioni dei diritti umani da parte di Israele non dovrebbe avere nulla a che fare con l’atteggiamento della gente nei confronti degli ebrei o di qualsiasi gruppo”.
Secondo il citato movimento pro Palestina, questo significa che “il mondo sta prendendo coscienza del fatto che il sostegno ai palestinesi e le critiche a Israele non hanno nulla a che fare con il proprio atteggiamento nei confronti del popolo ebraico”. Si dirà: si tratta di un sondaggio che riguarda solo gli USA. Ma tutti sappiamo quanto contano gli USA per Israele, se solo pensiamo al flusso di aiuti americani che beneficiano Israele e che potrebbero rischiare un ridimensionamento!
Cogliamo allora questi segnali positivamente, enfatizzandoli, perché vanno nella direzione giusta, da noi auspicata in sintonia con i movimenti pacifisti e di impegno sociale di cui parlava anche il patriarca latino di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa, in uno dei suoi illuminanti interventi che tra i tanti abbiamo ripreso nella nostra News.
Torneremo sulla questione, per opportuni approfondimenti, come nei nostri programmi.
—————-
- Nella foto in testa l’ingresso al campo profughi Aida di Betlemme (dicembre 2022).
——————————


Il direttore di Rocca, Mariano Borgognoni, nell’editoriale dell’ultimo numero di Rocca preannuncia, a partire dal prossimo numero, un approfondimento della questione israelo-palestinese, anticipando questo impegno con la copertina della rivista: “Abbiamo voluto dedicare la copertina a quella grande parte del popolo israeliano che, con una mobilitazione senza eguali nella storia di quel Paese, ha per ora bloccato la riforma di Netanyahu, volta ad azzerare i poteri della Corte Suprema (il Parlamento, oltre a scegliere i giudici, potrebbe annullare le decisioni della Corte). La partita tuttavia rimane drammaticamente aperta. (…) approfondiremo la questione con l’attenzione che merita per l’importanza che, da diversi punti di vista, rivestono quel Paese e quella tormentata area del mondo”. In piena sintonia con gli amici di Rocca e della Pro Civitate Christiana di Assisi, ai quali ci legano consolidati rapporti di amicizia e collaborazione, vogliamo con Aladinpensiero unirci a tale programma, sia “rimbalzando” gli articoli che Rocca proporrà, sia proponendone altri di carattere documentale, di analisi e opinioni. In questo contesto siamo anche impegnati a segnalare e sostenere le iniziative della Caritas diocesana di Cagliari che al termine di un Pellegrinaggio in Terrasanta, tenutosi tra la fine dello scorso dicembre e l’inizio del nuovo anno, ha deciso di partecipare a programmi di solidarietà con il popolo palestinese, proposti dalla Caritas di Gerusalemme, rivolti soprattutto ai giovani palestinesi e alle persone di quelle zone in situazione di particolare disagio. Non solo quindi documentazione, dibattito e confronto di idee ma anche concreta operatività, per quanto possiamo fare.
————————-
Cominciamo questa attività con la segnalazione di un importante documento, un dossier su “Apartheid in Israele – Appello urgente alle Chiese di tutto il mondo” redatto da Kairos Palestina e Global Kairos for Justice – 2022 e così firmato:

e, di seguito, alcuni articoli di Avvenire che danno conto di importanti iniziative di solidarietà in Palestina.
————————————–

APPELLO URGENTE
ALLE CHIESE
DI TUTTO IL MONDO
UN DOSSIER SU APARTHEID IN ISRAELE Per scaricare il testo pdf dell’Appello: https://smips.org/2023/03/24/appello-urgentealle-chiesedi-tutto-il-mondo/
———————————————–

———————————————–
 Solidarietà. Caritas-Focsiv insieme in Terra Santa per ripartire dai giovani
Solidarietà. Caritas-Focsiv insieme in Terra Santa per ripartire dai giovani
Luca Geronico, inviato a Gerusalemme e Betlemme sabato 1 aprile 2023
L’accesso per tutti all’istruzione, in Cisgiordania come in Israele, è la chiave dei progetti che si sviluppano intono alle nuove generazioni. «Quello che hanno smarrito è la speranza»
———————————————–
L’iniziativa. Betlemme: pane, amore e sviluppo
Luca Geronico, inviato a Betlemme martedì 4 aprile 2023
Il forno dei salesiani da più di un secolo è punto di riferimento nella città. Le Ong: «Un’impresa sociale da seguire» Martedì 4 aprile su Tv2000 e Radio InBlu la maratona di solidarietà «Insieme per gli ultimi»
—————————————-
![]() Democrazia fragile in Israele. Speranza nei giovani
Democrazia fragile in Israele. Speranza nei giovani
3 Aprile 2023 by Fabio | su C3dem.
La democrazia in Israele è fragile, i giovani la salveranno:
Francesca Caferri, In piazza con Grossman “La democrazia è fragile i giovani la salveranno” (la Repubblica).
- David Grossman.
————————————
Un sabato santo pieno di tensioni. Colloquio con il patriarca latino di Gerusalemme mons. Pierbattista Pizzaballa. Su formiche.net:
https://formiche.net/2023/04/conflitto-medio-oriente-patriarca-latino-gerusalemme/
———————————-
———Eventi segnalati————————-
———————————-
 Evento venerdì 21 aprile 2023.
Evento venerdì 21 aprile 2023.
L’incontro, dal titolo “Laicità e laicismo: una questione aperta”, si terrà venerdì 21 aprile 2023, alle ore 17.30, nell’Aula magna della Facoltà Teologica della Sardegna. Dopo i saluti del Preside della Facoltà, Mario Farci, interverrà Luca Diotallevi, docente ordinario di Sociologia all’Università Roma Tre. Modererà il giornalista Franco Siddi. L’evento è organizzato dalla Facoltà Teologica della Sardegna e dall’Associazione Suor Giuseppina Nicoli, con la collaborazione degli Amici del Cammino sinodale.
———-
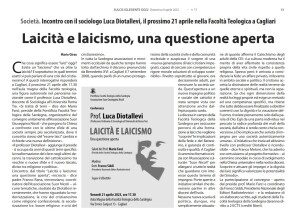
———————13 aprile 2023—
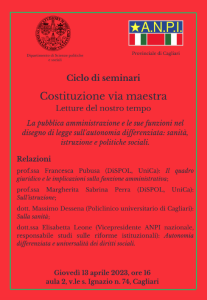
————————–
—————————————————————
Israele e Palestina


Il direttore di Rocca, Mariano Borgognoni, nell’editoriale dell’ultimo numero di Rocca preannuncia, a partire dal prossimo numero, un approfondimento della questione israelo-palestinese, anticipando questo impegno con la copertina della rivista: “Abbiamo voluto dedicare la copertina a quella grande parte del popolo israeliano che, con una mobilitazione senza eguali nella storia di quel Paese, ha per ora bloccato la riforma di Netanyahu, volta ad azzerare i poteri della Corte Suprema (il Parlamento, oltre a scegliere i giudici, potrebbe annullare le decisioni della Corte). La partita tuttavia rimane drammaticamente aperta. (…) approfondiremo la questione con l’attenzione che merita per l’importanza che, da diversi punti di vista, rivestono quel Paese e quella tormentata area del mondo”. In piena sintonia con gli amici di Rocca e della Pro Civitate Christiana di Assisi, ai quali ci leganoo consolidati rapporti di amicizia e collaborazione, vogliamo con Aladinpensiero unirci a tale programma, sia “rimbalzando” gli articoli che Rocca proporrà, sia proponendone altri di carattere documentale, di analisi e opinioni. In questo contesto siamo anche impegnati a segnalare e sostenere le iniziative della Caritas diocesana di Cagliari che al termine di un Pellegrinaggio in Terrasanta, tenutosi tra la fine dello scorso dicembre e l’inizio del nuovo anno, ha deciso di partecipare a programmi di solidarietà con il popolo palestinese, proposti dalla Caritas di Gerusalemme, rivolti soprattutto ai giovani palestinesi e alle persone di quelle zone in situazione di particolare disagio. Non solo quindi documentazione, dibattito e confronto di idee ma anche concreta operatività, per quanto possiamo fare.
————————-
Cominciamo questa attività con la segnalazione di un importante documento, un dossier su “Apartheid in Israele – Appello urgente alle Chiese di tutto il mondo” redatto da Kairos Palestina e Global Kairos for Justice – 2022 e così firmato:

e, di seguito, alcuni articoli di Avvenire che danno conto di importanti iniziative di solidarietà in Palestina.
————————————–

APPELLO URGENTE
ALLE CHIESE
DI TUTTO IL MONDO
UN DOSSIER SU APARTHEID IN ISRAELE Per scaricare il testo pdf dell’Appello: https://smips.org/2023/03/24/appello-urgentealle-chiesedi-tutto-il-mondo/
———————————————–

———————————————–
 Solidarietà. Caritas-Focsiv insieme in Terra Santa per ripartire dai giovani
Solidarietà. Caritas-Focsiv insieme in Terra Santa per ripartire dai giovani
Luca Geronico, inviato a Gerusalemme e Betlemme sabato 1 aprile 2023
L’accesso per tutti all’istruzione, in Cisgiordania come in Israele, è la chiave dei progetti che si sviluppano intono alle nuove generazioni. «Quello che hanno smarrito è la speranza»
———————————————–
L’iniziativa. Betlemme: pane, amore e sviluppo
Luca Geronico, inviato a Betlemme martedì 4 aprile 2023
Il forno dei salesiani da più di un secolo è punto di riferimento nella città. Le Ong: «Un’impresa sociale da seguire» Martedì 4 aprile su Tv2000 e Radio InBlu la maratona di solidarietà «Insieme per gli ultimi»
—————————————-
![]() Democrazia fragile in Israele. Speranza nei giovani
Democrazia fragile in Israele. Speranza nei giovani
3 Aprile 2023 by Fabio | su C3dem.
La democrazia in Israele è fragile, i giovani la salveranno:
Francesca Caferri, In piazza con Grossman “La democrazia è fragile i giovani la salveranno” (la Repubblica).
- David Grossman.
———————————————

———————————-
———Eventi segnalati————————-
———————————-
 Evento venerdì 21 aprile 2023.
Evento venerdì 21 aprile 2023.
L’incontro, dal titolo “Laicità e laicismo: una questione aperta”, si terrà venerdì 21 aprile 2023, alle ore 17.30, nell’Aula magna della Facoltà Teologica della Sardegna. Dopo i saluti del Preside della Facoltà, Mario Farci, interverrà Luca Diotallevi, docente ordinario di Sociologia all’Università Roma Tre. Modererà il giornalista Franco Siddi. L’evento è organizzato dalla Facoltà Teologica della Sardegna e dall’Associazione Suor Giuseppina Nicoli, con la collaborazione degli Amici del Cammino sinodale.
——————————————————————

La Pace è possibile? Incontro dibattito a Iglesias con Marco Tarquinio
America, America

DONALD TRUMP E IL CAOS
di Marino de Medici*
La carta che Donald Trump ha deciso di giocare per impedire la vittoria democratica a Novembre è una sola: il caos. E’ ormai chiaro infatti che l’intento del presidente repubblicano è di rendere impossibile una pacifica transizione del potere, generando un’incontrollabile agitazione civile e per l’appunto il caos politico, qualora dovesse perdere le elezioni. In tal caso, vale il suo grido di battaglia: “facciamola finita con la democrazia!”. Il preludio della guerra di Trump contro le istituzioni democratiche è ormai strettamente associato al costante messaggio che egli emana: “le elezioni sono una frode”. Lo va ripetendo con crescente intensità. Il messaggio più recente giunge a questo estremo: “In conseguenza delle schede inviate per posta, l’elezione del 2020 sarà la più truccata nella storia della nazione – a meno che non venga arrestato
un corso così stupido. Abbiamo votato durante la prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale senza problema, ma ora stanno servendosi del Covid al fine di truffare con il voto postale”. Senza il minimo ritegno, il presidente si è spinto fino a sostenere che le schede per il voto postale “già vengono stampate in Paesi stranieri”.
Più chiaro di così il presidente non potrebbe essere: se non dovesse vincere, sarà una frode, perpretata con il voto postale.
I fatti dimostrano che il voto postale non è un’invenzione recente dei democratici ma un metodo di voto che gli stessi repubblicani hanno usato in precedenti elezioni con risultati a loro favorevoli in certi casi. L’accanimento di Trump contro il voto postale è legato ad un altro fatto, che entrambi i partiti hanno investito ingenti risorse
nello sforzo diretto a far votare per posta il maggior numero possibile di cittadini per una giustificabile salvaguardia contro il flagello della pandemia. La strategia di Trump è un’altra: quella di preparare il terreno ad una serie di denunce e ricorsi alla magistratura come base del suo rifiuto di accettare una sconfitta elettorale.
Trump spera in uno o più eventi in cui il conteggio a lui favorevole dei suffragi espressi alle urne dovesse essere rovesciato al termine dello spoglio dei voti pervenuti per posta.
Si può purtroppo immaginare un film dell’orrore, quello di un’interminabile notte elettorale in cui i cittadini americani apprendono dalla televisione l’esito della consultazione in uno stato per poi essere trascinati nel dubbio dalla rimonta dei voti postali.
La democrazia impone che il conteggio dei voti sia scrupoloso ma anche che sia rapido.
E’ un fatto comunque che in diverse occasioni le autorità elettorali hanno dovuto sospendere l’annuncio dei risultati in attesa che venissero conteggiati i voti espressi per corrispondenza. In pratica, la democrazia ammette la possibilità di un ritardo nell’annuncio dell’esito elettorale ma è prevedibile che Trump sfrutterà il ritardo come prova di una frode, o addirittura di una congiura in atto. Il caos è l’obiettivo del presidente nel caso in cui gli exit polls dovessero segnalare la vittoria di Joe Biden.
Un altro aspetto strumentale della strategia del caos è quello della “suppression” del voto democratico, attraverso una serie di maligni artifizi che vanno dalle “purghe” dei registri elettorali all’imposizione di condizioni perverse come quelle degli stati
repubblicani che obbligano l’elettore a presentare un documento di identità con fotografia, approvato dall’autorita’ del luogo. Questi ed altri impedimenti alla democrazia rappresentativa non salveranno la presidenza Trump ma dovranno fornire lo spunto alla prossima aministrazione ed al Congresso per regolamentare un processo elettorale moderno ma tale da assicurare il pieno esercizio del diritto di voto per classi come quelle degli afro-americani e di gente di colore che da tempo immemorabile si sono trovate escluse in forza di norme come l’odiosa “poll tax” negli stati del sud o i documenti con foto e la prova di residenza dei giorni nostri.
In una panorama catastrofico come quello del mancato riconoscimento della potenza distruttiva del coronavirus prima e della sciagurata riapertura dopo (basti segnalare che i casi di infezione sono aumentati in misura pari a quelli registrati a Marzo), la sensazione dominante in una massa di americani è che l’America ha perso completamente il ruolo di leader mondiale. Non solo gli Stati Uniti hanno fallito nel compito di portare sotto controllo la pandemia al momento del suo insorgere, ma dopo aver registrato una crisi di pubblica sanità incomprensibile in un Paese scientificamente avanzato, hanno ripetuto ed aggravato il fallimento delle misure sanitarie. Il “genio stabile” che Trump si è pubblicamente vantato di essere ha ignorato le raccomandazioni degli esperti, pur avendo accesso a straordinarie risorse mediche e finanziarie, tali da far fronte alla pandemia. Il coronavirus che ha prostrato l’America non è il prodotto di una congiura democratica per cacciare Trump dalla Casa Bianca ma della sua assoluta incompetenza e del rifiuto della scienza.
L’ultima definitiva prova della insensibilità di Donald Trump dinanzi alla scandalosa deficienza della “public health” negli Stati Uniti è fornita dal ricorso della sua amministrazione alla Corte Suprema con la richiesta di annullamento della legge sanitaria conosciuta come Obamacare, che un giudice trumpista del Texas ha definito “anti-costituzionale”. La perdita dei benefici di Obamacare colpirebbe non meno di 23 milioni di americani che hanno perso il lavoro, e quindi la copertura assicurativa. In termini umani, la crociata anti-Obama
– una perdurante ossessione del presidente – nel bel mezzo di una pandemia che finora ha ucciso 130.000 americani – è “un atto di impenetrabile crudeltà”, come l’ha definito lo Speaker della Camera Nancy Pelosi. Ma il vero scandalo, che presumibilmente i democratici sfrutteranno a fondo nelle battute finali del dibattito elettorale, è l’ipocrisia di Trump nell’assicurare che Obamacare sarà rimpiazzata da “un’alternativa altamente migliore e molto meno costosa”. Di fatto, in tre anni di governo, l’Amministrazione Trump non ha introdotto ne’ proposto una simile “alternativa”. Nel quadro elettorale, torneranno certamente a farsi sentire le preoccupazioni per l’assistenza sanitaria di gran parte dell’elettorato che contribuirono in misura sostanziale alla vittoria dei democratici nelle elezioni per la Camera del 2018.
Molto lascia pensare che la contesa elettorale verrà decisa dal danno economico che l’America ha patito e continua a patire in conseguenza della pessima gestione sanitaria e dell’incapacità del presidente di dare fiducia ad una nazione sconvolta da una crisi mostruosa. Per tutta risposta, il presidente repubblicano ha tagliato i fondi per il “testing” ed ha propagato accuse di “complotti” che rispondono alla sua strategia di “guerra culturale” volta a dividere gli americani e a promuovere il “culto” di Donald Trump. Se verrà il caos, secondo Trump ed il suo vice Mike Pence sarà colpa della stampa che mira ad “infondere paura” tra gli americani. Da notare infine che lo stesso
Pence, come del resto il presidente, ha evitato di consigliare l’uso delle mascherine ma ha suggerito che gli americani seguano le istruzioni degli stati in merito alle “coperture facciali”. Il mediocre evangelico vice di Trump ha concluso con un appello: “continuate a pregare”. All’America insomma non resta che pregare perché non venga il caos predisposto da Donald Trump.
———————————————————

LE DONNE E I GIOVANI ARBITRI DEL VOTO
Le donne e i giovani sono le due ruote del lotto elettorale americano dal quale uscirà il nome del prossimo presidente degli Stati Uniti. Le previsioni sono sempre una scommessa che riposa su una gamma di sondaggi che in realtà rappresentano uno “snap shot”, una foto del momento. Al momento, se si considera lo “snap shot” di questa fase elettorale, Donald Trump è avviato ad una sonora sconfitta e il partito repubblicano alla perdita della maggioranza al Senato.
Cominciamo dalle donne e dalla previsione che voteranno a favore del candidato democratico Biden in misura maggiore rispetto al loro voto per Hillary Clinton nel 2016.
La forte condanna della stravolgente presidenza Trump è ormai associata al doloroso impatto del coronavirus, aggravato dagli errori dell’amministrazione all’insorgere della pandemia. Il “gender gap”, ossia il divario di genere che ha proiettato le donne verso le posizioni democratiche è risultato decisivo nelle elezioni congressuali del 2018 che hanno portato alla Camera dei Rappresentanti un numero record di donne, 117 contro le 89 della precedente legislatura. Nelle elezioni presidenziali del 2016 Hillary conquistò la maggioranza del voto femminile ma non nella proporzione necessaria per strappare il voto del Collegio Elettorale negli stati chiave, dove Trump prevalse grazie al voto degli uomini bianchi. Questa volta la musica è cambiata. Ad esempio, nel Wisconsin, la più inaspettata vittoria di Trump nel 2016, le donne votarono per Hillary con un margine di dieci punti (53 contro 43 per cento). Il rilevamento demoscopico di questi giorni nel Wisconsin conferisce a Biden un vantaggio di 20 punti tra le donne (55 contro 33 per cento) che in presenza di un voto costante per Trump tra gli uomini (55 per cento) dovrebbe conferire a Biden un margine di vantaggio del 3 per cento nello stato. Analoghi sondaggi registrano un netto vantaggio di Biden in taluni stati chiave per il Collegio Elettorale, tra cui la Pennsylvania, il Michigan e la Florida. In quest’ultimo stato Biden è appoggiato dal 51 per cento delle donne rispetto al 38 per cento a favore di Trump.
Nel quadro del voto femminile va fatta una distinzione, che di fatto Trump raccolse la maggioranza dei suffragi delle cosidette “working women” bianche, con un margine del 27 per cento. Le donne che lavorano non hanno un titolo di studio superiore. Il vantaggio in quella categoria si è ridotto ora, stando ai sondaggi, a 6 punti. Se questo dato dovesse essere confermato a Novembre, si tradurrebbe per Trump in una perdita di 2 punti del voto popolare suggellando la sua sconfitta elettorale.
Nel 2016 infatti Trump strappò la maggioranza del Collegio Elettorale con il 46 per cento del voto popolare. Con il 44 per cento non sarà possibile.
La macchina elettorale di Trump sta lavorando intensamente per recuperare il voto delle cosiddette “downshifters”, le donne che avevano votato per lui nel 2016 ma avevano poi abbandonato i candidati repubblicani nel 2018. Ma anche questa è una missione impossibile perchè le donne che lavorano sono quelle che hanno più sofferto dalla pandemia e dalla drammatica contrazione economica che tra l’altro ha sottratto loro i mezzi per pagare gli asili nido. Un’altra importante differenza emersa è che mentre il 59 per cento degli uomini bianchi senza laurea si pronunciano a favore del rilancio dell’economia rispetto allo sforzo di contenimento del virus, il 57 per cento delle donne che lavorano invocano la neutralizzazione del virus anche al costo di una sofferenza economica. I demografi confermano che sarà pressocchè impossibile per Trump far leva sul voto femminile in quanto le donne sono “stanche” della sua presidenza. Con Trump – osservano – le donne avevano provato “qualcosa di nuovo” ma ora sanno che il presidente repubblicano è “uno che non unisce ma divide”. In conclusione, le donne non rappresentano un blocco monolitico ne’ votano necessariamente in base alle priorità feminili, ma negli ultimi tre anni hanno preso parte attiva alla vita politica, in ragione del 29 per cento in più rispetto al passato, dovuto soprattutto al concorso della generazione dei “millennials” e delle donne appartenenti a minoranze. Un ultimo fattore che sospinge il voto femminile per i democratici è l’impegno assunto da Biden di scegliere una donna per la candidatura vicepresidenziale. L’effetto sarà tanto più rilevante se dovesse trattarsi di una donna di colore, un ulteriore forte incentivo al voto degli afro-americani.
Negli Stati Uniti, i giovani votano in misura nettamente inferiore rispetto alle maggiori età e sono meno propensi ad affiliarsi ad un partito politico. Ma le cose vanno cambiando anche per la generazione dei “millennials” e per la cosidetta “generazione Z”, quella dei nati tra il 1995 ed il 2015. Sono noti come “zoomers”, in pratica i nipoti dei famosi “boomers”. La peculiarità distintiva di queste nuove categorie di elettori è che sono nella maggior parte indipendenti, ne’ democratici ne’ repubblicani, portati a votare in base alle loro preferenze politiche oppure ai valori dei candidati in lizza. Un’indagine demoscopica tra gli elettori di età compresa tra i 17 e i 35 anni ha accertato
che il 35 per cento si classifica democratico, il 24 per cento repubblicano e il 37 per cento indipendente. Tra coloro che ancora non si sono iscritti nelle liste elettorali, la grande maggioranza – il 72 per cento – si definisce indipendente.
In generale, i giovani elettori appaiono bene informati ma alieni da una identificazione partitica. Di fatto, molti di loro professano una forte dose di scetticismo nei confronti del partito democratico e dei suoi leader. Quelli che si definiscono conservatori rifuggono da una identificazione con il partito repubblicano, e dissentono in particolare dai capisaldi della piattaforma repubblicana in materia di politiche sociali e del clima. Un altro aspetto che li contraddistingue è il fardello di debiti che li opprime in confronto al minor debito personale delle precedenti generazioni. La recessione economica generata dalla crisi del coronavirus ha accentuato la protesta dei giovani contro la diseguaglianza economica e le politiche sociali dell’amministrazione Trump, che per quanto abbia lievitato il mercato azionario, non ha accresciuto il reddito e la ricchezza della classe media.
Altrettanto cruciale ai termini delle preferenze dei giovani è il fatto che nella recrudescenza della pandemia sono i giovani a farne maggiormente le spese. I casi di coronavirus sono drammaticamente aumentati in 40 dei 50 stati americani e quattro stati in particolare – Arizona, Florida, California e Texas – hanno registrato un alto numero di infezioni tra le giovani generazioni. In ultima analisi, il comportamento dei giovani elettori non può che essere ricondotto all’impatto che su di essi ha avuto e sta avendo il “trumpismo”, un cocktail incendiario di populismo economico, nazionalismo anti-immigrazione ed isolazionismo alla fasulla insegna del MAGA (Make America Great Again). Nell’elezione midterm del 2018 ha votato il 22 per cento degli aventi diritto al voto tra i 18 e i 24 anni e il 30 per cento tra i 25 e i 29. L’affluenza sarà certamente più alta a Novembre anche perchè i giovani sono più portati a votare in una consultazione presidenziale. Non meno importante è il dato che gli elettori tra i 18 e i 29 anni appartengono all’unico gruppo demografico che ha accresciuto la sua
affluenza alle urne nell’arco di tempo tra il 2012 e il 2016. Tutti i rilevamenti demoscopici recentemente condotti pronosticano un’affluenza alle urne ancor maggiore, accompagnata ad un crescente livello di entusiasmo. Altrettanto interessante è la scoperta che il 54 per cento di coloro che seguono la campana elettorale sui “social media” ed offline si dichiara “estremamente propenso” a votare. E’ quindi prevedibile che il voto dei giovani in questo rilevante segmento di elettori che si affidano al telefono e al laptop anzichè alla televisione via cavo, peserà a favore dei candidati democratici alla Casa Bianca e Senato.
I giovani sono influenzati da preoccupazioni sociali ed economiche che vanno dal pesante debito contratto per gli studi universitari alle scarse opportunità di avanzamento socio-economico. Le adunate di giovani, bianchi e di razza mista, che sono scesi nelle piazze per le dimostrazioni del “Black Lives Matter” rappresentano un importante indicatore di sostegno delle candidature democratiche. I giovani tra i 18 e i 35 anni costituivano un settore non sfruttato dell’elettorato americano. Oggi, una percentuale in deciso aumento di giovani elettori è avviata a far valere le sue ragioni nella consultazione presidenziale e senatoriale. Sono infatti in palio 35 seggi senatoriali su 100 e i democratici puntano a guadagnarne quattro (senza perderne alcuno) per conquistare una maggioranza che cambierebbe il corso della politica americana dopo la rovinosa parentesi della presidenza Trump. In conclusione, donne e giovani forniranno il margine di successo di Joe Biden per il ritorno ad una amministrazione “normale”.
Gli americani di età superiore ai 65 anni sono di gran lunga i votanti più affidabili, con un’affluenza alle urne del 58 per cento nel 2014 e del 73 per cento nel 2016.
USA. Trump: una presidenza che sta scivolando verso la disperazione

 La battaglia delle mascherine .
La battaglia delle mascherine .
 di Marino de Medici.
di Marino de Medici.
L’America è spaccata a metà su una molteplicità di fronti che riconducono alla battaglia elettorale, che sarà decisa – convengono praticamente tutti gli osservatori – dal decorso della pandemia e dell’economia. Il contrasto più sconcertante è quello sulle mascherine di protezione. Una massa di americani si è sollevata contro le disposizioni statali e cittadine che impongono l’uso delle mascherine come se queste fossero un’imposizione tirannica invece che misure di controllo consigliate dalla scienza contro il coronavirus. Sono molti gli esercizi commerciali che violano deliberatamente le restrizioni precauzionali mentre vaste ammucchiate di festaioli di molti stati, dall’Arizona alla Florida, ignorano completamente le regole che impongono il distanziamento. Altri ancora, e non sono pochi, si sono semplicemente stancati di osservare le precauzioni prescritte da amministratori e autorità sanitarie.
L’America assiste allo sconcertante confronto tra stati sulle due coste, dove la Florida non impone l’impiego delle mascherine mentre nella California sono obbligatorie. In pratica, la pandemia è un altro campo in cui gli americani
sono divisi a motivo delle loro ideologie e simpatie politiche. Per alcuni la mascherina è sinonimo di accettazione di un dovere pubblico e della disponibilità ad accettare il sacrificio individuale per il bene pubblico. Per altri,le mascherine rappresentano l’ennesimo tentativo di espansione del potere federale ed una violazione delle libertà personali. Il presidente Trump ha incoraggiato la politicizzazione del confronto, con il chiaro intento di fomentare accesi contrasti e divisioni che egli spera possano ricreare il clima che lo portò sorprendentemente alla Casa Bianca.
Entro un paio di settimane, intanto, sapremo se il comizio all’aperto a Tulsa, cui sono intervenute poche migliaia di sostenitori invece dell’adunata che il presidente si aspettava, sia stato un disastro per la pubblica sanità oppure uno stimolo per la rielezione. In parole povere, Trump ha fatto una scommessa usando come posta le vite dei suoi fedelissimi. Gli osservatori possono scommettere a loro volta che Trump punterà ancora su oceanici comizi alla barba dei dati che registrano una crescente percentuale di contagi. Il comizio di Tulsa è stato un grosso errore anche perchè la macchina elettorale di Trump aveva pompato le aspettative in termini di partecipazione e di impatto sulla platea generale dell’elettorato. Lo stesso discorso del presidente ha confermato il sospetto di molti osservatori che il presidente abbia problemi psicologici che lo rendono incoerente. E’ questa un’altra importante ragione perchè il candidato democratico Biden osservi un basso profilo, lasciando che Donald Trump si autodistrugga.
[segue]
Il culto della personalità per sostituire la democrazia
 Il volto codardo dell’autoritarismo.
Il volto codardo dell’autoritarismo.
The New York Times del 3 dicembre 2018
di Timothy Snyder* – Traduzione di Raffaele Deidda
Prima vediamo la faccia. La faccia dell’America Donald Trump o dell’Ungheria Viktor Orban, o del russo Vladimir Putin, o del turco Recep Tayyip Erdogan, il volto di uomini che vogliono trasformare le democrazie in culti della personalità.
Il volto è il marchio più antico della leadership, il marchio che funziona per clan o tribù. Se vediamo solo la faccia, non pensiamo alle politiche o alla politica. Stiamo invece accettando il nuovo regime e le sue regole. Tuttavia una democrazia riguarda la gente, non una singola persona mitizzata. Le persone hanno bisogno della verità, quella che il culto della personalità distrugge. Le teorie della democrazia, dagli antichi greci attraverso l’illuminismo fino ad oggi, danno per scontato che il mondo intorno a noi dia la precedenza alla comprensione. Seguiamo i fatti insieme ai nostri concittadini. Ma nel culto della personalità la verità è sostituita dal credere e noi crediamo in ciò che il leader vuole che crediamo. Il volto sostituisce la mente.
La transizione dalla democrazia al culto della personalità inizia con un leader che è disposto a mentire sempre, con lo scopo di screditare la verità in quanto tale. La transizione è completa quando le persone non possono più distinguere tra verità e sentimento. Il culto della personalità funziona allo stesso modo ovunque; si basa sulla nozione imprecisa che il volto rappresenta in qualche modo la nazione. Il culto della personalità ci fa sentire, piuttosto che pensare. In particolare, ci fa sentire che la prima domanda della politica è “Chi siamo noi e chi sono loro?” piuttosto che “Com’è il mondo e cosa possiamo fare noi al riguardo?” Una volta che accettiamo che la politica riguardi “noi e loro”, sentiamo di sapere chi siamo “noi”, dal momento che sentiamo di sapere chi sono “loro”. In realtà, non sappiamo nulla, dal momento che abbiamo accettato la paura e l’ansia, le emozioni animali, come base della politica. Siamo stati giocati
Gli autoritari di oggi dicono bugie di media grandezza. Queste si riferiscono solo superficialmente alle esperienze; ci trascinano in una caverna di emozioni. Se crediamo che Barack Obama sia un musulmano nato in Africa (una menzogna americana con il sostegno russo), o che Hillary Clinton sia una mezzana pedofila (una menzogna russa con il sostegno americano), in realtà non stiamo pensando; stiamo cedendo il passo alla paura sessuale e fisica.
Queste menzogne di media grandezza non sono proprio le grandi bugie dei totalitarismi, sebbene gli attacchi di Orban a George Soros come leader di una cospirazione ebraica gli assomiglino. Sono, tuttavia, abbastanza grandi da contribuire a rendere disabile il mondo reale. Una volta accettate queste bugie, ci disponiamo a credere a tutta una serie di altre falsità, o almeno sospettiamo che ci siano altre, più vaste cospirazioni.
Il volto del leader diventa, di conseguenza, una bandiera, un indicatore arbitrario di “noi” e “loro”. Internet e i social media ci stanno aiutando a vedere la politica in questo modo binario. Pensiamo di fare delle scelte mentre stiamo seduti di fronte ai nostri computer ma le scelte sono, di fatto, strutturate per noi da algoritmi che apprendono cosa ci terrà online. La nostra attività online insegna alle macchine che gli stimoli più efficaci sono negativi: paura e ansia. Quando i social media diventano istruzioni politiche, ci sentiamo rappresentati dai politici che riproducono lo stesso binario: cosa ci fa paura e cosa ci fa sentire sicuri? Chi sono loro e chi siamo noi?
Una volta il culto della personalità aveva bisogno di monumenti; ora richiede “meme” (contenuti che in poco tempo diventano virali, n.d.r). I social media pervadono l’immaginazione pubblica come le gigantesche statue dei tiranni dei tempi passati che occupavano lo spazio pubblico. Ma, come ricordano quei monumenti, i tiranni muoiono sempre. La vuota postura eterosessuale, le foto insulse senza camicia, la misoginia e l’indifferenza per l’esperienza femminile, le campagne anti-gay, sono progettate per nascondere un fatto fondamentale: il culto della personalità è sterile. Non può riprodursi. Il culto della personalità è la mitizzazione di qualcosa di temporaneo. È quindi confusione e, in fondo, vigliaccheria: il leader non può accettare il fatto che morirà e sarà sostituito, e i cittadini sono complici dell’illusione dimenticando che condividono la responsabilità per il futuro. Il culto della personalità diminuisce la capacità di far andare avanti un paese. Quando accettiamo un culto della personalità, non stiamo solo rinunciando al nostro diritto di scegliere i leader, ma anche smussando le capacità e indebolendo le istituzioni che ci permetterebbero di farlo in futuro. Mentre ci allontaniamo dalla democrazia, dimentichiamo il suo scopo: dare a tutti noi un futuro. Il culto della personalità dice che una persona ha sempre ragione; così dopo la sua morte arriva il caos.
La democrazia dice che tutti noi commettiamo errori, ma che abbiamo la possibilità, ogni tanto, di correggere noi stessi. La democrazia è il modo coraggioso di avere un paese. Il culto della personalità è un modo vigliacco di distruggerne uno.
* Docente di Storia all’Università di Yale e membro permanente presso l’Institute for Human Sciences di Vienna.
Link all’articolo originale: https://www.nytimes.com/2018/12/03/opinion/authoritarian-leaders-trump-putin-orban.html?fbclid=IwAR2ZUru4uP4Adc5lRmFluk1Q_K7D8SkmHhNUMYo731-_XO8MUBlLq4JeksoH
Il peggio dell’America dall’America
INTERNAZIONALE. «Via lo ius soli»: l’ultimo attacco alle origini dell’America moderna.
Stati uniti d’America. Nuova minaccia di Trump ai migranti per guadagnare consenso a due settimane dal voto di medio termine: con un ordine esecutivo il presidente vuole stracciare uno dei pilastri del paese e della costituzione. Dure critiche dai democratici, dubbi dagli esperti: serve la maggioranza del Congresso
 New York, 25 settembre 2018: American Muslim Parade
New York, 25 settembre 2018: American Muslim Parade
© LaPresse.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
di Marina Catucci su il manifesto
NEW YORK
il manifesto , edizione del 31 ottobre 2018. [segue]
INTERNAZIONALE. La Cina investe in (si prende l’?) Africa.


L’espansione cinese in territorio africano
di Maurizio Salvi*
Lo scontro commerciale in atto fra Cina e Stati Uniti ha davvero un carattere planetario e molteplici angoli visuali. Agli aspetti più eclatanti e sensazionalistici – come il braccio di ferro a colpi incrociati di aumento dei dazi alle importazioni – i media hanno dato ampio spazio e non c’è quasi nulla in più da aggiungere. Ma ci sono terreni più appartati, dove l’informazione è carente e riservata solo agli addetti ai lavori, in cui pure il confronto per il primato fra il colosso cinese e quello statunitense è vivo, strategico e ricco di implicazioni. Uno di questi, e non il minore, è l’Africa. La partita fra Pechino e Washington era giocata là ad un tavolo grande già all’epoca del colonialismo, insieme all’allora Urss e a vari Paesi europei. Successivamente, chiusasi l’era sovietica, sì è capito che l’Europa non aveva né l’intenzione, né gli strumenti politici, ne quelli economici, per assumere un ruolo di primo piano. Per cui, a poco a poco la Cina, alla sua maniera discreta ma efficace, e gli Stati Uniti, soprattutto con il peso delle multinazionali ed il controllo degli organismi finanziari multilaterali (Fondo monetario internazionale e Banca mondiale) hanno finito per monopolizzare le iniziative nei confronti della cinquantina di Nazioni africane.
la prevalenza della filosofia cinese
Le preoccupazioni americane sulla crescita della presenza cinese nel Continente africano non sono recenti. Ma in passato esse non hanno mai raggiunto la categoria dell’emergenza, perché bilanciate da soddisfacenti risultati in termini politici ed economici della diplomazia e delle imprese statunitensi, sia a nord che a sud del deserto del Sahara. Ma negli ultimi anni la percezione di questo equilibrio è andata sfumando, ed è emersa più netta l’idea alla Casa Bianca, che la filosofia cinese di intervento stesse di fatto prevalendo.
E se vi fosse bisogno di una prova della eco che risalta delle iniziative di Pechino fra i governi africani, basterebbe sottolineare che all’inizio di settembre in occasione del Forum di Cooperazione Cina-Africa (Focac), si sono presentati capi di Stato, primi ministri e ministri di tutte le Nazioni, meno il piccolo Swaziland, che è l’unica della regione ad avere ancora fluide relazioni con Taiwan. «Se paragoniamo questo appuntamento con i più modesti vertici Francia-Africa e Gran Bretagna-Africa – ha osservato al riguardo David Bénazéraf, specialista delle relazioni sino-africane presso l’Agenzia internazionale dell’energia – possiamo avere un’idea della forza d’urto cinese». Creato nel 2000, il vertice si riunisce ogni tre anni stanziando somme via via più importanti per progetti, prevalentemente di infrastrutture. Nel 2005 i miliardi erano cinque, e nel 2015 sono diventati 60, equivalenti a quelli messi sul tavolo anche nel 2018: 15 miliardi in aiuti, prestiti senza interessi e prestiti agevolati; una linea di credito di 20 miliardi; un fondo speciale per lo sviluppo Cina-Africa ed un fondo speciale di cinque miliardi per l’import africano (tra il 2009 ed il 2015 la seconda economia mondiale ha più che raddoppiato le sue esportazioni verso il ‘Continente nero’ facendo lievitare il suo surplus commerciale). Inoltre quest’anno il presidente cinese Xi Jinping ha nuovamente promesso di cancellare il debito contratto dai Paesi più poveri, come era già avvenuto regolarmente, anche se con meno intensità, dal 2000.
dinamismo finanziario
Le Nazioni africane non esitano ad accedere alle offerte di denaro in prestito dalla Cina, perché ciò non solo comporta tassi di interesse minori rispetto a quelli praticati dagli organismi finanziari multilaterali, ma anche molti meno condizionamenti riguardo a corruzione e sana gestione dei conti pubblici, come avviene invece per il denaro offerto dai Paesi occidentali. E questo dinamismo finanziario, che riguarda investimenti nei settori di infrastrutture, energia, ed anche delle banche, ha fatto sì che molte centinaia di compagnie cinesi si siano insediate in Africa. In una prima fase si trattava di imprese di sostegno ai progetti di sviluppo previsti dagli accordi di cooperazione bilaterali. Ma successivamente, con l’aumento dei costi di produzione in territorio cinese, e per l’inasprirsi delle guerre commerciali legate anche alla persistente crisi planetaria, Pechino ha cominciato a delocalizzare la sua produzione manifatturiera alla ricerca di Paesi con salari meno alti. Da qui l’atterraggio in Paesi asiatici come il Bangladesh e il Vietnam, ma anche in Africa del Sud ed in altre realtà africane dove i prodotti, pur fabbricati con denaro e personale spesso solo cinese, vengono etichettati come di altra origine, evitando quindi l’imposizione dei dazi elevati fissati per la produzione cinese. E sempre Bénazéraf conferma che l’Africa «si configura oggi più che mai una zona di delocalizzazione delle imprese cinesi per il settore industriale a forte domanda di mano d’opera», per evitare, appunto, le sanzioni commerciali imposte a Pechino.
seguendo le antiche Vie della Seta
E ancora, grazie allo sviluppo dell’ambizioso progetto denominato ‘Belt and Road Initiative (Bri)’, la Cina è intenzionata a raccogliere attorno a sé il sostegno economico e politico internazionale necessario a realizzare un’opera maestosa di collegamento all’Europa e all’Africa Orientale, volta al miglioramento della cooperazione tra i Paesi dell’Eurasia. Si tratta dell’apertura di due corridoi infrastrutturali fra Estremo Oriente e continente europeo sulla falsariga delle antiche Vie della Seta: uno terrestre (Silk Road Economic Belt) e uno marittimo (Maritime Silk Road), con il coin- volgimento di 70 Paesi. Gli esperti ritengo- no che per completare questo programma siano necessari investimenti per la fantastica somma di 4.000-8.000 miliardi di dollari. Gli Stati Uniti in questi anni non sono rimasti ovviamente a guardare e per provare ad ostacolare l’ambizione cinese hanno cercato di far progredire due blocchi commerciali: uno transatlantico con l’Europa, l’altro transpacifico con i Paesi dell’Asia vicini a Washington, senza però riuscire, sostengono gli esperti, a frenare la progressione del Bri cinese. E poi, se pure qualche ostacolo Xi Jinping trova nella regione asiatica, il Focac ha dimostrato che la musica è assai diversa in Africa dove il capo dello Stato si è recato quattro volte negli ultimi cinque anni, e dove ingenti investimenti sono stati accolti di recente per opere infrastrutturali da Egitto, Kenya, Africa del Sud, Senegal e Marocco, solo per fare alcuni nomi. E non è neppure un caso che l’unica base militare permanente della Cina all’estero sia a Gibuti, nel Corno d’Africa, all’estremità meridionale del Mar Rosso.
una valvola per l’economia
Insomma, sostiene Thierry Pairault, ricercatore capo del Centro nazionale della ricerca scientifica (Cnrs) francese, «c’è del vero nella tesi ufficiale di Pechino secondo cui le relazioni sino-africane si muovono nella logica ‘win-win’ (vantaggi di entrambe le parti)». Per l’Africa, spiega, «la Cina è una opportunità fenomenale che le permette di non dover sopportare più un faccia a faccia con le potenze occidentali. E per la Cina, questa spinta africana funge da valvola per una economia da tempo sostenuta dalle esportazioni e che ha bisogno di sfogo dovendo affrontare sia la politica protezionista del presidente Donald Trump, sia le barriere tariffarie europee». I punti polemici di questa cooperazione sono comunque ancora molti sotto accusa, c’è anche il grande acquisto di terre coltivabili realizzato in diversi Paesi africani per produrre derrate agricole volte a soddisfare la forte domanda di alimenti per i 1.300 milioni di cinesi. Questo feno- meno, hanno denunciato associazioni della società civile, ha accelerato una fuga di africani che abbandonano l’agricoltura e si trasferiscono nei centri urbani, dove spesso vivono in condizioni di massima povertà.
la crescita verde
Da questo tipo di rilievi ha preso spunto il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, quando ha dichiarato nel Forum di Pechino che il partenariato sino-africano deve rispondere a due grandi priorità: una «mondializzazione giusta e la promozione di uno sviluppo inclusivo». In particolare Guterres ha insistito sull’aiuto che la Cina può fornire ai Paesi africani in materia di sviluppo sostenibile. Dopo aver ricordato i rischi gravi che l’Africa corre a causa dei cambiamenti climatici, il segretario generale ha sottolineato come «uno sviluppo rispettoso del clima sia necessario per la Cina, per l’Africa, e per il mondo intero». «La Cina – ha concluso – è oggi un leader mondiale in quanto a soluzioni climatiche. È dunque importante che condivida i suoi progressi in materia con l’Africa per consentire a questo continente di andare oltre lo sviluppo tradizionale inquinante a favore della crescita verde».
* Maurizio Salvi su Rocca.
————————–
ROCCA 15 OTTOBRE 2018
INTERNAZIONALE

Usa. Il sogno improbabile di Trump

Il declino relativo degli Stati Uniti e i pericoli dell’isolazionismo di Donald Trump
di Gianfranco Sabattini*
Il nuovo equilibrio mondiale tra le grandi potenze economiche del mondo sta preoccupando l’opinione pubblica americana, spingendola all’”isolazionismo”, al quale gli Stati Uniti hanno sempre teso, ritirandosi entro i confini della loro “Isola” ogni volta che si sono convinti che l’”American way of life” fosse minacciata da forze esterne. E’ questo il fondamento dell’ideologia sulla quale Donald Trump ha costruito le proprie fortune elettorali.
Il nuovo presidente ha utilizzato, infatti, con successo il mito dell’isolazionismo, le cui conseguenze non sono certo neutrali e ininfluenti per il resto del mondo; soprattutto, per quella parte dei Paesi occidentali che, per ragioni storiche, devono muoversi nel mercato internazionale avvalendosi dell’area valutaria costruita dagli USA dopo la fine del secondo conflitto mondiale. E’, questa, la tesi che Manlio Graziano, docente di Geopolitica alla Sorbona, sostiene nel suo recente volume “L’Isola al centro del mondo. Una geopolitica degli Stati Uniti”.
Per capire le ragioni del pericolo, per il resto del mondo del successo elettorale di Trump e della sua propensione a ridimensionare gli impegni internazionali dell’America, è necessaria, secondo Graziano, un’analisi geopolitica, che evidenzi le cause remote delle scelte americane attuali; ciò, al fine di indurre il resto del mondo a sperare, nell’interesse di tutti, che il trumpismo abbia il “fiato corto”.
“Gli Stati Uniti – afferma Graziano – sono oggi attanagliati da una nuova psicologia di inquietudine e di frustrazione. La crisi del 2008 ha messo in chiaro che gli americani non potranno più permettersi di vivere, in futuro, come avevano vissuto nel passato”; si tratta di un’inquietudine comune a tutte quelle potenze che, dopo aver dominato per secoli, sul piano politico ed economico, molti altri Paesi, assistono improvvisamente al fatto che la loro posizione dominante è contestata da altre potenze emergenti, interessate ad accrescere sulla scena mondiale la loro visibilità.
L’inquietudine, però, si manifesta in termini più cogenti per gli USA, “la cui breve storia è stata contrassegnata dalla promessa, quasi sempre mantenuta, di un miglioramento costante delle condizioni di vita della maggior parte dei suoi cittadini”. L’intento di Graziano è quello di fornire, da un punto di vista geopolitico, una “griglia di lettura” di quanto sta ora accadendo nella società americana, per valutare le possibili ricadute politiche ed economiche globali, iscrivendole, però, nella “continuità geopolitica degli Stati Uniti”.
Il libro di Graziano traccia la storia dei tre momenti essenziali dell’esperienza degli USA, comprendendo l’intero ciclo che va dall’ascesa (con la descrizione di tutte le condizioni che hanno condotto alla formazione dello Stato-nazione americano) alla maturità e al declino di quell’esperienza. Prescindendo dal momento originario, caratterizzato dalla particolare forma assunta dallo Stato americano, tanto diversa da quella degli Stati-nazione europei, è essenziale capire, secondo Graziano, come si è affermata la sua maturità che, iniziata con la guerra civile, è culminata con “l’intervento militare americano nei due oceani, la loro sottomissione, e lo spodestamento di Londra come potenza egemone mondiale”. E’, questo, un epilogo della maturità dell’esperienza vissuta dagli Stati Uniti cui sono riconducibili i prodromi del suo declino attuale.
La fine della Seconda Guerra mondiale ha permesso agli Stati Uniti – afferma Graziano – “di realizzare il vecchio sogno di Woodrow Wilson di costruire un nuovo ordine mondiale modellato sui principi e soprattutto sugli interessi americani”. Ciò ha comportato che gli USA si esponessero sulla scena internazionale, più di quanto avevano fatto dopo la Grande Guerra, in quanto il loro benessere veniva a dipendere dalla loro capacità di riuscire a mantenere quell’esposizione; un’esposizione non solo economica, perché la crescita interna dipendeva dal coinvolgimento internazionale, ma anche strategica, perché “le scelte compiute durante la guerra avevano creato nuovi equilibri che avrebbero retto solo se gli americani avessero mantenuto la loro presenza sui diversi scacchieri”.
A tal fine, a partire già da prima che finisse la guerra, sono stati creati diversi organismi, strumentali ad assicurare consistenza alla posizione dominante raggiunta: con la Conferenza di Bretton Woods e la creazione delle Nazioni Unite si è dato vita a diverse istituzioni, il cui scopo è stato quello di riorganizzare il sistema economico e finanziario mondiale, perché gli Stati Uniti potessero approfondire e conservare la posizione dominante raggiunta. In tal modo, sono state gettate le basi “di quello che sarà chiamato molto più tardi – afferma Graziano – il ‘Washington Consensus’, cioè un modello economico e di sviluppo ispirato da Washington nell’interesse di Washington”.
In altri termini, all’interno del mercato economico e finanziario facente capo agli USA, le nuove istituzioni hanno creato le condizioni perché i Paesi che avessero deciso di iniziare la propria ricostruzione materiale ed economica, integrandosi in quel mercato, fossero costretti a conformarsi ai requisiti di convertibilità monetaria e di libera competizione posti dagli americani; requisiti, questi, nuovi per gli stessi USA, un Paese caratterizzato da forti propensioni protezionistiche, a meno di brevi periodi della loro storia. Con il libero scambio e la libera competizione internazionale posti a fondamento della ricostruzione del mercato mondiale, gli USA hanno inteso anche contrastare tutte le posizioni colonialistiche che impedivano di aprire il mercato mondiale all’esportazione dei loro prodotti e dei loro capitali.
Inoltre, con i nuovi organismi posti alla base della ricostruzione del mercato mondiale, gli USA hanno potuto infliggere una doppia sconfitta al Paese leader tra quelli coloniali, la Gran Bretagna; da un lato, perché con il libero scambio è stata resa obsoleta la clausola della “preferenza imperiale”; dall’altro lato, perché con il sistema dei cambi fissi centrato sul dollaro (convertibile in oro a 35 dollari l’oncia) è stata “messa a tacere” la pretesa di Londra di creare un sistema monetario mondiale “fondato su un’unità di riserva neutra, non legata ad alcun Paese”. In tal modo, per gli USA è stato possibile organizzare e rilanciare l’economia mondiale, imperniata sul dollaro e non più attorno alla sterlina, come accadeva sino al più immediato passato.
Dopo l’apoteosi del dopoguerra, come si è detto, è iniziato il declino che, per quanto sia stato lento e pressoché invisibile agli inizi, ha subito un’accelerazione “in conseguenza dei miracoli giapponese e tedesco”, finché il carattere multipolare dell’ordine mondiale si è definitivamente imposto agli inizi degli anni Settanta. Si è trattato, però, secondo Graziano, di un “declino relativo”; ciò perché, durante il suo manifestarsi, gli USA hanno continuato a veder crescere il loro prodotto reale. L’indebolimento della loro posizione rispetto ai competitori si è configurato nel differente ritmo della crescita, tra il 1945 e il 2016, del prodotto interno lordo: mentre il PIL americano è cresciuto di sette volte e mezzo, quello mondiale è cresciuto di circa venti volte.
Per un giudizio più comprensivo del declino relativo degli USA, occorre tener conto, secondo Graziano, che esso si è verificato nell’arco di due periodi successivi molto diversi tra loro: il periodo della Guerra Fredda e quello successivo, caratterizzato dal crollo dell’URSS. Durante il primo periodo, gli USA sono stati impegnati in un duro confronto con l’Unione Sovietica, limitato però al solo piano ideologico; per cui, a dispetto di quello che le ideologie contrapposte intendevano far credere, Mosca ha svolto un ruolo di “stampella” in pro del consolidamento dell’egemonia globale degli USA. Infatti, sino agli anni Settanta, l’Unione Sovietica è stata uno dei due pilastri che hanno sorretto la struttura dell’ordine globale creatosi dopo la Seconda Guerra mondiale.
Il suo rapido crollo – afferma Graziano – ha mandato in “frantumi” quegli equilibri, per cui “il peso politico delle potenze che erano state tenute in scacco dal contrappeso russo” (in primo luogo la Germania, il Giappone e la Cina) è aumentato rapidamente. Ciò ha comportato che, nello spazio di pochi mesi, tutte le potenze vecchie e nuove si siano trovate “in territorio sconosciuto”. Ma gli Usa non hanno saputo approfittare della situazione di vuoto di potere globale, mancando di espandere e consolidare la propria egemonia.
L’incertezza che ha caratterizzato la posizione di Washington dopo il crollo dell’URSS veniva da lontano: la decisione di Richard Nixon di abbandonare la parità tra dollaro e oro stabilita a Bretton Woods, la recessione provocata degli shock petroliferi e dalla crisi dei mercati delle materie prime degli anni Settanta, il problema del debito dei paesi arretrati e il crollo di fiducia seguito alla fine della guerra in Vietnam hanno indotto l’opinione pubblica americana, e con essa la classe politica del Paese, a convincersi che l’epoca del dominio quasi totale della scena mondiale dell’America era sulla via del declino.
Stando cos’ le cose, è da considerarsi mal riposto, secondo Graziano, l’ottimismo che, nell’ultimo decennio del secolo scorso, l’America sembrava trarre da un periodo in cui la propria economia risultava in espansione (con una disoccupazione in calo, un mercato immobiliare florido e un prestigio internazionale accresciuto dalla vittoria sull’”impero del male”), Quell’ottimismo, infatti, appena iniziato il nuovo secolo, è venuto meno; prima, per via degli effetti negativi provocati sui mercati finanziari dallo scoppio della bolla speculativa “dot com” (sviluppatasi tra il 1997 e il 2000); successivamente, per l’attentato dell’11 settembre 2001 alle Torri Gemelle (che è valso a rimuovere la convinzione degli americani dell’inviolabilità del loro suolo).
Ma non basta; tutti gli avvenimenti negativi che sono accaduti tra la fine del secolo scorso e l’inizio del nuovo hanno segnato solo la “calma che precede la tempesta”; nel 2008 è sopraggiunto lo sconquasso provocato dai prestiti sub-prime che, dopo aver squilibrato profondamente l’economia americana, si è abbattuto sulle restanti economie di mercato del mondo intero. Il 2008 è stato un punto di svolta riguardo alla capacità degli USA di poter continuare a difendere la propria primazia economica globale; in quell’anno, infatti, l’U.S. National Intelligence Council (NIC), nel suo rapporto quadriennale diretto al presidente in carica (Barack Obama), scriveva che, dato il declino relativo della loro potenza economica, gli Stati Uniti non potevano più avere “la stessa flessibilità nelle scelta tra le tante opzioni politiche” della quale potevano disporre nel passato.
Il presidente Obama, sulla base del rapporto del NIC, ha potuto iniziare la politica di riduzione della “sovraesposizione imperiale” degli USA, mediante una riduzione delle spese federali (retrenchment), non tanto per definire nuove priorità, quanto per stabilire – sostiene Graziano – “quali ‘obblighi’ avrebbero dovuto essere sacrificati a quelle priorità. Non si trattava tanto di una scelta, quanto della presa d’atto di un’inaggirabile necessità”; in altre parole, la nuova politica degli Stati Uniti doveva essere fondata sul riconoscimento che tutto doveva essere ridimensionato, perché gli impegni tradizionali che avevano fatto degli USA i “gendarmi del mondo” erano andati ben al di là delle loro possibilità.
La strategia di Obama, è consistita nella individuazione degli impegni periferici che gli USA dovevano abbandonare, rinsaldando antiche alleanze e inaugurandone di nuove, al fine di contenere le spinte espansive del competitore in ascesa, la Cina, giudicato il più “pericoloso”. Il successore di Obama, Donal Trump, ha però abbandonato la strategia del “retrenchment”, pensando di poter perseguire gli stessi obiettivi adottandone un’altra, “molto più affine alla tradizione ideologica americana”: l’isolazionismo, che “nell’era della globalizzazione e del declino relativo” non può che essere per gli USA – conclude Graziano . “un suicidio per paura di morire”.
Delle due facce dell’isolazionaismo, il protezionismo e il ritiro dagli impegni internazionali, resta da valutare quale tra esse potrebbe portare per prima alla rovina gli Stati Uniti; un evento di tal fatta sarebbe portatore di instabilità e crisi inimmaginabili, sia sul pieno economico che politico, per tutte le economie integrate nel mercato internazionale. Perché tutto ciò non accada, c’è solo da fare affidamento sul fatto che Donald Trump non rappresenti l’insieme della classe politica americana e, quel che più conta, che la “burocrazia imperiale” della quale gli USA dispongono, faccia valere la propria visione realistica degli “affari internazionali”, con cui evitare il possibile “salto nel buio” cui è esposto il mondo dai possibili esiti dell’isolazionismo trumpiano.
——-
* Anche su Avanti! Online.
DIBATTITO. Europa?
 Il problema dell’Unione Europea? Mancano strategia, ambizione e pragmatismo
Il problema dell’Unione Europea? Mancano strategia, ambizione e pragmatismo
La rassegna stampa europea di questa settimana a cura della News LINKIESTA. In primo piano l’Europa, in crisi esistenziale, a cui mancano strategia e ambizione e poi la questione della tassa sui robot
di EuVisions, Carlo Burelli e Alexander Damiano Ricci.

(9 Marzo 2017 – 14:17)
Il futuro dell’Europa
Al Libro bianco della Commissione sul futuro dell’Europa mancano strategia e ambizione. L’Europa ha bisogno di pragmatismo perché si trova in una crisi esistenziale
La questione sociale
Al Libro bianco della Commissione sul futuro dell’Europa mancano strategia e ambizione: questo il commento di Judy Dempsey, di Carnegie Europe. La pecca principale sta nel cercare di compiacere ciascuno dei 28 (presto 27) Stati membri. Il Libro bianco illustra 5 possibili scenari: proseguire lungo la strada già intrapresa; concentrarsi esclusivamente sul mercato unico; consentire una maggiore integrazione degli Stati membri, laddove la si voglia; fare meno ma in modo più efficiente; ed infine fare molto di più, tutti insieme. Il rischio sta nel fatto che tutti si sentiranno in diritto di scegliere l’opzione più vantaggiosa tra quelle presenti in questa “lista della spesa”: la Commissione sembra aver perso autorevolezza e capacità di leadership, e rende palese il fatto di non avere una strategia definita per il futuro.
Secondo Juha Sipilä, il Primo ministro della Finlandia, l’Europa in questo momento ha bisogno di pragmatismo. I cittadini non pensano che lo Stato federale sia un obiettivo per cui valga la pena lottare, ma nonostante questo isolarsi sarebbe una scelta sbagliata. Se si vogliono perseguire delle forme di solidarietà tra paesi, occorre ricordare che alla base di tutto c’è la fiducia, e dunque gli Stati membri devono assumersi la propria parte di responsabilità e rispettare le norme comuni. La cooperazione europea è stata costruita nel corso del tempo su tre principi fondamentali – pace, prosperità e valori comuni – quando l’Europa, devastata dal secondo conflitto mondiale, aveva bisogno di stabilità. L’Unione europea deve riconoscere le sue radici, e quindi salvaguardare la stabilità, la prosperità e i valori comuni del continente.
La crisi multiforme che l’UE si trova ad affrontare è diversa dalle precedenti: secondo Claire Courteille-Mulder e Olivier De Schutter (Euractiv) si tratta di una crisi esistenziale, dal momento che tocca la nozione stessa di integrazione, il che rende più che mai necessaria una ridefinizione dell’Europa in uno scenario di crisi che, iniziata nel 2008, ancora fa sentire le sue conseguenze sociali. Nell’immediato, è necessario intraprendere azioni concrete volte a dare maggiore coerenza ai diversi obiettivi nazionali, siano essi di natura fiscale, sociale o economica. Più a lungo termine, si dovrà riaprire il dibattito su come portare l’UE sotto la giurisdizione di organismi sovranazionali che tutelano i diritti della persona, se non altro per far sì che gli Stati membri siano in grado di rispettare gli obblighi derivanti dalla ratifica di trattati internazionali.
L’automazione può ridurre i costi per i consumatori: una tassa sui robot che possa ridurre l’impiego di macchinari nell’assistenza sanitaria e che quindi faccia crescere i costi delle cure mediche potrebbe danneggiare tanti lavoratori quanti ne aiuterebbe
L’Economist prende in esame la tassa sui robot proposta da Bill Gates, sostenendo che ne deriverebbero due vantaggi: maggiori risorse e rallentamento dell’automazione. Di solito gli economisti non amano le imposte sugli investimenti, dal momento che l’acquisto e l’impiego di nuove attrezzature aumentano la produttività e la crescita. Ma se il ritmo dell’automazione è troppo rapido da gestire per la società, rallentare l’automazione potrebbe apportare benefici maggiori degli svantaggi. Tuttavia, ci sono motivi per essere scettici riguardo questo approccio. Non tutti i nuovi robot rimpiazzano il lavoro umano e alcuni rendono maggiormente produttivi i lavoratori esistenti. L’automazione può anche ridurre i costi per i consumatori: una tassa sui robot che portasse a ridurre l’impiego di macchinari nell’assistenza sanitaria e che quindi facesse crescere i costi delle cure mediche potrebbe danneggiare tanti lavoratori quanti ne aiuterebbe. Un ulteriore problema è che almeno per ora la crescita della produttività rimane deludente, e questo suggerisce che semmai l’automazione sta avvenendo troppo lentamente, piuttosto che troppo rapidamente come si teme.
Rutger Bregman propone un ‘modo semplice’ per eliminare la povertà, sostenendo che dovremmo abbandonare l’idea secondo cui i ricchi “meritano” la loro condizione sociale superiore. Un lavoro di Eldar Shafir, docente a Princeton, esamina il caso dei coltivatori di canna da zucchero in India: questi ultimi ricevono circa il 60% del loro reddito annuo in una sola volta, ossia subito dopo la raccolta, il che li rende poveri per una parte dell’anno e ricchi per l’altra. Sorprendentemente, i loro test del QI mostrano che quando sono “poveri” ottengono 14 punti in meno rispetto allo stesso test effettuato quando sono “ricchi”. Ciò si spiega con il fatto che le persone si comportano in maniera diversa quando percepiscono “scarsità”, concentrandosi su una mancanza immediata piuttosto che guardare alla prospettiva di lungo termine. Questo è il motivo per cui così tanti programmi contro la povertà falliscono. Una soluzione semplice sarebbe un reddito di base universale, misura rivelatasi efficace quando è stata sperimentata per 4 anni a Dauphin, a partire dal 1974: l’esperimento ha mostrato che le persone non solo si arricchiscono, ma diventano anche più intelligenti e più sane. Il rendimento scolastico dei bambini è migliorato notevolmente, il tasso di ospedalizzazione si è ridotto dell’8,5%, e anche la violenza domestica è diminuita, così come i problemi di salute mentale. Inoltre, le persone non hanno abbandonato il proprio impiego per ricevere il sussidio. Un reddito di base fungerebbe da capitale di rischio per le persone, e sarebbe conveniente dato che la povertà ha enormi costi occulti.
—————————————-
Leggi anche:
– Greece: Lenders take unacceptable hard line on worker rights – Euractiv
– Britain may find it hard to escape the European Court of Justice – Economist
– Michael Gove on the Trouble with Experts – Chatham House
– Leaving the EU is the start of a liberal insurgency – The Guardian
——————————————————————————————————-
Cinque possibili strade per l’Unione Europea
di Vincenzo Comito su eddyburg.

«Nel Libro Bianco del presidente della Commissione europea per la prima volta viene avanzata l’idea che in tema di costruzione europea l’Unione possa anche fare dei passi indietro». Sbilanciamoci.info, 9 marzo 2017 (c.m.c.)
Che il progetto dell’Unione Europea sia da tempo in una crisi profonda non è certo una questione controversa. I sintomi del male sono chiari: basti ricordare il crescente euroscetticismo che si va diffondendo dovunque e l’attacco quasi quotidiano, da parte dei rappresentati politici di molti paesi, verso Bruxelles.
Per parte nostra, su di un piano politico, ricordiamo come l’Europa si sia intrappolata in una deriva tecnocratica e neo-liberista, con la corsa all’austerità, le svalutazioni “interne” e le cosiddette riforme “strutturali”, i favori ai paradisi fiscali, il taglio dei bilanci comunitari, l’assenza di politiche di sviluppo.Semmai oggi le incertezze planano sul che fare di fronte a tali minacce e a tali problemi.
Alcuni progetti di riforma
Negli ultimi mesi si vanno elaborando da diverse parti dei progetti di riforma su tutta o su una qualche parte della costruzione europea. Meraviglia semmai che esse non siano poi troppo numerosi, né che il dibattito in merito si presenti come molto vivace, o di livello adeguato, sintomi forse anche questi di una crisi profonda del progetto europeo.
Intanto c’è questa proposta della Merkel mirante ad un’Europa a più velocità, idea sufficientemente vaga per dare adito a diverse possibili interpretazioni; sempre in Germania, invece, Schultz, che comunque è d’accordo su questa ipotesi della cancelliera, vuole peraltro chiudere con la politica di austerità, da lui considerata come una delle cause fondamentali della crisi e vuole invece introdurre gli eurobond per migliorare le prospettive delle economie indebitate.
Ad un summit tenutosi a Versailles il 6 marzo, anche Francia, Italia e Spagna si sono dichiarate d’accordo con l’idea della Merkel, anche se temiamo che ogni paese, utilizzando l’espressione, pensi a cose almeno in parte diverse da quelle degli altri.
D’altra parte, si va discutendo di portare avanti la costruzione europea mettendo in comune in tutto o in parte il settore della difesa; ma non ci sembra poi una grande idea quella di rilanciare il progetto cominciando proprio da lì. Eccellono nell’esercizio pan-militare i governi italiano e francese.
Va ancora segnalato che il parlamento olandese sta avviando una commissione di inchiesta per valutare i pro ed i contro del mantenimento del paese nell’eurozona (Barber, 2017). Trattandosi di uno dei sei paesi fondatori della costruzione europea questo non appare certo un bel segnale.
Per quanto riguarda l’Italia, hanno destato un certo clamore le conclusioni a cui è giunta una ricerca della società Macrogeo, una creatura di Carlo De Benedetti, che da per scontata una chiusura dell’esperimento europeo e l’emergere invece di un polo mega-tedesco, cui farebbero capo paesi quali l’Olanda, la Polonia, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, alcune realtà scandinave ed eventualmente il Nord dell’Italia, che così si staccherebbe dal resto del paese.Come si vede il livello di confusione appare piuttosto elevato.
Le dimissioni di Juncker
Juncker aveva già fatto parlare di se qualche settimana fa, quando sembrava che egli fosse sul punto di presentare le dimissioni dalla carica, essendo la Commissione al crocevia di una serie di contraddizioni difficilmente sanabili. Egli ha apparentemente poi cambiato idea. Ricordiamo, a proposito dei problemi che egli può avere incontrato a Bruxelles negli ultimi tempi, solo un episodio che riguarda il nostro paese. La Commissione, ponendo molte speranze nelle promesse di rinnovamento del governo Renzi, aveva allentato le briglie sui conti dell’Italia per ben 19 miliardi di euro; col risultato di ricevere in cambio degli insulti dal capo del governo della penisola, che voleva ottenere ancora di più, ma contemporaneamente anche gli attacchi della Merkel, che gli ricordava come lo stesso Renzi avesse poi utilizzato le concessioni della Commissione per il varo di misure quali l’abolizione dell’Imu sulla prima casa e il versamento di denaro ai giovani per permettere loro di comprare i biglietti per il cinema.
Il libro bianco
In questo clima si colloca il cosiddetto “libro bianco” del presidente della Commissione, reso pubblico ai primi di marzo e presentato come un contributo della stessa Commissione al dibattito sull’avvenire dell’Unione. Il testo dovrebbe essere dibattuto al summit di Roma del 25 sempre di questo mese, quando sarà celebrato il 60° anniversario del trattato di fondazione dell’Unione.
Ricordiamo che il testo sarà completato da qui all’estate da cinque rapporti specifici, che esploreranno “l’avvenire dell’Europa sociale”, “le risposte alla globalizzazione”, “le vie per l’approfondimento dell’unione economica e monetaria”, “la difesa” e “la finanza”.
Le trenta pagine del fascicolo appena pubblicato presentano cinque possibili scenari.
Il primo è quello che l’Unione si limiti al solo mercato unico. Il libro bianco sottolinea i lati negativi dell’ipotesi, quali la perdita della libertà di circolazione, i pericoli per la stabilità finanziaria, la riduzione di status e di peso internazionale dei vari paesi europei e di tutto il continente.
Lo scenario più ambizioso propone invece un’Europa federale. Ma l’ipotesi non appare in sintonia con l’aria del tempo ed essa viene valutata come oggi politicamente non credibile.
Il terzo scenario è quello dello status quo, linea chiaramente aperta a grandi criticità, gran parte delle quali conosciamo bene già adesso, ma che sarebbero presumibilmente destinate ad aggravarsi nel tempo.
Restano i due ultimi scenari.
Il primo rilancia l’idea della Merkel, ormai appoggiata dagli altri grandi paesi dell’Unione, di un’Europa a più velocità. Le politiche comuni attuali e qualcuna di quelle future rimarrebbero per tutti i paesi, ma alcuni di essi potrebbero decidere di andare più avanti, caso per caso, come nella difesa, nella giustizia, nel diritto commerciale, nell’armonizzazione fiscale.
L’ultimo scenario, possibilmente complementare a quello precedente, vedrebbe l’Unione restituire ai singoli Stati alcune competenze oggi collocate a Bruxelles. Si tratterebbe di “fare meno ma meglio”, in tema ad esempio di politiche regionali, nonché di parte delle politiche sociali e dell’occupazione, delineando anche soltanto degli standard minimi su altri soggetti, come ad esempio la protezione dei consumatori e gli standard sanitari.
Va in proposito segnalato che è la prima volta che qualcuno suggerisce il principio che in tema di costruzione europea si può anche arretrare.
Parallelamente, invece, si dovrebbe andare più avanti su alcuni grandi dossier politici ed economici, quali la politica dell’innovazione, il commercio estero, i migranti e il diritto d’asilo, la protezione dei confini, la difesa. Ai maggiori poteri in alcune aree dovrebbe poi anche corrispondere il potere di implementare direttamente da parte di Bruxelles le decisioni collettive una volta prese.
Pur senza avanzare preferenze nette, comunque il documento suggerisce che sarebbero le due ultime opzioni quelle preferite.
Conclusioni
Come capo della Commissione, in presenza dei gravi problemi già prima ricordati, nonché della scadenza del 60° anniversario dell’Unione, della pendenza della Brexit e infine delle supposte minacce che pongono oggi gli Usa di Trump e la Russia di Putin, Juncker non poteva certo mancare di fare il punto sulla situazione e di aprire ufficialmente il dibattito.
Peraltro il suo approccio, pur con qualche spunto positivo, non ci appare complessivamente molto convincente e comunque esso fa intravedere una risposta molto debole di fronte ai problemi che si pongono.
Si può ricordare, tra l’altro, che negli ultimi anni molti studiosi ed operatori hanno elaborato delle idee e pubblicato delle ricerche che affrontano il problema in maniera anche molto approfondita. Di tutte queste analisi nel libro bianco ci sembra che non ci sia sostanzialmente traccia.
E’ vero che come presidente della Commissione Juncker non può imporre ai vari Stati le sue idee, ma comunque uno sforzo maggiore poteva, a nostro parere, essere fatto non solo a livello di analisi, ma anche di proposte.
Al di là di questo, entrando brevemente nel merito di quello che nel documento manca, ci sarebbe, tra l’altro, bisogno di attenzione ad una maggiore giustizia sociale ed economica, di andare inoltre verso la cancellazione delle politiche di austerità, di avviare grandi investimenti pubblici verso l’economia verde, le nuove tecnologie e la riduzione delle diseguaglianze tra paesi, in vista anche della messa a punto di un modello sociale europeo. Per non parlare della necessità di rinnovare la macchina organizzativa di Bruxelles, oggi tra l’altro facile preda di tutte le lobbies, come mostra in questi giorni il caso dei glifosfati e di cambiare alcuni principi di funzionamento, come quello dell’unanimità.
Ma di tutto questo nel documento non c’è traccia. Il progetto europeo, se si baserà sulle sole ipotesi del libro bianco, non sembra presentare motivi di entusiasmo.
Più in dettaglio, ad esempio sul piano sociale Juncker aveva dichiarato nel 2014 «…io vorrei che l’Europa avesse la “tripla A” sociale, altrettanto importante della “tripla A” economica e finanziaria…» (Ducourtieux, 2017). Ma la realtà non appare certo in linea con tali dichiarazioni. Per il vero, l’8 di marzo si è tenuto un “vertice sociale tripartito”, tra i dirigenti dell’Unione, i rappresentanti del padronato e quelli dei sindacati europei. Ma si è trattato, come al solito, di un dialogo tra sordi. La Commissione prepara inoltre per il 26 aprile la pubblicazione di una piattaforma europea dei diritti sociali, ma sono in pochi ad aspettarsi qualcosa da tali sforzi (Ducourtieux, 2017).
—-
-Barber T., Europe starts to think the untinkable : breaking up, www.ft.com, 2 marzo 2017
-Ducourtieux C., L’Europe a bien du mal à prendre l’accent social, Le Monde, 8 marzo 2017
DIBATTITO. Questa Europa è in crisi e la Sinistra non riesce a trovare proposte convincenti per un’altra Europa

 SOCIETÀ E POLITICA
SOCIETÀ E POLITICA
Europa, la minaccia della disintegrazione
«Dalla Brexit alla divisione tra Nord e Sud alle politica in materia di migrazioni. La crisi del processo di integrazione europeo nel rapporto Euromemorandum 2017 che verrà presentato a Roma il 16 marzo».
Sbilanciamoci info, 2 marzo 2017 (c.m.c.)
La crisi del processo di integrazione europeo ha molte sfaccettature e si è aggravata negli ultimi anni. Il sintomo più visibile è stato il referendum britannico sull’uscita dalla Ue, ma questo non è certo l’unico indicatore del diffondersi delle tendenze disgregatrici e delle crescenti contestazioni alle politiche europee.
Brexit
La disintegrazione dell’Unione è stata introdotta esplicitamente nell’agenda politica dal referendum britannico. Si può inquadrare il risultato del referendum nel contesto globale delle rivolte contro le élite politiche. La crescita delle diseguaglianze, l’insicurezza economica, la stagnazione o diminuzione del reddito subita da larghi strati di popolazione, insieme alla riduzione dei servizi pubblici, sono i fattori alla base di questo malcontento, le cui espressioni politiche variano enormemente.
In Gran Bretagna, come in molte altre nazioni, gli immigrati sono diventati i capri espiatori, accusati di aver causato problemi economici, quando in realtà la mobilità dei capitali, non del lavoro, è stata una delle principali cause della riduzione degli standard di vita medi e dell’erosione dei diritti dei lavoratori e della protezione sociale. In Gran Bretagna un altro capro espiatorio è stato trovato nei più bisognosi e sia i conservatori che i laburisti, prima del cambio nella leadership del partito, hanno invocato un’ulteriore riduzione dei già inadeguati livelli di protezione sociale.
Durante la coalizione tra conservatori e liberal-democratici, nel 2010-2015, i demagoghi dell’Independence Party britannico (Ukip), sono riusciti a indirizzare il malcontento popolare contro la Ue e a fomentare un nazionalismo xenofobo, che individua i nemici nei lavoratori provenienti dagli altri Paesi dell’Unione. La crescente forza dell’Ukip ha allarmato i partiti tradizionali. Ciò che ne è seguito è stato, almeno in parte, guidato dal caso.
Per cercare di fermare l’avanzata politica dell’Ukip, il primo ministro britannico David Cameron ha promesso un referendum sulla permanenza del Regno Unito nell’Unione, in un momento nel quale la coalizione al governo sembrava destinata a continuare a governare il Paese; poiché i liberal-democratici non avrebbero mai potuto condividere la decisione di tenere il referendum, i conservatori erano sicuri che tale promessa non avrebbe potuto realizzarsi nella pratica. Tuttavia, l’inaspettata vittoria di una maggioranza conservatrice alle elezioni ha costretto Cameron a rispettare l’impegno preso.
Il trionfo della campagna del leave (uscire dalla Ue) ha coinvolto due grandi correnti politiche: da una parte il nazionalismo xenofobo promosso dall’Ukip; dall’altra la corrente ultra-liberale interna ai conservatori. Michael Gove e John Redwood, due conservatori membri del parlamento britannico, hanno visto l’Europa come un ostacolo al capitalismo globale deregolamentato di cui sono promotori. Nigel Lawson, ministro dell’economia britannico negli anni ottanta, sostenitore di questa corrente scrisse “la Brexit completerà la rivoluzione economica iniziata da Margaret Thatcher”.
Queste due correnti sono potenzialmente in conflitto, poiché la radicale deregolamentazione proposta dai conservatori porterebbe, con molta probabilità, ad accrescere la precarietà economica della maggior parte della popolazione. Sino a oggi tale conflitto è, tuttavia, rimasto sopito. D’altra parte, però, è già scoppiato un aperto conflitto all’interno del governo post-Brexit di Theresa May. Alcuni ministri, influenzati da potenti gruppi di interesse – quelli finanziari innanzitutto – sono preoccupati per le possibili conseguenze dell’uscita del Regno Unito dal Mercato Unico e dai rischi di instabilità economica, che hanno portato a un forte deprezzamento della sterlina. Essi stanno adoperandosi per una ligth-Brexit, una interpretazione minimalista dell’uscita dall’Unione, che preservi il più possibile lo status quo. Altri, invece, sono determinati nel dare seguito alle richieste populiste di controlli sull’immigrazione, anche a costo di distruggere i rapporti con la Ue. Non è ancora chiaro quale delle due strade verrà seguita.
Le posizioni e le argomentazioni del movimento laburista sono state quasi ininfluenti nel dibattito referendario. La posizione accettata quasi unanimemente dal partito è stata che l’Europa, per come è adesso, non fa gli interessi dei lavoratori, ma un’uscita dall’Unione associata a un programma politico xenofobo e a un’agenda che punta alla deregolamentazione non può certo migliorare la situazione. Nonostante questa posizione fosse più che ragionevole, la debolezza del partito laburista, unita alla posizione pro-Brexit della stampa di destra, ha fatto sì che essa risultasse marginale nel dibattito.
La Brexit ha reso concreta la minaccia che forze centrifughe possano erodere, o forse addirittura distruggere, il progetto europeo. In particolare, il trionfo, con la Brexit, di due portati della destra radicale – liberismo economico estremo e nazionalismo xenofobo – rafforzano le tendenze disgregatrici in tutta Europa. Il fallimento dei leader europei nel rispondere al malessere sociale, che trova invece una distorta espressione in queste forze distruttrici, aumenta certamente le minacce per l’Unione. La passività con cui essa sta affrontando l’avanzata delle forze nazionaliste in tutta Europa è in evidentemente contrasto con la durezza e determinazione con le quali è stata schiacciata la proposta, razionale e pro-europea, di superamento dell’austerità in Grecia.
La divisione Nord e Sud nell’area euro
Non è stato solo il primo ministro britannico Cameron a spargere il seme della discordia in Europa. A suo modo, il ministro delle finanze tedesco, Wolfgang Schäuble, ha fatto lo stesso quando, a luglio dello scorso anno, confrontandosi con il governo greco, non ha dato alternative se non accettare l’austerità e le riforme strutturali richieste o lasciare l’area euro. Schäuble, che già nel 1994 aveva proposto un’Europa caratterizzata da un nucleo centrale, ha chiarito che l’appartenenza all’Unione dei Paesi (quelli periferici!) è reversibile, se questi non si adeguano ai cambiamenti strutturali e all’austerità fiscale e salariale.
Il governo guidato da Syriza non era pronto ad affrontare l’uscita dall’euro e, sotto fortissima pressione, ha accettato le condizioni imposte dagli altri Stati membri dell’area euro, guidati dalla Germania. A causa della continua contrazione della domanda interna, nel 2015 il Pil greco è diminuito ancora dello 0.2%, mentre il tasso di disoccupazione è rimasto attorno al 25%. Se le politiche restrittive hanno abbassato il deficit della bilancia commerciale, senza peraltro affrontarne le cause, hanno però peggiorato i problemi legati al debito greco. Negli ultimi mesi, il conflitto tra Europa e Fondo Monetario Internazionale sulla sostenibilità del debito pubblico greco e la necessità di un suo taglio si è intensificato. I Paesi dell’Europa centrale, tra cui la Germania, sono particolarmente riluttanti all’idea di tagliare il debito greco, nonostante i loro governi siano pienamente coscienti del fatto che ciò sarà inevitabile.
I programmi di adeguamento strutturale sostenuti dalla Commissione Europea e dai governi del nucleo centrale europeo, non hanno affrontato la profonda divisione che corre tra Nord e Sud, né il problema della debolezza delle strutture produttive e della deindustrializzazione nella periferia Ue. Il deprezzamento dell’euro, unito al trasferimento del turismo di massa da Egitto, Turchia e Tunisia ai Paesi dell’ovest del Mediterraneo, ha alleviato la situazione di Spagna e Portogallo.
Analogamente, la riduzione del grado di restrittività delle politiche macro deciso sia dal governo provvisorio della destra in Spagna, sia dal neo eletto governo progressista portoghese, con la sua aperta politica anti austerità, hanno contribuito a una qualche, lieve ripresa economica. Nonostante i due governi non abbiano rispettato le regole di bilancio imposte dalla Commissione Europea, in autunno 2016 non sono stati sanzionati. Anche il governo tedesco ha sostenuto questa decisione, il che ha lasciato margine di manovra al partito popolare spagnolo, importante alleato del tedesco Cdu/Csu, in uno scenario politico particolarmente incerto. Tuttavia la flessibilità concessa non deve essere interpretata come un cambio di direzione generale.
Sebbene i Paesi del nord Europa godano di un tasso di disoccupazione più basso rispetto a quelli del sud, sono anche loro esposti ai pericoli causati dagli squilibri presenti nell’economia europea. Ad esempio, essi sono, data la loro apertura economica e commerciale, particolarmente vulnerabili all’eventualità di una recessione indotta dalla Brexit in Gran Bretagna e nei maggiori Paesi europei. La crescita delle esportazioni (misurate in valore per includere il petrolio norvegese), dopo una lieve ripresa successiva alla crisi, è stata bassa in tutti i Paesi del nord (con l’eccezione dell’Islanda).
La situazione in Svezia e Norvegia è stata in qualche modo alleggerita grazie alla variabilità del tasso di cambio delle rispettive monete, mentre la Finlandia, facendo parte anche dell’Unione Monetaria, non ha potuto far fronte con il deprezzamento della moneta agli specifici shock che l’hanno colpita – i problemi della Nokia e le sanzioni alla Russia in particolare –, la qual cosa sarebbe stata particolarmente necessaria per sostenere l’industria del legno e dell’acciaio.
Analogamente, in Danimarca l’ancoraggio della moneta all’euro ha contribuito alla stagnazione delle esportazioni, sin dal 2010. Sebbene il flusso dei migranti abbia causato una crescita della spesa pubblica in Svezia, tale politica attiva discrezionale non è stata usata per aumentare l’occupazione; in Finlandia, invece, la crisi è stata ulteriormente aggravata dalle politiche di correzione fiscale mirate a soddisfare le richieste europee. In generale, l’ortodossia economica non ha permesso politiche di bilancio attive e solo la politica monetaria fortemente espansiva della Bce e delle banche centrali svedesi e norvegesi, con il loro pericoloso impatto sui prezzi delle case, ha permesso alla spesa interna di compensare, almeno parzialmente, la bassa domanda di esportazioni.
I rifugiati e la rottura dell’area Shengen
L’arrivo di un gran numero di rifugiati dal Medio Oriente e dai Paesi africani nel 2015 e a inizio 2016 ha evidenziato le spaccature interne alla Ue. Mentre le procedure non formalizzate utilizzate per gestire la crisi hanno portato a scaricare il peso sui Paesi periferici, la regolamentazione Ue sui rifugiati – derivante dalla Convenzione di Dublino – indica esplicitamente che a farsi carico dei migranti devono essere i Paesi di primo ingresso nell’Unione, tipicamente i più poveri. Nel 2015 questa scelta ha messo particolarmente in difficoltà la Grecia. Nell’estate del 2015 è apparso evidente che il governo greco – già affamato dalle politiche di austerità – era ormai sopraffatto dall’emergenza.
La decisione del governo tedesco di accogliere i rifugiati di guerra, particolarmente siriani, ha aiutato la Grecia, ma ha comportato problemi con altri governi, dall’Ungheria alla Svezia. Essa, assunta senza previa consultazione degli altri Paesi, ha riconosciuto implicitamente il fallimento degli accordi di Dublino. Da settembre 2015 a marzo 2016 sono state adottate soluzioni temporanee, non previste dalla normativa in vigore, come quella dei corridoi umanitari tra Germania e Croazia, attraverso i quali ai rifugiati è stato consentito di raggiungere l’Europa centrale.
Queste misure sono state, però, fortemente avversate da forze nazionaliste conservatrici come il governo di Fidesz in Ungheria. Esse si sono fortemente mobilitate per chiudere le frontiere agli immigrati e costruire muri. Queste istanze hanno trovato risonanza nei partiti cristiano-democratici e, addirittura, in alcuni partiti social-democratici. Rappresentanti di alto rango di governi come quello ungherese e austriaco sono andati in visita in Macedonia – Paese candidato a entrare nell’Unione – elogiando come questa stesse difendendo i confini “europei”. Implicitamente, hanno così mostrato come ci sia un Paese considerato “ridondante” nell’area Shengen – ancora una volta la Grecia.
I Paesi Ue si sono dimostrati incapaci di trovare una nuova formula per distribuire gli oneri associati alla crisi dei migranti. Invece di un più che giustificato approccio umanitario associato a circostanze eccezionali, hanno optato per esternalizzare la gestione del problema. A tal fine, il 10 marzo 2016 è stato siglato un accordo con la Turchia, che prevede che essa accetti i rifugiati in cambio di soldi, mentre la Ue si impegna a ricevere un numero limitato di rifugiati siriani provenienti dalla Turchia; inoltre, è prevista l’accelerazione dei negoziati di accesso della Turchia all’Unione e l’abolizione del visto per l’ingresso nella Ue dei cittadini turchi. In pratica, il governo turco ha bloccato i rifugiati in Turchia, impedendogli di raggiungere la Ue, in cambio dell’acquiescenza europea rispetto al carattere sempre più repressivo del regime che governa quel Paese.
L’imposizione del Comprehensive Trade and Economic Agreement col Canada (Ceta)
Alla fine di ottobre 2016 la Commissione e, più in generale, tutte le forze liberiste hanno utilizzato tutti gli strumenti a loro disposizione per far sottoscrivere a tutti gli Stati membri il trattato Ceta con il Canada. Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha elogiato questo accordo di libero scambio come “il più progressivo” mai siglato dall’Unione. Forti correnti interne ai partiti di sinistra, ai sindacati e ai movimenti sociali hanno, però, visto in questo accordo molti elementi regressivi dal punto di vista della democrazia e dello stato di diritto.
Una delle clausole più controverse riguarda la creazione di un tribunale che permetterebbe agli “investitori” (le grandi multinazionali) di citare in giudizio i governi per ottenere compensazioni economiche nei casi in cui ritengano che la regolamentazione nazionale leda i loro diritti, così precostituendo un privilegio legale per le imprese multinazionali. Altri elementi di preoccupazione riguardano, fra gli altri, i servizi pubblici e gli standard sanitari. Accordi commerciali come il Ceta scolpiscono nella roccia le regole liberiste, riducendo grandemente lo spazio per una ri-regolamentazione democratica. Le negoziazioni per il Ceta sono rimaste riservate a lungo, nascoste all’ombra delle trattative per la Transatlantic Trade and Investment Partnership (il Ttip), basata sulla stessa filosofia.
Quando le negoziazioni per il Ttip sono saltate, viste le forti resistenze, le forze del libero mercato hanno messo l’approvazione del Ceta fra le loro priorità. Di fatto, molte società americane hanno sedi in Canada e possono, perciò, comunque avvalersi del Ceta. In un certo senso, il Ceta è un sotterfugio per imporre comunque le regole del Ttip. Sebbene in Germania le proteste contro il Ttip e il Ceta siano state particolarmente accese, i social-democratici hanno ceduto alle pressioni dei conservatori loro alleati, del mondo degli affari e di Bruxelles.
Il partito social-democratico austriaco ha negoziato una dichiarazione interpretativa di alcuni punti critici, che verrà allegata al trattato. L’ultimo ostacolo alla firma è venuto dalle regioni belghe della Vallonia e di Bruxelles. La Vallonia, in particolare, aveva evidenziato già un anno prima le sue obiezioni alla Commissione ma, ciononostante, quest’ultima ha scelto di fissare comunque la data della cerimonia per la firma. Ciò si è rivelato in parte un errore di calcolo, in quanto il governo regionale ha fatto slittare la data prevista, cedendo, infine, solo dopo aver negoziato una dichiarazione speciale.
Il commissario europeo Günther Oettinger ha reagito alle controversie sul Ceta chiedendo che i governi nazionali non interferiscano con le politiche commerciali europee. L’intento di questa dichiarazione è, evidentemente, quello di contrastare l’opposizione al trattato tramite la centralizzazione. Il percorso di ratifica del Ceta da parte dei parlamenti nazionali si preannuncia, tuttavia, accidentato. Di fatto, il modo in cui l’Europa ha insistito per l’approvazione del Ceta aggrava la crisi di legittimità europea e fomenta le tendenze disgregatrici.
Le relazioni Ue-Usa dopo l’elezione di Trump
L’ascesa dei partiti nazionalisti di estrema destra non è rimasta confinata all’Europa. Negli Usa, l’oligarca Donald Trump ha vinto con un margine ristrettissimo le elezioni presidenziali, grazie al supporto di varie forze di destra. Gli elementi chiave della sua campagna sono stati un’aggressiva retorica anti-immigrati, la promessa di abbassare le tasse e la fine di trattati commerciali come il Ttip. Se realizzate, le promesse di interrompere le negoziazioni per il Ttip e di ridurre le spese americane a sostegno della Nato cambieranno significativamente le relazioni tra Usa e Ue.
Dopo l’elezione di Trump, si è riacceso il dibattito sulla formazione di una “difesa comune”. In un contesto di “cooperazione strutturale permanente”, la cooperazione militare tra gli Stati membri non può che aumentare. In effetti, sia i deputati europei cristiano-democratici che quelli social-democratici hanno chiesto un aumento della spesa militare da parte dei singoli Paesi: in un contesto dove molteplici sono gli elementi di crisi, emerge dunque un ampio consenso, che va dai social-democratici alle destre nazionaliste, per una maggiore militarizzazione dell’Unione e una politica estera più aggressiva. Questa spinta militarista deve essere contrastata con decisione dalle forze di sinistra e dai movimenti per la pace.
Idee e strategie per leggere le tendenze disgregative
L’ampio consenso tra i cristiano-democratici, i social-democratici e i nazionalisti di destra non va oltre la militarizzazione della politica estera. Le élite europee hanno intrapreso percorsi differenziati per fronteggiare le molteplici crisi e le tendenze disgregative. Queste strategie sono strettamente legate ai differenti scenari futuri considerati e ai diversi modi di guardare all’Europa. Come nel caso della Brexit in Gran Bretagna, anche in Europa sono le forze di destra che dominano il dibattito sul futuro dell’Unione.
Cercare di sopravvivere in qualche modo: questo è il modo prevalente di gestione delle molte crisi che affliggono l’Europa. È l’approccio privilegiato dalla maggior parte dei cristiano-democratici, come dei social-democratici e dei liberali. Si tratta di una strategia che punta a proseguire nell’attuazione del modello neoliberista di integrazione e a preservare l’attuale configurazione geografica dell’Unione Monetaria e dell’area Shengen. È un approccio che ottiene il supporto delle maggiori multinazionali, ma che non fa in alcun modo i conti né con le divisioni tra centro e periferia dell’Unione, né con la sua perdita di legittimazione agli occhi delle classi popolari. Nonostante questa strategia abbia la pretesa di preservare il processo di integrazione europeo e i suoi confini geografici, la mancanza di elementi di promozione della coesione non potrà che accelerare il processo di disgregazione europeo.
Vanno anche evidenziate due sotto-varianti di questa strategia.
Cercare di sopravvivere con un po’ più di flessibilità fiscale e maggiori investimenti pubblici. È la strategia perseguita principalmente dai social-democratici e, in parte, dalle forze di sinistra in Francia e nei Paesi mediterranei. Essa punta a integrare l’approccio sopra descritto con una combinazione di flessibilità fiscale e investimenti pubblici. Si cerca di ampliare lo spazio per gli interventi di politica economica alleggerendo le regole fiscali. Questa strategia è caratterizzata da una qualche maggiore attenzione ai problemi di coesione dell’Unione rispetto alla variante principale.
Cercare di sopravvivere restringendo e rendendo più rigida l’area Schengen. Questa variante invoca il ritorno temporaneo dei controlli alle frontiere nell’area Schengen e vuole escludere dall’area i Paesi che non sono disposti a tenere rifugiati e migranti “indesiderati” fuori dai confini nazionali. Quest’approccio è perseguito soprattutto dalle correnti nazionaliste interne ai partiti cristiano-democratici dei Paesi del nucleo centrale europeo e dei Paesi più orientali dell’Europa centrale, ma esso gode del sostegno anche di alcuni partiti social-democratici. De facto questa strategia sta già prendendo piede, come dimostrato, ad esempio, dalla reintroduzione di controlli temporanei alle frontiere e dalla costruzione di barriere fisiche di confine all’interno della stessa area Schengen.
Core Europe: la costruzione di un nucleo centrale europeo. L’Europa è già caratterizzata da differenti gradi di integrazione. Tradizionalmente, il concetto di Europa core è stato finalizzato a intensificare l’integrazione neoliberista tra i Paesi che ne dovrebbero farne parte. Per questo come area di riferimento si guarda a un insieme di Paesi più ristretto e omogeneo all’interno dell’area euro. Questa visione è stata ampiamente dibattuta all’interno dei circoli cristiano-democratici dei Paesi interessati. I partiti della destra nazionalista che propongono questa visione, come Freiheitliche Partei Osterreichs (Fpö) o Alternative fur Deutschland (AfD), puntano soprattutto a rendere l’Unione più piccola e omogenea, vogliono liberarsi dei Paesi periferici che ritengono un peso. Le proposte delle forze di destra dei Paesi periferici, come in Italia la Lega Nord o, in modo più lieve, il Movimento 5 Stelle, puntano ad abbandonare l’eurozona e sono dunque complementari a quelle che mirano alla costruzione del nucleo centrale.
L’Europa delle nazioni. Alcuni partiti della destra nazionalista sostengono che il processo di integrazione europeo debba focalizzarsi sul Mercato Unico e la relativa regolazione economica. I partiti della destra nazionalista nell’Europa dell’est, come Fidesz in Ungheria o Prawo i Sprawiedliwość (PiS), in Polonia ritengono, invece, fondamentali anche gli apporti dei fondi europei per lo sviluppo regionale. Tuttavia, essi invocano negli altri campi più libertà per gli Stati nazionali, in parte per realizzare strategie competitive, in parte per promuovere un’agenda politica nazionalista e conservatrice (ad esempio, in ambiti quali l’identità sessuale o le politiche sociali). Alcune forze della destra nazionalista, come il Front National in Francia, hanno formulato vaghe idee di “un’altra Europa”, tanto poco definite da non apparire sostanzialmente distinte da quelle che mirano alla completa dissoluzione dell’Unione.
Idee e strategie per la sinistra
Un’altra Europa: un federalismo europeo di sinistra: il concetto di un’altra Europa è stato usato anche da alcune forze di sinistra, ma con un significato completamente diverso. Il fine è quello di rifondare democraticamente la Ue, gettando le basi per un federalismo democratico europeo e per un’integrazione più equilibrata. Il punto è che i presupposti politici per l’attuazione di questa agenda sono particolarmente difficili da realizzare, sarebbe necessario un largo consenso generale e tra gli Stati membri, un contesto, insomma, opposto a quello che sembra prevalere attualmente.
A fronte del manifestarsi di forti disequilibri di potere fra i Paesi Ue e dopo l’esperienza greca, un crescente numero di forze di sinistra chiede ora l’attuazione di esplicite politiche di promozione sociale, che contemplino il non rispetto delle regole europee e, laddove necessario per intraprendere politiche progressiste, anche l’abbandono della moneta unica.
I due differenti approcci della sinistra differiscono principalmente nel giudizio su cosa sia politicamente realizzabile all’interno dell’Unione e su cosa potrebbe essere realizzato attraverso le singole politiche economiche nazionali.
Entrambe le prospettive appaiono di difficile realizzazione senza una maggiore unità politica e un maggiore incidenza elettorale della sinistra rispetto all’attuale. Malgrado contestazioni radicate negli specifici contesti nazionali costituiscano la più immediata forma di sfida alle politiche attuali, EuroMemo continua a ritenere indispensabile una prospettiva internazionale e a sostenere la necessità di un approccio coordinato a livello europeo per promuovere la ripresa economica e la giustizia sociale.
DIBATTITO. Dobbiamo ancora credere nell’Europa?

![]() La linea degli Europeisti critici ma Europeisti convinti, come Umberto Allegretti.
La linea degli Europeisti critici ma Europeisti convinti, come Umberto Allegretti.
UNIONE EUROPEA
di Umberto Allegretti, su Rocca
problemi transizioni prospettive
Col nuovo anno, la situazione in seno all’Unione Europea, che si era già così complicata nei due anni precedenti con le reazioni alle migrazioni e con il referendum britannico per l’uscita del Regno Unito dall’Unione (cosiddetta Brexit), si è fatta ulteriormente complessa e delicata. Così da suscitare gravi preoccupazioni in chi, come crediamo si debba, ritiene che questo lascito delle precedenti generazioni – la costruzione di un’Europa unita – sia positivo nonostante alcuni notevoli difetti che la affliggono. La sua creazione dopo i nazionalismi dell’Ottocento e della prima metà del Novecento, che hanno condotto alle due terribili guerre mondiali, ha realizzato la pace nel nostro continente (salvo la brutta vicenda della ex-Jugoslavia). E ha dato ai popoli europei l’unico modo di essere ancora nel mondo portatori di grandi valori e capaci di farli valere autorevolmente con una propria cultura e una propria politica, di fronte alla crescita delle grandi unità – oltre che gli Stati Uniti, la Russia, la Cina e gli altri giganti asiatici – presenti ormai come attori sulla scala mondiale. I singoli Stati europei non sarebbero infatti capaci di far fronte a quei grandi complessi continentali su un piano di parità, promuovendo la democrazia – per carente che sia –, il valore e la libertà della persona umana e la socialità e solidarietà fra tutti gli uomini, anch’esse carenti ma operanti e pregne di possibilità di espansione e di miglioramento.
migrazioni e reazioni
Nel 2015 e 2016 non a caso l’Europa ha rappresentato il maggior polo di attrazione delle grandi migrazioni dall’Africa e anche dall’America Latina, e non solo per l’attrazione della sua economia sviluppata. Purtroppo, a fianco di atteggiamenti complessivamente virtuosi della Germania (con l’accoglienza data a circa un milione di rifugiati), e dell’Italia, che si sta prodigando per salvare nel Mediterraneo le vite umane di tanti africani spinti verso di lei dalle loro guerre e dalla loro fame, sono andati maturando gravi comportamenti egoistici. Come quelli – per vero incredibili, vista la esiguità delle quote di rifugiati loro assegnate dalle decisioni dell’Unione – dei paesi detti di Visegrad e comunque di tutti i paesi dell’Europa centro-orientale usciti dall’esperienza comunista sovietica, a cui corrispondono anche comportamenti di rifiuto dell’immigrazione da parte di fasce e partiti delle nostre società occidentali, la cui influenza si teme possa aggravarsi con gli eventi elettorali previsti in vari paesi membri dell’Unione per il 2017.
Questo del come affrontare le migrazioni rimane uno dei massimi problemi irrisolti nell’Unione. Sembra ora che alcuni progetti in corso o avanzati potrebbero migliorare la situazione. Il piano europeo che prevede investimenti in Africa, soprattutto nella fascia del Sahel da cui provengono i più tra i migranti, dovrebbe aiutare a trattenere nei loro paesi – se gli investimenti saranno adeguati e ben sorvegliati nel loro uso a favore dei popoli e non di governi spesso corrotti – una buona parte di coloro che fuggono per i fattori sopra ricordati. Ma a che punto sia la realizza- zione non è noto. Si è poi proposto, dalla nostra rappresentante Mogherini e da altri membri della Commissione europea, un ulteriore piano di vigilanza sulle immigrazioni attraverso la Libia, che è responsabile, assieme alla traversata del deserto da UNIONE parte degli abitanti del Sahel. Il piano consiste nella diretta sorveglianza europea della costa libica contro i barconi di migranti in cui tanti muoiono; ma purtroppo richiederebbe la collaborazione di quel governo libico con base a Tripoli che l’Onu ha riconosciuto ma che non ha l’effettivo governo del vasto paese. Infatti una seconda ipotesi prevede che la sorveglianza europea – a cui comunque gli stati del centro e nord Europa dovrebbero partecipare più vigorosamente di quanto ancora non facciano, per evitare che tutto il peso ricada sulle forze italiane – si svolga nel mare non territoriale, al largo della Libia, ma sarebbe indubbiamente meno efficace. Che invece l’Europa possa vigilare i confini tra i paesi del Sahel e il Sud libico pare ancora più problematico e comunque richiede anch’esso l’accordo dei vari paesi africani.
l’integrazione e le questioni aperte
Rimane poi il problema di una vera integrazione dei migranti in Europa; e su questo punto l’Italia è ancora indietro, perché tarda ad approvare norme di legge, pur da tempo proposte, che diano la cittadinanza ai nati stranieri nel nostro paese (cosiddetto jus soli) e non dispone ancora di sufficienti mezzi di promozione dei diritti (allo studio, alla casa ecc.) degli stranieri stessi immigrati, in cambio di un lavoro e di un apporto demografico che essi danno al nostro paese.
Un secondo grande problema è quello dei modi di uscita della Gran Bretagna dall’Unione, voluto dal referendum dello scorso giugno. Le questioni aperte riguardano le due parti: la Gran Bretagna e l’Unione. Sul primo versante, la May, primo ministro inglese, comportandosi peggio della Thatcher, si è confermata, dopo incertezze e discussioni, per un’uscita «dura» («non manterremo neanche un pezzo di Ue», che prevede non solo la fuoriuscita dal mercato comune ma anche restrizioni gravi all’ingresso di stranieri anche europei nel paese, per esempio per motivi di studio. La May ha per giunta minacciato di uscire dall’unione doganale (che è cosa diversa dal mercato comune) e di abbassare le tasse sulle società, trasformando così il suo paese in un gigantesco paradiso fiscale! Vorrebbe al tempo stesso stringere con l’Unione accordi di libero scambio che diano alla Gran Bretagna uno status simile nel commercio e sul piano finanziario a quello dell’Unione e altri privilegi, non più giustificati dalla sua uscita.
Non c’è molto da sperare dalla discussione nel Parlamento inglese, di cui pure, con correttezza costituzionale, le corti inglesi hanno imposto al governo l’intervento prima di notificare ufficialmente all’Unione l’uscita stessa, notificazione non ancora avvenuta ma promessa per fine marzo. Anche se il voto parlamentare potrebbe imporre al Governo alcune condizioni più moderate per le trattative con l’Unione.
la Scozia europeista e il fattore Usa
C’è poi il problema della contrarietà all’uscita da parte di porzioni significative del Regno Unito, per prima la Scozia, che nel voto ha negato il suo consenso alla Brexit, e che nel caso potrebbe chiedere la separazione dall’Inghilterra e l’ammissione all’Unione come nuovo partner. Sul secondo versante l’Unione deve negoziare con forza le condizioni di uscita, ma per ora non lo sta facendo a sufficienza.
Poi c’è il fattore americano. Il nuovo (purtroppo!) Presidente Trump è fiero partigiano di un rapporto privilegiato con quel che rimarrà della Gran Bretagna dopo la esecuzione della Brexit, e addirittura vuole favorire la disintegrazione dell’Unione. Riuscirà la sua influenza su questa doppia problematica? Lo si può temere e però anche sperare il contrario: molto dipende dall’atteggiamento dei membri dell’Unione.
in cerca dello spirito europeo
Ci sono infine i problemi più noti. La politica dell’Unione sul terreno economico, imposta soprattutto dalla Germania, ha diviso sempre più l’Unione in due parti: un Nord leader e avvantaggiato, un Sud discriminato. A parte alcune colpe di scarsa avvedutezza imputabili al Sud (come quelle italiane) è l’egoismo del Nord che finora ha escluso una politica di crescita attraverso forti investimenti. Ora alcuni piani di investimento sarebbero pronti, ma ancora non c’è certezza, e tutto dipende da come verranno gestiti.
Insomma, gravi questioni ci aspettano e occorre perciò che in paesi come il nostro si incentivi lo spirito europeo, affinché noi possiamo dare un apporto positivo, come governo e come popolo, per la soluzione dei problemi sul campo.
Umberto Allegretti
OGGI sabato 25 febbraio 2017





————————————————————————————————-
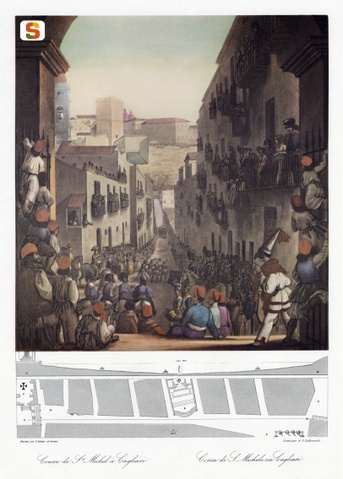
 Carnevale cagliaritano e anfiteatro romano: piccoli successi da festeggiare.
Carnevale cagliaritano e anfiteatro romano: piccoli successi da festeggiare.
![]() di Vito Biolchini, su vitobiolchini.it.
di Vito Biolchini, su vitobiolchini.it.
————————————————————————————————————

——————————————————————–
 INTERNAZIONALE
INTERNAZIONALE
Birmania. I silenzi della Signora.
di Raffaele Deidda su Aladinews.






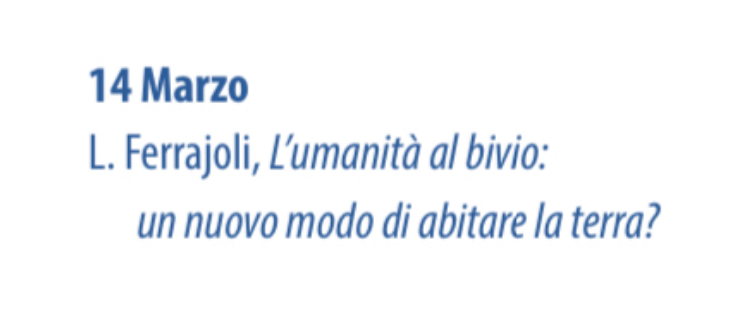





 AService Studio
AService Studio