Editoriali
Rocca e’ online
 Venti di guerra continuano a percorrere tre tra il mondo portando morte, distruzione, catene di odio seminate per le generazioni future. Fiorisce il commercio delle armi e ci si dota di leggi per nasconderlo. Ritorna l’idea nefasta e storicamente falsificata del si vis pacem para bellum. Insomma a sopravvivere oltre l’ideologia del libero mercato come longa manus capace di governare il mondo verso magnifiche sorti e progressive, torna con forza la sua speculare sorella, secondo la quale la sicurezza si realizza blindandosi tutti dentro la corazza d’acciaio di sistemi d’armi sempre più sofisticati, letali, costosi. Ringraziamo Amaro Rafael De Charvalho (Amaro della Quercia) per l’opera che ci ha consentito di utilizzare per la nostra copertina e salutiamo con lui Alberto Maggi e Ricardo Perez Marquez che animano l’esperienza preziosa e amica del Centro Studi Biblici “Giovanni Vannucci” di Montefano (Mc). L’immagine ci restituisce con grande e drammatica forza la disperazione, il dolore e insieme la volontà di vita a Gaza e nelle altre zone di guerra. Una guerra che ormai e sempre più uccide i civili, le donne che danno e curano la vita, i vecchi nella stagione del loro riposo e soprattutto i bambini ammazzati o mutilati mentre proteggono i loro amici animali o i loro giocattoli animati.
Venti di guerra continuano a percorrere tre tra il mondo portando morte, distruzione, catene di odio seminate per le generazioni future. Fiorisce il commercio delle armi e ci si dota di leggi per nasconderlo. Ritorna l’idea nefasta e storicamente falsificata del si vis pacem para bellum. Insomma a sopravvivere oltre l’ideologia del libero mercato come longa manus capace di governare il mondo verso magnifiche sorti e progressive, torna con forza la sua speculare sorella, secondo la quale la sicurezza si realizza blindandosi tutti dentro la corazza d’acciaio di sistemi d’armi sempre più sofisticati, letali, costosi. Ringraziamo Amaro Rafael De Charvalho (Amaro della Quercia) per l’opera che ci ha consentito di utilizzare per la nostra copertina e salutiamo con lui Alberto Maggi e Ricardo Perez Marquez che animano l’esperienza preziosa e amica del Centro Studi Biblici “Giovanni Vannucci” di Montefano (Mc). L’immagine ci restituisce con grande e drammatica forza la disperazione, il dolore e insieme la volontà di vita a Gaza e nelle altre zone di guerra. Una guerra che ormai e sempre più uccide i civili, le donne che danno e curano la vita, i vecchi nella stagione del loro riposo e soprattutto i bambini ammazzati o mutilati mentre proteggono i loro amici animali o i loro giocattoli animati.
La via della guerra e del riarmo uccide in molti modi: distruggendo persone e cose (e quante macabre riunioni per posizionarsi bene alla roulette esclusiva della ricostruzione); seminando odio e rancore che solitamente definiamo bestiali ma che in realtà nessuna bestia prova ma che possono essere solo tragicamente umani; creando povertà con la concentrazione di grandi risorse verso le spese militari. Per le quali non ci sono mai i vincoli di bilancio che limitano gli investimenti per la salute, l’istruzione, il sostegno a chi sopravvive ai limiti della miseria.
Di fronte a ciò è veramente necessario che la richiesta di cessate il fuoco e di vie negoziali sia sospinta da una decisa e ampia mobilitazione nonviolenta contro l’aumento delle spese militari, per la loro trasparenza, per la ricostruzione di una grammatica della pace, capace di garantire buon vivere e sicurezza assai più delle armi. D’altra parte quanto più gigantesca si fa la sproporzione delle forze tanto più la via della nonviolenza diventa quella attraverso cui i popoli possono far sentire la propria voce e far pesare il proprio bisogno di pace, di libertà e di uguaglianza. Parole desuete, vecchie bandiere da ritirar su dalla fanghiglia ideologica in cui erano state abbandonate.
Dentro questo difficile orizzonte si può rilanciare una forte stagione europeista, secondo l’ispirazione immaginata a Ventotene nel periodo nero delle dittature e del suicidio di questo antico continente. Pensare un’Europa che in crescente autonomia sia tra i protagonisti del mondo multipolare che già si delinea. Numerosi, autorevoli contributi, approfondiscono in questo numero i temi qui appena accennati.
*
In Italia si accresce lo stillicidio di morti sul lavoro, a Firenze e in ogni parte del Paese. Soprattutto ma non solo nel settore dell’edilizia. Di solito alla base vi è una feroce logica di sfruttamento, di lavoro nero, di evasione contributiva, di risparmio sui presidi di sicurezza. I controlli quasi non ci sono. La medicina del lavoro è pressoché morta. I subappalti a cascata fanno il resto. E alla fine nessuno paga, le aziende peggiori competono slealmente con quelle migliori. Gli immigrati “cattivi” diventano buone risorse da fatica e da schiavitù. Se compiono reati bisogna metterli dentro e buttar via la chiave si dice, se i reati li compiono imprenditori nostrani senza scrupoli facendoli lavorare in scarsa sicurezza e pochi soldi, ciccia. Tutto ciò è parte di una generale svalutazione del lavoro, in particolare di quello operaio e produttivo. E sarebbe ora che chi pensa di rappresentarlo si desse una mossa, imponendo con la lotta (e come se no?), misure efficaci e controlli severi. Le proposte ci sono, per ora manca la volontà.
*
Ultime dalla Sardegna. Su populu sardu ha deciso di cambiare. Una scelta coraggiosa l’elezione di una donna, competente, combattiva. Un segnale pesante per il centralismo romano che pensa di calare come un falco sui territori (ma che diavolo di autonomia differenziata è!). Un segnale incoraggiante non tanto per un generico campo largo ma per un campo di forze aperto, capace di procedere senza schemi rigidi, cogliendo le peculiarità dei territori, costruendo una tensione unitaria che via via sia capace di darsi un convincente programma di governo. Ma non bisogna dimenticare che anche in Sardegna la metà degli aventi diritto non è andata a votare. C’è ancora molto lavoro da fare per ricostruire un rapporto di fiducia tra cittadini e politica. O meglio per riportare i cittadini all’impegno politico e civile.
—————————————-

——————————————-
*Alessandra Todde
Si laurea all’Università di Pisa in Ingegneria informatica, successivamente consegue una laurea in Scienze della Formazione.
Fondatrice e CEO di Energeya, acquisita da FIS Global nel 2015, ha ricoperto il ruolo di Senior Advisor Energy Markets in FIS Global. E’ stata Sales Director South & Eastern Europe in Sungard e Client Relationship Manager Sud Europa in Nexant.
Amministratrice delegata di Olidata, si è poi dimessa perché candidata alle elezioni europee con il Movimento 5 stelle.
A dicembre 2014 la delegazione sarda di AIDDA (Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti di Azienda) la premia come imprenditrice dell’anno.
A dicembre 2018 è stata nominata tra le Inspiring Fifty italiane, riconoscimento alle 50 donne italiane considerate più influenti nel mondo della tecnologia.
Cari sardi abbiamo un’opportunità storica : competenza , onestà e finalmente una Presidente donna ❤
—————————————-
La vittoria di Alessandra Todde. Non sprechiamo l’occasione storica per una nuova Rinascita della Sardegna
 Cara presidente,
Cara presidente,
Ti abbiamo sostenuta non appena la tua candidatura è stata proposta e poi ufficializzata dalla coalizione aperta del centro sinistra. Al di là di ogni appartenenza, sei il nome nuovo che da tanto tempo aspettavamo per guidare una nuova rinascita della Sardegna. Hai vinto nonostante molte avversità, tra cui il fuoco amico di Renato Soru ( che ti ha impedito un’affermazione di più larga portata), le consuete diffidenze di tanti intellettuali spaccapelo e di componenti indipendentiste distanti dal popolo che vorrebbero rappresentare, la celata opposizione di tanti all’affermarsi di una leadership femminile. Sei risultata credibile per ridare dignità alla Regione Autonoma della Sardegna, come strumento al servizio del popolo sardo, creato per consentirne un giusto benessere. Dopo cinque anni disastrosi nei quali sono peggiorate le condizioni di vita della popolazione sarda, soprattutto dei ceti meno abbienti, l’elettorato ha dato fiducia a chi proponeva il rinnovamento. Ai partiti e movimenti appartenenti al cd campo largo, per noi, semplicemente a una coalizione di centro sinistra, il merito di avere intercettato e dato una possibile risposta a questa esigenza diffusa di rinnovamento, anche dei tanti, troppi, che esprimono con l’astensione al voto il proprio dissenso verso la politica così come praticata dai politici al potere. A te Alessandra il compito difficile di guidare questi processi che possono avere compimento solo con la partecipazione popolare, anche attivando concretamente spazi e opportunità, a cominciare dalla radicale modifica della legge elettorale sarda. Così come rifiutiamo la logica del “salvatore della patria”, non intendiamo caricarti come nuova presidente di missioni impossibili, convinti come siamo che dalla situazione di disagio del popolo sardo si possa uscire solo con un impegno collettivo che punti sulla valorizzazione di tutti i cittadini, innanzitutto dei nostri giovani. Con questi intenti, assicurandoti la nostra convinta collaborazione, ci sia consentito pensare che un mondo migliore sia possibile anche con il nostro piccolo contributo.
Siamo appena all’inizio di un percorso impervio ma percorribile ed entusiasmante. Auguri di buon lavoro a te Alessandra carissima, agli eletti della coalizione e a tutti noi.
Franco Meloni, direttore di Aladinpensiero News online.
—————————————-
—————————————-

https://www.vistanet.it/cagliari/2024/02/27/la-foto-del-giorno-uno-splendido-arcobaleno-nel-cielo-di-cagliari/
—————————————-
A Gaza la guerra ha cambiato natura divenendo un genocidio
 INTERVENTO ALLA BIBLIOTECA DEL SENATO
INTERVENTO ALLA BIBLIOTECA DEL SENATO
6 febbraio 2024
Raniero La Valle
Giusta è la vostra proposta che ci ha qui riunito, e tutte vere le cose che sono state dette fin qui, però io credo che noi dobbiamo alzare il livello di coscienza riguardo alla tragedia in atto. Che cosa aspettiamo a prendere atto della catastrofe di cui siamo nello stesso tempo responsabili e autori? Noi non stiamo parlando infatti della guerra di Gaza, come meritoriamente ci avete invitato a fare. La guerra di Gaza è di fatto una radiografia della situazione mondiale, una radiografia fatta con mezzo di contrasto e ad alta definizione. È una confessione sullo stato del mondo. Non è un pezzo di una guerra mondiale a pezzi, come ormai da tempo la chiama papa Francesco, ma è l’anticipazione di una guerra globale ripristinata e sponsorizzata come sostenibile anche “in questa età che si gloria della potenza atomica” (Pacem in terris), un’età dunque nella quale la guerra è stata pienamente recuperata e posta come fonte e culmine della politica
La valutazione che ci avete chiamato a fare della tragedia in corso a Gaza consta di due fattori. Il primo è l’interpretazione di ciò che sta avvenendo, il secondo è l’indicazione delle soluzioni possibili. La soluzione che qui viene proposta è quella di affidare a un mandato dell’ONU la gestione della cosiddetta Striscia di Gaza dopo la fine della guerra, sottraendo questo territorio e la sua popolazione al controllo di Israele. È una soluzione di per sé plausibile, ma è di fatto oggi impossibile per l’avversione che Israele ha concepito verso l’Onu accusata di aver mancato di solidarietà con Israele dopo gli attentati del 7 ottobre, e perché Netanyahu vuole il risultato opposto, il controllo di Gaza per portare a termine l’impresa e farla finita con la questione palestinese.
Più in generale si può dire che questa soluzione è oggi impossibile perché si basa su un errore nella comprensione degli eventi. La questione principale è come debba interpretarsi e definirsi lo scontro militare senza esclusione di colpi che è in corso a Gaza. Questa interpretazione e tanto più necessaria perché come abbiamo detto gli eventi di Gaza non si presentano come una delle tante crisi oggi aperte nel mondo ma rappresentano il punto di caduta, l’evento rivelatore e il codice interpretativo del sistema di guerra in cui si compendia oggi l’intera situazione internazionale.
L’evento di Gaza non è una guerra – la guerra stessa si offenderebbe se quella di Gaza fosse chiamata così – ma è un genocidio. A Gaza la guerra ha cambiato natura divenendo un genocidio. Ancora più esatto è dire che oggi ogni guerra è un genocidio. Come tale la guerra non è più un evento regolato da uno ius in bello in cui si possono commettere dei crimini di guerra, ma è essa stessa un crimine di diritto pubblico, un crimen organizzato compiuto con armi pubbliche invece che con armi private. È come se avessimo perduto la lezione non solo della Shoà, ma di tutta la seconda guerra mondiale con i suoi 60 o 70 milioni di morti. Se a Gaza su una popolazione di 2 milioni e duecentomila abitanti siamo arrivati a decine di migliaia di morti e feriti e un’intera compagine etnica estirpata e distrutta, che cosa sarà mai quando si giungerà a colpire l’obiettivo finale, come il Corriere della Sera chiama il nemico ucciso, rappresentato da un miliardo e 400 milioni di cinesi?
Questo mutato scenario dipende dalla nuova concezione della guerra che è stata adottata a partire dalle scelte strategiche sulla sicurezza compiute degli Stati Uniti dopo gli attentati alle Torri gemelle dell’undici settembre 2001. Quello fu un errore che. come ha detto lo stesso Biden, mai più si dovrà ripetere, e invece oggi ci siamo. Il documento della Casa Bianca sulla sicurezza nazionale degli Stati Uniti del settembre 2002 impostava tutta la concezione della vita internazionale e la tutela della sicurezza degli Stati Uniti sulla lotta al terrorismo che avrebbe dovuto procurare al mondo la realizzazione di una società pacifica a guida americana improntata alla democrazia alla libera impresa e al libero scambio. In questo passaggio veniva teorizzata la nuova concezione della guerra secondo la quale non era più sufficiente la dissuasione dall’aggressione affidata alla potenza militare pronta all’uso e fornita di armi di distruzione di massa: no, non bastava più questo perché questo, anche se ci aveva salvato con l’equilibrio del terrore per tutto il Novecento, non poteva salvarci più, una tale strategia veniva considerata ormai insufficiente a garantire la sicurezza. Essa poteva andare bene durante la guerra fredda quando “la deterrenza era una difesa effettiva” mentre oggi, si affermava, una “deterrenza basata solo sull’ attesa di una risposta non funzionerebbe”. Pertanto veniva adottata la dottrina della prevenzione basata sul fatto che “la migliore difesa e l’offesa”, che “non si poteva permettere agli avversari di sparare per primi” e che tale difesa preventiva per quanto esercitata con prudenza non poteva essere condizionata da limiti di luoghi e di circostanze. Sappiamo dalla storia, diceva la Casa Bianca, che i deterrenti possono fallire e sappiamo dall’esperienza che contro certi nemici non esistono deterrenti. Gli Stati Uniti possono e vogliono mantenere la capacità di sconfiggere ogni tentativo fatto da un nemico, sia uno Stato che un non Stato, di imporre la propria volontà agli Stati Uniti, ai nostri alleati, o ai nostri amici. “Le nostre forze saranno abbastanza forti da dissuadere gli avversari potenziali dal perseguire una campagna militare nella speranza di superare o eguagliare il potere degli Stati Uniti. Quanto maggiore è la minaccia tanto maggiore è il rischio di mancanza di capacità di reazione e più impellente la necessità di intraprendere un’azione anticipatoria in difesa di noi stessi, persino nell’incertezza del luogo e dell’ora dell’attacco da parte dei nemici”.
Così nel settembre 2002. Dopo qualche anno la dottrina totalizzante della lotta al terrorismo veniva considerata superata e veniva sostituita dalla visione del rapporto internazionale come di una competizione strategica la cui posta in gioco è il predominio di una grande Potenza su tutti gli altri. La competizione consisteva appunto nella lotta per vedere chi dovesse essere questo unico soggetto, questo sovrano universale che dovesse imporsi su tutti. “La competizione strategica fra Stati, non il terrorismo, è ora la prima preoccupazione per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti”, diceva il documento sulla sicurezza nazionale firmato dal segretario alla difesa di Trump, Jim Mattis, nel 2018. Andate a vedere su Internet, c’è scritto tutto, l’Intelligenza artificiale lo sa benissimo, siamo noi che non lo sappiamo. Tale documento varato nel corso del 2018 dalla Presidenza Trump presentava la Cina come l’antagonista finale degli Stati Uniti avendo essa come obiettivo di medio termine quello di diventare la potenza egemone dello scacchiere Indo Pacifico e nel lungo termine scalzare gli Stati Uniti dal ruolo di prima potenza mondiale. Questa impostazione è ribadita nei documenti del 12 ottobre 2022 firmati da Biden e Loyd Austin, che ne prevedono la realizzazione entro il decennio o al massimo entro i due prossimi decenni.
Ebbene, la strage in corso a Gaza dimostra che con tale impostazione ogni guerra diventa un genocidio. Se infatti nella discrezionale percezione della minaccia l’imperativo nazionale della sicurezza nazionale è quello della prevenzione, la certezza del raggiungimento dell’obiettivo sta solo nella distruzione o comunque nella riduzione all’impotenza, nella riduzione a niente dell’avversario. Nella guerra della Russia contro l’Ucraina, intentata come azione preventiva per fronteggiare la minaccia della NATO, questo esito non si era ancora reso evidente grazie all’uso controllato della forza da parte della Russia, non dimentica dell’ecatombe della seconda guerra mondiale, mentre si è pienamente manifestato a Gaza dove la estirpazione della popolazione palestinese è stata esplicitamente assunta come obiettivo della guerra, e la prevenzione è giunta fino alle operazioni contro gli ospedali e all’uccisione dei bambini nelle incubatrici e nel ventre delle madri. Se la migliore difesa sta nell’abolizione violenta del nemico, il suo adempimento è inevitabilmente il genocidio. Perciò le guerre di cui una volta si pensava che dovessero essere concluse con una vittoria, non possono più essere concluse se non col genocidio di uno dei due contendenti, o di tutti e due. Questo vuol dire che i mezzi tradizionali per porre termine alle guerre e per evitarne di nuove non funzionano più e che anche le tregue o le garanzie giuridiche offerte da terzi non bastano.
———
ORMAI C’È UNA SOLA USCITA dal sistema di guerra, è la riconciliazione. Questa è la vera risposta all’erompere della crisi di Gaza: la riconciliazione tra ebrei e palestinesi, non solo tra palestinesi ed israeliani ma anche di palestinesi ed arabi con i fratelli semiti del popolo ebreo della diaspora. Come si fa? Non lo so. Non con le armi, ma ormai nemmeno solo col diritto. C’è una grandezza e miseria del diritto, come diceva la tesi di laurea di Giuseppe Dossetti, grandezza e miseria che in questa occasione sono più che mai manifeste. Ci vuole la pace, ma non una pace assoluta come sono accusati di volere i pacifisti, ci vuole una pace anche imperfetta, relativa, non una giusta pace, ma ci vuole una ingiusta pace. Perché è chiaro che oggi una pace fatta in queste condizioni sarebbe una pace ingiusta per i palestinesi, ma anche per i coloni, che ce l’hanno messa tutta per fare i loro kibbutz e i loro insediamenti, sarebbe una pace ingiusta perché ancora non in condizioni di costituire i due Stati per i due popoli, sarebbe ingiusta perché ancora non in condizione di garantire contro ogni rischio possibile la sicurezza dello Stato di Israele, perché non sarebbe in grado di garantire contro il dr. Stranamore di turno l’astensione dall’uso dell’atomica, la pace nel mondo. Eppure questa pace ingiusta è l’unica che oggi può salvarci, come ci ha salvato durante la guerra fredda, che ora è diventata calda. Una riconciliazione tra palestinesi e israeliani che renda possibile la loro convivenza in un’unica terra non è oggi una iperbole umanitaria nè una opzione del buon cuore ma è una soluzione politica, l’unica soluzione politica che finalmente dopo una notte durata più di settant’anni possa porre termine alla tragedia palestinese e anche nostra.
Perché questa soluzione politica possa prodursi bisogna fare appello non solo al diritto, alla politica, ma anche all’etica, alle religioni, alle fedi. Gli incontri tra ebraismo islam e cristianesimo possono offrire una prospettiva di conversione dalle teologie di guerra alle tradizioni di misericordia e di pace. Perché non PENSARE A UN INCONTRO DELLE TRE RELIGIONI SULLA COLLINA di Sion, uno spazio extra territoriale incluso nello Stato israelo-palestinese con capitale Gerusalemme?
“Non c’è nulla che vada oltre le nostre capacità. Possiamo farcela, per il nostro futuro e per il mondo”, hanno scritto, nero su bianco, gli americani a conclusione della loro ultima strategia, 12 ottobre 2022, firmato Joe Biden. Se ce la possono fare loro, ce la possiamo fare tutti.
Ditelo al papa, ditelo a Netanyahu, ditelo a Putin, ditelo alle persone serie, fosse anche il folle di Nietzsche che va gridando Dio è morto.
E non so quale documento consegnarvi alla fine, a quali parole, del presente o del passato, si possa fare appello. Mi è venuto in mente il primo canto della letteratura italiana, il suo autore è Francesco d’Assisi che l’ha composto nel 1226. … “Laudato sii, o mio Signore, per tutte le creature… “ con la preghiera che lo ha accompagnato : “fa di me uno strumento della tua pace: dove è odio, fa ch’io porti amore, dove è offesa, ch’io porti il perdono, dove è la disperazione, ch’io porti la speranza… “
——————————

Newsletter n.329 del 16 febbraio 2024
IL GENOCIDIO E I SUOI CONTI
Cari Amici,
mercoledì 14 febbraio nella nuova sede della Federazione della Stampa in via delle Botteghe Oscure a Roma, Raniero La Valle e Michele Santoro hanno presentato in una conferenza stampa il nuovo soggetto politico “Pace Terra Dignità” e detto del suo disperato grido all’Europa in vista delle prossime elezioni europee, alle quali esso intende partecipare. Questo soggetto politico, nato da un appello firmato da La Valle e Santoro nel settembre scorso per “dare una rappresentanza a tre soggetti ideali che ancora non l’hanno o l’hanno perduta, a tre beni comuni: la PACE, la TERRA e la DIGNITÀ”, vede ufficialmente la luce nel momento in cui nell’ecatombe di Gaza la guerra, quale è stata finora pensata e istituzionalizzata a cominciare dall’Occidente, è giunta al punto di caduta finale oltre il quale c’è solo o il rovesciamento delle politiche in atto o la catastrofe. Il link alla registrazione della conferenza stampa e all’esposizione di Michele Santoro è questo: mentre il testo della introduzione ai giornalisti di Raniero La Valle è pubblicato in questo sito.
Una parola chiarificatrice si deve dire sull’uso del termine genocidio che è diventato motivo di scandalo nella politica italiana e nelle prese di posizione di Israele, quando la vera questione non è quella di regolare l’uso di questa parola, ma di porre termine al crimine che essa significa, come ha chiesto avanzandone la massima urgenza la Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja. Le migliaia di morti, i milioni di persone braccate, in fuga e ammassate nell’ultimo lembo della striscia di Gaza e gli stessi ostaggi israeliani ancora in mano ad Hamas sono indifferenti al modo in cui viene chiamato il loro olocausto, ne sono vittime e basta. Tanto più che nella insensata diatriba sul nome da dare alla carneficina di Gaza e allo scempio del 7 ottobre che l’ha provocata, dopo “56 anni di soffocante occupazione”, come aveva ricordato il segretario generale dell’ONU Guterres, si è giunti a sostenere che il criterio in base al quale decidere se si deve parlare di genocidio o no sarebbe la “proporzione” tra l’entità dell’offesa e l’entità della rappresaglia o vendetta. Da un certo momento in poi perfino Biden, Macron e Tajani hanno cominciato a dire che non c’è proporzione tra il terrorismo del 7 ottobre e il terrore delle 19 settimane che vi hanno fatto seguito fin qui, anche se non è stato precisato a quale punto di questa singolare contabilità di costi e ricavi si doveva fissare l’asticella: giusta la proporzione tra le 1400 vittime tra uccisi ed ostaggi del 7 ottobre e i due milioni e duecentomila persone dell’intera popolazione di Gaza perseguita come colpevole, 1500 per uno? Giusto il prezzo di 28.000 morti palestinesi in cambio dei 105 ostaggi rilasciati grazie al primo negoziato, 267 palestinesi morti per ogni israeliano vivo? Appropriato radere al suolo un gran pezzo di Rafah e almeno 70 morti accertati in cambio della liberazione di due ostaggi? E ha ragione Netaniahu quando dice che non si fermerà finché non avrà finito il lavoro e liberato i 103 ostaggi residui, uno per uno, contro il milione di persone che ha fatto concentrate e fatto bersaglio a Rafah, rendendole per ciò stesso ultimi “scudi umani” di Hamas? Anche il cardinale Parolin ha definito “certamente non proporzionato, con 30 mila morti, il diritto alla difesa invocato da Israele per giustificare questa operazione”, e l’ambasciatore di Israele presso la Santa Sede ha bollato come “deplorevole” questa dichiarazione; ma lui stesso ne ha fatto una questione di proporzione, rivendicando come giusta la percentuale delle vittime di Gaza, che sarebbe di “tre civili per ogni militante di Hamas ucciso”, quando “nelle guerre e nelle operazioni passate delle forze Nato o delle forze occidentali in Siria, Iraq o Afghanistan, la proporzione era di 9 o 10 civili per ogni terrorista”, perciò di tre volte superiore “alla percentuale dell’esercito di Israele”.
Quando si arriva a questa contabilità, vuol dire che l’anima del mondo è perduta, e se ingrandiamo il campo della crisi, fino a comprendervi e a vedervi le altre guerre e l’intera crisi mondiale, scopriamo che l’intera realtà umana e fisica del mondo, e la sua stessa dignità è oggi al punto da poter essere perduta. E giustamente l’”Osservatore Romano” ha replicato che “nessuno può definire quanto sta accadendo nella Striscia un ‘danno collaterale’ della lotta al terrorismo. Il diritto alla difesa, il diritto di Israele di assicurare alla giustizia i responsabili del massacro di ottobre, non può giustificare questa carneficina”.
Si può tornare così all’uso della parola “genocidio”. È una parola nuova che non esisteva anche se popoli interi erano stati sterminati, dagli Indiani d’America agli Armeni in Turchia. Essa è stata coniata dal giurista ebreo polacco Raphael Lemkin, prima ancora che venisse a definire l’olocausto del popolo ebreo, ciò per cui fu adottata nella Convenzione dell’ONU per la prevenzione e repressione del crimine di genocidio, perché questo non avesse a ripetersi mai più nella forma di “distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religiose, come tale”. Genocidio è perciò una parola comune, mentre Shoà è la parola di specie che definisce quello perpetrato contro gli Ebrei. Esso è stato tale da essere considerato non paragonabile con qualunque altro, e per gli Ebrei stessi è diventata una parola sacra che non può riferirsi ad altro che al loro olocausto. Questa è la ragione per cui si può capire la ferita profonda che questa parola apre nella coscienza del mondo, e il rischio che sia confusa con l’antisemitismo, anche se purtroppo essa è atta a nominare altre realtà. Ma è anche la ragione per cui, per amore degli Ebrei e della fraterna amicizia che si desidera mantenere con loro, si può benissimo fare a meno di usarla, non per questo chiudendo gli occhi su altre tragedie. Ma per la stessa avvedutezza occorrerebbe che lo Stato di Israele non fornisse un’autorappresentazione di sé, avanzata come espressione autentica dell’intero Israele, che facesse apparire un popolo vittima di un genocidio come legittimato a infliggerlo ad altri.
Nel sito pubblichiamo un articolo di “Avvenire” che riferisce della controversia tra la Santa Sede e l’ambasciatore israeliano e un articolo tratto dal sito “Gariwo” su Lemkin e il neologismo “genocidio”.
Con i più cordiali saluti,
Chiesa di Tutti Chiesa dei Poveri
Verso l’Assemblea di Costituente Terra

OGGETTO: Assemblea straordinaria
Ai soci di Costituente Terra e alle persone interessate
Carissimi soci di Costituente Terra,
preso atto delle dimissioni del Presidente, Raniero La Valle, al quale esprimo il mio più vivo ringraziamento per il ruolo da lui finora svolto, convoco in qualità di vice-presidente l’Assemblea di Costituente Terra, in base all’art. 21 dello statuto, alle ore 10 del 21 febbraio 2024, presso la biblioteca Vallicelliana, in piazza della Chiesa Nuova 18, Roma, sul seguente ordine del giorno:
———————————-
Relazione introduttiva;
Approvazione del bilancio di Costituente Terra;
Rinnovo degli organi dell’Associazione;
Modifiche dello statuto;
Varie ed eventuali.
————————————-
Attualmente i candidati al Comitato esecutivo sono le seguenti persone, impegnatesi tutte negli ultimi mesi nell’organizzazione di Costituente Terra: Angelica Andreetto, Matteo Bellucci, Claudio Bocci, Silvano Falocco, Carlo Ferruccio Ferrajoli, Luigi Ferrajoli, Lucrezia Fortuna, Dario Ippolito, Andrea Mulas, Paola Paesano, Mimmo Rizzuti, Riccardo Valeriani e Massimo Zucconi. Inoltre, chi vorrà candidarsi a far parte del Comitato esecutivo potrà farlo in Assemblea
Sono soci, ai sensi dello statuto coloro che hanno pagato la quota di iscrizione. Coloro che intendono partecipare alla nostra Associazione in qualità di soci, sono pregati: a) di comunicare, rispondendo a questa lettera – e precisamente all’indirizzo mail di paola.bocci@tim.it – la loro formale decisione di essere soci di Costituente Terra, l’indicazione della città in cui vivono e dei temi della bozza di Costituzione della Terra ai quali sono maggiormente interessati; b) di versare, anche in occasione dell’Assemblea – oppure nelle modalità che vi saranno a suo tempo indicate – la quota di iscrizione, stabilita finora tra un minimo di 1 euro e un massimo di 100 euro.
Molti cordiali saluti,
Il Vice Presidente Luigi Ferrajoli
Costituente Terra
———————————————————-
OGGETTO: Rettifica per la convocazione all’assemblea del 21 febbraio 2024
Ai soci di Costituente Terra e alle persone interessate
Carissimi soci e sostenitori di Costituente Terra,
su richiesta di molti l’assemblea è stata posticipata dalle ore 10.00 alle ore 15.00 del giorno 21 febbraio 2024. Rimane invariato il luogo d’incontro, la Biblioteca Vallicelliana, situata in Piazza della Chiesa Nuova, n.18, Roma. Cogliamo l’occasione per ricordare quanto segue:
Preso atto delle dimissioni del Presidente, Raniero La Valle, al quale esprimo il mio più vivo ringraziamento per il ruolo da lui finora svolto, convoco in qualità di vice-presidente l’Assemblea di Costituente Terra, in base all’art. 21 dello statuto, sul seguente ordine del giorno:
Relazione introduttiva;
Approvazione del bilancio di Costituente Terra;
Rinnovo degli organi dell’Associazione;
Modifiche dello statuto;
Varie ed eventuali.
Attualmente i candidati al Comitato esecutivo sono le seguenti persone, impegnatesi tutte negli ultimi mesi nell’organizzazione di Costituente Terra: Angelica Andreetto, Matteo Bellucci, Silvano Falocco, Carlo Ferruccio Ferrajoli, Luigi Ferrajoli, Lucrezia Fortuna, Dario Ippolito, Andrea Mulas, Paola Paesano, Mimmo Rizzuti, Riccardo Valeriani e Massimo Zucconi. Inoltre, chi vorrà candidarsi a far parte del Comitato esecutivo potrà farlo in Assemblea
Sono soci, ai sensi dello statuto coloro che hanno pagato la quota di iscrizione. Coloro che intendono partecipare alla nostra Associazione in qualità di soci, sono pregati: a) di comunicare, rispondendo a questa lettera – e precisamente all’indirizzo mail di paola.bocci@tim.it – la loro formale decisione di essere soci di Costituente Terra, l’indicazione della città in cui vivono e dei temi della bozza di Costituzione della Terra ai quali sono maggiormente interessati; b) di versare, anche in occasione dell’Assemblea – oppure nelle modalità che vi saranno a suo tempo indicate – la quota di iscrizione, stabilita finora tra un minimo di 1 euro e un massimo di 100 euro.
Molti cordiali saluti,
Il Vice Presidente Luigi Ferrajoli
Costituente Terra
————————————————————

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Luigi_Ferrajoli
————————————————-

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Raniero_La_Valle
——————————————
—————————————-


——————————————-

Antonello Lai, un giornalista al servizio dei cittadini.
———————————————

————————————————


————————————————-

—————————————————

—————————————————-

————————————————-
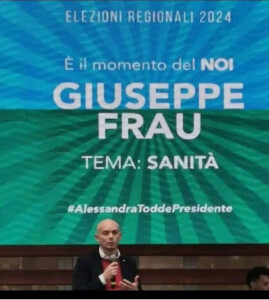
—————————————————-

——————————————————-

———————————————————-

————————————————————

————————————————————-

—————————————————————-
Elezioni che fatica!

Considerazioni partigiane.
Dopo aver riguardato i dati delle precedenti consultazioni elettorali, specie delle ultime due, dico quanto segue.
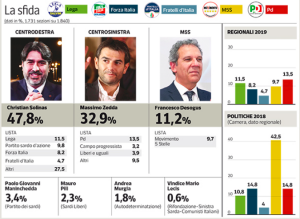
1) Lo scontro sarà inesorabilmente tra le due grandi coalizioni, avvantaggiata quella di centro sinistra. Spiego più avanti.
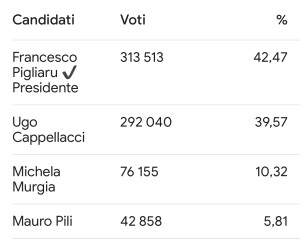
[Elezioni regionali 2014]
 2) La coalizione di Renato Soru nella sostanza sarà ininfluente (confronto obbligato con i dati della sconfitta di Michela Murgia. Vedi nota in calce).
2) La coalizione di Renato Soru nella sostanza sarà ininfluente (confronto obbligato con i dati della sconfitta di Michela Murgia. Vedi nota in calce).
3) La sequenza storica delle ultime consultazioni ha visto l’alternarsi al potere delle coalizioni di centro destra e centro sinistra. Sempre soccombente la coalizione al potere. In questa tornata spetterebbe dunque al centro sinistra la vittoria.
4) Tra i due candidati presidente, spicca la debolezza di Paolo Truzzu, sia per il personaggio in sé, sia per il percorso, pasticciato e controverso che lo ha portato alla nomination.
Paolo Truzzu non è gran che conosciuto in diverse zone della Sardegna.
Senza dubbio meno di Alessandra Todde, a cui peraltro ha giovato, il vantaggio temporale della pre-campagna. Truzzu non sembra proprio entusiasta di questa investitura: “micca l’ho chiesta io!” Sembrerebbe puntualizzare con la sua mimica facciale, più che con le parole.
5) Riproponendo – mutatis mutandis – l’impostazione della precedente campagna elettorale, dove il vero candidato Solinas era “sostituito” nei maxi manifesti dal leader leghista Salvini, questa volta l’immagine giusta sarebbe quella di Giorgia Meloni.  Si fa grande affidamento al vento ancora sostenuto della destra. I risultati non sono certo scontati.
Si fa grande affidamento al vento ancora sostenuto della destra. I risultati non sono certo scontati.
6) I fallimenti della gestione politica uscente sono talmente evidenti, che all’interno della coalizione di centro destra assistiamo a un ricorrente, un po’ ridicolo “scarica barile”. E siccome il capro espiatorio non potrebbe che essere Christian Solinas, ecco l’isolamento del PSdAz, che potrebbe avere come conseguenza il non voto per Paolo Truzzu, da parte di molti sardisti. Difficilmente a beneficiarne direttamente sarà Alessandra Todde, ma di fatto a favorirla.
—————————————————-
7) Molto difficile individuare come si distribuirà l’astensionismo, presumibilmente in aumento.
—————————————————-
8) Non potendo fare un confronto “qualitativo” tra i candidati delle liste delle due coalizioni, conoscendo pochi dello schieramento di centro destra, occorre dire che i candidati del centro sinistra, appaiono complessivamente molto competitivi. Qualcuno farà certo le statistiche, ma a occhio la situazione appare davvero ottima.  Solo un particolare che si ritiene significativo: nell’ambito della coalizione di centro sinistra e’ presente la lista Demos, che rappresenta oggi nei suoi attuali esponenti l’eredità del cattolicesimo democratico.
Solo un particolare che si ritiene significativo: nell’ambito della coalizione di centro sinistra e’ presente la lista Demos, che rappresenta oggi nei suoi attuali esponenti l’eredità del cattolicesimo democratico.
——
Molto dipenderà dalla campagna elettorale? Sicuramente, ma le condizioni di partenza, fanno indurre ad ottimismo, se lo si saprà “praticare”.
Franco Meloni
——————
 Note
Note
Il dato di Michela Murgia è di difficile valicazione da parte di Renato Soru, che dispone di potenziale di gran lunga inferiore. Murgia si fermò al 10,30 e le sue liste molto al di sotto. Con la dispersione totale dei voti.
———————-
Dopo quell’esperienza, da segnalare che in quella successiva (con Solinas vincitor), le tre coalizioni identitarie (Maninchedda, Pili, Murgia) si schiantarono. Tutto secondo le previsioni! In questa tornata è presente la lista di testimonianza Sardegna R-esiste (quella dei quattro mori), candidata presidente Lucia Chessa. Previsioni tutt’altro che buone, ma se questo è nella consapevolezza dei proponenti, auguri!
—————————
Illustrazione inviataci da Angelo Corda

Ma la Politica è un’altra cosa.

———————————
Il fatto di stasera (mercoledì 17 gennaio 2024).
La Procura affossa Solinas ma in Sardegna la “questione morale” non esiste più da tempo
17/01/2024 alle 19:30 di Vito Biolchini su vitobiolchini.it
Corriere.it del 17 febbraio 2024
Decidendo, con una tempistica che non può che far sorgere qualche domanda, un bel sequestro cautelare di beni e immobili per un valore di circa 350 mila euro nei confronti di sette persone, tra cui il presidente della Regione Christian Solinas e il suo consigliere regionale più fidato Nanni Lancioni, la procura di Cagliari ha tolto, volente o nolente, le castagne dal fuoco al centrodestra. Il candidato sarà Paolo Truzzu e i sardisti, a poche ore dalla chiusura delle liste e degli apparentamenti, diventano i paria di questa competizione elettorale.
Chi se li vuole caricare, adesso? Chi vorrà i loro voti? E i Quattro mori fra due giorni cosa decideranno di fare? Tornare con la coda tra le gambe nel centrodestra e sostenere il candidato imposto da Fratelli d’Italia? Oppure andare da soli? Oppure, soluzione fantasticata da più parti in queste settimane, provare a trovare casa nella Coalizione Sarda di Renato Soru?
Sia come sia, la decisione della procura dimostra, se ancora ce ne fosse bisogno, che la “questione morale” in Sardegna non esiste più. Assente, dissolta nel nulla, irrilevante. Sparita dalle agende di tutti i partiti.
Compresi quelli di centrosinistra. Compreso dei Cinquestelle. Che in anni passati non avrebbero esitato a far presente che non sarebbe stato opportuno per un politico sotto processo per reati connessi alla pubblica amministrazione, ripresentarsi al giudizio degli elettori. Avrebbero posto al centro dei loro attacchi politici la torbidità e la scarsa trasparenza che ha caratterizzato in questi anni l’attività della giunta di centrodestra. Citando casi specifici ben noti e facendo nomi e cognomi.
E invece nulla. Silenzio assoluto.
E che la questione morale non abbia più alcun senso anche per i giornali è dimostrato dal fatto che in questi mesi nessuno abbia mai pensato di chiedere a Renato Soru se non ritiene inopportuna la sua candidatura, visto che tra meno di un mese sarà chiamato a rispondere del reato di bancarotta nell’ambito del processo per il fallimento del quotidiano l’Unità.
Certo, il reato contestato non è tra quelli previsti dalla legge Severino (per cui in caso di condanna e di elezione, Soru non sarebbe costretto alle dimissioni), ma una domanda, semplice semplice, comunque si sarebbe potuta rivolgere: “Dottor Soru, lei è sotto processo per bancarotta. Non pensa che per questo la sua candidatura possa essere inopportuna, visto che per anni il centrosinistra ha attaccato il centrodestra, chiedendo ai politici indagati di fare un passo indietro?”.
Una domanda semplice, onesta. Che oggi suona quasi infantile per quanto è anacronistica. Perché la famosa “questione morale” in Sardegna non esiste più. Per Solinas, per Soru, per nessuno.
Facciamocene una ragione.
———————————-
 Da molto tempo la questione morale è un optional. Per molti, come per noi, No!
Da molto tempo la questione morale è un optional. Per molti, come per noi, No!
Non dico 100%, ma possiamo avere la pretesa che la maggioranza dei politici sia onesta e faccia politica innanzitutto per il bene dei cittadini? Leggete questo raccontino di Giulio Andreotti, che parla di Alcide De Gasperi, di quando ne fu giovane segretario (lasciamo perdere qui vicende successive).
“(…) Accennavo alle difficoltà economiche che affrontò durante il fascismo. De Gasperi resta d’esempio proprio per questa sua coerenza personale: non ebbe mai transazioni sui principi e, quando arrivò al potere, non profittò mai della vita pubblica per avere quello che forse poteva essere un giusto compenso per i momenti in cui la società gli aveva tolto beni materiali e i suoi diritti di cittadino. Vorrei ricordare una frase, quasi di scherno, che mi ha sempre colpito negativamente, detta una volta dal comandante Lauro, su De Gasperi: «Si dice sempre “bravo De Gasperi”, ma uno che arriva a settant’anni e non ha messo insieme un patrimonio, vuol dire che non è così bravo». De Gasperi, è vero, non ha mai messo da parte un patrimonio, la casa dove abitava a Roma, in via Bonifacio, era in affitto ed era modesta. Quando la Dc gli regalò una villetta vicino al lago di Albano, nei castelli romani, De Gasperi ne fu molto contento, ed era la prima volta che diventava proprietario di un immobile. Ma non è mai stato vittimista, solo qualche volta era stato un po’ amaro, pensando a quelli che si erano squagliati ai tempi dell’instaurazione del regime e che avevano fatto finta di non conoscerlo. Furono, come detto, anche tempi di grande disagio economico per lui, e, a causa della persecuzione politica, anche il Vaticano faticò per trovare un escamotage per dargli un piccolo lavoro in biblioteca. Eppure non ebbe mai sentimenti di vendetta o rivalsa. Anzi, quando molti “ex” si rifecero vivi solo perché il fascismo era al tramonto, li riaccolse a braccia aperte. Mi viene in mente la parabola del figliol prodigo”.
———
Fonte

—————————-
E il buon politico cattolico che deve fare?

“Prego il Signore che ci regali più politici che abbiano davvero a cuore la società, il popolo, la vita dei poveri. E’ indispensabile che i governanti e il potere finanziario alzino lo sguardo e amplino le loro prospettive, che facciano in modo che ci sia un lavoro degno, istruzione e assistenza sanitaria per tutti i cittadini. E perché non ricorrere a Dio affinché ispiri i loro piani? Sono convinto che a partire da un’apertura alla trascendenza potrebbe formarsi una nuova mentalità politica ed economica e il bene comune sociale” (n. 205). Qui il “di più” chiede alla politica di “alzare lo sguardo” e di “ampliare le prospettive”. Ma non saremo noi a riuscire a fare ciò, Se Dio non ispira i nostri piani. Si noti che così avvenendo, capita che anche il campo proprio della politica, che il passo individua nell’economia e nel bene comune da rimettere insieme, riacquista in pienezza il proprio significato e diventa possibile, non di per sé, ma in virtù di quel “di più” che gli viene donato”
Da Evangelii gaudium
—————
Approfondimenti: https://stefanorolando.it/?p=2181
Costituente Terra

Newsletter n. 144 del 4 gennaio 2024
LA CRISI
Cari Amici,
apro il Vangelo e leggo: “quando sentirete di guerre e di rumori di guerre… chi si trova sulla terrazza non scenda e non entri a prendere qualcosa nella sua casa, e chi si trova nel campo non torni indietro a prendersi il mantello. In quei giorni guai alle donne incinte e a quelle che allattano…”. Oggi ci sono più che guerre e rumori di guerre, il mondo è spezzato, a Gaza è in corso un genocidio e in Ucraina una guerra: addirittura secondo il Presidente della Repubblica che, non sappiamo in base a quali indiscrezioni, ce ne ha dato la singolare notizia nel discorso di fine anno, la Russia intenderebbe con la guerra annettersi l’Ucraina, ciò che inevitabilmente, stando ai moniti americani, significherebbe la terza (e forse ultima) guerra mondiale. La Turchia continua a mietere vittime e a distruggere ospedali, fabbriche e altre infrastrutture per colpire i Kurdi nella Siria del nord-est, prendendo di mira diverse zone del Rojava, il Kurdistan occidentale. Tutto ciò mostra, contro le speranze che avevamo concepito di un nuovo ordine, e persino di una Costituzione, mondiale, che il sistema giuridico internazionale è distrutto: le leggi sono rimaste, il diritto è sparito. La competizione strategica militare che gli Stati Uniti hanno voluto istituire come regola dei rapporti mondiali ha fatto sì che si sia spezzata quella struttura inventata dopo la Seconda guerra mondiale, che era il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che nell’intesa tra i cinque suoi Membri permanenti, doveva garantire la pace e la sicurezza tra tutti. In questa situazione, personalmente io non penso di potermi occupare d’altro che di una politica capace di invertire quest’ordine delle cose, non solo per un lontano futuro, ma per la tragica urgenza di oggi.
Perciò, tenuto conto dei miei limiti, ho deciso di lasciare la Presidenza di Costituente Terra, il cui mandato per conseguenza ai sensi dell’art. 21 dello Statuto, fino a un’Assemblea da convocare entro due mesi è confidato, del resto con ottime prospettive, al vicepresidente Luigi Ferrajoli.
Comunicando con una mia lettera al Comitato esecutivo dell’Associazione questa mia decisione, ho scritto: «Penso che abbiamo fatto un buon lavoro insieme, e nel frattempo abbiamo avuto un cambiamento d’epoca. Siamo partiti alla fine di un’epoca storica spaventosa, segnata dalla reciproca minaccia di un’ecatombe nucleare, quando sembrava che tutto potesse ricominciare di nuovo, che un nuovo ordine del mondo fosse teoricamente concepibile e politicamente attuabile anche se arduo, concordi come siamo stati nel dire “Ora si può”, ciò che fino a quel momento era apparso impossibile. Oggi siamo all’inizio di una nuova epoca, ancora più malvagia di quella da cui pensavamo di essere usciti, e quelli che dovrebbero essere gli attori del nuovo assetto costituzionale del mondo che abbiamo elaborato e sognato, Stati e governanti, si sono mutati in mostri che si azzannano tra loro promettendosi rovina e perfino legittimando e intestandosi il genocidio in corso e quello che viene ormai spensieratamente ipotizzato come terza guerra mondiale. È necessario perciò convocare tutte le risorse che ci possono trattenere dal precipizio, non solo il diritto, “grandezza e miseria” come scriveva Dossetti, ma la politica, la cultura, la comunicazione, le fedi.
«È in questa nuova situazione che dovrà operare Costituente Terra nel perseguimento dei suoi fini sociali. Non mi permetto di dire nulla in proposito, se non constatare che l’ONU è stata in questi frangenti l’unica realtà istituzionale (a parte il papato) che ha mantenuto un volto umano ed ha operato in termini di unità umana. Penso perciò che per promuovere un futuro costituzionale mondiale, non lo si debba fare come se si dovesse ricominciare da capo, ma a partire da quanto già acquisito, e arricchendo il patrimonio costituzionale di cui l’ONU è riuscita anche in mezzo a questi orrori a farsi interprete. Come già si disse dopo l’89, è proprio da una riforma e da un potenziamento dell’ONU che si può costruire un’alternativa credibile. Per esempio compensando con maggiori poteri attribuiti al Segretario Generale, da scegliersi sempre tra i Paesi meno favoriti, i poteri oggi attribuiti ai cinque Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, le cui decisioni, quando si manifestassero come veto, dovrebbero comunque essere avallate da consensi parlamentari o popolari. Ma queste sono fantasie del futuro».
In attesa della prevista assemblea, allo scopo di non far venir meno la continuità del lavoro intrapreso, continuerò tuttavia a curare i due siti “Costituente Terra” e “La biblioteca di Alessandria” e questa newsletter, con i cui destinatari sarò lieto di mantenere comunque il rapporto.
Nel sito pubblichiamo un articolo di Riccardo Gullotta, “L’Intelligenza artificiale va alla guerra”, e l’omelia della notte di Natale del Patriarca Latino di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa, “Non c’era posto per loro”.
Con i più cordiali saluti
Raniero La Valle
Costituente Terra
———————————————————
Newsletter n. 145 dell’11 gennaio 2024
DOV’È IL FASCISMO
Cari amici,
È stato fuorviante il dibattito protrattosi per giorni e giorni sul fascismo della signora Meloni. Esso non consiste nel beneplacito al saluto romano, ma nella cultura fascista che la determina nella sua azione di governo. Se ne possono fare solo alcuni esempi.
Il primo è quello di riferirsi sempre all’Italia come alla “Nazione”, per marcare un’identità, non per vezzo di linguaggio. Ma l’Italia, secondo la Costituzione, è una Repubblica, non è un Nazione, ed è la Repubblica, cioè il diritto, non sono le viscere, a fare il cittadino. Altrimenti si fa lo Stato etnico, e se arrivano altri si grida alla sostituzione etnica, si sogna il blocco navale, si chiudono i porti oppure, arrivati, li si imprigiona, li si segrega e li si deporta, fuori dalla vista, fuori dai confini, in Albania o in Tunisia, magari a pagamento. È quanto accade con lo Stato di Israele, che la discriminazione etnica l’ha messa addirittura in una legge di rango costituzionale che definisce Israele come lo “Stato nazione del popolo ebraico”, e solo a questo, “esclusivamente” riserva “il diritto di esercitare l’autodeterminazione nazionale”, che vuol dire negare agli altri la partecipazione alla sovranità, i diritti politici e perfino, come pretende il generale Effi Eitam, leader del partito religioso, il porto d’armi; e questo è il fascismo che porta al genocidio, come oggi a Gaza e che i palestinesi li vuole mandare nel deserto, in Egitto, in Congo, o tenerli in prigioni a cielo aperto (lo “Stato” palestinese della soluzione a due Stati, raccomandata, ma solo ora, da Biden).
Altra prova di fascismo è l’orgogliosa reiterata rivendicazione di un potere non “ricattabile”. Ma “ricattare” vuol dire minacciare un male per ottenere un bene: la democrazia è che un potere può essere tolto se non obbedisce al bene comune, e la minaccia di togliere potere al potere la fanno i Parlamenti nelle Repubbliche parlamentari e gli elettorati quando sono chiamati a votare. Il fascismo è che il Parlamento non può togliere la fiducia ai governi, gli elettorati non possono votare per uno o più lustri, e il potere è inamovibile; l’elezione diretta di un presidente del consiglio (la madre, per la Meloni, di tutte le riforme) lo rende non “ricattabile”: non può infirmarne il potere né un Parlamento, né un Presidente della Repubblica né, fin quando il potere non lo chiami alle urne, l’elettorato: e questo è fascismo. È stato quando il Gran Consiglio del fascismo ha “ricattato” Mussolini a piazza Venezia, che il Duce è stato ficcato dal re in un’ambulanza.
Altra prova di fascismo è la passione della guerra e l’entusiasmo per le armi. E quando la guerra non la si può fare in proprio, la si fa fare agli altri, senza far loro mancare le armi, perché quelle non finiscano mai, lasciando invece che finiscano i soldati, che è il regalo che stiamo facendo all’Ucraina, al suo autogenocidio (e il Partito Democratico si astiene).
Ci sarebbero tante altre cose proprie del fascismo: la subalternità ai potenti Alleati, il corporativismo, il classismo fiscale, l’invenzione del nemico, la propaganda. Non il folklore dei vecchi riti. Di questo dovremmo accorgerci.
Nel sito pubblichiamo il discorso d’inizio d’anno agli Ambasciatori, nel quale papa Francesco ha fatto l’inventario della catastrofe in atto in “un mondo sempre più lacerato”, dove la geografia delle stragi, da Gaza all’Ucraina attraverso il Mediterraneo, “diventato nell’ultimo decennio un grande cimitero”, si proietta verso tutto il pianeta; pubblichiamo inoltre un richiamo alla posizione di Aldo Moro quale era espressa nel “memoriale Moro” scritto durante la detenzione nella prigione delle Brigate Rosse sulla crisi mediorientale e la politica di Israele, nonché un articolo sui problemi suscitati dalla costruzione di una nuova grande diga sul fiume Azzurro che mette in pericolo la funzione ecologica del Nilo.
Con i più cordiali saluti,
Costituente Terra (Raniero La Valle)
————————————————-
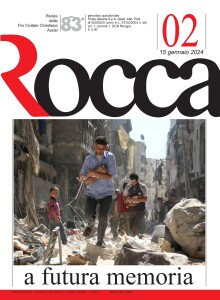 E’ in distribuzione il nuovo numero di Rocca (n.2/2024)
E’ in distribuzione il nuovo numero di Rocca (n.2/2024)
Come di consueto pubblichiamo in anteprima L’editoriale del direttore Mariano Borgognoni.
L’EDITORIALE
Il tempo è adesso
di Mariano Borgognoni
5 Gennaio 2024
Come ogni anno, ormai da qualche decennio, ho acquistato “Un giorno una parola”, l’agile e rigorosa guida alla lettura quotidiana della Bibbia, pubblicata dalla Claudiana, che è poi l’edizione italiana delle Meditazioni bibliche giornaliere dei Fratelli Moravi e che è, pensate, al suo 294° anno. La trovo, per la mia affannosa esigenza di fare i conti con la Scrittura e di metterla a contatto con la vita quotidiana pubblica e privata, un indispensabile ed efficace elemento d’ordine. È una pubblicazione che va in mano a migliaia di sorelle e fratelli evangelici nel nostro Paese. Per me, nato e vissuto e nella mattonella cattolica è anche un modo per respirare una sensibilità protestante così importante per cercare di vivere da cristiani nel mondo secolarizzato. D’altra parte questa ormai evidente condizione di minoranza dei cristiani in modo particolare in Europa e in diverse aree del mondo fa sì che o si diventa sempre più radicalmente ecumenici o si disperde una ricchezza di esperienze da far incontrare nel convivio delle differenze e, come già avvertiva Giovanni nel suo Evangelo, si corre il rischio di non essere credibili: siate una cosa sola perché il mondo creda. Uniti intorno all’essenziale certo ma al contempo capaci di mettere reciprocamente a frutto la sensibilità per l’eucaristia, quella per la liturgia, quella per la predicazione della Parola su cui si sono venute storicamente caratterizzando le diverse Chiese. Ormai doni da scambiare non identità da blindare dentro le rispettive ridotte.
Qui in Cittadella Laudato si’ abbiamo appena terminato un Convegno “Parole, segni e idee per abitare la casa comune” in cui molto si è insistito sull’esigenza di un fruttuoso dialogo tra le diverse fedi, religioni e spiritualità al servizio soprattutto dell’umano fragile e della terra ferita. Come cristiani dobbiamo sentire il compito, oserei dire il mandato evangelico, di una fertile convivenza nella libertà dello Spirito e nella faticosa fedeltà alla sequela del Signore, da tessere nella compagnia delle donne e degli uomini del nostro tempo. E da vivere laicamente nella polis comune. Sappiamo che questo processo ecumenico è andato incontro in questi ultimi anni a impensati gesti di reciproca accoglienza ma anche a scandalosi rovesci, come nella situazione ucraina. A maggior ragione sulla domanda e sulla lotta per la pace e contro il riarmo, omicida sin dal concepimento, sulla progressiva pratica della nonviolenza, sulla centralità delle periferie esistenziali e sociali contro la dittatura del profitto, sull’emersione universale del femminile, se provano ad essere degni del nome che portano, devono battere insieme un colpo. Parlare di unità e praticare la divisione senza riconciliazione è una controtestimonianza. Pregare, operare ciò che è giusto e attendere il tempo di Dio, per usare l’espressione di Bonhoeffer è la strada da battere. Nel suo piccolo Rocca continuerà, con le sue autrici e suoi autori, a offrire riflessioni utili a sostenere questo cammino sapendo, per citare un passo dei Pirqè avot (Detti dei padri) nel Talmud, che “non spetta a te portare a termine il lavoro ma non sei nemmeno libero di sottrartene”.
Leggendo la consueta introduzione a “Un giorno, una parola” da parte del Pastore Paolo Ricca, prestigioso e carissimo amico della rivista e della Pro Civitate Christiana ho avuto il piacere di veder citata Rocca a proposito di un’intervista a noi rilasciata dal pittore Marcello Silvestri, alcune delle cui bellissime tavole illustrano le letture bibliche e i brevi commenti del libro. L’idea che chi lo legge incontri in qualche modo la nostra rivista mi pare un piccolo segno verso quella comunione tra cristiani di confessioni diverse che battono cammini comuni per alleggerire il mondo dalle sofferenze e per costruire esperienze di promozione umana. E che sperano di trovarsi presto a spezzare il pane insieme, come il Signore ci ha comandato di fare.
————————-
—————————

——————————
——————————
Newsletter n.326 dell’11 gennaio 2024
DOV’È IL FASCISMO
Cari amici,
È stato fuorviante il dibattito protrattosi per giorni e giorni sul fascismo della signora Meloni. Esso non consiste nel beneplacito al saluto romano, ma nella cultura fascista che la determina nella sua azione di governo. Se ne possono fare solo alcuni esempi.
Il primo è quello di riferirsi sempre all’Italia come alla “Nazione”, per marcare un’identità, non per vezzo di linguaggio. Ma l’Italia, secondo la Costituzione, è una Repubblica, non è un Nazione, ed è la Repubblica, cioè il diritto, non sono le viscere, a fare il cittadino. Altrimenti si fa lo Stato etnico, e se arrivano altri si grida alla sostituzione etnica, si sogna il blocco navale, si chiudono i porti oppure, arrivati, li si imprigiona, li si segrega e li si deporta, fuori dalla vista, fuori dai confini, in Albania o in Tunisia, magari a pagamento. È quanto accade con lo Stato di Israele, che la discriminazione etnica l’ha messa addirittura in una legge di rango costituzionale che definisce Israele come lo “Stato nazione del popolo ebraico”, e solo a questo, “esclusivamente” riserva “il diritto di esercitare l’autodeterminazione nazionale”, che vuol dire negare agli altri la partecipazione alla sovranità, i diritti politici e perfino, come pretende il generale Effi Eitam, leader del partito religioso, il porto d’armi; e questo è il fascismo che porta al genocidio, come oggi a Gaza e che i palestinesi li vuole mandare nel deserto, in Egitto, in Congo, o tenerli in prigioni a cielo aperto (lo “Stato” palestinese della soluzione a due Stati, raccomandata, ma solo ora, da Biden).
Altra prova di fascismo è l’orgogliosa reiterata rivendicazione di un potere non “ricattabile”. Ma “ricattare” vuol dire minacciare un male per ottenere un bene: la democrazia è che un potere può essere tolto se non obbedisce al bene comune, e la minaccia di togliere potere al potere la fanno i Parlamenti nelle Repubbliche parlamentari e gli elettorati quando sono chiamati a votare. Il fascismo è che il Parlamento non può togliere la fiducia ai governi, gli elettorati non possono votare per uno o più lustri, e il potere è inamovibile; l’elezione diretta di un presidente del consiglio (la madre, per la Meloni, di tutte le riforme) lo rende non “ricattabile”: non può infirmarne il potere né un Parlamento, né un Presidente della Repubblica né, fin quando il potere non lo chiami alle urne, l’elettorato: e questo è fascismo. È stato quando il Gran Consiglio del fascismo ha “ricattato” Mussolini a piazza Venezia, che il Duce è stato ficcato dal re in un’ambulanza.
Altra prova di fascismo è la passione della guerra e l’entusiasmo per le armi. E quando la guerra non la si può fare in proprio, la si fa fare agli altri, senza far loro mancare le armi, perché quelle non finiscano mai, lasciando invece che finiscano i soldati, che è il regalo che stiamo facendo all’Ucraina, al suo autogenocidio (e il Partito Democratico si astiene).
Ci sarebbero tante altre cose proprie del fascismo: la subalternità ai potenti Alleati, il corporativismo, il classismo fiscale, l’invenzione del nemico, la propaganda. Non il folklore dei vecchi riti. Di questo dovremmo accorgerci.
Nel sito pubblichiamo il discorso d’inizio d’anno agli Ambasciatori, nel quale papa Francesco ha fatto l’inventario della catastrofe in atto in “un mondo sempre più lacerato”, dove la geografia delle stragi, da Gaza all’Ucraina attraverso il Mediterraneo, “diventato nell’ultimo decennio un grande cimitero”, si proietta verso tutto il pianeta; pubblichiamo inoltre un richiamo alla posizione di Aldo Moro quale era espressa nel “memoriale Moro” scritto durante la detenzione nella prigione delle Brigate Rosse sulla crisi mediorientale e la politica di Israele, nonché un articolo sui problemi suscitati dalla costruzione di una nuova grande diga sul fiume Azzurro che mette in pericolo la funzione ecologica del Nilo.
Con i più cordiali saluti,
Chiesa di Tutti Chiesa dei Poveri
Mi permette Presidente…
 Ecco la Lettera aperta al Presidente Mattarella, che ho scritto con Andrea Catone, e la collaborazione di Fabio Marcelli, in risposta al suo messaggio di Capodanno.
Ecco la Lettera aperta al Presidente Mattarella, che ho scritto con Andrea Catone, e la collaborazione di Fabio Marcelli, in risposta al suo messaggio di Capodanno.
Finora le adesioni sono già oltre quota 1500 (in poche ore). Il testo è stato già ripreso dal giornale L’Identità e domani lo troveremo su altri giornali: il manifesto, Il Fatto Quotidiano, L’Unità.
Diamo un segnale. Non abbandoniamo la Palestina all’orrore, rimanendo silenti, ossia complici.
Per aderire: italiapalestina2024@gmail.com
_________________________________________
NON IN NOSTRO NOME
Lettera aperta al Presidente Sergio Mattarella
Signor Presidente,
noi sottoscritti cittadini e cittadine Suoi connazionali, lavoratori della città e della campagna, studenti e persone impegnate nel mondo della cultura, dell’insegnamento, dell’associazionismo, ci permettiamo di ricordarLe la situazione in atto in Palestina:
circa 30.000 vittime civili a Gaza, senza contare i presumibili 10.000 sotto le macerie.
70.000 feriti che non possono essere adeguatamente curati in ospedali distrutti da Israele.
1000 bambini che hanno perso uno o entrambi gli arti inferiori o superiori.
90% degli edifici rasi al suolo: “non è rimasto brandello di muro”, dichiarano i pochi osservatori ONU rimasti sul campo.
Una economia, una società, un paesaggio annichilati.
Oltre 2 milioni di persone sono senza un tetto, né acqua, né cibo, né medicinali, né carburanti, e sono spinte dall’esercito israeliano in una piccola sacca a Gaza sud, che peraltro continua ad essere bombardata.
Intanto si susseguono dichiarazioni di governanti israeliani sulla necessità di espellere dal territorio di Gaza i palestinesi sopravvissuti, e sul progetto di ricolonizzazione di Gaza da parte dei coloni israeliani, mentre addirittura si pubblicano annunci di lussuosi villaggi turistici da costruire sulle macerie e sui corpi insepolti della popolazione palestinese.
In Cisgiordania (secondo l’ONU, “Territori Occupati”) gli oltre 700.000 coloni israeliani, che hanno occupato illegalmente il territorio e rendono molto problematica, per non dire impossibile, la soluzione “due popoli, due Stati”, spalleggiati dall’esercito di Israele attaccano quotidianamente e uccidono i contadini palestinesi, compresi donne, anziani, adolescenti.
Israele ha ucciso 138 funzionari dell’ONU e continua a bombardare i convogli dell’agenzia per i rifugiati dell’ONU. Colpisce le ambulanze che trasportano i feriti. Cattura, e umilia denudandoli e ingiuriandoli, centinaia di cittadini colpevoli semplicemente di essere palestinesi.
Israele ha trucidato un centinaio di giornalisti e fotografi nell’esercizio del loro lavoro.
Il segretario generale dell’ONU Guterres ha denunciato ripetutamente la “catastrofe umanitaria”, l’Assemblea generale dell’ONU approva la risoluzione che chiede l’immediato cessate il fuoco.
Alcuni stati, come il SudAfrica deferiscono Israele alla Corte Internazionale di Giustizia (dell’ONU) per genocidio e diversi altri Stati denunciano quella nazione per violazione del diritto internazionale e del diritto umanitario di fronte alla Corte Penale Internazionale. Milioni di persone in tutto il mondo chiedono che venga perseguito Netanyahu e la cupola politico-militare israeliana per questi motivi. Altri Paesi della UE annunciano varie azioni contro Israele, mentre il nostro governo appare silente o complice dei crimini in corso.
Quando l’Armata Rossa sovietica liberò Auschwitz il 27 gennaio 1945 e vennero alla luce gli orrori della Shoah, alcuni giustificarono il loro silenzio e la loro inazione dicendo di ignorare cosa stesse accadendo nei lager nazisti. Oggi assistiamo in diretta alla pulizia etnica e all’olocausto del popolo palestinese. Nessuno può dire “non so”.
È per noi grave che Ella nel Suo messaggio riduca il genocidio in corso a “un’azione militare [di Israele] che provoca anche [evidenziazione nostra] migliaia di vittime civili e costringe, a Gaza, moltitudini di persone ad abbandonare le proprie case, respinti da tutti”. Nient’altro. Ella, Signor Presidente, avrebbe potuto, e riteniamo dovuto, riprendere le dichiarazioni del segretario dell’Onu, le risoluzioni dell’Assemblea generale e levare una voce per l’immediato cessate il fuoco in Palestina. Come anche alcuni leader europei hanno chiesto.
Ella, invece, ha taciuto, Signor Presidente.
Nelle sue parole il genocidio del popolo palestinese in corso (è la definizione dello storico israeliano Ilan Pappé, costretto ad abbandonare il suo paese e la sua università per le minacce di cui è stato oggetto) è stato ridotto alla reazione israeliana “che provoca anche migliaia di vittime civili”. Durante la Resistenza antifascista i massacri operati dai nazifascisti si chiamavano “rappresaglia”; alle Fosse Ardeatine i nazisti applicarono la formula del “10 italiani per un tedesco”. La rappresaglia di Israele (se di rappresaglia si può parlare e non di un piano preordinato di svuotare Gaza della popolazione palestinese e riportarla sotto il diretto controllo israeliano) supera di molto il criterio nazista delle Fosse Ardeatine.
Tra l’altro, Ella evita di dare un nome al popolo vittima del massacro: nel Suo discorso sono “moltitudini di persone”. NO, non sono “moltitudini”, “volgo disperso che nome non ha”: è il popolo palestinese che subisce da 75 anni l’occupazione di Israele, è il popolo che si oppone e resiste all’occupazione, come fecero i nostri patrioti nel Risorgimento e i partigiani nella Resistenza antinazifascista italiana.
Ella dice che i giovani vanno educati alla pace, ma non si educa se non si compie un’operazione di verità, e la verità non è solo non dire il falso, ma dare un quadro completo delle cose. Il Suo discorso – un discorso ufficiale, a reti televisive unificate a tutto il Paese – per quel che dice e per quello che NON dice, viola i principi cui pure Ella dichiara di ispirarsi, non educa alla verità, né alla giustizia, in difesa morale di ogni popolo oppresso.
La parte del Suo discorso dedicata al conflitto in Medio Oriente è in definitiva schiacciata sulla politica bellicistica e disumana del governo di Israele, che annuncia un 2024 di guerra. Legando mani e piedi il nostro Paese alla politica oltranzista di Israele, Ella rompe con quella politica mediterranea di apertura ed equilibrio con i paesi arabi e di riconoscimento delle ragioni del popolo palestinese, promossa tra gli anni Sessanta e Ottanta del secolo scorso da statisti come Moro, Andreotti, Craxi, o da un sindaco eccezionale testimone di pace e costruttore di ponti fra i popoli, come Giorgio La Pira. Il Suo discorso, Signor Presidente, non è solo un inaccettabile silenzio sul genocidio palestinese in corso, è anche un tradimento della storia italiana, e un colpo ai nostri interessi nazionali.
Ebbene, in piena coscienza, e con il massimo rispetto per la carica che Ella riveste, noi sottoscritti ci permettiamo di osservare e di comunicarLe che Ella ha parlato non in nostro nome.
2 gennaio 2024
Angelo d’Orsi, Storico e giornalista, già Ordinario Univ. Di Torino – Direttore “Historia Magistra” e “Gramsciana”
Fabio Marcelli, Roma, dirigente di ricerca, Istituto di studi giuridici internazionali CNR
Andrea Catone, Bari, direttore editoriale edizioni MarxVentuno
_________________________________________
Il messaggio del Presidente. Soffermiamoci solo su una parte, molto importante e significativa, laddove le parole pesanti come pietre pendono da una parte sola
 ASIMMETRIE DI FINE D’ANNO
ASIMMETRIE DI FINE D’ANNO
di Gianni Loy
Poco prima della scadenza di un anno indimenticabile, ho ascoltato con attenzione il messaggio che il Presidente della Repubblica ha rivolto al paese. Poco dopo, le più alte cariche dello Stato hanno riferito di un “consenso unanime”.
Il fatto che la mia voce non si unisca al sonito di altre mille farebbe venir meno l’unanimità. Ciò poco importa, ma sinché sarà possibile esercitare il diritto di critica, lo farò. In questo caso, dissento profondamente con la tecnica utilizzata per la descrizione della guerra in atto. Ciò riguarda solo una piccola parte del messaggio del presidente della Repubblica, per il resto ampiamente condivisibile, ma una parte qualificante.
Riguarda la scelta delle parole. Spero, sinceramene, che non corrisponda al vero quanto subito affermato la seconda carica dello Stato, e cioè che “la scelta delle parole è stata significativa”. Spero, invece, che si sia trattato di una distrazione. Perché è proprio della scelta delle parole che intendo parlare. Delle parole che descrivono due fatti, ben pecisi: da una parte “l’attacco terroristico di Hamas” (descritto in appena 19 parole, al netto di preposizioni e articoli) e dall’altra parte la “reazione del governo israeliano” (18 parole).
«Possano i fedeli cristiani, i credenti di varie religioni e gli uomini e le donne di buona volontà collaborare in armonia per cogliere le opportunità e affrontare le sfide poste dalla rivoluzione digitale, e consegnare alle generazioni future un mondo più solidale, giusto e pacifico»

MESSAGGIO
DI SUA SANTITÀ
FRANCESCO
PER LA LVII
GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
1° GENNAIO 2024
Intelligenza artificiale e pace
All’inizio del nuovo anno, tempo di grazia che il Signore dona a ciascuno di noi, vorrei rivolgermi al Popolo di Dio, alle nazioni, ai Capi di Stato e di Governo, ai Rappresentanti delle diverse religioni e della società civile, a tutti gli uomini e le donne del nostro tempo per porgere i miei auguri di pace.
1. Il progresso della scienza e della tecnologia come via verso la pace
La Sacra Scrittura attesta che Dio ha donato agli uomini il suo Spirito affinché abbiano «saggezza, intelligenza e scienza in ogni genere di lavoro» (Es 35,31). L’intelligenza è espressione della dignità donataci dal Creatore, che ci ha fatti a sua immagine e somiglianza (cfr Gen 1,26) e ci ha messo in grado di rispondere al suo amore attraverso la libertà e la conoscenza. La scienza e la tecnologia manifestano in modo particolare tale qualità fondamentalmente relazionale dell’intelligenza umana: sono prodotti straordinari del suo potenziale creativo.
Nella Costituzione Pastorale Gaudium et spes, il Concilio Vaticano II ha ribadito questa verità, dichiarando che «col suo lavoro e col suo ingegno l’uomo ha cercato sempre di sviluppare la propria vita» [1]. Quando gli esseri umani, «con l’aiuto della tecnica», si sforzano affinchè la terra «diventi una dimora degna di tutta la famiglia umana» [2], agiscono secondo il disegno di Dio e cooperano con la sua volontà di portare a compimento la creazione e di diffondere la pace tra i popoli. Anche il progresso della scienza e della tecnica, nella misura in cui contribuisce a un migliore ordine della società umana, ad accrescere la libertà e la comunione fraterna, porta dunque al miglioramento dell’uomo e alla trasformazione del mondo.
Giustamente ci rallegriamo e siamo riconoscenti per le straordinarie conquiste della scienza e della tecnologia, grazie alle quali si è posto rimedio a innumerevoli mali che affliggevano la vita umana e causavano grandi sofferenze. Allo stesso tempo, i progressi tecnico-scientifici, rendendo possibile l’esercizio di un controllo finora inedito sulla realtà, stanno mettendo nelle mani dell’uomo una vasta gamma di possibilità, alcune delle quali possono rappresentare un rischio per la sopravvivenza e un pericolo per la casa comune [3].
I notevoli progressi delle nuove tecnologie dell’informazione, specialmente nella sfera digitale, presentano dunque entusiasmanti opportunità e gravi rischi, con serie implicazioni per il perseguimento della giustizia e dell’armonia tra i popoli. È pertanto necessario porsi alcune domande urgenti. Quali saranno le conseguenze, a medio e a lungo termine, delle nuove tecnologie digitali? E quale impatto avranno sulla vita degli individui e della società, sulla stabilità internazionale e sulla pace?
2. Il futuro dell’intelligenza artificiale tra promesse e rischi
I progressi dell’informatica e lo sviluppo delle tecnologie digitali negli ultimi decenni hanno già iniziato a produrre profonde trasformazioni nella società globale e nelle sue dinamiche. I nuovi strumenti digitali stanno cambiando il volto delle comunicazioni, della pubblica amministrazione, dell’istruzione, dei consumi, delle interazioni personali e di innumerevoli altri aspetti della vita quotidiana.
Inoltre, le tecnologie che impiegano una molteplicità di algoritmi possono estrarre, dalle tracce digitali lasciate su internet, dati che consentono di controllare le abitudini mentali e relazionali delle persone a fini commerciali o politici, spesso a loro insaputa, limitandone il consapevole esercizio della libertà di scelta. Infatti, in uno spazio come il web, caratterizzato da un sovraccarico di informazioni, possono strutturare il flusso di dati secondo criteri di selezione non sempre percepiti dall’utente.
Dobbiamo ricordare che la ricerca scientifica e le innovazioni tecnologiche non sono disincarnate dalla realtà e «neutrali» [4], ma soggette alle influenze culturali. In quanto attività pienamente umane, le direzioni che prendono riflettono scelte condizionate dai valori personali, sociali e culturali di ogni epoca. Dicasi lo stesso per i risultati che conseguono: essi, proprio in quanto frutto di approcci specificamente umani al mondo circostante, hanno sempre una dimensione etica, strettamente legata alle decisioni di chi progetta la sperimentazione e indirizza la produzione verso particolari obiettivi.
Questo vale anche per le forme di intelligenza artificiale. Di essa, ad oggi, non esiste una definizione univoca nel mondo della scienza e della tecnologia. Il termine stesso, ormai entrato nel linguaggio comune, abbraccia una varietà di scienze, teorie e tecniche volte a far sì che le macchine riproducano o imitino, nel loro funzionamento, le capacità cognitive degli esseri umani. Parlare al plurale di “forme di intelligenza” può aiutare a sottolineare soprattutto il divario incolmabile che esiste tra questi sistemi, per quanto sorprendenti e potenti, e la persona umana: essi sono, in ultima analisi, “frammentari”, nel senso che possono solo imitare o riprodurre alcune funzioni dell’intelligenza umana. L’uso del plurale evidenzia inoltre che questi dispositivi, molto diversi tra loro, vanno sempre considerati come “sistemi socio-tecnici”. Infatti il loro impatto, al di là della tecnologia di base, dipende non solo dalla progettazione, ma anche dagli obiettivi e dagli interessi di chi li possiede e di chi li sviluppa, nonché dalle situazioni in cui vengono impiegati.
L’intelligenza artificiale, quindi, deve essere intesa come una galassia di realtà diverse e non possiamo presumere a priori che il suo sviluppo apporti un contributo benefico al futuro dell’umanità e alla pace tra i popoli. Tale risultato positivo sarà possibile solo se ci dimostreremo capaci di agire in modo responsabile e di rispettare valori umani fondamentali come «l’inclusione, la trasparenza, la sicurezza, l’equità, la riservatezza e l’affidabilità» [5].
Non è sufficiente nemmeno presumere, da parte di chi progetta algoritmi e tecnologie digitali, un impegno ad agire in modo etico e responsabile. Occorre rafforzare o, se necessario, istituire organismi incaricati di esaminare le questioni etiche emergenti e di tutelare i diritti di quanti utilizzano forme di intelligenza artificiale o ne sono influenzati [6].
L’immensa espansione della tecnologia deve quindi essere accompagnata da un’adeguata formazione alla responsabilità per il suo sviluppo. La libertà e la convivenza pacifica sono minacciate quando gli esseri umani cedono alla tentazione dell’egoismo, dell’interesse personale, della brama di profitto e della sete di potere. Abbiamo perciò il dovere di allargare lo sguardo e di orientare la ricerca tecnico-scientifica al perseguimento della pace e del bene comune, al servizio dello sviluppo integrale dell’uomo e della comunità [7].
La dignità intrinseca di ogni persona e la fraternità che ci lega come membri dell’unica famiglia umana devono stare alla base dello sviluppo di nuove tecnologie e servire come criteri indiscutibili per valutarle prima del loro impiego, in modo che il progresso digitale possa avvenire nel rispetto della giustizia e contribuire alla causa della pace. Gli sviluppi tecnologici che non portano a un miglioramento della qualità di vita di tutta l’umanità, ma al contrario aggravano le disuguaglianze e i conflitti, non potranno mai essere considerati vero progresso [8].
L’intelligenza artificiale diventerà sempre più importante. Le sfide che pone sono tecniche, ma anche antropologiche, educative, sociali e politiche. Promette, ad esempio, un risparmio di fatiche, una produzione più efficiente, trasporti più agevoli e mercati più dinamici, oltre a una rivoluzione nei processi di raccolta, organizzazione e verifica dei dati. Occorre essere consapevoli delle rapide trasformazioni in atto e gestirle in modo da salvaguardare i diritti umani fondamentali, rispettando le istituzioni e le leggi che promuovono lo sviluppo umano integrale. L’intelligenza artificiale dovrebbe essere al servizio del migliore potenziale umano e delle nostre più alte aspirazioni, non in competizione con essi.
3. La tecnologia del futuro: macchine che imparano da sole
Nelle sue molteplici forme l’intelligenza artificiale, basata su tecniche di apprendimento automatico (machine learning), pur essendo ancora in fase pionieristica, sta già introducendo notevoli cambiamenti nel tessuto delle società, esercitando una profonda influenza sulle culture, sui comportamenti sociali e sulla costruzione della pace.
Sviluppi come il machine learning o come l’apprendimento profondo (deep learning) sollevano questioni che trascendono gli ambiti della tecnologia e dell’ingegneria e hanno a che fare con una comprensione strettamente connessa al significato della vita umana, ai processi basilari della conoscenza e alla capacità della mente di raggiungere la verità.
L’abilità di alcuni dispositivi nel produrre testi sintatticamente e semanticamente coerenti, ad esempio, non è garanzia di affidabilità. Si dice che possano “allucinare”, cioè generare affermazioni che a prima vista sembrano plausibili, ma che in realtà sono infondate o tradiscono pregiudizi. Questo pone un serio problema quando l’intelligenza artificiale viene impiegata in campagne di disinformazione che diffondono notizie false e portano a una crescente sfiducia nei confronti dei mezzi di comunicazione. La riservatezza, il possesso dei dati e la proprietà intellettuale sono altri ambiti in cui le tecnologie in questione comportano gravi rischi, a cui si aggiungono ulteriori conseguenze negative legate a un loro uso improprio, come la discriminazione, l’interferenza nei processi elettorali, il prendere piede di una società che sorveglia e controlla le persone, l’esclusione digitale e l’inasprimento di un individualismo sempre più scollegato dalla collettività. Tutti questi fattori rischiano di alimentare i conflitti e di ostacolare la pace.
4. Il senso del limite nel paradigma tecnocratico
Il nostro mondo è troppo vasto, vario e complesso per essere completamente conosciuto e classificato. La mente umana non potrà mai esaurirne la ricchezza, nemmeno con l’aiuto degli algoritmi più avanzati. Questi, infatti, non offrono previsioni garantite del futuro, ma solo approssimazioni statistiche. Non tutto può essere pronosticato, non tutto può essere calcolato; alla fine «la realtà è superiore all’idea» [9]e, per quanto prodigiosa possa essere la nostra capacità di calcolo, ci sarà sempre un residuo inaccessibile che sfugge a qualsiasi tentativo di misurazione.
Inoltre, la grande quantità di dati analizzati dalle intelligenze artificiali non è di per sé garanzia di imparzialità. Quando gli algoritmi estrapolano informazioni, corrono sempre il rischio di distorcerle, replicando le ingiustizie e i pregiudizi degli ambienti in cui esse hanno origine. Più diventano veloci e complessi, più è difficile comprendere perché abbiano prodotto un determinato risultato.
Le macchine “intelligenti” possono svolgere i compiti loro assegnati con sempre maggiore efficienza, ma lo scopo e il significato delle loro operazioni continueranno a essere determinati o abilitati da esseri umani in possesso di un proprio universo di valori. Il rischio è che i criteri alla base di certe scelte diventino meno chiari, che la responsabilità decisionale venga nascosta e che i produttori possano sottrarsi all’obbligo di agire per il bene della comunità. In un certo senso, ciò è favorito dal sistema tecnocratico, che allea l’economia con la tecnologia e privilegia il criterio dell’efficienza, tendendo a ignorare tutto ciò che non è legato ai suoi interessi immediati [10].
Questo deve farci riflettere su un aspetto tanto spesso trascurato nella mentalità attuale, tecnocratica ed efficientista, quanto decisivo per lo sviluppo personale e sociale: il “senso del limite”. L’essere umano, infatti, mortale per definizione, pensando di travalicare ogni limite in virtù della tecnica, rischia, nell’ossessione di voler controllare tutto, di perdere il controllo su sé stesso; nella ricerca di una libertà assoluta, di cadere nella spirale di una dittatura tecnologica. Riconoscere e accettare il proprio limite di creatura è per l’uomo condizione indispensabile per conseguire, o meglio, accogliere in dono la pienezza. Invece, nel contesto ideologico di un paradigma tecnocratico, animato da una prometeica presunzione di autosufficienza, le disuguaglianze potrebbero crescere a dismisura, e la conoscenza e la ricchezza accumularsi nelle mani di pochi, con gravi rischi per le società democratiche e la coesistenza pacifica [11].
5. Temi scottanti per l’etica
In futuro, l’affidabilità di chi richiede un mutuo, l’idoneità di un individuo ad un lavoro, la possibilità di recidiva di un condannato o il diritto a ricevere asilo politico o assistenza sociale potrebbero essere determinati da sistemi di intelligenza artificiale. La mancanza di diversificati livelli di mediazione che questi sistemi introducono è particolarmente esposta a forme di pregiudizio e discriminazione: gli errori sistemici possono facilmente moltiplicarsi, producendo non solo ingiustizie in singoli casi ma anche, per effetto domino, vere e proprie forme di disuguaglianza sociale.
Talvolta, inoltre, le forme di intelligenza artificiale sembrano in grado di influenzare le decisioni degli individui attraverso opzioni predeterminate associate a stimoli e dissuasioni, oppure mediante sistemi di regolazione delle scelte personali basati sull’organizzazione delle informazioni. Queste forme di manipolazione o di controllo sociale richiedono un’attenzione e una supervisione accurate, e implicano una chiara responsabilità legale da parte dei produttori, di chi le impiega e delle autorità governative.
L’affidamento a processi automatici che categorizzano gli individui, ad esempio attraverso l’uso pervasivo della vigilanza o l’adozione di sistemi di credito sociale, potrebbe avere ripercussioni profonde anche sul tessuto civile, stabilendo improprie graduatorie tra i cittadini. E questi processi artificiali di classificazione potrebbero portare anche a conflitti di potere, non riguardando solo destinatari virtuali, ma persone in carne ed ossa. Il rispetto fondamentale per la dignità umana postula di rifiutare che l’unicità della persona venga identificata con un insieme di dati. Non si deve permettere agli algoritmi di determinare il modo in cui intendiamo i diritti umani, di mettere da parte i valori essenziali della compassione, della misericordia e del perdono o di eliminare la possibilità che un individuo cambi e si lasci alle spalle il passato.
In questo contesto non possiamo fare a meno di considerare l’impatto delle nuove tecnologie in ambito lavorativo: mansioni che un tempo erano appannaggio esclusivo della manodopera umana vengono rapidamente assorbite dalle applicazioni industriali dell’intelligenza artificiale. Anche in questo caso, c’è il rischio sostanziale di un vantaggio sproporzionato per pochi a scapito dell’impoverimento di molti. Il rispetto della dignità dei lavoratori e l’importanza dell’occupazione per il benessere economico delle persone, delle famiglie e delle società, la sicurezza degli impieghi e l’equità dei salari dovrebbero costituire un’alta priorità per la Comunità internazionale, mentre queste forme di tecnologia penetrano sempre più profondamente nei luoghi di lavoro.
6. Trasformeremo le spade in vomeri?
In questi giorni, guardando il mondo che ci circonda, non si può sfuggire alle gravi questioni etiche legate al settore degli armamenti. La possibilità di condurre operazioni militari attraverso sistemi di controllo remoto ha portato a una minore percezione della devastazione da essi causata e della responsabilità del loro utilizzo, contribuendo a un approccio ancora più freddo e distaccato all’immensa tragedia della guerra. La ricerca sulle tecnologie emergenti nel settore dei cosiddetti “sistemi d’arma autonomi letali”, incluso l’utilizzo bellico dell’intelligenza artificiale, è un grave motivo di preoccupazione etica. I sistemi d’arma autonomi non potranno mai essere soggetti moralmente responsabili: l’esclusiva capacità umana di giudizio morale e di decisione etica è più di un complesso insieme di algoritmi, e tale capacità non può essere ridotta alla programmazione di una macchina che, per quanto “intelligente”, rimane pur sempre una macchina. Per questo motivo, è imperativo garantire una supervisione umana adeguata, significativa e coerente dei sistemi d’arma.
Non possiamo nemmeno ignorare la possibilità che armi sofisticate finiscano nelle mani sbagliate, facilitando, ad esempio, attacchi terroristici o interventi volti a destabilizzare istituzioni di governo legittime. Il mondo, insomma, non ha proprio bisogno che le nuove tecnologie contribuiscano all’iniquo sviluppo del mercato e del commercio delle armi, promuovendo la follia della guerra. Così facendo, non solo l’intelligenza, ma il cuore stesso dell’uomo, correrà il rischio di diventare sempre più “artificiale”. Le più avanzate applicazioni tecniche non vanno impiegate per agevolare la risoluzione violenta dei conflitti, ma per pavimentare le vie della pace.
In un’ottica più positiva, se l’intelligenza artificiale fosse utilizzata per promuovere lo sviluppo umano integrale, potrebbe introdurre importanti innovazioni nell’agricoltura, nell’istruzione e nella cultura, un miglioramento del livello di vita di intere nazioni e popoli, la crescita della fraternità umana e dell’amicizia sociale. In definitiva, il modo in cui la utilizziamo per includere gli ultimi, cioè i fratelli e le sorelle più deboli e bisognosi, è la misura rivelatrice della nostra umanità.
Uno sguardo umano e il desiderio di un futuro migliore per il nostro mondo portano alla necessità di un dialogo interdisciplinare finalizzato a uno sviluppo etico degli algoritmi – l’algor-etica –, in cui siano i valori a orientare i percorsi delle nuove tecnologie [12]. Le questioni etiche dovrebbero essere tenute in considerazione fin dall’inizio della ricerca, così come nelle fasi di sperimentazione, progettazione, produzione, distribuzione e commercializzazione. Questo è l’approccio dell’etica della progettazione, in cui le istituzioni educative e i responsabili del processo decisionale hanno un ruolo essenziale da svolgere.
7. Sfide per l’educazione
Lo sviluppo di una tecnologia che rispetti e serva la dignità umana ha chiare implicazioni per le istituzioni educative e per il mondo della cultura. Moltiplicando le possibilità di comunicazione, le tecnologie digitali hanno permesso di incontrarsi in modi nuovi. Tuttavia, rimane la necessità di una riflessione continua sul tipo di relazioni a cui ci stanno indirizzando. I giovani stanno crescendo in ambienti culturali pervasi dalla tecnologia e questo non può non mettere in discussione i metodi di insegnamento e formazione.
L’educazione all’uso di forme di intelligenza artificiale dovrebbe mirare soprattutto a promuovere il pensiero critico. È necessario che gli utenti di ogni età, ma soprattutto i giovani, sviluppino una capacità di discernimento nell’uso di dati e contenuti raccolti sul web o prodotti da sistemi di intelligenza artificiale. Le scuole, le università e le società scientifiche sono chiamate ad aiutare gli studenti e i professionisti a fare propri gli aspetti sociali ed etici dello sviluppo e dell’utilizzo della tecnologia.
La formazione all’uso dei nuovi strumenti di comunicazione dovrebbe tenere conto non solo della disinformazione, delle fake news, ma anche dell’inquietante recrudescenza di «paure ancestrali [...] che hanno saputo nascondersi e potenziarsi dietro nuove tecnologie» [13]. Purtroppo, ancora una volta ci troviamo a dover combattere “la tentazione di fare una cultura dei muri, di alzare muri per impedire l’incontro con altre culture, con altra gente” [14]e lo sviluppo di una coesistenza pacifica e fraterna.
8. Sfide per lo sviluppo del diritto internazionale
La portata globale dell’intelligenza artificiale rende evidente che, accanto alla responsabilità degli Stati sovrani di disciplinarne l’uso al proprio interno, le Organizzazioni internazionali possono svolgere un ruolo decisivo nel raggiungere accordi multilaterali e nel coordinarne l’applicazione e l’attuazione [15]. A tale proposito, esorto la Comunità delle nazioni a lavorare unita al fine di adottare un trattato internazionale vincolante, che regoli lo sviluppo e l’uso dell’intelligenza artificiale nelle sue molteplici forme. L’obiettivo della regolamentazione, naturalmente, non dovrebbe essere solo la prevenzione delle cattive pratiche, ma anche l’incoraggiamento delle buone pratiche, stimolando approcci nuovi e creativi e facilitando iniziative personali e collettive [16].
In definitiva, nella ricerca di modelli normativi che possano fornire una guida etica agli sviluppatori di tecnologie digitali, è indispensabile identificare i valori umani che dovrebbero essere alla base dell’impegno delle società per formulare, adottare e applicare necessari quadri legislativi. Il lavoro di redazione di linee guida etiche per la produzione di forme di intelligenza artificiale non può prescindere dalla considerazione di questioni più profonde riguardanti il significato dell’esistenza umana, la tutela dei diritti umani fondamentali, il perseguimento della giustizia e della pace. Questo processo di discernimento etico e giuridico può rivelarsi un’occasione preziosa per una riflessione condivisa sul ruolo che la tecnologia dovrebbe avere nella nostra vita individuale e comunitaria e su come il suo utilizzo possa contribuire alla creazione di un mondo più equo e umano. Per questo motivo, nei dibattiti sulla regolamentazione dell’intelligenza artificiale, si dovrebbe tenere conto della voce di tutte le parti interessate, compresi i poveri, gli emarginati e altri che spesso rimangono inascoltati nei processi decisionali globali.
* * *
Spero che questa riflessione incoraggi a far sì che i progressi nello sviluppo di forme di intelligenza artificiale servano, in ultima analisi, la causa della fraternità umana e della pace. Non è responsabilità di pochi, ma dell’intera famiglia umana. La pace, infatti, è il frutto di relazioni che riconoscono e accolgono l’altro nella sua inalienabile dignità, e di cooperazione e impegno nella ricerca dello sviluppo integrale di tutte le persone e di tutti i popoli.
La mia preghiera all’inizio del nuovo anno è che il rapido sviluppo di forme di intelligenza artificiale non accresca le troppe disuguaglianze e ingiustizie già presenti nel mondo, ma contribuisca a porre fine a guerre e conflitti, e ad alleviare molte forme di sofferenza che affliggono la famiglia umana. Possano i fedeli cristiani, i credenti di varie religioni e gli uomini e le donne di buona volontà collaborare in armonia per cogliere le opportunità e affrontare le sfide poste dalla rivoluzione digitale, e consegnare alle generazioni future un mondo più solidale, giusto e pacifico.
Dal Vaticano, 8 dicembre 2023
FRANCESCO
[1] N. 33.
[2] Ibid., 57.
[3] Cfr Lett. enc. Laudato si’ (24 maggio 2015), 104.
[4] Cfr ibid., 114.
[5] Udienza ai partecipanti all’Incontro “Minerva Dialogues” (27 marzo 2023).
[6] Cfr ibid.
[7] Cfr Messaggio al Presidente Esecutivo del “World Economic Forum” a Davos-Klosters (12 gennaio 2018).
[8] Cfr Lett. enc. Laudato si’, 194; Discorso ai partecipanti al Seminario “Il bene comune nell’era digitale” (27 settembre 2019).
[9] Esort. ap. Evangelii gaudium (24 novembre 2013), 233.
[10] Cfr Lett. enc. Laudato si’, 54.
[11] Cfr Discorso ai partecipanti alla Plenaria della Pontificia Accademia per la Vita (28 febbraio 2020).
[12] Cfr ibid.
[13] Lett. enc. Fratelli tutti (3 ottobre 2020), 27.
[14] Cfr ibid.
[15] Cfr ibid., 170-175.
[16] Cfr Lett. enc. Laudato si’, 177.
Copyright © Dicastero per la Comunicazione – Libreria Editrice Vaticana
—————————————-

Disperazione e Spes contra Spem


 Chiesadituttichiesadeipoveri: Newsletter n.324 del 28 dicembre 2023
Chiesadituttichiesadeipoveri: Newsletter n.324 del 28 dicembre 2023
Costituente Terra: Newsletter n. 143 del 28 dicembre 2023
DUE (O PIÙ) CATASTROFI E UNA RIVELAZIONE
Cari amici,
abbiamo vissuto questo doloroso Natale con due catastrofi e una rivelazione.
La prima è la catastrofe umanitaria. Secondo le ultime notizie giunte da Gaza, sono stati uccisi finora 21.110 palestinesi tra cui 8.800 bambini, 6.300 donne, 3111 medici e personale sanitario, 40 addetti alla protezione civile e più di 100 giornalisti; 7.000 persone risultano disperse, 55.243 sono state ferite, 92 scuole e università, 115 moschee e tre chiese sono state distrutte insieme a decine di migliaia di case, 23 ospedali e 53 centri medici non sono più operativi, 102 ambulanze sono state attaccate, l’intera popolazione è errante, Nemmeno è venuta meno la catastrofe in Ucraina e nel mar Nero.
La seconda catastrofe è quella del potere e dell’informazione in Israele, in Ucraina e in tutto l’Occidente.
In Israele ieri il quotidiano Haaretz e il Canale televisivo 12, hanno informato che lo Shin Bet, il servizio segreto israeliano per l’interno, aveva saputo in anticipo che Hamas stava allestendo un attacco “significativo” a Gaza, mentre il famoso e accreditato giornalista americano Seymour Hersh ha scritto di aver appreso da un funzionario israeliano che Netanyahu aveva “visto e letto” le anticipazioni sull’attacco palestinese. Il New York Times da parte sua aveva parlato a fine novembre di questa informazione di cui disponeva Israele. L’ex responsabile italiano del controspionaggio e del contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, Marco Mancini (quello dell’incontro con Renzi) aveva a sua volta spiegato a TV 7 che era impossibile che Israele non avesse scorto Hamas preparare un attacco dato che vi stava per impiegare visibilissimi alianti a motore; come poi si è visto sono stati impiegati anche robusti bulldozer per aprire i varchi nella recinzione del confine. A ciò si può accostare quanto sostenuto da Hamas, che gli attaccanti intendevano prendere ostaggi per riaprire la partita con Israele, e aspettandosi di incontrare una forte resistenza, avevano messo in campo molti uomini, scontando di perderne un gran numero (“martiri”); invece non hanno trovato difese, mentre attraverso i varchi così aperti hanno fatto irruzione molti altri palestinesi che, inferociti per i lunghi tormenti subiti ad opera del nemico, si sono abbandonati alla strage (1417 israeliani uccisi, mai tanti ebrei tutti in una volta dopo la Shoah).
Che Netanyahu avesse adottato la politica di non contrastare Hamas per indebolire l’autorità palestinese a Ramallah e porre fine all’idea di uno Stato palestinese, era cosa risaputa da tempo. Resta da chiarire il motivo per cui Netanyahu, ormai identificato da più lustri con lo Stato di Israele, pur sapendolo non abbia impedito l’azione terroristica a Gaza; e la ragione non può essere se non la “ragion di Stato” di provocare, grazie a quell’azione (non prevista però in quella dimensione dandosi per scontata la debolezza di Hamas) il casus belli che gli permettesse di sferrare l’offensiva finale per chiudere la “questione palestinese”. Accusato perciò anche in Israele del disastro, Netanyahu ha risposto portando fino alle estreme conseguenze l’eccidio a Gaza (da lui stesso, accusato da Erdogan, paragonato al genocidio turco dei Curdi), e respingendo, perfino con Biden, ogni esortazione a interromperlo. A questo punto si è aggiunta la catastrofe della politica degli Stati Uniti, che dopo l’appello a Israele di non ripetere “l’errore” americano fatto dopo l’11 settembre, hanno votato contro la tregua all’ONU, mentre Biden, dopo una lunga infruttuosa telefonata con Netanyahu, ha penosamente dichiarato trattarsi di una “conversazione privata” e di non avere chiesto al premier israeliano il “cessate il fuoco”.
A questa catastrofe politica si aggiunge quella dell’Ucraina, a cui si è fatto credere di poter sconfiggere la Russia riconquistando la Crimea ed entrando nella NATO, e si trova ora con un popolo mandato al sacrificio, senza i dollari americani e le armi che deve perciò implorare dall’Europa, impeditane dal veto di Orban.
L’Occidente, dal canto suo, grazie anche al suo sistema mediatico, che ha un po’ mistificato e un po’ taciuto tutto questo, ha perduto così ogni fondamento nel vantare la superiorità dei propri valori e la sua pretesa di dominio sulle autocrazie e sul “resto del mondo”.
Queste le catastrofi. La rivelazione che ne è venuta è questa: che la guerra non è solo “una follia senza scuse”, come ha detto papa Francesco nel suo messaggio di Natale. È anche e soprattutto un suicidio per chi la intraprende, prima ancora che sconfigga il nemico o lo voti al genocidio; ciò è avvenuto con la Germania nazista, avviene con i sogni di gloria degli Stati Uniti e della loro NATO, avviene con Israele, avviene con l’Ucraina. Contro i fautori di guerra e chi fabbrica e li rifornisce di armi, dovrebbe essere questo l’argomento decisivo. Purtroppo però esso può funzionare con i popoli, non funziona con gli Stati e i loro apparati di governo. Finché noi glielo permettiamo.
Nel sito pubblichiamo il messaggio del Papa per Natale, un articolo di Haaretz sull’identificazione di Netanyahu e di Israele (da cui è sempre più necessario distinguere il popolo ebreo della Diaspora, come voleva Primo Levi), e il testo di un intervento natalizio “su Gesù” di Raniero La Valle, sulla piattaforma digitale “Servizio Pubblico””.
Con i più cordiali saluti,
Chiesa di Tutti Chiesa dei Poveri
Costituente Terra
——————————-
Israele può cambiare: Un nuovo Israele è possibile?


La proposta di Primo Levi
DISTINGUERE LO STATO DI ISRAELE DALLA DIASPORA EBRAICA
21 DICEMBRE 2023 / EDITORE / DICE LA STORIA /
Lo Stato d’Israele può cambiare la sua natura e diventare uno Stato democratico costituzionale e di più popoli (compresi i palestinesi), le cui tradizioni culturali e religiose siano salvaguardate senza essere ridotte ad affare privato come negli Stati atei dell’Occidente
Raniero La Valle su Costituente Terra e su Chiesadituttichiesadeipoveri.
Pubblichiamo l’intervento di Raniero La Valle al meeting romano “Non è una striscia. È Gaza” del 9 dicembre 2023.
Mi avete posto la domanda se Israele può cambiare: Un nuovo Israele è possibile? Prima di tutto vediamo perché è necessario.
Ciò che è oggi lo Stato di Israele è sancito dalla Legge fondamentale approvata dalla Knesset giovedì 19 luglio 2018, dalla quale lo Stato di Israele era definito come lo “Stato nazione del Popolo Ebraico”. Essa però impegna lo Stato come istituzione, non il popolo d’Israele come tale, tanto è vero che fu approvata da una ristrettissima maggioranza di 62 voti favorevoli e 55 contrari, con la contrarietà dell’allora presidente di Israele Reuven Rivlin, che in una lettera ai parlamentari aveva espresso il timore che essa potesse “recare danno al popolo ebraico, agli Ebrei nel mondo e allo Stato di Israele”, e con la contrarietà di una ampia corrente di ebrei secondo la fede.
Perché è necessario il cambiamento? Perché con questa identità dello Stato che esso viva in pace è impossibile, e il genocidio è inevitabile. La terra come diritto naturale, storico e religioso, quindi assoluto, non si può discutere nemmeno per una sua piccola parte, compresa Gaza e la Cisgiordania: i rabbini della corrente ortodossa si opposero al ritiro da Gaza deciso da Sharon e lo accusarono di essere un nazista. Gerusalemme è definita, senza alcun compromesso possibile, come una città indivisibile e capitale eterna di Israele. Il popolo ebreo esercita un diritto originario all’autodeterminazione, cioè alla sovranità e ai diritti politici, ed è l’unico a cui è riservato tale diritto all’autodeterminazione. Lo Stato di Israele estende la sua competenza anche agli Ebrei della diaspora, quando fossero in pericolo, in quanto ebrei, indipendentemente dalla loro cittadinanza.
Dunque per i palestinesi non c’è posto se non in quanto privati dei diritti e soggiogati, e siccome questo non è definitivamente possibile, devono essere espulsi o indotti o costretti ad andarsene. La guerra di Gaza è un momento della realizzazione politica, cioè effettiva, di questo modello giuridico.
Per questa ragione Liliana Segre ha espresso il suo disagio dicendo:
“L’eterno ritorno della guerra mi fa sentire prigioniera di una trappola mentale senza uscita, spettatrice impotente, in pena per Israele ma anche per tutti i palestinesi innocenti, entrambi intrappolati nella catena delle violenze e dei rancori”. “E non ho soluzioni. E non ho più parole. Ho solo pensieri tristi. Provo angoscia per gli ostaggi e per le loro famiglie – sottolinea – Provo pietà per tutti i bambini, che sono sacri senza distinzione di nazionalità o di fede, che soffrono e muoiono. Che pagano perché altri non hanno saputo trovare le vie della pace”.
Questo è perché è necessario.
Il secondo punto è se è possibile. Io credo di sì, ma non se si propone un cambiamento impossibile. Il cambiamento impossibile è quello proposto dalla cultura avanzata e laica dei palestinesi. Parlo dei palestinesi che si rifanno alla tradizione di Arafat e dell’OLP, e non della cultura di Hamas e degli estremisti islamici. Questa proposta è quella di uno Stato laico, democratico e pluralista in Palestina.
Questo è anche l’unico modello proposto dall’Occidente. Dato che ormai è stato reso impossibile dall’esercito, dai coloni e dal governo la soluzione dei due Stati; è rimasta solo l’opzione di un solo Stato democratico, non etnico, non confessionale, non mitico. Questa è la soluzione che corrisponde all’attuale cultura dell’Occidente, laica secolare post-teista, Di fatto, anche se non di nome, la concezione dello Stato in Occidente è una concezione atea, tanto che Berlinguer dovette differenziarne il PCI dicendo che esso era non teista, non ateista, non antiteista. Se non lo era il PCI tanto meno lo può essere Israele. Chiedere a Israele di non essere più uno Stato la cui ragione di essere è la fede religiosa dell’ebraismo, cioè il riferimento alla legge, alla Torah, e ai profeti, e che non sia più la patria d’elezione, sicura e riconosciuta, di tutti gli Ebrei che vi si vogliano insediare e vivere significa, questo sì, negare l’esistenza dello Stato d’Israele e buttare a mare tutte le decisioni dell’ONU a favore di Israele e tutta la storia di questi 75 anni.
Quindi la soluzione è la più difficile. Deve cambiare la concezione e la natura dello Stato, che non deve essere né lo Stato moloch né lo Stato leviatano che sta nell’ideologia bellicista e sovranista dell’Occidente, ma uno Stato in cui coesistano diversi ordinamenti giuridici che permettano e garantiscano a ognuno dei popoli che lo abitano di mantenere la propria cultura, le proprie tradizioni e la propria religione. Questo Stato non esiste in natura, e non esiste finché noi ci comportiamo come i nipotini di Thomas Hobbes e di Friedrich Nietzsche, ma che in qualche modo fu intuito dai Costituenti italiani che fecero la battaglia per una Costituzione laica e democratica, ma che includesse gli art. 7, 8 e 9 della Costituzione repubblicana (cioè convivenza Stato-Chiesa, religioni libere ma non affare privato, tutela del patrimonio storico della nazione in funzione delle generazioni future, dunque uno Stato in cui le religioni, le culture e la vita delle generazioni culture erano riconosciute non come fatti privati, ma come realtà e patrimoni pubblici e plurali.
Realizzare questo progetto di Stato è difficilissimo, e tanto più lo è oggi nelle condizioni attuali dell’ideologia politica e del patriarcato militarista e violento dello Stato di Israele, ma questo è possibile, come è stata possibile l’uscita dal regime di cristianità.
Tuttavia questo sicuramento non è possibile oggi, ma potrà esserlo attraverso un lungo e per noi imprevedibile percorso. Certo non basta, come tutti dicono, far fuori Netanhyau.
Iinvece c’è un altro cambiamento possibile e necessario oggi. È quello reclamato da Primo Levi nella intervista a Gad Lerner del 1984, ed è una distinzione, se non una presa di distanza, tra la Diaspora degli Ebrei sparsi nel mondo e lo Stato di Israele, e per noi la distinzione tra lo Stato di Israele e il popolo ebreo della diaspora, a cominciare dagli Ebrei di Roma e d’Italia. Il centro di irradizione dell’ebraismo, dice Primo Levi, non può essere oggi lo Stato di Israele, a cui noi ebrei della diaspora dobbiamo ricordare la tradizione ebraica di tolleranza. Diceva Levi che questo passaggio del baricentro dell’ebraismo dallo Stato di Israele agli ebrei della diaspora, riguardava l’attuale – e sottolineava l’attuale – Israele, cioè l’Israele di allora, figuriamoci che cosa si debba dire dello Stato di Israele di oggi. Solo se si riesce a separare il popolo ebreo dalla macelleria israeliana di Gaza e della Cisgiordania è possibile resistere all’antisemitismo risorgente, e per dirla in modo ancora più angosciato, solo se si distingue lo Stato apocalittico di Israele dal resto dell’ebraismo, si può salvare il popolo ebreo.
Ma in ogni caso proporre e promuovere questa soluzione che salva insieme il popolo d’Israele e il popolo palestinese, è il nostro compito politico, ed anche per questo vogliamo un soggetto politico che lotti per la pace, la Terra di tutti, e la dignità di tutte le persone ed i popoli.
————————————————————
LA BUONA NOTIZIA: MILIONI DI EBREI SI OPPONGONO AL GENOCIDIO A GAZA
21 DICEMBRE 2023 / COSTITUENTE TERRA / L’UNITÀ UMANA /
L’abuso dell’Olocausto per giustificare le politiche dello Stato di Israele. La falsa tesi della debolezza delle vittime
Sig Giordano
La storia dei miei nonni sopravvissuti all’Olocausto mi ha insegnato cos’è un genocidio, ed è così che posso condannare ciò che Israele sta facendo a Gaza in questo momento. Come osa Israele sfruttare la sofferenza della mia famiglia per cercare di giustificare il suo genocidio a Gaza?
Se i miei nonni fossero ancora vivi, in questo ottobre si sarebbe celebrato l’ottantesimo anniversario del loro incontro. Nel 1943 i miei nonni, Isidor e Marianne, si incontrarono a Theresienstadt, un campo di concentramento nella Cecoslovacchia occupata dai nazisti. Ero molto legato a mio nonno Isi, che sopravvisse alla nonna. Tra le sue cose mi affidò la stella “ebraica” di stoffa gialla con sopra la parola “Jude” che gli avevano fatto indossare nel campo.
Durante un incontro alle Nazioni Unite (ONU) il 31 ottobre, Gilad Erdan, ambasciatore israeliano all’ONU, ha indossato una stella ebraica simile a quella di mio nonno. Rivolgendosi al Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha dichiarato che indossava la stella per denunciare il silenzio del Consiglio riguardo all’attacco del 7 ottobre contro Israele. Erdan ha paragonato questo silenzio al silenzio che permise che si verificasse l’Olocausto. In risposta Dani Dayan, il direttore dello Yad Vashem, il museo israeliano memoriale dell’Olocausto, ha subito denunciato quell’uso improprio della stella, sostenendo che Erdan stava “disonorando le vittime dell’Olocausto, così come lo Stato di Israele”.
Dayan aveva assolutamente ragione nel richiamare l’attenzione su quanto fosse offensivo che Erdan indossasse la stella gialla. Le ragioni di Dayan, tuttavia, sono completamente sbagliate. Per sostenere il suo argomento, Dayan ha sostenuto che la stella gialla simboleggia la debolezza del popolo ebraico durante l’Olocausto, ribadendo una narrazione storica inquietante e falsa.
I sionisti hanno a lungo cercato di raffigurare le vittime dell’Olocausto come deboli per sostenere la fondazione e poi il mantenimento dello Stato di Israele. Questa mossa iniziò anche prima dell’Olocausto, quando alcuni sionisti si allinearono con la scienza razziale eugenetica dell’epoca sostenendo che gli ebrei dovevano purificare la propria razza e creare una propria razza forte. Arthur Ruppin, eminente scienziato sociale e capo dell’ufficio palestinese dell’Organizzazione sionista mondiale all’inizio del XX secolo, promosse l’insediamento in Palestina come risposta ai pericolosi risultati della “mescolanza razziale” degli ebrei europei. Non era il solo, poiché molti intellettuali ebrei sostenevano che la formazione dello Stato sionista avrebbe consentito agli ebrei di “rigenerare i propri corpi” degenerati nelle condizioni di assimilazione nell’Europa occidentale e di oppressione in quella orientale.
Una volta fondato Israele, le vittime dell’Olocausto furono regolarmente trattate come deboli e come esempi all’opposto di ciò che rappresentava lo Stato sionista, il che portò al pessimo trattamento per i sopravvissuti che divennero cittadini israeliani. Come Dayan stesso ha ribadito, l’Olocausto rappresenterebbe un monito sul contrapporre la debolezza degli ebrei nella diaspora alla forza degli ebrei nello Stato di Israele.
Nonostante la distanza delle loro opinioni, leader israeliani come Erdan e Dayan fanno regolarmente uso dell’Olocausto per difendere la violenza di Stato contro i palestinesi. A differenza di Erdan e Dayan, conoscere il genocidio contro i miei antenati mi ha permesso di capire che ciò che sta accadendo oggi in Palestina è un genocidio. Sapere che si sta perpetrando un genocidio è doloroso di per sé. Sapere che un genocidio viene compiuto presumibilmente a mio nome (in quanto ebreo) è estremamente doloroso. Ma sapere che un genocidio viene giustificato con l’appropriazione della sofferenza della mia famiglia mi fa infuriare. Sono furioso. Come osa lo Stato di Israele insultare la storia della mia famiglia?
Gli orrori che la mia famiglia ha dovuto sopportare sono inimmaginabili per la maggior parte delle persone. Mia nonna e mio nonno, adolescenti quando si incontrarono al campo, sono gli unici membri sopravvissuti delle loro famiglie. Mio nonno faceva parte della resistenza nel campo, e nascondeva le persone che erano sulle liste per essere deportate ad Auschwitz. Mio nonno ha letteralmente salvato la vita a mia nonna. Questa non è una storia di debolezza. Tuttavia, è una storia dalla quale ho imparato molte lezioni sulle condizioni che consentono il genocidio.
Ricordo che avevo 8 o 9 anni e sedevo al tavolo di cucina a fare colazione mentre mia madre cucinava. La radio era accesa come ogni mattina e trasmetteva le notizie di 1010 WINS [radio privata di New York, ndt.]: “Dacci 22 minuti, ti daremo il mondo”. Nei titoli un gruppo di resistenza rivendicava la responsabilità di un attentato da qualche parte fuori dagli Stati Uniti. Ho chiesto a mia madre: “Cos’è un gruppo di resistenza?” Lei mi ha spiegato l’idea di resistenza parlando dell’Olocausto e della lotta di suo padre per reagire.
Anche se non tutte le persone che affermano di resistere sono automaticamente nel giusto, quando sono cresciuto mi sono reso conto che il modo in cui si vede la resistenza in una determinata situazione dipende dal proprio punto di vista. Ciò può sembrare ovvio, ma nei media occidentali, nella politica e nei contesti educativi vediamo regolarmente un’associazione tra gruppi di resistenza e terrorismo che crea un lato giusto e uno sbagliato dati per scontati.
Nei giorni successivi all’11 settembre 2001, come cittadino americano che vive negli Stati Uniti mi sono ricordato che quando mi opponevo all’idea di invadere l’Afghanistan ero “con noi” o “contro di noi”. Il nazionalismo forzato mi ha ricordato gli studi sull’Olocausto che avevo intrapreso durante il college. La creazione della mentalità “Noi contro loro” per proteggere la Germania era stata una parte fondamentale nel coinvolgere ampi segmenti di tedeschi non ebrei nella lotta contro il popolo ebraico.
La resistenza si muove contro coloro che detengono il potere. Inoltre essere oppressi, per definizione, significa essere dalla parte dei perdenti in una dinamica di potere. Allora, com’è possibile che Israele, un paese con uno degli eserciti più potenti del mondo, sostenuto dalla più potente potenza militare ed economica del mondo, gli Stati Uniti, abbia cercato di dipingersi come il campione di un popolo oppresso che deve lottare contro i movimenti di resistenza palestinesi?
Jonathan Greenblatt, direttore dell’Anti-Defamation League (ADL) [organizzazione non governativa ebraica internazionale con sede a New York in difesa dei diritti civili e contro l’antisemitismo, ndt.] ha pubblicato un articolo sulla rivista Time dopo l’attacco del 7 ottobre sostenendo che non c’è modo di interpretare l’attacco di Hamas se non come “odio” e “intolleranza tossica nella sua forma più pura”. E se invece di rendere eccezionale l’esperienza ebraica in modo che l’Olocausto diventi un esempio di migliaia di anni di odio per gli ebrei prestassimo attenzione alle reali lezioni che possiamo imparare dagli orrori dell’Olocausto? La lezione di cui abbiamo bisogno non è che gli ebrei sono sempre stati e sempre saranno odiati. La lezione dell’Olocausto è che coloro che detenevano il potere economico e politico usarono il nazionalismo e l’idea a giustificazione del genocidio che i tipi di persone cosidette inferiori costituissero una minaccia per lo Stato-nazione.
Molti ebrei e non ebrei resistettero per quanto poterono. Il problema non era una resistenza debole, il problema era la forza delle narrazioni nazionaliste ed eugenetiche.
La buona notizia è che milioni di persone e di ebrei stanno prendendo posizioni critiche della situazione e opponendosi ai messaggi che ci vengono porti dai più potenti leader israeliani e statunitensi. Siamo solidali con i palestinesi che lottano per il loro diritto all’esistenza e all’autodeterminazione. Vediamo cambiamenti nei sondaggi d’opinione pubblica, e il numero di azioni guidate e sostenute dagli ebrei contro l’attuale genocidio è più grande che mai. Molti parlano apertamente e dicono ad alta voce che “Mai più” significa “Mai più per nessuno”.
(traduzione dall’inglese di Luciana Galliano)
18 dicembre 2023, da Mondoweiss
———————————————-
Rocca e’ online
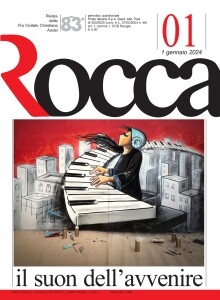
————————————————
E’ Natale!
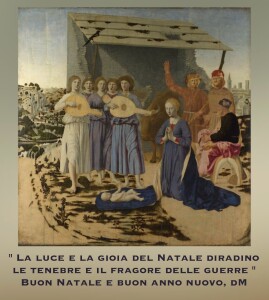 Natale: «La parola avvenne nella carne e pose la sua tenda in mezzo a noi» (Giovanni 1,14)
Natale: «La parola avvenne nella carne e pose la sua tenda in mezzo a noi» (Giovanni 1,14)
22-12-2023 – di: Andrea Bigalli su Volerelaluna*.
Una lettura storica sulle prospettive della chiesa cattolica non appare certo consolante. L’erosione del patrimonio culturale e sociale che portava a sentirsi parte di essa è evidente. Da un lato c’è la mancata trasmissione generazionale di un’identità sempre meno compresa; dall’altro il peso di vari scandali (in primis quello degli abusi del clero) ha creato una frattura di fiducia nei confronti di una istituzione che faceva proprio della formazione fiduciaria delle giovani generazioni uno dei suoi punti di forza. Neanche un pontificato ricco di aperture e intuizioni straordinarie sembra invertire una tendenza che non appare transitoria. È un’analisi sommaria che potrebbe elencare altro: in ultima analisi comprendendo l’ipotesi che il cristianesimo – il teismo in genere – abbia esaurito la sua spinta propulsiva nel rispondere alle esigenze dell’antropologia contemporanea. Se fino a qualche anno fa si poteva pensare che fosse il positivismo scientifico a minare i presupposti della fede, quanto constatato nella stretta contemporaneità (le contestazioni arbitrarie al pensiero medico scientifico in pandemia, per esempio) fa supporre che il pensiero religioso non sia stato sostituito da una costruzione del tutto logica delle convinzioni esistenziali. Ma ne occorrono davvero? Magari no. Non mi sembra però che rimuovere la questione della metafisica abbia prodotto serenità diffusa, fiducia nel futuro, gratificazione dalla buona qualità di vita. Se si pensa alla trascendenza solo su un piano religioso, si perde la prospettiva di un’evoluzione consapevole, che per gli esseri umani può passare solo per la dimensione della domanda difficile, della provocazione, della consapevolezza della finitudine, ma, al contempo, del valore dell’esperienza umana in quanto tale. Su tutto questo c’è molta poca analisi, la società in cui viviamo ci educa alle prospettive unidirezionali. Herbert Marcuse aveva ragione. Un altro Natale. Ancora più spoglio di significati che non siano quelli del mercato, della convenzione artificiosa riguardo alle relazioni affettive, di modelli di vita sicuramente usurati ed inadeguati. Prevale un crescente disagio, venato dalla preoccupazione riguardo al futuro e dal senso di colpa che ci portiamo dentro. Stiamo assistendo a conflitti sempre più pervasivi, da cui niente sembra poterci esentare: inclusi quelli rappresentati dalla violenza di genere e dalla guerra suicida all’ecosistema. In colpa perché la nostra impotenza diventa rassegnazione. Atterriti nel constatare che le vie di progresso si fanno involute. Lettrici e lettori penseranno che mi sto mettendo nei guai da solo. Da un lato enuncio una crisi, quella del cattolicesimo, dall’altro ne inserisco i termini in quella generale della contemporaneità. Quindi? Ciò che dovrebbe sostenere le Chiese cristiane, la Bibbia, scaturisce per lo più da contesti di crisi, personale e delle società, fino al punto di farmi sostenere che il concetto stesso di crisi ne sia una chiave di lettura basilare. I cattolici arrivano a celebrare Natale guidati da un profeta, Isaia, il cui libro è ossatura fondamentale delle liturgie di Avvento: questo testo, con almeno tre diversi livelli storici e composto a più mani, ruota intorno alla memoria storica e teologica dell’evento più devastante vissuto dal Regno di Israele. Annientati dall’impero babilonese, gli ebrei sono destinati alla deportazione e alla cattività. Nel prima, durante e dopo l’esilio, Isaia ammonisce, contesta, prospetta, consola, sostiene, illumina. Soprattutto presenta una visione: letto il presente con gli occhi di Dio, se ne possono proiettare gli elementi verso il futuro. Non troverete in ciò traccia alcuna di un ottimismo fine a sé stesso, un’ingenuità sul tempo vissuto, la prospettiva artificiosa del fideismo. La Scrittura è scabra, aspra, brutale nel dichiarare ciò che avviene e mettere ognuno davanti alle proprie responsabilità. Ma proprio per questo è veritiera anche quando ti espone il dato dell’imprevedibile, che non può essere solo foriero di negatività. Il Dio che si presenta così educa alla speranza: chiede l’onestà sugli errori, sostiene il cambiamento, condurrà ogni popolo al proprio Esodo, ad una pedagogia di liberazione. I Vangeli sono scritti con lo stile letterario profetico, Cristo è il compimento della profezia stessa: è un codice di comprensione importante, talvolta poco seguito dagli esegeti. Gesù di Nazareth nasce in un tempo difficilissimo: un tempo di dominazione imperiale, di difficile resistenza alle sue istanze culturali di idolatria della forza e del potere, di minorità e marginalità di popoli interi. La società era governata da un potere teocratico che aveva perso ogni autorità, ripetendo stancamente a favore del fariseismo la lettura di un Dio giudicante, divisivo, escludente. Il dio classista dei potenti e dei garantiti: sempre invocato per stroncare le dissidenze, spegnere le profezie, annichilire le speranze. Dio avviene nella carne in questo quadro. E avviene riducendosi a niente, nascendo povero, mite, coraggioso e veritiero in un tempo – quando mai no, però? – della menzogna eletta a sistema di comunicazione. Giovanni, nel primo capitolo, ci dice che il Logos, il senso più alto dell’intelletto, il genio comunicativo e intessuto di razionalità pienamente umana – quindi affettiva, generativa, fantasiosa – avviene nella fragilità e nella contraddittorietà della carne. La prospettiva della condizione effimera, sia pur meravigliosa, della corporeità umana, deve far sintesi con il presupposto intellettivo mai così definito in positivo come nell’idea del Logos/Parola. Il Divino si immerge totalmente nella contraddizione, la crudeltà, la fatica, la sofferenza, la dignità e la bellezza di ciò che è nella dimensione concreta dell’esistere delle donne e degli uomini. Se il Natale lo leggo in questa prospettiva trovo la necessità di incarnarsi nel proprio vivere, nella stagione storica a cui siamo stati consegnati. La verità dei nostri limiti si definisce attraverso le fragilità del relazionarsi: il desiderio, il bisogno, la transitorietà di tutto. Al contempo possiamo capire che ciò che stiamo vivendo si iscrive nella potenzialità dell’altrove, di ciò che procede più in là da quanto definito e conosciuto. La crisi si può abitare in una dimensione profetica: imparando a decifrare i segni di quella che attanaglia l’istituzione che la produce, la governa, gode e profitta del suo essere. Certo, qui una componente fideista c’è e passa per pensare che le vittime e i violentati vedranno la crisi volgersi in crescita perché è l’Impero, racconta l’Apocalisse, il libro che è la summa delle intuizioni profetiche di tutta la Scrittura, che dovrà rassegnarsi al proprio crollo. L’Impero è il simbolo di tutto quel male che ha preteso di governare la storia umana: è stato fondato sul disumanesimo, sussiste in virtù di esso, non può che sprofondare nelle sue stesse logiche di morte. Chi ha conservato una logica di vita, di tenerezza e di solidarietà, sopravviverà. Quando parlo di fede ne intendo una vasta, non necessariamente teista, anzi: sostenuta da quell’umanesimo distillato dalle grandezze e dai fallimenti delle prassi storiche, è la fiducia che gli esseri umani – come sosteneva il mio maestro Ernesto Balducci – hanno in sé potenzialità inedite ancora nascoste, in lento travaglio verso la piena espressione. L’umano della pace non si è del tutto svelato, ma è già presente. Talvolta soccombe, ma la sua piena e feconda espressione è irriducibile, avverrà comunque. Nel 2024 celebreremo i cento anni dalla nascita di Franco Basaglia, la cui azione ha espresso un umanesimo totale e radicale, che si genera e si comprende a partire dalla ragione dei sofferenti, dei malati, di quelli e quelle ascritte alle varie categorie dell’esclusione. Per capire che siamo comunque ai margini, dato che tutti chiediamo salvezza, soffriamo il male di vivere. Essere consapevoli del nostro male, per questo solidali e dediti alla cura, è l’unico modo per acquisire lucidità riguardo alla propria crisi, la comprensione di come essa si tramuti nella pace. Può sembrare mera retorica ma bisogna assumere tutto il peso dello scandalo folle del Vangelo che dichiara beati i poveri, chiedendoci di ragionare secondo la logica della vera povertà, liberi dal troppo, gioiosi nell’essenziale. Un conto è la tutela del necessario e di quel di più che garantisce autentica contentezza, un conto è farsi soffocare dal bisogno indotto, che snatura il senso bello dell’avere senza possedere, di esistere per l’abbondanza del condiviso. «Para todos, todo. Para nosotros, nada» affermano gli zapatisti dell’Ezln (continuano a resistere all’Impero, anche se non si parla di loro). Il senso di questa povertà è pienezza dell’avere, perché è avere insieme. Il Vangelo non esalta la povertà in sé, avversa semmai radicalmente la miseria, perché sa che l’avere non è male: dominare senza condividere, quello è il peccato alla radice della condizione umana. Avere senza cuore, pensiero, fantasia, com/passione. È un bambino, nasce ai margini, non nei luoghi garantiti, privilegiati e sicuri. Accolto tra i primi dai pastori. I membri della mia comunità sono rimasti molto colpiti quando abbiamo studiato insieme che erano parte di una categoria disprezzata, guardata con sospetto per la promiscuità con il mondo animale, randagia, nomade, talora irregolare e violenta, per reazione al disamore. Eppure sono i primi ad ascoltare, andare, vedere, gioire. Cosa? Il tempo nuovo di un umanesimo che non si fa dominare, spengere, addomesticare, irregimentare. Libero, intelligente, felice. Spinto da una creatività invincibile. Impastato con le sante essenze della sororità e della fraternità. In transito, eppure nella stabilità in equilibrio non definitivo di chi ha una tenda e non la prigionia dei palazzi.
——————————————
* Andrea Bigalli, fiorentino, è stato ordinato sacerdote nel 1990. Dal 1999 è parroco a Sant’Andrea in Percussina (San Casciano Val di Pesa). Vice direttore della “Caritas” toscana dal 1998 al 2005 è attualmente referente di Libera per la Toscana e membro del direttivo della rivista “Testimonianze”. Insegna religione nelle scuole superiori di Firenze.
——————————

——————————
Gli Auguri del nostro Editore

——————————-
Illustrazione in testa
Stupendo! La Natività è un dipinto, olio su tavola (124,4×122,6 cm), dell’ultima fase artistica di Piero della Francesca, databile al 1470-1475 (o secondo alcuni fino al 1485) e oggi conservato nella National Gallery di Londra (oggetto di un restauro molto discusso nel 2022) Da wikipedia.
————————————
Editoriale
di Franco Meloni
Sono un semplice elettore, anzi un elettore semplice, e dichiaro di non capire cosa sta succedendo nella politica sarda. I protagonisti da tutte le parti se la cantano e se la suonano, senza preoccuparsi che la gente capisca. L’agone politico è roba loro e non hanno da dare spiegazioni a nessuno. Ma così gli elettori sono sempre più disorientati. Sicuramente aumenteranno coloro che diserteranno le urne. Alcuni esperti valutano che l’astensionismo supererà il 50% dell’elettorato. Ma, che importa. Anzi per i nostri politici, almeno per la maggior parte di essi, vale lo slogan “meno siamo meglio stiamo”, che riferito all’elettorato si traduce in “meno sono [gli elettori] meglio stiamo noi, a meno gente dobbiamo rendere conto: lasciate fare a noi…”. La “partecipazione popolare” è un bel concetto che nessun politico rinnegherà, a parole, nei fatti “una grande rottura di c.”. Gli astensionisti avrebbero tutte le ragioni di questo mondo: perché scomodarsi a votare se la propria opinione è ininfluente rispetto alle decisioni da prendere per l’amministrazione della Regione? C’è poi il sospetto che gli stessi politici alla guida della Regione contino ben poco rispetto alle grandi scelte dell’economia, appannaggio di livelli superiori (bene che vada) o delle potenti multinazionali. Tale e’ la sensazione di impotenza, che ci si chiede se ha senso mantenere in piedi diverse Istituzioni. Se per ipotesi si potesse fare un referendum per abrogare l’Istituzione regionale, il risultato sarebbe probabilmente maggioritariamente favorevole.
—————-
Il vecchio mondo sta morendo. Quello nuovo tarda a comparire. E in questo chiaroscuro nascono i mostri.
Antonio Gramsci
——————
Mario Arca, leader sardo di Demos* , chiudendo la bella serata presso la Collina, il 6 dicembre u.s., promossa da diverse formazioni politiche di ispirazione cristiana, ha fatto una citazione a me molto cara: quella
————-
Per cominciare: Shomèr ma mi llailah? Un verso di Isaia (21,11- 12), Shomèr ma mi-lailah è alla base di una delle canzoni più famose di Francesco Guccini. Il verso è misterioso. Tradotto, vuol dire: Sentinella, a quanto della notte, a che punto è la notte? Isaia, uno di quei profeti che minacciano in continuazione e lanciano fuoco e fiamme, all’improvviso si lascia andare, in questo verso bellissimo e altamente poetico, ad una grande speranza.
La sentinella risponde: La notte sta per finire ma l’alba non è ancora arrivata. Tornate, domandate, insistete.
http://www.specchiomagazine.it/2019/06/shomer-ma-mi-lailah-sentinella-a-quanto-della-notte/?fbclid=IwAR29kHJnQi5hq0ixBZdeutd-OtG4tJxY9lO4sENYSbqIGKp7WyikzHf3nLU
——————————-
La canzone di Guccini: https://youtu.be/gyTqIV7otos
Su Dossier Caritas 2023. COP28: Dubai e oltre Dubai

Lunedì 18 dicembre la Caritas di Cagliari ha presentato il XIII Dossier Caritas 2023. Il volume è ricco di informazioni sulla vasta attività dell’istituzione durante il corrente anno, nonché di riflessioni su quanto accade nel nostro tempo. Avremo occasioni per riproporre almeno una parte di tali contenuti nella nostra news, dando ad essi adeguato spazio e rilievo. Nel presente spazio-editoriale riportiamo l’articolo del direttore sull’esortazione apostolica Laudate Deum di Papa Francesco, pubblicata il 4 ottobre u.s., dedicata alle questioni ambientali, un vero e proprio aggiornamento dell’enciclica Laudato si’, in previsione della COP28 tenutasi come previsto a Dubai dal 30 novembre al 12 dicembre (prolungatasi per alcuni giorni). Lo stesso pontefice avrebbe dovuto parteciparvi nei gg. 1-3 dicembre, ma ha dovuto rinunciare per ragioni di salute. L’articolo è andato in stampa ben prima dell’evento di Dubai, riporta pertanto previsioni e auspici, da confrontare oggi con quanto effettivamente accaduto e deciso nei documenti finali. Per completezza di informazione, aggiornata ad oggi, riportiamo di seguito all’articolo del direttore, tre pezzi di valutazione a conclusione della COP28 di Dubai, che crediamo ne mostrino luci ed ombre, obbiettivi raggiunti (pochi), obbiettivi parzialmente soddisfacenti, obbiettivi totalmente mancati (tanto che alcuni parlano di fallimento). Ai lettori un giudizio motivato, sulla base della documentazione fornita o comunque di altra disponibile in rete.
 Aspettando Dubai, oltre Dubai
Aspettando Dubai, oltre Dubai
L’Esortazione apostolica di Papa Francesco Laudate Deum
di Franco Meloni
Premessa: con Papa Francesco, Giovanni XXIII, Paolo VI
Papa Francesco tiene molto nelle sue encicliche ed esortazioni e, in generale, nelle sue dichiarazioni a ricollegarsi ai suoi predecessori, soprattutto a quelli più vicini, nella linea della “continuità nel rinnovamento” del magistero della Chiesa. Ma sono specialmente due i Pontefici a cui fa riferimento, quelli più legati al Concilio Vaticano II: Giovanni XXIII, che lo ha indetto e iniziato; Paolo VI, che lo ha ripreso e portato a compimento [1]. E sappiamo quanto Papa Francesco ami e consideri il Concilio: «evento di grazia per la Chiesa e per il mondo», «i cui frutti non si sono esauriti» e che «non è stato ancora interamente compreso, vissuto e applicato (…) Dal Concilio Ecumenico Vaticano II abbiamo ricevuto molto. Abbiamo approfondito, ad esempio, l’importanza del popolo di Dio, categoria centrale nei testi conciliari, richiamata ben centottantaquattro volte, che ci aiuta a comprendere il fatto che la Chiesa non è un’élite di sacerdoti e consacrati e che ciascun battezzato è un soggetto attivo di evangelizzazione”. E continua: “dobbiamo riscoprire l’ispirazione del Concilio e come passo dopo passo questo evento abbia trasformato la vita della Chiesa, è l’occasione per affrontare meglio il percorso sinodale, che è fatto innanzitutto di ascolto, di coinvolgimento, di capacità di far spazio al soffio dello Spirito, lasciando a Lui la possibilità di guidarci”.[2]
Anch’io in premessa delle mie considerazioni sull’Esortazione apostolica di Papa Francesco Laudate Deum (LD) [3] faccio riferimento ai medesimi due Pontefici.
- A Giovanni XXIII, laddove mi soffermo sui destinatari del messaggio pontificio che appare nel titolo stesso della LD: “…a tutte le persone di buona volontà”.
Si tratta di un’ulteriore innovazione che va oltre quanto Papa Francesco già sottolineava nella Laudato sì’ sotto l’intitolazione “Niente di questo mondo ci risulta indifferente”, Papa Francesco ricordava: “Più di cinquant’anni fa, mentre il mondo vacillava sull’orlo di una crisi nucleare, il santo Papa Giovanni XXIII scrisse un’Enciclica con la quale non si limitò solamente a respingere la guerra, bensì volle trasmettere una proposta di pace. Diresse il suo messaggio Pacem in terris a tutto il “mondo cattolico”, ma aggiungeva «nonché a tutti gli uomini di buona volontà». Adesso, di fronte al deterioramento globale dell’ambiente, voglio rivolgermi a ogni persona che abita questo pianeta (…)”. E ribadisce: “In questa Enciclica (LS), mi propongo specialmente di entrare in dialogo con tutti riguardo alla nostra casa comune” (LS 3). La novità della Laudate Deum consiste, nel rivolgersi “a primo acchito” all’intera umanità, almeno a quella pensante, di buona volontà, (formata da “persone”, non “uomini”, al fine di superare la tradizionale prevalenza del maschile), prima ancora che ai “fedeli cattolici”, a cui dedica gli ultimi paragrafi dell’Esortazione (LD 61-73).
- A Paolo VI [4], precisamente alla sua prima Enciclica, Ecclesiam Suam (ES) [4bis], laddove individua “le posizioni concrete, in cui l’umanità si trova rispetto alla Chiesa cattolica (…) a guisa di tre cerchi concentrici” che la circondano [5] In questa trattazione ci interessa il primo.
Dall’Enciclica di Paolo VI Ecclesiam suam alla Costituzione conciliare Gaudium et Spes
Paolo VI lo descrive come “(…) un immenso cerchio, di cui non riusciamo a vedere i confini; essi si confondono con l’orizzonte; cioè riguardano l’umanità in quanto tale, il mondo. Noi misuriamo la distanza che da noi lo tiene lontano; ma non lo sentiamo estraneo. Tutto ciò ch’è umano ci riguarda. Noi abbiamo in comune con tutta l’umanità la natura, cioè la vita, con tutti i suoi doni, con tutti i suoi problemi. Siamo pronti a condividere questa prima universalità; ad accogliere le istanze profonde dei suoi fondamentali bisogni, ad applaudire alle affermazioni nuove e talora sublimi del suo genio. E abbiamo verità morali, vitali, da mettere in evidenza e da corroborare nella coscienza umana, per tutti benefiche. Dovunque è l’uomo in cerca di comprendere se stesso e il mondo, noi possiamo comunicare con lui; dovunque i consessi dei popoli si riuniscono per stabilire i diritti e i doveri dell’uomo, noi siamo onorati, quando ce lo consentono, di assiderci fra loro. Se esiste nell’uomo un’anima naturalmente cristiana, noi vogliamo onorarla della nostra stima e del nostro colloquio”. E prosegue: “Noi potremmo ricordare a noi stessi e a tutti gli altri come il nostro atteggiamento sia, da un lato, totalmente disinteressato; non abbiamo alcuna mira politica o temporale; dall’altro, sia rivolto ad assumere, cioè ad elevare a livello soprannaturale e cristiano, ogni onesto valore umano e terreno; non siamo la civiltà, ma fautori di essa. (…)” (ES 101-102).
È un’anticipazione della costituzione conciliare “Gaudium et Spes” [6] di cui cito lo splendido incipit: “Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. La loro comunità, infatti, è composta di uomini i quali, riuniti insieme nel Cristo, sono guidati dallo Spirito Santo nel loro pellegrinaggio verso il regno del Padre, ed hanno ricevuto un messaggio di salvezza da proporre a tutti”.
Dall’Enciclica Laudato sì’ all’Esortazione Laudate Deum
Nell’intervista fattagli di recente dalla Rai [7], Papa Francesco ricorda un suo viaggio a Strasburgo: “Non dimentico quando il 25 novembre 2014, invitato dal Parlamento europeo, incontrai la ministra francese dell’Ambiente, Ségolène Royal, con cui parlai di quello che stavo scrivendo sull’ambiente e del progetto di un lavoro comune con scienziati e teologi. «Per favore, lo pubblichi prima della Conferenza sul clima di Parigi [8]»: furono queste le parole della ministra. Ed in effetti il 24 maggio 2015 fu emanata l’enciclica Laudato si’” (LS). Il Papa dunque giocò d’anticipo, riuscendo in certa misura a far pesare, con l’autorevolezza di un’Enciclica, le sue argomentazioni, che non sono dogma, ma rappresentano l’aggiornamento della dottrina sociale della Chiesa cattolica in materia di ambiente, cambiamento climatico, ecologia integrale… in sostanza quanto si compendia nella “cura del Creato”. La capacità di Papa Francesco di “cogliere i segni dei tempi” [9] fino ad anticipare gli eventi è un suo carisma che si è appalesato non solo rispetto alla COP21 di Parigi, ma, come rilevo sul Dossier Caritas 2019 [10], anche rispetto alla risoluzione dell’Onu con cui il 25 settembre 2015 fu approvata l’Agenda Onu 2030 [11], anticipata di quattro mesi dalla Laudato sì’. Ma su questo argomento rinvio ad altri approfondimenti.
Con l’Esortazione Laudate Deum, ad oltre otto anni dalla LS, il Papa si comporta in modo analogo rispetto alla imminente scadenza della COP28 a Dubai [12], non certo per il gusto dell’arrivare primo, quanto piuttosto per enfatizzarne l’importanza, dando la sveglia a tutti… .
Dice il Papa in una delle sue esternazioni “Dopo Parigi purtroppo le cose non sono andate come speravo, e questo continua a preoccuparmi”. Il perché lo spiega nell’Esortazione: “(…) con il passare del tempo, mi rendo conto che non reagiamo abbastanza, poiché il mondo che ci accoglie si sta sgretolando e forse si sta avvicinando a un punto di rottura. Al di là di questa possibilità, non c’è dubbio che l’impatto del cambiamento climatico danneggerà sempre più la vita di molte persone e famiglie. Ne sentiremo gli effetti in termini di salute, lavoro, accesso alle risorse, abitazioni, migrazioni forzate e in altri ambiti” (LD 2) . Le conseguenze della crisi climatica globale sono sotto gli occhi di tutti: “Negli ultimi anni abbiamo assistito a fenomeni estremi, frequenti periodi di caldo anomalo, siccità e altri lamenti della terra che sono solo alcune espressioni tangibili di una malattia silenziosa che colpisce tutti noi (…) È verificabile che alcuni cambiamenti climatici indotti dall’uomo aumentano in modo significativo la probabilità di eventi estremi più frequenti e più intensi. Sappiamo quindi che ogni volta che la temperatura globale aumenta di 0,5 gradi centigradi, aumenta anche l’intensità e la frequenza di forti piogge e inondazioni in alcune aree, di grave siccità in altre, di caldo estremo in alcune regioni e di forti nevicate in altre ancora. Se fino a ora potevamo avere ondate di calore alcune volte all’anno, cosa accadrebbe con un aumento della temperatura globale di 1,5 gradi centigradi, a cui siamo vicini? Tali onde di calore saranno molto più frequenti e più intense. Se si superano i 2 gradi, le calotte glaciali della Groenlandia e di gran parte dell’Antartide si scioglieranno completamente, con conseguenze enormi e molto gravi per tutti” (LD 5).
Dalla Conferenza sull’Ambiente e sullo Sviluppo delle Nazioni Unite di Rio de Janeiro del 1992 alla COP 28 di Dubai
Dopo aver passato in rassegna le COP che hanno preceduto e seguito quella di Parigi e che dopo quest’ultima hanno prodotto risultati deludenti [13], il Papa s’interroga: “Cosa ci si aspetta dalla COP28 di Dubai?” [13] Si mostra speranzoso: “Se abbiamo fiducia nella capacità dell’essere umano di trascendere i suoi piccoli interessi e di pensare in grande, non possiamo rinunciare a sognare che la COP28 porti a una decisa accelerazione della transizione energetica, con impegni efficaci che possano essere monitorati in modo permanente. Questa Conferenza può essere un punto di svolta, comprovando che tutto quanto si è fatto dal 1992 [14] era serio e opportuno, altrimenti sarà una grande delusione e metterà a rischio quanto di buono si è potuto fin qui raggiungere”. E ancora: “Nonostante i numerosi negoziati e accordi, le emissioni globali hanno continuato a crescere. È vero che si può sostenere che senza questi accordi sarebbero cresciute ancora di più. Ma su altre questioni ambientali, dove c’è stata la volontà, sono stati raggiunti risultati molto significativi, come nel caso della protezione dello strato di ozono. Invece la necessaria transizione verso energie pulite, come quella eolica, quella solare, abbandonando i combustibili fossili, non sta procedendo abbastanza velocemente. Di conseguenza, ciò che si sta facendo rischia di essere interpretato solo come un gioco per distrarre (…) Se c’è un sincero interesse a far sì che la COP28 diventi storica, che ci onori e ci nobiliti come esseri umani, allora possiamo solo aspettarci delle forme vincolanti di transizione energetica che abbiano tre caratteristiche: che siano efficienti, che siano vincolanti e facilmente monitorabili. Questo al fine di avviare un nuovo processo che sia drastico, intenso e possa contare sull’impegno di tutti. Ciò non è accaduto nel cammino percorso finora, ma solo con un tale processo si potrebbe ripristinare la credibilità della politica internazionale, perché solo in questo modo concreto sarà possibile ridurre notevolmente l’anidride carbonica ed evitare in tempo i mali peggiori. (…) Speriamo che quanti interverranno siano strateghi capaci di pensare al bene comune e al futuro dei loro figli, piuttosto che agli interessi di circostanza di qualche Paese o azienda. Possano così mostrare la nobiltà della politica e non la sua vergogna. Ai potenti oso ripetere questa domanda: «Perché si vuole mantenere oggi un potere che sarà ricordato per la sua incapacità di intervenire quando era urgente e necessario farlo?». [15] (…) Sappiamo che, di questo passo, in pochi anni supereremo il limite massimo auspicabile di 1,5 gradi centigradi e a breve potremmo arrivare a 3 gradi, con un alto rischio di raggiungere un punto critico. Anche se questo punto di non ritorno non venisse raggiunto, gli effetti sarebbero disastrosi e bisognerebbe prendere misure in maniera precipitosa, con costi enormi e con conseguenze economiche e sociali estremamente gravi e intollerabili. Se le misure che adotteremo ora hanno dei costi, essi saranno tanto più pesanti quanto più aspetteremo.
Il paradigma tecnocratico
Papa Francesco non manca l’occasione di rammentare, come già affermato nella Laudato si’, che alla base della degradazione dell’ambiente, vi è quello che lui chiama il paradigma tecnocratico [15] , «un modo di comprendere la vita e l’azione umana che è deviato e che contraddice la realtà fino al punto di rovinarla; come se la realtà, il bene e la verità sbocciassero spontaneamente dal potere stesso della tecnologia e dell’economia. Da qui si passa facilmente all’idea di una crescita infinita o illimitata, che ha tanto entusiasmato gli economisti, i teorici della finanza e della tecnologia» (LD 20; LS 101-106).
Ricorda che «un ambiente sano è anche il prodotto dell’interazione dell’uomo con l’ambiente, come avviene nelle culture indigene e come è avvenuto per secoli in diverse regioni della Terra. I gruppi umani hanno spesso “creato” l’ambiente, rimodellandolo in qualche modo senza distruggerlo o metterlo in pericolo. Il grande problema di oggi è che il paradigma tecnocratico ha distrutto questo rapporto sano e armonioso» (LD 28). E’ dunque un imperativo fermare il degrado del nostro ecosistema, invertire la rotta e promuovere azioni concrete, forti e senza perdere tempo prezioso, per mitigare il più possibile il cambiamento climatico e, nello stesso tempo, per adattarci alle condizioni climatiche che si vanno determinando. Al riguardo sono importanti sia gli accordi tra i governi delle nazioni in un’ottica di un nuovo multilateralismo che nasce dal basso, sia la condotta individuale e collettiva delle persone, adottando stili di vita sostenibili con l’ambiente e solidali con la gran parte dell’umanità che soffre drammaticamente le violenze esercitate dall’uomo sulla terra. (LD 37-38). Giova rammentare che il Papa a sostegno delle sue posizioni sul clima si appoggia alla stragrande maggioranza degli studiosi in materia [16] e non ha alcuna timidezza nel condannare i negazionismi e a richiamare alla ragione quanti se ne fanno portatori, anche all’interno della Chiesa cattolica (LD 14). Certo è che non bisogna illudersi che l’attuale economia che egemonizza il mondo, basata sulla “logica del massimo profitto al minimo costo, mascherata da razionalità, progresso e promesse illusorie” possa avere la priorità del bene comune, della difesa della casa comune, della “promozione degli scartati della società” (LD 31). Occorre la ricerca e la pratica di una diversa economia che non sia disgiunta dall’etica e che pertanto metta al centro la persona e il suo benessere. Dice il Papa che “dobbiamo tutti ripensare alla questione del potere umano”, per difendere “la nostra stessa sopravvivenza”. E’ efficace al riguardo la citazione ironica di Solov’ëv: “Un secolo così progredito che perfino gli era toccato in sorte essere l’ultimo” (LD 28) [17]. Il Papa coglie l’occasione per richiamare la necessità di quello che chiama “il pungiglione etico”, richiamando il valore dell’impegno, della crescita delle capacità, del lodevole spirito di iniziativa, della ricerca e pratica della reale uguaglianza di opportunità, contro le “idee sbagliate sulla cosiddetta ‘meritocrazia’” (LD 29-33).
———————–
Armato di queste convinzioni, come detto, Papa Francesco si recherà a Dubai nei gg. 1, 2 e 3 dicembre 2023 per implorare tutti i governanti del mondo affinché facciano qualcosa di molto preciso per salvare la Terra, la nostra casa comune. E’ una “chiamata a responsabilità” che si aggiunge ai numerosi altri appelli che il Papa fa quotidianamente per la Pace del mondo, sconvolto da innumerevoli guerre e conflitti, portatori di morte e distruzioni e anch’essi gravemente colpevoli dei disastri ambientali. Ci consola che Papa Francesco non sia solo tra i grandi leader religiosi. Non sappiamo quanti altri fisicamente parteciperanno alla Conferenza, ma è di buon auspicio il documento firmato da 28 leader religiosi il 6 novembre 2023 ad Abu Dhabi, con il quale i religiosi chiedono ai delegati mondiali un’azione decisiva per frenare il cambiamento climatico [18].
Aspettando Dubai, oltre Dubai
Altrimenti? Quanto potrà ancora accadere non è forse attendibilmente prevedibile, come continuamente afferma la stragrande maggioranza degli studiosi? Lo confermano una serie di simulazioni che sono oggi già in grado di farci vedere drammaticamente come sarà la Terra se non si interverrà con la massima urgenza, subito. Gli artisti con la loro capacità immaginifica sono in grado di farci vedere anticipatamente tutto quello che potrà accadere. Tra i tanti, il cantautore-poeta Francesco Guccini ce lo mostra in una sua bellissima e struggente canzone [19].
————————————————
Il vecchio e il bambino, di Francesco Guccini.
Un vecchio e un bambino si preser per mano
E andarono insieme incontro alla sera
La polvere rossa si alzava lontano
Il sole brillava di luce non vera
Immensa pianura sembrava arrivare
Fin dove l’occhio di un uomo poteva guardare
E tutto di intorno, non c’era nessuno
Solo il tetro contorno di torri di fumo
I due camminavano e il giorno cadeva
Il vecchio parlava, e piano piangeva
Con l’anima assente, con gli occhi bagnati
Seguiva il ricordo di miti passati
I vecchi subiscon le ingiuria degli anni
Non sanno distinguere il vero dai sogni
I vecchi non sanno nel loro pensiero
Distinguer nei sogni il falso dal vero
Il vecchio diceva guardando lontano
“Immagina questo coperto di grano
Immagina i frutti, immagina i fiori
E pensa alle voci e pensa ai colori”
E in questa pianura, fin dove si perde
Crescevano gli alberi e tutto era verde
Cadeva la pioggia, segnavano i soli
Il ritmo dell’uomo e delle stagioni
Il bimbo ristette, lo sguardo era triste
Gli occhi guardavano cose mai viste
E poi disse al vecchio con voce sognante
“Mi piaccion le fiabe, raccontane altre” [19]
————————————
Note
(Segue)
SA NOVENA de PASCH’E NADALE in CASTEDDU
 A partire dal 16 dicembre, alle ore 18, la Confraternita di S. Efisio riproporrà nella chiesa dedicata al Santo, la Novena di Natale in Gregoriano, con una novità: la liturgia avverrà integralmente in lingua sarda.
A partire dal 16 dicembre, alle ore 18, la Confraternita di S. Efisio riproporrà nella chiesa dedicata al Santo, la Novena di Natale in Gregoriano, con una novità: la liturgia avverrà integralmente in lingua sarda.
 Si tratta, allo stesso tempo, di un ritorno alla tradizione e di una prospettiva per il futuro. La Novena di Natale era particolarmente sentita nel quartiere di Stampace, introdotta dal solenne canto del Regem Venturum Dominum eseguito all’organo. A partire da quest’anno, l’organo accompagnerà i canti dei fedeli assieme alle launeddas, il più antico strumento musicale della Sardegna.
Si tratta, allo stesso tempo, di un ritorno alla tradizione e di una prospettiva per il futuro. La Novena di Natale era particolarmente sentita nel quartiere di Stampace, introdotta dal solenne canto del Regem Venturum Dominum eseguito all’organo. A partire da quest’anno, l’organo accompagnerà i canti dei fedeli assieme alle launeddas, il più antico strumento musicale della Sardegna.
E’ una proiezione verso il futuro, perché, con la celebrazione della novena in lingua sarda, si vuol favorire il compimento delle novità del Concilio Vaticano II che, guardando ai segni dei tempi, ha aperto la liturgia all’uso delle lingue nazionali. La Sardegna vive proprio l’attesa – l’avvento – del riconoscimento della sua lingua anche per la celebrazione della Santa Messa. Il rapido diffondersi, in diverse località dell’Isola, della celebrazione della Novena di Natale in lingua sarda – avvenuta proprio a Cagliari nel 2008 nella Chiesa del Santo Sepolcro – spinge in tale direzione.
Nella chiesa di Sant’Efiso, assieme alla Novena, sarà inoltre possibile visitare anche lo storico presepio della Gioc, che la Confraternita di S. Efisio, negli ultimi anni, ha recuperato e riproposto.
Ogni ulteriore informazione sarà fornita il 16 dicembre, a partire dalle ore 17,30, prima dell’inizio della Novena.
Il presidente Andrea Loi
Si allega una breve introduzione all’iniziativa.
———————
PRESENTAZIONE
Quando si arrivava alla metà del mese di dicembre, la sera – nelle vie del quartiere – cominciava ad essere accompagnata dalle esplosioni di una miscela di zolfo e clorato di potassio, innescata dalle scintille prodotta dallo sfregamento di una piccola pietra levigata che, molti di noi, in quelle settimane, custodivano nella tasca di calzoni corti attillati.
La pietra veniva poggiata sul mucchietto di polvere esplosiva; poi un colpo secco con il tallone, a strisciare, provocava lo scoppio. Quegli scoppi annunciavano che era giunto il tempo delle lunghe feste di fine anno e avrebbero fatto compagnia alle nostre serate sino ai botti trionfali con i quali si salutava l’anno nuovo.
E poi c’era la Novena, in Chiesa, solennemente introdotta dal “Regem venturum Dominum”, accompagnato dall’organo in tonalità maggiore, e l’odore intenso di incenso che ci penetrava nell’anima.
I canti gregoriani si susseguivano, l’uno dopo l’altro, con l’inno “En clara vox”, gregoriano di tempi uguali che la maggior parte di noi trasformava in marcetta: e il “Tantum ergo” …
Cosa volessero dire quelle parole, naturalmente, lo sapevano solo i preti e pochi laici eruditi; ché le nostre madri, e le nostre nonne, per poter rispondere all’invocazione del celebrante, erano state costrette ad elaborare un versario, in puro vernacolo dialettale, ricco di assonanze con quella lingua sconosciuta. Così, “procedenti ab utroque”, diventava facilmente “proceddeddus a ogus trottus”. Il celebrante, di solito, non percepiva la storpiatura del testo latino, ma anche nel caso se ne avvedesse, preferiva tacere. Al Padre eterno, poi, che aveva ben altre rogne a cui badare, al più scappava un sorrisetto.
Così, tra botti, canti, luminarie, e le immancabili bancarelle, la festa prendeva vigore. L’intero quartiere di Stampace vi partecipava.
Il fatto di esordire con un richiamo all’ambiente di una Novena di Natale – che siamo in pochi, oramai, ad aver vissuto in prima persona – potrebbe suggerire l’idea che il lavoro che presentiamo sia espressione della vena nostalgica che spesso accompagna l’età avanzata. Niente di più errato.
Rispettiamo ogni nostalgia, ovviamente, a patto che non riveli incapacità di vivere il presente, ma l’intendimento di questo lavoro, che ricostruisce e traduce in lingua sarda le liturgie e i canti che hanno accompagnato l’età della nostra fanciullezza, è ben altro.
La stagione di una liturgia, spesso solenne e pomposa, per di più celebrata in una lingua incomprensibile ai più, è terminata. Anzi, a dirla tutta, è durata anche troppo.
Il Concilio Vaticano II, oltre mezzo secolo fa, ha invitato la Chiesa a saper leggere i segni dei tempi, ci ha ricordato che i laici non sono “fedeli” ma parte integrante e indispensabile delle Chiese; ci ha ricordato l’importanza della comunità ecclesiale …
E poi, finalmente, ha posto fine al tabù della lingua latina per la celebrazione, aprendo all’uso del volgare, che ha consentito una più intensa partecipazione del popolo. Grazie a quel segno di uguaglianza il celebrante ha anche smesso di dare le spalle ai “fedeli”, ha incominciato a rivolgersi ad essi “faccia a faccia” durante le celebrazioni. Tante Comunità hanno potuto tornare a nuova vita, e prosperare.
Tuttavia, il declino del latino ha lasciato il posto a volgari nobili, quelli “legittimamente approvati” e quelli che invece, come la lingua sarda, ancora attendono una “autorizzazione” che, per la verità, è stata avanzata soltanto nel 2023, nonostante le insistenti richieste di laici e sacerdoti sardi che risalgono almeno dall’ultimo decennio del secolo scorso.
Più recentemente, l’allora Arcivescovo di Cagliari mons. Arrigo Miglio ha incoraggiato con convinzione l’avvio di un percorso finalizzato al riconoscimento della piena dignità della lingua sarda nella vita della chiesa locale. Un riconoscimento che, ha affermato, “non solo è un percorso che si può compiere, ma assolutamente utile dal punto di vista pastorale e culturale”.
Ci troviamo, in questo, in perfetta sintonia con l’ammonimento di Papa Francesco che, più volte, in occasione del rito del battesimo nella Cappella Sistina, nel gennaio del 2018, ha ribadito con forza che “la trasmissione della fede soltanto può farsi in dialetto, nella lingua intima delle coppie, nel dialetto della famiglia, nel dialetto di papà e mamma, di nonno e nonna”. Di Papa Francesco che ha ricordato che Gesù parlava in aramaico, perché era naturale che un bambino cresciuto in una modesta famiglia della Galilea parlasse la lingua del popolo, e che nella sua lingua materna, quella appresa da Giuseppe e da Maria abbia spezzato il pane e versato il vino.
Vorremo, in definitiva, contribuire, al compiersi del programma del Concilio Vaticano II, sostenere gli sforzi di quanti, negli ultimi anni, si sono adoperati in questa direzione, contribuire al movimento che reclama un pieno riconoscimento della lingua sarda in ambito liturgico e per questo la Confraternita di Sant’Efisio ripropone la liturgia della novena in lingua sarda.
Alcuni cenni storici della Novena gregoriana.
La novena in gregoriano è stata eseguita, per la prima volta, a Torino, nella chiesa dell’Immacolata, affidata ai preti della Missione, nel Natale del 1720.
Su sollecitazione della Marchesa Gabriella Marolles delle Lanze, il padre Antonio Vacchetta compose una nuova Novena cantata, contenente testi delle Profezie e dei Salmi.
Dopo la prima celebrazione del 1720, la Marchesa, apprezzando la composizione, dispose un lascito di cinquemila lire per consentire che la Novena si continuasse a celebrare ogni anno.
I missionari e i preti che frequentavano la Casa della Missione, hanno poi diffuso questa Novena nelle Diocesi del Piemonte, della Lombardia e della Liguria e, successivamente, si è estesa ad altre regioni dell’Italia e del Mondo.
L’origine della Novena di Natale in lingua sarda.
La Novena in lingua sarda, ispirata al modello gregoriano, è stata celebrata per la prima volta a Cagliari, nel 2008, nella chiesa del Santo Sepolcro per iniziativa di Don Mario Cugusi, allora parroco della parrocchia di S. Eulalia, con la partecipazione del gruppo di laici che frequentava la parrocchia e con il sostegno della Fondazione Sardinia e del suo direttore Salvatore Cubeddu.
Il Concilio plenario sardo, promulgato il 1° luglio del 2001, ha rappresentato un significativo momento di svolta della Chiesa Sarda per quanto riguarda l’utilizzazione della lingua sarda nella liturgia. Mentre il Concilio Plenario del 1924, “inibiva l’uso della lingua sarda e la guardava con diffidenza”. Il Concilio del 2001, invertendo radicalmente tale orientamento, definisce la lingua sarda “un singolare strumento comunicativo della fede” e ne auspica la valorizzazione nella liturgia.
——————————
——————————
http://www.fondazionesardinia.eu/ita/?s=Sa+novena+de++nadale
———————————–——

—————————



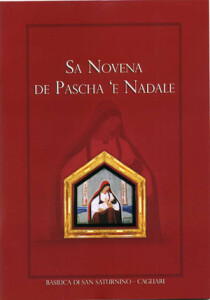





 AService Studio
AService Studio