Editoriali
Papa Francesco: due parole-chiave dell’ecologia integrale: contemplazione e compassione

![]() Anticipazioni. Tre giornali online (il manifesto sardo, Giornalia e Aladinpensiero)
Anticipazioni. Tre giornali online (il manifesto sardo, Giornalia e Aladinpensiero)
 organizzano per domenica 4 ottobre (festa di san Francesco), ore 18-19, un video-incontro sulle tematiche della “Fratellanza universale nel mondo sconvolto dalla pandemia e dalle disuguaglianze. Il ruolo delle grandi Culture dalle contrapposizioni all’integrazione”. Ci stiamo lavorando. La nuova enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti” e la dichiarazione di Abu Dhabi del 4 febbraio 2019 costituiranno due importanti riferimenti dell’iniziativa.
organizzano per domenica 4 ottobre (festa di san Francesco), ore 18-19, un video-incontro sulle tematiche della “Fratellanza universale nel mondo sconvolto dalla pandemia e dalle disuguaglianze. Il ruolo delle grandi Culture dalle contrapposizioni all’integrazione”. Ci stiamo lavorando. La nuova enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti” e la dichiarazione di Abu Dhabi del 4 febbraio 2019 costituiranno due importanti riferimenti dell’iniziativa.

DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO AI PARTECIPANTI ALL’INCONTRO COMUNITÀ LAUDATO SI’
Aula Paolo VI, Sabato, 12 settembre 2020.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Vi do il benvenuto, e salutando voi desidero raggiungere tutti i membri delle Comunità Laudato si’ in Italia e nel mondo. Ringrazio il Signor Carlo Pertini nella mia lingua paterna, non materna: “Carlìn”. Avete posto come centro propulsore di ogni vostra iniziativa l’ecologia integrale proposta dall’Enciclica Laudato si’. Integrale, perché tutti siamo creature e tutto nel creato è in relazione, tutto è correlato. Anzi, oserei dire, tutto è armonico. Anche la pandemia lo ha dimostrato: la salute dell’uomo non può prescindere da quella dell’ambiente in cui vive. È poi evidente che i cambiamenti climatici non stravolgono solo gli equilibri della natura, ma provocano povertà e fame, colpiscono i più vulnerabili e a volte li obbligano a lasciare la loro terra. L’incuria del creato e le ingiustizie sociali si influenzano a vicenda: si può dire che non c’è ecologia senza equità e non c’è equità senza ecologia.
Voi siete motivati a prendervi cura degli ultimi e del creato, insieme, e volete farlo sull’esempio di San Francesco d’Assisi, con mitezza e laboriosità. Vi ringrazio per questo, e rinnovo l’appello a impegnarsi per salvaguardare la nostra casa comune. È un compito che riguarda tutti, specialmente i responsabili delle nazioni e delle attività produttive. Serve la volontà reale di affrontare alla radice le cause degli sconvolgimenti climatici in atto. Non bastano impegni generici – parole, parole… – e non si può guardare solo al consenso immediato dei propri elettori o finanziatori. Occorre guardare lontano, altrimenti la storia non perdonerà. Serve lavorare oggi per il domani di tutti. I giovani e i poveri ce ne chiederanno conto. È la nostra sfida. Prendo una frase del teologo martire Dietrich Bonhoeffer: la nostra sfida, oggi, non è “come ce la caviamo”, come noi usciamo da questa realtà; la nostra sfida vera è “come potrà essere la vita della prossima generazione”: dobbiamo pensare a questo!
Cari amici, ora vorrei condividere con voi due parole-chiave dell’ecologia integrale: contemplazione e compassione.
Contemplazione. Oggi, la natura che ci circonda non viene più ammirata, contemplata, ma “divorata”. Siamo diventati voraci, dipendenti dal profitto e dai risultati subito e a tutti i costi. Lo sguardo sulla realtà è sempre più rapido, distratto, superficiale, mentre in poco tempo si bruciano le notizie e le foreste. Malati di consumo. Questa è la nostra malattia! Malati di consumo. Ci si affanna per l’ultima “app”, ma non si sanno più i nomi dei vicini, tanto meno si sa più distinguere un albero da un altro. E, ciò che è più grave, con questo stile di vita si perdono le radici, si smarrisce la gratitudine per quello che c’è e per chi ce l’ha dato. Per non dimenticare, bisogna tornare a contemplare; per non distrarci in mille cose inutili, occorre ritrovare il silenzio; perché il cuore non diventi infermo, serve fermarsi. Non è facile. Bisogna, ad esempio, liberarsi dalla prigionia del cellulare, per guardare negli occhi chi abbiamo accanto e il creato che ci è stato donato.
Contemplare è regalarsi tempo per fare silenzio, per pregare, così che nell’anima ritorni l’armonia, l’equilibrio sano tra testa, cuore e mani; tra pensiero, sentimento e azione. La contemplazione è l’antidoto alle scelte frettolose, superficiali e inconcludenti. Chi contempla impara a sentire il terreno che lo sostiene, capisce di non essere al mondo solo e senza senso. Scopre la tenerezza dello sguardo di Dio e comprende di essere prezioso. Ognuno è importante agli occhi di Dio, ognuno può trasformare un po’ di mondo inquinato dalla voracità umana nella realtà buona voluta dal Creatore. Chi sa contemplare, infatti, non sta con le mani in mano, ma si dà da fare concretamente. La contemplazione ti porta all’azione, a fare.
Ecco dunque la seconda parola: compassione. È il frutto della contemplazione. Come si capisce che uno è contemplativo, che ha assimilato lo sguardo di Dio? Se ha compassione per gli altri – compassione non è dire: “questo mi fa pena…”, compassione è “patire con” –, se va oltre le scuse e le teorie, per vedere negli altri dei fratelli e delle sorelle da custodire. Quello che ha detto alla fine Carlo Petrini sulla fratellanza. Questa è la prova, perché così fa lo sguardo di Dio che, nonostante tutto il male che pensiamo e facciamo, ci vede sempre come figli amati. Non vede degli individui, ma dei figli, ci vede fratelli e sorelle di un’unica famiglia, che abita la stessa casa. Non siamo mai estranei ai suoi occhi. La sua compassione è il contrario della nostra indifferenza. L’indifferenza – mi permetto la parola un po’ volgare – è quel menefreghismo che entra nel cuore, nella mentalità, e che finisce con un “che si arrangi”. La compassione è il contrario dell’indifferenza.

Vale anche per noi: la nostra compassione è il vaccino migliore contro l’epidemia dell’indifferenza. “Non mi riguarda”, “non tocca a me”, “non c’entro”, “è cosa sua”: ecco i sintomi dell’indifferenza. C’è una bella fotografia – l’ho detto altre volte –, fatta da un fotografo romano, si trova nell’Elemosineria. Una notte d’inverno, si vede che esce da un ristorante di lusso una signora di una certa età, con la pelliccia, il cappello, i guanti, ben coperta dal freddo esce, dopo aver mangiato bene – che non è peccato, mangiare bene! [ridono] – e c’è alla porta un’altra donna, con una stampella, malvestita, si vede che sente il freddo… una homeless, con la mano tesa… E la signora che esce dal ristorante guarda da un’altra parte. La foto si chiama “Indifferenza”. Quando l’ho vista, ho chiamato il fotografo per dirgli: “Sei stato bravo a prendere questo in modo spontaneo”, e ho detto di metterla nell’Elemosineria. Per non cadere nello spirito dell’indifferenza. Invece, chi ha compassione passa dal “di te non m’importa” al “tu sei importante per me”. O almeno “tu tocchi il mio cuore”. Però la compassione non è un bel sentimento, non è pietismo, è creare un legame nuovo con l’altro. È farsene carico, come il buon Samaritano che, mosso da compassione, si prende cura di quel malcapitato che neppure conosce (cfr Lc 10,33-34). Il mondo ha bisogno di questa carità creativa e fattiva, di gente che non sta davanti a uno schermo a commentare, ma di gente che si sporca le mani per rimuovere il degrado e restituire dignità. Avere compassione è una scelta: è scegliere di non avere alcun nemico per vedere in ciascuno il mio prossimo. E questa è una scelta.
Questo non vuol dire diventare molli e smettere di lottare. Anzi, chi ha compassione entra in una dura lotta quotidiana contro lo scarto e lo spreco, lo scarto degli altri e lo spreco delle cose. Fa male pensare a quanta gente viene scartata senza compassione: anziani, bambini, lavoratori, persone con disabilità… Ma è scandaloso anche lo spreco delle cose. La FAO ha documentato che, nei Paesi industrializzati, vengono buttate via più di un miliardo – più di un miliardo! – di tonnellate di cibo commestibile! Questa è la realtà. Aiutiamoci, insieme, a lottare contro lo scarto e lo spreco, esigiamo scelte politiche che coniughino progresso ed equità, sviluppo e sostenibilità per tutti, perché nessuno sia privato della terra che abita, dell’aria buona che respira, dell’acqua che ha il diritto di bere e del cibo che ha il diritto di mangiare.
Sono certo che i membri di ogni vostra Comunità non si accontenteranno di vivere da spettatori, ma saranno sempre protagonisti miti e determinati nel costruire il futuro di tutti. E tutto questo fa la fraternità. Lavorare come e da fratelli. Costruire la fraternità universale. E questo è il momento, questa è la sfida di oggi. Vi auguro di alimentare la contemplazione e la compassione, ingredienti indispensabili dell’ecologia integrale. Vi ringrazio ancora per la vostra presenza e per il vostro impegno. Vi ringrazio per le vostre preghiere. A coloro di voi che pregano, chiedo di pregare, e a chi non prega, almeno mandatemi buone onde, ne ho bisogno! [ridono, applauso]
E adesso vorrei chiedere a Dio che benedica ognuno di voi, benedica il cuore di ognuno di voi, che sia credente o non credente, di qualsiasi tradizione religiosa sia. Che Dio benedica tutti voi. Amen.
——————-
La foto di Carlo Petrini con Papa Francesco è tratta dal sito web delle Comunità Laudato si’, dove è anche pubblicato il video dell’udienza del 13 settembre 2020, di cui sotto richiamiamo il link.
Papa Francesco:due parole-chiave dell’ecologia integrale: contemplazione e compassione
—————–——


———-
- Anche su Giornalia.
Uscire dalla crisi del capitalismo o dal capitalismo in crisi? Un vecchio quanto attuale dilemma. Dibattito

![]() Riprendiamo di seguito l’editoriale di Donato Speroni, direttore del sito web dell’ASviS (Alleanza per lo Sviluppo sostenibile), organizzazione a cui Aladinpensiero News è associata, pubblicato l’11 settembre u.s. Riteniamo sia un utile contributo al Dibattito in corso sul mondo con e dopo il coronavirus. Per gli aspetti legati alle trasformazioni del lavoro e delle imprese, segnaliamo, per correlazione, l’articolo di Nino Lisi, apparso su Sbilanciamoci! e ripubblicato dal nostro sito.
Riprendiamo di seguito l’editoriale di Donato Speroni, direttore del sito web dell’ASviS (Alleanza per lo Sviluppo sostenibile), organizzazione a cui Aladinpensiero News è associata, pubblicato l’11 settembre u.s. Riteniamo sia un utile contributo al Dibattito in corso sul mondo con e dopo il coronavirus. Per gli aspetti legati alle trasformazioni del lavoro e delle imprese, segnaliamo, per correlazione, l’articolo di Nino Lisi, apparso su Sbilanciamoci! e ripubblicato dal nostro sito.
————————————————————–
È possibile costruire un capitalismo sostenibile?
Negli ultimi 40 anni, il modello neoliberista ha consentito uno sviluppo senza precedenti, ma ha aggravato le disuguaglianze e il degrado del Pianeta. Per modificarne i meccanismi è necessaria un’ampia partecipazione democratica e un “rimbalzo in avanti” dalla crisi in cui siamo, come indica l’Europa.
di Donato Speroni, ASviS.

La domanda circola da tempo: il capitalismo è compatibile con la costruzione di un mondo sostenibile? Già nel World economic forum di Davos del gennaio scorso, quindi in tempi pre-Covid, il tema prescelto era how stakeholder capitalism can solve the world’s urgent challenges. Il concetto di stakeholder capitalism già implicava una svolta rispetto allo shareholder capitalism, indicando un capitalismo attento agli interessi di tutti (lavoratori, consumatori, comunità locali) e non solo agli azionisti, cioè ai profitti.
Lo shareholder capitalism, di matrice anglosassone, ha dominato il mondo economico negli ultimi quarant’anni, ma ha dimostrato la sua inadeguatezza davanti alle sfide del presente, creando una situazione di insostenibilità sociale e ambientale. Sociale, perché ha creato diseguaglianze sempre più forti, senza essere in grado di assicurare la loro riduzione; ambientale, perché l’economia industriale si è sviluppata senza tener conto in modo stringente delle cosiddette “esternalità”: il consumo di risorse naturali non rinnovabili, l’inquinamento, le emissioni di gas serra responsabili del riscaldamento globale. Sono stati introdotti alcuni correttivi, come il meccanismo di scambio delle emissioni (Ets nell’acronimo inglese di Emission trading scheme) sancito dal protocollo di Kyoto, ma non sono stati sufficienti per porre un freno al degrado del Pianeta.
Ci si chiede, dunque, se l’attuale sistema economico è in grado di autoemendarsi per far fronte alle sfide del futuro. Un interrogativo reso drammatico anche dal fatto che le caratteristiche di un possibile sistema alternativo, il cosiddetto “postcapitalismo”, sono molto nebulose. In contrapposizione all’ideologia liberista, dovrebbe trattarsi di un sistema nel quale gli Stati (e le organizzazioni internazionali) riacquistano un forte potere regolatorio e di intervento. Ma qui si apre una seconda questione: i sistemi democratici che governano queste istituzioni sono in grado di gestire sfide a medio e lungo termine come la crisi climatica, oppure le classi dirigenti (e anche l’opinione pubblica) tendono soltanto a guardare all’immediato, all’arco di una legislatura o di una prossima elezione, sempre accantonando i temi del futuro e scaricandoli sulle prossime generazioni?
Nell’introduzione al dossier “Beyond capitalism” edito da The progressive post si afferma:
Oggi il capitalismo è in crisi profonda. Questo semplice fatto era già conosciuto prima dell’attuale crisi economica, ma è stato messo a nudo per tutti dall’ avvento del coronavirus e dal danno che ha provocato alle sue strutture globalizzate e finanziarizzate, costruite sulla fragile fondazione di debiti e crediti. Non è più in grado di garantire il benessere umano e spinge l’ecosistema del Pianeta verso il collasso. Nella sua forma digitalizzata stimola le disuguaglianze anche se alimenta l’illusione dell’empowerment individuale, favorendo propensioni autoritarie in molti Paesi.
Tra gli articoli contenuti nel dossier, quello di Fabrizio Barca, promotore del Forum Diseguaglianze Diversità e coordinatore del gruppo di lavoro ASviS sul Goal 10, che chiede una “inversione a U” nella dinamica delle disuguaglianze che tendono a rendere questo sistema sempre meno sostenibile dal punto di vista sociale.
Non si tratta di investire grandi risorse, ma di ribilanciare i poteri verso una maggiore giustizia sociale e ambientale, ringiovanendo la democrazia.
L’essenza della proposta di Barca non è nella ridistribuzione delle risorse, ma nei meccanismi di formazione: occorre dare più spazio al lavoro rispetto ai detentori del capitale e in questo modo si ottiene un cambiamento degli obiettivi collettivi verso una maggiore giustizia sociale. Tuttavia mi domando: questa visione presuppone che i lavoratori – quelli che un tempo erano chiamati la classe operaia – siano i più disposti a stimolare il cambiamento verso la sostenibilità sociale ed ambientale. Ma numerosi studi, tra cui un recente articolo del Financial Times, avvertono che la classe lavoratrice oggi vota più a destra, e quindi è meno disposta al cambiamento, della classe media, forse perché teme di perdere quel poco che ha conquistato.
È possibile cambiare questa situazione? Nel suo libro “Changemaker? Il futuro industrioso dell’economia digitale”, Sossella editore/cheFare, Adam Arviddson sostiene che l’economia industriale, ad alta intensità di capitale, si sta contraendo e sta espellendo sempre più manodopera. C’è però la possibilità, grazie alle nuove tecnologie, di ritornare a una “economia industriosa”, ad alta intensità di lavoro.
Arviddson spiega in una intervista ad Alex Giordano, sul Corriere della. Sera:
Nel modello industrioso esiste un grande desiderio di cambiamento: questa imprenditorialità non è necessariamente un fatto di necessità ma è un desiderio, una visione. Alla base c’è una volontà di trasformazione, seppur spesso puramente personale. Si tratta quindi di progetti che non vengono inseriti in grandi schemi politici ma che hanno a che fare con percorsi di autorealizzazione individuale. Questo riguarda pesantemente il knowledge worker ma riguarda anche quelli che lavorano nei piani più bassi dell’economia: i lavoratori delle fabbriche di elettronica di Shen Zhen se riescono aprono piccolo banco nel mercato e si mettono a riparare o customizzare o hackerare gli iPhone. Nei mercati africani è pieno di piccoli negozi di mobile phone dove puoi ricaricare o crackare il cellulare e dove vengono usate anche forum di software open source.
Le nuove tecnologie consentirebbero dunque di ridefinire il lavoro e di offrire nuove opportunità di autoimpiego, evitando l’emarginazione di milioni di persone. Questa nuova classe lavoratrice sarà più aperta alle scelte necessarie per uno sviluppo sostenibile? Una possibile risposta ci viene dal saggio “After carbon democracy” di Alyssa Battistoni. e Jediah Britton-Purdy, pubblicato di Dissent e ripreso in italiano dalla rivista Una città.
Dunque, siamo davvero noi il problema? Quali sono le prospettive per una “no-carbon democracy” nel Ventunesimo secolo?
Nel “Financial Times”, affidabile barometro del pensiero elitario, un redattore si è recentemente domandato: “La democrazia può sopravvivere senza il petrolio?”. La risposta non è facile: “Nessun elettorato voterà mai per ridimensionare il proprio stile di vita? Non possiamo certo incolpare i politici cattivi o le corporation. È colpa nostra: preferiremo sempre la crescita al clima”.
Persino i meglio disposti, a sinistra, non possono non preoccuparsi di quello che un drastico cambiamento delle condizioni materiali di vita potrebbe comportare per il destino della democrazia. Nel suo libro Carbon Democracy, lo storico Timothy Mitchell sostiene che “le politiche democratiche si sono sviluppate grazie al petrolio con un particolare orientamento verso il futuro; il futuro era l’orizzonte infinito della crescita”. Ora sappiamo che quell’orizzonte si sta restringendo.
Gli autori si pongono la domanda se è possibile combattere il cambiamento climatico in un sistema democratico: apparentemente, un regime autoritario, “capace di costruire ferrovie ad alta velocità o di interrompere da un giorno all’altro una produzione di carbone” ha migliori possibilità di intervenire sul clima. Ma “non è ancora ora di mandare la democrazia nel dimenticatoio”: bisogna invece convincere la maggioranza e in realtà una maggioranza a favore delle scelte ambientaliste si può costruire.
In effetti, esiste un programma climatico ambizioso, che si propone di sostenere alti costi a beneficio di popolazioni straniere e delle generazioni future e che sta mobilitando gli attivisti e attraendo a sé i candidati delle primarie democratiche.
Il Green New Deal rappresenta una scommessa sul fatto che sia più democrazia, e non meno, la strada per affrontare il cambiamento climatico, anche se non abbiamo ancora una democrazia perfetta. La premessa è che l’azione climatica, per avere successo politicamente, deve essere popolare; ciò significa che deve offrire benefici alle persone, e non solo chiedere loro sacrifici per il bene del futuro.
Oggi però “non esiste una base elettorale per un movimento di austerity ecologista”, ma in prospettiva
non hai bisogno di cambiare lo spirito e la mentalità di tutti, in un Paese; non devi necessariamente produrre una trasformazione morale improvvisa. È sufficiente convincere una maggioranza di persone. E una grande maggioranza di persone ha indicato il proprio sostegno a molte delle componenti del Green New Deal: la garanzia di occupazione lavorativa; l’investimento su energie rinnovabili al 100%; il ripristino di terreni e foreste; l’investimento nei trasporti pubblici, e così via.
Conclude il saggio:
Ci aspetta una lotta lunga e difficile, piena di tensioni e di domande: qual è la volontà del popolo, e chi è il popolo, e come realizzare la sua volontà con istituzioni rigide, infrastrutture ancor più rigide, un capitale a piede libero e un popolo invece non pienamente libero? Il tutto mentre la natura, sempre più imprevedibile, si disinteressa di noi.
Questo è, sfortunatamente, lo stato della politica, di questi tempi, anche in momenti in cui la posta in gioco è alta e chiara e l’obiettivo è quello di realizzare pienamente la democrazia. Tuttavia, non c’è un’altra via d’uscita: bisogna passare di qui.
Proviamo a riassumere questo complesso ragionamento sulla base degli articoli citati: l’economia di mercato, cioè il capitalismo come l’abbiamo conosciuto finora, non è in grado di affrontare i temi della sostenibilità sociale e ambientale. Ma il capitalismo sta nuovamente cambiando, anche perché le nuove tecnologie rivalutano il ruolo dell’individuo e aprono nuove prospettive di partecipazione e di potere alla classe lavoratrice. Non è però scontato che i lavoratori siano disposti a fare scelte di medio e lungo termine che possono comportare sacrifici, anche se cresce la sensibilità ai temi dell’ambiente e della difesa del Pianeta. Dobbiamo dunque trasformare questa nuova sensibilità in una maggioranza “non silenziosa” per imporre un sistema che regoli i meccanismi di mercato nel rispetto del Pianeta e verso un maggiore equilibrio sociale. Questa è la battaglia politica che abbiamo davanti.
Vaste programme, avrebbe detto il generale De Gaulle. È importante però che in questa battaglia si possa contare sull’impegno dell’Europa, confermato in questi giorni dalla pubblicazione del primo Strategic foresight report annuale, diffuso in vista dello State of the Union che la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen presenterà il 15 settembre. La parola chiave del rapporto è “resilienza” riecheggiando in questa scelta la parola d’ordine lanciata da tempo dall’ASviS: soltanto consolidando i nostri punti di forza – sostiene la Commissione – si può “rimbalzare avanti” dopo la crisi del Covid.
Il rapporto analizza la resilienza nelle sue quattro dimensioni interconnesse: socioeconomica, geopolitica, verde e digitale, e spiega la sua importanza per raggiungere i nostri obiettivi strategici di lungo termine nel contesto delle transizioni verde, digitale e giusta.
Il documento non si limita alle parole, ma propone anche due prototipi di dashboard, strumentazioni statistiche per misurare le resilienze dei Paesi dell’Unione in campo socioeconomico e in campo geopolitico, verde, digitale. Come nell’Agenda 2030 dell’Onu, infatti, ogni effettiva trasformazione si deve poter monitorare attraverso indicatori che anno dopo anno indichino lo stato dell’arte e la necessità di interventi.
Questo documento può essere letto come una conferma della volontà europea di perseguire un modello di sviluppo che si basi su un capitalismo emendato per poter raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e su una crescita dei meccanismi democratici che diano più forza alla partecipazione popolare.

I segni che cogliamo nella nostra attività confermano i progressi nella sensibilità collettiva anche in Italia. Li vediamo nella mobilitazione per il prossimo Festival dello Sviluppo Sostenibile, nel nuovo protagonismo dei giovani, anche nella nuova attenzione all’Agenda 2030 mostrata dal mondo politico, con il collegamento reso esplicito sul sito della Camera tra il lavoro delle Commissioni permanenti e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Il Rapporto annuale che l’ASviS presenterà l’8 ottobre a conclusione del Festival metterà in chiaro le priorità da perseguire per uno sviluppo sostenibile in questa epoca così diversa da come ce l’eravamo immaginata e contribuirà alle scelte del Paese che deve cogliere l’occasione unica dei fondi europei per scelte di rinnovamento verso l’economia verde e la digitalizzazione.
Venerdì 11 Settembre 2020, su ASviS.
Appello: non si restringano gli spazi di partecipazione!
 “Il Dibattito Pubblico affossato prima ancora di nascere”
“Il Dibattito Pubblico affossato prima ancora di nascere”
————
Il Senato in considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 ha approvato nel disegno di legge Semplificazioni una norma di deroga al ricorso alla procedura di dibattito pubblico prima di una grande opera pubblica, come previsto dal Dpcm n. 76/2018 che ha introdotto nel nostro ordinamento il «Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico». L’appello perché la legge vigente non venga modificata. Aladinpensiero aderisce e s’impegna nella diffusione dell’appello.
————
Appello per un cambio di prospettiva della partecipazione in Italia
Siamo esperti di processi partecipativi, studiosi di democrazia deliberativa, membri di associazioni che si occupano di innovazione democratica, cittadini impegnati per il bene comune. Scriviamo per esprimere la nostra preoccupazione per una norma approvata dal Senato nel disegno di legge Semplificazioni: l’introduzione di una deroga al ricorso alla procedura di dibattito pubblico prima di una grande opera pubblica.
Ecco la norma approvata all’articolo 8 del disegno di legge Semplificazioni:
6-bis. In considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e delle conseguenti esigenze di accelerazione dell’iter autorizzativo di grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull’ambiente, sulle città o sull’assetto del territorio, sino al 31 dicembre 2023, su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici, le regioni, ove ritengano le suddette opere di particolare interesse pubblico e rilevanza sociale, previo parere favorevole della maggioranza delle amministrazioni provinciali e comunali interessate, possono autorizzare la deroga alla procedura di dibattito pubblico di cui all’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e al relativo regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76, consentendo alle medesime amministrazioni aggiudicatrici di procedere direttamente agli studi di prefattibilità tecnico-economica nonché alle successive fasi progettuali, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Cos’è il Dibattito Pubblico
Il dibattito pubblico è un processo di informazione, partecipazione e confronto pubblico che ha lo scopo di accrescere il coinvolgimento dei cittadini e cittadine nei processi di realizzazione delle grandi opere e si svolge nelle fasi iniziali di elaborazione del progetto, al fine di valutare gli impatti delle diverse alternative e orientare le scelte. Ispirato al modello francese del débat public (introdotto dalla c.d. legge Barnier nel 1995) e già previsto in alcune leggi regionali, non è vincolante per il decisore pubblico ma permette di individuare e trattare con anticipo possibili conflitti che rischierebbero di rallentare la realizzazione degli interventi, come si è verificato in numerosi casi di infrastrutture controverse. Tale procedura ha una durata di pochi mesi, portando benefici sia in termini di trasparenza e democraticità delle decisioni sia in termini di speditezza ed efficacia dell’azione amministrativa, sottraendola alle pressioni settoriali e localistiche. Il dibattito pubblico è uno strumento nato per gestire una conflittualità latente o esplicita e per migliorare la qualità della progettazione delle opere, serve ad aiutare e facilitare la decisione. Non è un elemento di complicazione o rallentamento delle procedure e può essere svolto anche negli ambienti digitali, nel rispetto dei principi inclusivi sul piano del confronto e della deliberazione, della celerità e della tutela sanitaria.
Perché questa deroga è inopportuna
Ci preoccupa la deroga alle norme sul dibattito pubblico. La partecipazione civica è un diritto e una modalità per rendere le scelte più condivise e quindi più sostenibili, non è un intralcio. La norma approvata dal Senato sembra invece appoggiare l’erronea percezione che informare e ascoltare il punto di vista dei cittadini sia una complicazione ed una perdita di tempo, mentre numerose opere in Italia sono ferme proprio a causa della mancanza di dialogo e di informazione delle popolazioni. Un preventivo ascolto civico tende ad accorciare piuttosto che ad allungare un processo decisionale.
Questa deroga nega dunque non solo un diritto individuale riconosciuto da legislazioni internazionali, europee e nazionali, ma impedisce l’adozione di decisioni strategiche e di politiche pubbliche di migliore qualità. E questo proprio in una congiuntura emergenziale durante la quale il coinvolgimento dei cittadini diventa più prezioso in quanto garanzia di trasparenza e di dialogo sociale.
Cosa proponiamo
Chiediamo al Legislatore di ripensarci e di abrogare la norma che introduce la deroga al dibattito pubblico. Invitiamo il Governo a rispettare gli impegni presi anche in sedi internazionali (l’Italia è firmataria della Convenzione di Aahrus) e di mettere al primo posto l’interesse generale e la tutela dei diritti di cittadine e cittadini. La deroga costituisce una regressione dei diritti e un peggioramento dei metodi di decisione e di costruzione delle politiche pubbliche. Da questo punto di vista la scelta del Senato appare non solo incomprensibile, ma anche nociva per la qualità delle opere infrastrutturali di cui il paese ha bisogno.
Le socie ed i soci di Aip2 – Associazione Italiana per la Partecipazione Pubblica
Insieme a:
Chiara L. Pignaris, presidente Associazione Italiana per la Partecipazione Pubblica
Giandiego Càrastro, socio Aip2 e membro Argomenti2000 Senigallia
Giovanni Allegretti, Centro de Estudos Sociais dell’Universitá di Coimbra, Portogallo
Marianella Sclavi, presidente di Ascolto Attivo srl e docente al Master ProPart di Venezia
Agnese Bertello, facilitatrice di Ascolto Attivo srl
Ilaria Casillo, prof. associata Facoltà di urbanistica Università Gustave Eiffel Parigi
Francesca Gelli, direttrice del Master IUAV in Progettazione Partecipata – ProPART
Susan George, docente Università di Pisa, presidente Aip2 2016-2019
Alfonso Raus, formatore, esperto di processi partecipativi e di innovazione territoriale – socio Aip2
Antonio Floridia, dirigente del Settore Politiche per la partecipazione della Regione Toscana
Andrea Pirni, prof. associato di Sociologia dei fenomeni politici, Università di Genova
Sofia Mannelli, presidente associazione Chimica Verde Bionet
Veronica Dini, presidente Systasis – Centro Studi per la prevenzione e la gestione dei conflitti ambientali
Iolanda Romano, socia fondatrice di Avventura Urbana
Ilaria Ramazzotti, Coordinatrice Argomenti2000 Senigallia
Umberto Allegretti, già professore ordinario di diritto pubblico presso l’università di Firenze
Maria Chiara Prodi
Giuseppe Maiorana, direttore dello spazio museale di Belìce/EpiCentro della Memoria Viva _CRESM
Elena Pivato, Urban Center Brescia
Lucia Lancerin, architetto (VI) – socia di Aip2
Elena Farnè, socia di Aip2
Andrea Panzavolta, di Formattiva – socio di Aip2
Giovanni Realdi, insegnante
Gabriella Giornelli
Maria Cristina Venanzi, consulente comunicazione pubblica
Antonio Sgueglia
Sara Giacomozzi, architetto paesaggista – socia di Aip2
Andrea Caccìa, facilitatore – socio Aip2
Andrea Pillon, Avventura Urbana Srl
Lilli Antonacci, facilitatrice e animatrice sociale – socia Aip2
Maurizio Schifano, Service Designer – Associazione Coltivatori di bellezza
Luca Raffini, ricercatore in Sociologia dei fenomeni politici, Università di Genova – socio Aip2
Alessio Conti, professore
Angelo D. Marra, avvocato
Mauro Julini, facilitatore, mediatore, formatore di mediatori e negoziatori – socio Aip2
Antonella Giunta, Aip2
Sara Serravalle, esperta di gestione di conflitti urbani ed ambientali e dottore di ricerca – socia Aip2
Franco Meloni, direttore, e la redazione di Aladinpensiero online
……………..
Per sottoscrivere l’appello inviare una mail a: info@aip2italia.org
Per scaricare il documento
—————————————
Fonte illustrazione: https://www.aladinpensiero.it/?p=112366
—————————————
Per correlazione

 -Buone brevi letture: Umberto Allegretti “Democrazia partecipativa e processi di democratizzazione”, 2009.
-Buone brevi letture: Umberto Allegretti “Democrazia partecipativa e processi di democratizzazione”, 2009.
- Buone impegnative letture. “Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998″. Ratificata dall’Italia con Legge del 16 marzo 2001, n. 108 (Suppl. alla G.U. n.85 dell’11 aprile 2001).

CONVENZIONE INTERNAZIONALE 25 giugno 1998, Aarhus.
Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998
Ratificata con Legge del 16 marzo 2001, n. 108 (Suppl. alla G.U. n.85 dell’11 aprile 2001)
——————————–
- Anche su Giornalia.
Vogliamo la Scuola! Una priorità per l’utilizzo del Recovery Fund.
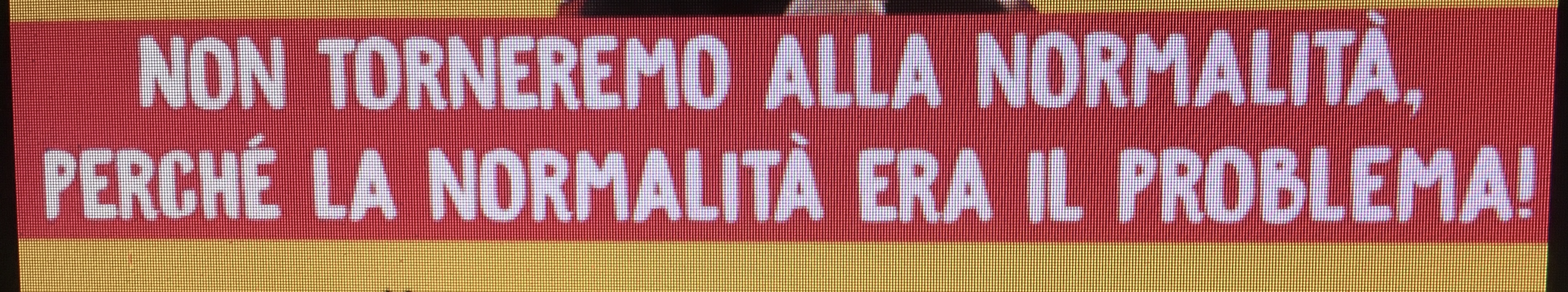
Il futuro non è la normalità nella scuola
di Giacomo Cossu
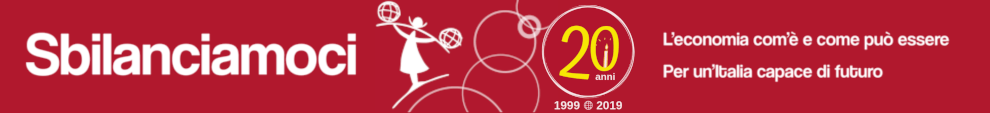
Sbilanciamoci!, 8 Settembre 2020 | Sezione: Editoriale
Per l’istruzione serve un piano strategico che riguardi gli edifici e i banchi ma non solo. I tagli al personale hanno causato fenomeni dannosi per la didattica – e per la sicurezza – come le “classi pollaio”, privando le scuole del personale necessario per ampliare l’offerta didattica e innovare i metodi di insegnamento.
Negli scorsi mesi a Santiago del Cile spiccava un grattacielo la scritta “non torneremo alla normalità, perché la normalità era il problema”. Nel pieno dell’emergenza sanitaria, di fronte alle enormi difficoltà nel riaprire le scuole e le università in condizioni di sicurezza, questo slogan dovrebbe essere la bussola di ogni riflessione riguardo l’istruzione. La garanzia del diritto allo studio e la tutela della funzione democratica dell’istruzione possono realizzarsi solamente se si guarda alle difficoltà di questi giorni con attenzione a quali sono le radici strutturali di questa crisi. Ci sono tre aspetti particolarmente significativi da analizzare, che permettono di inquadrare gli ostacoli ad una ripartenza in sicurezza all’interno di una seria e concreta visione organica per il rilancio dell’istruzione: le possibilità di accesso alla formazione, la condizione delle lavoratrici e dei lavoratori della conoscenza, lo stato dell’edilizia scolastica e universitaria. Questi focus permettono di individuare i principali danni causati dal taglio dei finanziamenti alla scuola e all’università – rispettivamente di 8 miliardi e 1,5 miliardi – operati da Tremonti e Gelmini dieci fa e mai più compensati dai Governi successivi.
L’accesso all’istruzione nel nostro Paese è solo formalmente garantito, ma non ci sono adeguati strumenti per garantire a tutte e tutti gli studenti le stesse possibilità e la libertà di studiare. Secondo il Rapporto BES 2019 dell’ISTAT, l’uscita precoce dagli studi riguarda il 14,5% dei giovani, un dato che arriva ad oltre il doppio nelle regioni meridionali. Nel corso degli ultimi mesi questa drammatica esclusione di centinaia di migliaia di giovani dalla formazione è esplosa a causa dell’introduzione emergenziale della didattica a distanza. Infatti il sistema scolastico ed universitario, già privo di adeguati strumenti per garantire a tutti la partecipazione alla formazione, ha ulteriormente escluso ampie fasce di studenti privi dei dispositivi tecnologici o di un contesto familiare che potesse supportare la partecipazione alle lezioni in condizioni straordinarie. Secondo l’indagine Italia sotto sforzo. Diario della transizione 2020/1 del CENSIS, solo l’11% dei dirigenti scolastici intervistati ritiene che tutti gli studenti delle loro scuole abbiano partecipato alle lezioni online, mentre risulta che nel 40% delle scuole oltre il 5% degli studenti non abbia avuto accesso alla didattica a distanza – anche in questo caso al Meridione si riscontrano dati nettamente peggiori. Lo stesso ministero dell’Istruzione a luglio 2019 pubblicava un report in cui si sostiene che la dispersione scolastica sia direttamente connessa ai livelli di povertà e ai livelli di istruzione della famiglia di provenienza. Gli interventi dello Stato per risanare questa ingiustizia e mancata applicazione della Costituzione si sono mostrati fallimentari in tempi ordinari e ancor più nella pandemia. Occorre approvare una legge nazionale per il diritto allo studio che garantisca l’abolizione dei costi diretti legati all’istruzione – dal contributo volontario alle tasse universitarie – così come i costi indiretti, fornendo i materiali didattici tradizionali e digitali in comodato d’uso a tutti gli studenti che ne abbiano necessità, oltre che rendendo gratuiti i servizi indispensabili alla frequenza delle lezioni e allo studio, dall’abbonamento per il trasporto pubblico alla connessione personale ad internet. Insieme all’abolizione di questi ostacoli economici, devono essere risolte le disparità territoriali nell’offerta didattica, in particolare garantendo l’apertura delle scuole di tutto il Paese per tutta la giornata, finanziando il tempo pieno e progetti didattici e autogestiti da parte degli studenti, in modo da coinvolgere gli studenti che provengono dalle condizioni socio-culturali che più spingono ad abbandonare l’istruzione.
La necessità di potenziare l’offerta didattica e la qualità della formazione evidenzia un altro enorme fallimento dello Stato in materia di istruzione. Il nostro Paese ha infatti un’età media del corpo docente tra le più alte nell’area OCSE, accanto ad un rapporto tra docenti e studenti molto elevato. I tagli alla spesa in istruzione hanno comportato una forte riduzione del personale docente e amministrativo, causando fenomeni dannosi per la didattica – e per la sicurezza – come le “classi pollaio” e privando le scuole del personale necessario per ampliare l’offerta didattica e innovare i metodi di insegnamento. Nell’università il calo del numero dei docenti e il dimezzamento del numero dei ricercatori a tempo indeterminato causati dalla riforma Gelmini hanno comportato un eguale problema di carenza di personale. La pandemia ha spinto il Governo ad un intervento emergenziale, con la programmazione di un nuovo concorso straordinario da 70 mila cattedre e con l’assunzione di 50 mila precari per colmare una parte della carenza di organico nella scuola, dimostrando ancora una volta quanto la classe dirigente del nostro Paese non abbia la minima capacità di affrontare i problemi strutturali dell’istruzione. Una seria politica dell’istruzione dovrebbe prevedere la stabilizzazione di tutte le migliaia di lavoratori che hanno 36 mesi di servizio alle spalle – come peraltro prevede il diritto dell’UE – insieme ad una programmazione delle assunzioni calibrata sul fabbisogno delle scuole, uscendo dal metodo dei concorsi straordinari e dalla trappola della precarietà in cui sono costretti tantissimi lavoratori della conoscenza.
Il rispetto dei diritti dei lavoratori della conoscenza e maggiori assunzioni permetterebbero di appianare grandi disuguaglianze presenti nel sistema di istruzione del Paese, ma non sarebbero sufficienti senza un piano radicale per l’edilizia scolastica e universitaria. Metà degli edifici scolastici è stato costruito prima del 1970 e presentano una struttura degli edifici assolutamente inadeguata a metodi didattici innovativi e alle esigenze di studenti e docenti. Se guardiamo all’edilizia universitaria, notiamo che l’espansione del numero programmato e del numero chiuso – che oggi con la pandemia dimostra la sua pericolosità data la carenza di medici – è stata in gran parte la risposta delle autorità accademiche e del governo nazionale alla carenza di strutture per la didattica, nonostante la falsa retorica inaccettabile sull’esclusione dagli studi per motivi meritocratici. Oggi paghiamo i mancati investimenti nell’edilizia scolastica e universitaria, non avendo a disposizione spazi adeguati per garantire il distanziamento sociale e la tutela della salute di studenti e lavoratori della conoscenza. La pandemia avrebbe dovuto indurre all’elaborazione di un piano urgente di ristrutturazione degli edifici scolastici e universitari, una politica che avrebbe effetti positivi sull’occupazione e sulla riconversione ecologica del patrimonio pubblico, come richiesto da sindacati e associazioni, ma l’attenzione del Governo è stata rivolta alla deregolamentazione degli appalti con il DL Semplificazioni, anziché alla pianificazione di un intervento pubblico per rispondere alle reali necessità della popolazione.
Questi tre fondamentali aspetti della crisi dell’istruzione avrebbero dovuto indurre il Governo ad evitare slogan e approssimazione, riconoscendo immediatamente che il sistema scolastico e universitario non hanno gli strumenti per rispondere alle necessarie tutele della salute pubblica. Da questa consapevolezza si deve partire per elaborare un programma di governo serio e concreto, per garantire innanzitutto l’accesso alla formazione a distanza, mentre si predispone la stabilizzazione del personale necessario e un piano di edilizia scolastica e universitaria urgente. Le risorse necessarie sarebbero ingenti, come denunciano da anni studenti e lavoratori della conoscenza. Le risorse stanziate dal Governo sono irrisorie rispetto alle necessità e nettamente inferiori alle risorse destinate agli sgravi fiscali a pioggia per le imprese come il taglio dell’IRAP. Approfittando degli stanziamenti del Next Generation EU, lo Stato dovrebbe investire oltre 20 miliardi in istruzione, portando la quota di PIL destinato alla formazione al 5%, in linea con la media dell’area OCSE, in cui siamo stabilmente agli ultimi posti per investimenti in istruzione con solamente il 3,6% del PIL. Si tratta di scelte coraggiose ma indispensabili, per non tornare ad una normalità dominata da ingiustizia e contraddizioni, bensì per costruire un futuro migliore per tutto il Paese.
————————

Rapporto Bes Istat 2019
Oriente e Occidente. Riflessioni aspettando l’enciclica “Fratelli tutti”.
Il 3 ottobre 2020 Papa Francesco firmerà la nuova enciclica sulla fratellanza universale. Sarà una proposta all’Umanità per praticare l’unica via per la sua salvezza e insieme quella della Terra.
————————————————-

![]() Il 3 ottobre Papa Francesco sarà a Assisi, sulla tomba di San Francesco, per firmare la nuova enciclica “Fratelli tutti – Sulla fraternità e l’amicizia sociale“. Quella che segue è solo una libera e breve riflessione su alcuni degli importanti concetti che il documento papale crediamo riproporrà magistralmente, sulla scia della Laudato sì‘, della dichiarazione di Abu Dhabi e, in generale, della consolidata Dottrina sociale della Chiesa, anche per aiutarci tutti ad affrontare la pandemia e le sue conseguenze..
Il 3 ottobre Papa Francesco sarà a Assisi, sulla tomba di San Francesco, per firmare la nuova enciclica “Fratelli tutti – Sulla fraternità e l’amicizia sociale“. Quella che segue è solo una libera e breve riflessione su alcuni degli importanti concetti che il documento papale crediamo riproporrà magistralmente, sulla scia della Laudato sì‘, della dichiarazione di Abu Dhabi e, in generale, della consolidata Dottrina sociale della Chiesa, anche per aiutarci tutti ad affrontare la pandemia e le sue conseguenze..
———————————-
di Franco Meloni.
 Il Dalai Lama e gli uomini dell’Occidente
Il Dalai Lama e gli uomini dell’Occidente
«Quello che mi ha sorpreso di più negli uomini dell’Occidente è che perdono la salute per fare i soldi e poi perdono i soldi per recuperare la salute. Pensano tanto al futuro che dimenticano di vivere il presente in tale maniera che non riescono a vivere né il presente, né il futuro. Vivono come se non dovessero morire mai e muoiono come se non avessero mai vissuto».
————-
Questa frase del Dalai Lama mi è tornata in mente leggendo il documento sulla Fratellanza umana, firmato da Francesco e dall’imam al-Tayyeb ad Abu Dhabi il 4 febbraio del 2019 [nella foto], in particolare il passaggio che sotto riporto. In sintesi e pertanto in modo semplificato, vengono riconosciute le ragioni del reciproco vantaggio di un fecondo rapporto tra le due grandi Civiltà (Oriente e Occidente). Nelle “virtù” dell’Oriente personalmente leggo la possibilità per gli occidentali di praticare stili di vita propri degli orientali, ovviamente con opportuni adattamenti, per il superamento della situazione descritta in modo sferzante dal Dalai Lama. Mentre le “virtù” dell’Occidente vengono richiamate nella potenza scientifica e nella pratica dei valori della democrazia e dei diritti umani (la semplificazione in questo caso è mia). Strumenti e Valori che si propongono all’Oriente. È dunque evidente il vantaggio di un rapporto virtuoso di reciproca conoscenza, rispetto delle diversità e di integrazione. Utopie irrealizzabili? Io credo di no. Non si confondano le difficoltà con l’impossibilità! La via della Fratellanza, tracciata dal richiamato documento e che sarà rilanciata dalla nuova enciclica, appare come la più realistica per la salvezza del genere umano. In definitiva l’unica. Ne sono convinto.
—————————————-
(…) – Il rapporto tra Occidente e Oriente è un’indiscutibile reciproca necessità, che non può essere sostituita e nemmeno trascurata, affinché entrambi possano arricchirsi a vicenda della civiltà dell’altro, attraverso lo scambio e il dialogo delle culture. L’Occidente potrebbe trovare nella civiltà dell’Oriente rimedi per alcune sue malattie spirituali e religiose causate dal dominio del materialismo. E l’Oriente potrebbe trovare nella civiltà dell’Occidente tanti elementi che possono aiutarlo a salvarsi dalla debolezza, dalla divisione, dal conflitto e dal declino scientifico, tecnico e culturale. È importante prestare attenzione alle differenze religiose, culturali e storiche che sono una componente essenziale nella formazione della personalità, della cultura e della civiltà orientale; ed è importante consolidare i diritti umani generali e comuni, per contribuire a garantire una vita dignitosa per tutti gli uomini in Oriente e in Occidente, evitando l’uso della politica della doppia misura.
—————-————–

- In versione diversa anche su Giornalia.
—-———————————-
Approfondimenti.
———————————————-
DOCUMENTO SULLA FRATELLANZA UMANA PER LA PACE MONDIALE E LA CONVIVENZA COMUNE
———————-

Luigi Accattoli, “Virus, solidarietà, Islam. L’enciclica di Francesco” (Corriere della sera). “‘Fratelli tutti’, Francesco firmerà la sua Enciclica il 3 ottobre ad Assisi” (vatican.news).
———————————————————————-
In nome della fratellanza umana
 Un documento di straordinaria importanza per l’Umanità tutta sta per esserci offerto da Francesco, Papa dei cattolici e dialogante per la pace e la giustizia con tutti gli altri abitanti del pianeta. Credenti e non credenti chiamati insieme a confrontarsi sui destini del Mondo. Una occasione da non perdere per costruire ponti in alternativa ai muri, ai confini, ai nazionalismi, al razzismo e a tutto ciò che alimenta conflitti, odio, sofferenza e morte. Una responsabilità che grava su tutti noi al di la del proprio credo religioso e dei propri convincimenti politici. (V.T.)
Un documento di straordinaria importanza per l’Umanità tutta sta per esserci offerto da Francesco, Papa dei cattolici e dialogante per la pace e la giustizia con tutti gli altri abitanti del pianeta. Credenti e non credenti chiamati insieme a confrontarsi sui destini del Mondo. Una occasione da non perdere per costruire ponti in alternativa ai muri, ai confini, ai nazionalismi, al razzismo e a tutto ciò che alimenta conflitti, odio, sofferenza e morte. Una responsabilità che grava su tutti noi al di la del proprio credo religioso e dei propri convincimenti politici. (V.T.)
———————————-
In attesa di conoscere il testo della nuova enciclica “Fratelli tutti – Sulla fraternità e l’amicizia sociale“, pubblichiamo il documento sulla Fratellanza umana, firmato da Francesco e dall’imam al-Tayyeb ad Abu Dhabi il 4 febbraio del 2019, che la precede con particolare riferimento al dialogo tra i credenti di diverse religioni, nella pratica della libertà, della giustizia, della solidarietà, della tolleranza [nella foto la firma del documento].
————-
DOCUMENTO SULLA FRATELLANZA UMANA
PER LA PACE MONDIALE E LA CONVIVENZA COMUNE
PREFAZIONE
La fede porta il credente a vedere nell’altro un fratello da sostenere e da amare. Dalla fede in Dio, che ha creato l’universo, le creature e tutti gli esseri umani – uguali per la Sua Misericordia –, il credente è chiamato a esprimere questa fratellanza umana, salvaguardando il creato e tutto l’universo e sostenendo ogni persona, specialmente le più bisognose e povere.
Partendo da questo valore trascendente, in diversi incontri dominati da un’atmosfera di fratellanza e amicizia, abbiamo condiviso le gioie, le tristezze e i problemi del mondo contemporaneo, al livello del progresso scientifico e tecnico, delle conquiste terapeutiche, dell’era digitale, dei mass media, delle comunicazioni; al livello della povertà, delle guerre e delle afflizioni di tanti fratelli e sorelle in diverse parti del mondo, a causa della corsa agli armamenti, delle ingiustizie sociali, della corruzione, delle disuguaglianze, del degrado morale, del terrorismo, della discriminazione, dell’estremismo e di tanti altri motivi.
Da questi fraterni e sinceri confronti, che abbiamo avuto, e dall’incontro pieno di speranza in un futuro luminoso per tutti gli esseri umani, è nata l’idea di questo «Documento sulla Fratellanza Umana». Un documento ragionato con sincerità e serietà per essere una dichiarazione comune di buone e leali volontà, tale da invitare tutte le persone che portano nel cuore la fede in Dio e la fede nella fratellanza umana a unirsi e a lavorare insieme, affinché esso diventi una guida per le nuove generazioni verso la cultura del reciproco rispetto, nella comprensione della grande grazia divina che rende tutti gli esseri umani fratelli.
DOCUMENTO
In nome di Dio che ha creato tutti gli esseri umani uguali nei diritti, nei doveri e nella dignità, e li ha chiamati a convivere come fratelli tra di loro, per popolare la terra e diffondere in essa i valori del bene, della carità e della pace.
In nome dell’innocente anima umana che Dio ha proibito di uccidere, affermando che chiunque uccide una persona è come se avesse ucciso tutta l’umanità e chiunque ne salva una è come se avesse salvato l’umanità intera.
In nome dei poveri, dei miseri, dei bisognosi e degli emarginati che Dio ha comandato di soccorrere come un dovere richiesto a tutti gli uomini e in particolar modo a ogni uomo facoltoso e benestante.
In nome degli orfani, delle vedove, dei rifugiati e degli esiliati dalle loro dimore e dai loro paesi; di tutte le vittime delle guerre, delle persecuzioni e delle ingiustizie; dei deboli, di quanti vivono nella paura, dei prigionieri di guerra e dei torturati in qualsiasi parte del mondo, senza distinzione alcuna.
In nome dei popoli che hanno perso la sicurezza, la pace e la comune convivenza, divenendo vittime delle distruzioni, delle rovine e delle guerre.
In nome della «fratellanza umana» che abbraccia tutti gli uomini, li unisce e li rende uguali.
In nome di questa fratellanza lacerata dalle politiche di integralismo e divisione e dai sistemi di guadagno smodato e dalle tendenze ideologiche odiose, che manipolano le azioni e i destini degli uomini.
In nome della libertà, che Dio ha donato a tutti gli esseri umani, creandoli liberi e distinguendoli con essa.
In nome della giustizia e della misericordia, fondamenti della prosperità e cardini della fede.
In nome di tutte le persone di buona volontà, presenti in ogni angolo della terra.
In nome di Dio e di tutto questo, Al-Azhar al-Sharif – con i musulmani d’Oriente e d’Occidente –, insieme alla Chiesa Cattolica – con i cattolici d’Oriente e d’Occidente –, dichiarano di adottare la cultura del dialogo come via; la collaborazione comune come condotta; la conoscenza reciproca come metodo e criterio.
Noi – credenti in Dio, nell’incontro finale con Lui e nel Suo Giudizio –, partendo dalla nostra responsabilità religiosa e morale, e attraverso questo Documento, chiediamo a noi stessi e ai Leader del mondo, agli artefici della politica internazionale e dell’economia mondiale, di impegnarsi seriamente per diffondere la cultura della tolleranza, della convivenza e della pace; di intervenire, quanto prima possibile, per fermare lo spargimento di sangue innocente, e di porre fine alle guerre, ai conflitti, al degrado ambientale e al declino culturale e morale che il mondo attualmente vive.
Ci rivolgiamo agli intellettuali, ai filosofi, agli uomini di religione, agli artisti, agli operatori dei media e agli uomini di cultura in ogni parte del mondo, affinché riscoprano i valori della pace, della giustizia, del bene, della bellezza, della fratellanza umana e della convivenza comune, per confermare l’importanza di tali valori come àncora di salvezza per tutti e cercare di diffonderli ovunque.
Questa Dichiarazione, partendo da una riflessione profonda sulla nostra realtà contemporanea, apprezzando i suoi successi e vivendo i suoi dolori, le sue sciagure e calamità, crede fermamente che tra le più importanti cause della crisi del mondo moderno vi siano una coscienza umana anestetizzata e l’allontanamento dai valori religiosi, nonché il predominio dell’individualismo e delle filosofie materialistiche che divinizzano l’uomo e mettono i valori mondani e materiali al posto dei principi supremi e trascendenti.
Noi, pur riconoscendo i passi positivi che la nostra civiltà moderna ha compiuto nei campi della scienza, della tecnologia, della medicina, dell’industria e del benessere, in particolare nei Paesi sviluppati, sottolineiamo che, insieme a tali progressi storici, grandi e apprezzati, si verifica un deterioramento dell’etica, che condiziona l’agire internazionale, e un indebolimento dei valori spirituali e del senso di responsabilità. Tutto ciò contribuisce a diffondere una sensazione generale di frustrazione, di solitudine e di disperazione, conducendo molti a cadere o nel vortice dell’estremismo ateo e agnostico, oppure nell’integralismo religioso, nell’estremismo e nel fondamentalismo cieco, portando così altre persone ad arrendersi a forme di dipendenza e di autodistruzione individuale e collettiva.
La storia afferma che l’estremismo religioso e nazionale e l’intolleranza hanno prodotto nel mondo, sia in Occidente sia in Oriente, ciò che potrebbe essere chiamato i segnali di una «terza guerra mondiale a pezzi», segnali che, in varie parti del mondo e in diverse condizioni tragiche, hanno iniziato a mostrare il loro volto crudele; situazioni di cui non si conosce con precisione quante vittime, vedove e orfani abbiano prodotto. Inoltre, ci sono altre zone che si preparano a diventare teatro di nuovi conflitti, dove nascono focolai di tensione e si accumulano armi e munizioni, in una situazione mondiale dominata dall’incertezza, dalla delusione e dalla paura del futuro e controllata dagli interessi economici miopi.
Affermiamo altresì che le forti crisi politiche, l’ingiustizia e la mancanza di una distribuzione equa delle risorse naturali – delle quali beneficia solo una minoranza di ricchi, a discapito della maggioranza dei popoli della terra – hanno generato, e continuano a farlo, enormi quantità di malati, di bisognosi e di morti, provocando crisi letali di cui sono vittime diversi paesi, nonostante le ricchezze naturali e le risorse delle giovani generazioni che li caratterizzano. Nei confronti di tali crisi che portano a morire di fame milioni di bambini, già ridotti a scheletri umani – a motivo della povertà e della fame –, regna un silenzio internazionale inaccettabile.
È evidente a questo proposito quanto sia essenziale la famiglia, quale nucleo fondamentale della società e dell’umanità, per dare alla luce dei figli, allevarli, educarli, fornire loro una solida morale e la protezione familiare. Attaccare l’istituzione familiare, disprezzandola o dubitando dell’importanza del suo ruolo, rappresenta uno dei mali più pericolosi della nostra epoca.
Attestiamo anche l’importanza del risveglio del senso religioso e della necessità di rianimarlo nei cuori delle nuove generazioni, tramite l’educazione sana e l’adesione ai valori morali e ai giusti insegnamenti religiosi, per fronteggiare le tendenze individualistiche, egoistiche, conflittuali, il radicalismo e l’estremismo cieco in tutte le sue forme e manifestazioni.
Il primo e più importante obiettivo delle religioni è quello di credere in Dio, di onorarLo e di chiamare tutti gli uomini a credere che questo universo dipende da un Dio che lo governa, è il Creatore che ci ha plasmati con la Sua Sapienza divina e ci ha concesso il dono della vita per custodirlo. Un dono che nessuno ha il diritto di togliere, minacciare o manipolare a suo piacimento, anzi, tutti devono preservare tale dono della vita dal suo inizio fino alla sua morte naturale. Perciò condanniamo tutte le pratiche che minacciano la vita come i genocidi, gli atti terroristici, gli spostamenti forzati, il traffico di organi umani, l’aborto e l’eutanasia e le politiche che sostengono tutto questo.
Altresì dichiariamo – fermamente – che le religioni non incitano mai alla guerra e non sollecitano sentimenti di odio, ostilità, estremismo, né invitano alla violenza o allo spargimento di sangue. Queste sciagure sono frutto della deviazione dagli insegnamenti religiosi, dell’uso politico delle religioni e anche delle interpretazioni di gruppi di uomini di religione che hanno abusato – in alcune fasi della storia – dell’influenza del sentimento religioso sui cuori degli uomini per portali a compiere ciò che non ha nulla a che vedere con la verità della religione, per realizzare fini politici e economici mondani e miopi. Per questo noi chiediamo a tutti di cessare di strumentalizzare le religioni per incitare all’odio, alla violenza, all’estremismo e al fanatismo cieco e di smettere di usare il nome di Dio per giustificare atti di omicidio, di esilio, di terrorismo e di oppressione. Lo chiediamo per la nostra fede comune in Dio, che non ha creato gli uomini per essere uccisi o per scontrarsi tra di loro e neppure per essere torturati o umiliati nella loro vita e nella loro esistenza. Infatti Dio, l’Onnipotente, non ha bisogno di essere difeso da nessuno e non vuole che il Suo nome venga usato per terrorizzare la gente.
Questo Documento, in accordo con i precedenti Documenti Internazionali che hanno sottolineato l’importanza del ruolo delle religioni nella costruzione della pace mondiale, attesta quanto segue:
- La forte convinzione che i veri insegnamenti delle religioni invitano a restare ancorati ai valori della pace; a sostenere i valori della reciproca conoscenza, della fratellanza umana e della convivenza comune; a ristabilire la saggezza, la giustizia e la carità e a risvegliare il senso della religiosità tra i giovani, per difendere le nuove generazioni dal dominio del pensiero materialistico, dal pericolo delle politiche dell’avidità del guadagno smodato e dell’indifferenza, basate sulla legge della forza e non sulla forza della legge.
- La libertà è un diritto di ogni persona: ciascuno gode della libertà di credo, di pensiero, di espressione e di azione. Il pluralismo e le diversità di religione, di colore, di sesso, di razza e di lingua sono una sapiente volontà divina, con la quale Dio ha creato gli esseri umani. Questa Sapienza divina è l’origine da cui deriva il diritto alla libertà di credo e alla libertà di essere diversi. Per questo si condanna il fatto di costringere la gente ad aderire a una certa religione o a una certa cultura, come pure di imporre uno stile di civiltà che gli altri non accettano.
- La giustizia basata sulla misericordia è la via da percorrere per raggiungere una vita dignitosa alla quale ha diritto ogni essere umano.
- Il dialogo, la comprensione, la diffusione della cultura della tolleranza, dell’accettazione dell’altro e della convivenza tra gli esseri umani contribuirebbero notevolmente a ridurre molti problemi economici, sociali, politici e ambientali che assediano grande parte del genere umano.
- Il dialogo tra i credenti significa incontrarsi nell’enorme spazio dei valori spirituali, umani e sociali comuni, e investire ciò nella diffusione delle più alte virtù morali, sollecitate dalle religioni; significa anche evitare le inutili discussioni.
- La protezione dei luoghi di culto – templi, chiese e moschee – è un dovere garantito dalle religioni, dai valori umani, dalle leggi e dalle convenzioni internazionali. Ogni tentativo di attaccare i luoghi di culto o di minacciarli attraverso attentati o esplosioni o demolizioni è una deviazione dagli insegnamenti delle religioni, nonché una chiara violazione del diritto internazionale.
- Il terrorismo esecrabile che minaccia la sicurezza delle persone, sia in Oriente che in Occidente, sia a Nord che a Sud, spargendo panico, terrore e pessimismo non è dovuto alla religione – anche se i terroristi la strumentalizzano – ma è dovuto alle accumulate interpretazioni errate dei testi religiosi, alle politiche di fame, di povertà, di ingiustizia, di oppressione, di arroganza; per questo è necessario interrompere il sostegno ai movimenti terroristici attraverso il rifornimento di denaro, di armi, di piani o giustificazioni e anche la copertura mediatica, e considerare tutto ciò come crimini internazionali che minacciano la sicurezza e la pace mondiale. Occorre condannare un tale terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni.
- Il concetto di cittadinanza si basa sull’eguaglianza dei diritti e dei doveri sotto la cui ombra tutti godono della giustizia. Per questo è necessario impegnarsi per stabilire nelle nostre società il concetto della piena cittadinanza e rinunciare all’uso discriminatorio del termine minoranze, che porta con sé i semi del sentirsi isolati e dell’inferiorità; esso prepara il terreno alle ostilità e alla discordia e sottrae le conquiste e i diritti religiosi e civili di alcuni cittadini discriminandoli.
- Il rapporto tra Occidente e Oriente è un’indiscutibile reciproca necessità, che non può essere sostituita e nemmeno trascurata, affinché entrambi possano arricchirsi a vicenda della civiltà dell’altro, attraverso lo scambio e il dialogo delle culture. L’Occidente potrebbe trovare nella civiltà dell’Oriente rimedi per alcune sue malattie spirituali e religiose causate dal dominio del materialismo. E l’Oriente potrebbe trovare nella civiltà dell’Occidente tanti elementi che possono aiutarlo a salvarsi dalla debolezza, dalla divisione, dal conflitto e dal declino scientifico, tecnico e culturale. È importante prestare attenzione alle differenze religiose, culturali e storiche che sono una componente essenziale nella formazione della personalità, della cultura e della civiltà orientale; ed è importante consolidare i diritti umani generali e comuni, per contribuire a garantire una vita dignitosa per tutti gli uomini in Oriente e in Occidente, evitando l’uso della politica della doppia misura.
- È un’indispensabile necessità riconoscere il diritto della donna all’istruzione, al lavoro, all’esercizio dei propri diritti politici. Inoltre, si deve lavorare per liberarla dalle pressioni storiche e sociali contrarie ai principi della propria fede e della propria dignità. È necessario anche proteggerla dallo sfruttamento sessuale e dal trattarla come merce o mezzo di piacere o di guadagno economico. Per questo si devono interrompere tutte le pratiche disumane e i costumi volgari che umiliano la dignità della donna e lavorare per modificare le leggi che impediscono alle donne di godere pienamente dei propri diritti.
[segue]
Occorre un forte impegno per un’Italia diversa da quella realizzata, in una continuità ideale con l’Italia immaginata da Mazzini e prefigurata nella Costituzione repubblicana; ovvero un’Italia che, fondata sulla democrazia e la giustizia sociale, si opponga ai soprusi delle élite dominanti.

Il cosmopolitismo può evocare fantasmi del passato se dissociato da un senso di appartenenza
di Gianfranco Sabattini
Sul numero 2/2020 di MicroMega, Mirko Canevaro (docente di Storia greca all’Università di Edimburgo) ha pubblicato “Ripensare da sinistra l’identità nazionale”, un interessante articolo nel quale egli affronta il tema del successo della Lega, sottolineando come nelle numerose analisi che ne trattano vengano spesso confusi, quasi fossero necessariamente collegati tra loro, populismo, nazionalismo, sovranismo, razzismo e xenofobia; è bene, invece, afferma l’autore, tenerli separati “per coglierne differenze, similitudini e sovrapposizioni, e comprendere come la Lega sia stata capace di allinearne i caratteri distintivi in un messaggio potente”.
Il populismo, ad esempio, è un messaggio in base al quale tutti i movimenti, o i partiti che ad esso si rifanno, dividono il corpo elettorale attraverso una polarità che contrappone le élite dominanti al popolo, concepito quest’ultimo in termini unitari, prescindendo dalla varietà degli interessi che lo contraddistinguono; così inteso, il popolo diviene un’”entità unitaria in quanto unificata essenzialmente dal suo non essere élite”. La Lega, perciò (e in generale tutti i movimenti che si sono rifatti al concetto di popolo così inteso), si è trasformata in movimento populista, perché ha teso “a costruire un’idea trasversale di popolo contrapposto a un’élite che gli è nemica”, facendo della contrapposizione il motivo del suo successo sul piano elettorale.
In tal modo, la Lega, annullando le differenze socioeconomiche presenti nel suo elettorato, ha fatto della contrapposizione la ragione che motiva il popolo a perseguire la sua sovranità nei confronti di “un’élite che l’ha usurpata a suo uso e consumo”. E’ in questa contrapposizione che, a parere di Canevaro, va individuata l’origine del sovranismo della Lega, inteso come aspirazione del popolo a tornare “sovrano del proprio destino [...] contro la presunta usurpazione di questa sovranità da parte di chi non ne fa parte, o di chi fa gli interessi di entità che a questo popolo non fanno riferimento”.
Ma se il popolo, così come è stato inteso dalla Lega, è un’entità eterogenea, qual è allora la vera forza comune che lo tiene unito per conquistare la propria identità, contrapponendosi ad un’élite che l’ha usurpata? E’ qui – afferma Canevaro – che “entra in gioco l’identità nazionale, declinata in nazionalismo”; il comune denominatore del popolo leghista, malgrado la sua eterogeneità, è “la sua italianità”, espressa da tutti gli italiani che rivendicano la sovranità sul loro territorio di riferimento, “contro un’élite che veramente italiana non è”, in quanto composta da soggetti (esprimenti la classe dirigente nazionale) “i cui interessi sono allineati a quelli di un’èlite transnazionale [...] chiaramente non ‘italiana’”.
Sul successo politico della Lega molto si è detto, attraverso numerose analisi riguardanti la sua strategia elettorale, il fatto che prima di diventare partito nazionale volesse, alleandosi col “partito dei miliardari”, approfondire la divisione fra il Nord e il Sud del Paese e la fallacia della sua idea di sovranità sulla quale poggiare un messaggio politico che legittimasse atteggiamenti razzisti e xenofobi. Ciò su cui le analisi hanno “mancato il bersaglio” – a parere di Canevaro – è consistito nel trattare il nazionalismo della Lega senza considerare che esso rientrava nella categoria dei “moderni nazionalismi”.
Canevaro ritiene pertanto che nelle analisi del messaggio leghista sarebbe prevalsa una “vulgata” secondo la quale esso avrebbe acriticamente identificato il sovranismo e il nazionalismo con un ideale di omogeneità etnico-raziale, “non soltanto falsa e anacronistica, ma necessariamente escludente, xenofoba, razzista”. E’ accaduto così che il sovranismo espresso dalla Lega sia stato la “base identitaria” del suo nazionalismo, del quale razzismo e xenofobia sono state “conseguenze inevitabili”. L’identità nazionale cui si riferisce il messaggio leghista è talmente “povera” sul piano storico e culturale (proprio perché fondata su un’identità etnico-raziale), per cui è stato gioco forza che l’“italianità leghista” abbia potuto esprimersi solo in termini razzisti e xenofobi; ciò perché, “al fondo, – sostiene Canevaro – è identità vuota che non ha altro a cui appoggiarsi. E tuttavia, per quanto vuota, [ha esercitato] una grande forza di attrazione verso masse umiliate e impoverite dalle diseguaglianze”; si è trattato, quindi, di un’identità che ha creato un senso di appartenenza che è valso a rafforzare in ciascun componente il popolo leghista il mantenimento del senso di sé.
Stando così le cose, l’opposizione alla Lega deve essere allora trovata nella formulazione di “un’altra, diversa, identità italiana, che sia però anch’essa attraente per le masse popolari”, e non solo per le élite dominanti. Questo – sottolinea Canevaro – è stato il difetto che ha caratterizzato i tentativi esperiti negli ultimi anni per ricuperare il senso dell’identità nazionale: da quelli coincidenti con la celebrazione del 150° anniversario dell’Unità italiana, a quelli compiuti sulla base di “storytelling” (costruzioni narrative con scopi unicamente persuasivi) à la Berlusconi e à la Renzi; tentativi risoltisi tutti nella formulazione di identità significative per i pochi e non per i molti.
Il successo delle Lega va perciò ricondotto alla debolezza e parzialità di tali tentativi, ma soprattutto al “rifiuto della sinistra” di elaborare una versione del concetto di identità, improntata alla storia dei propri valori, nella quale tutti (masse impoverite ed élite dominanti) potessero identificarsi. La sinistra ha pensato, invece, che “di un’identità nazionale si potesse fare a meno”, lasciando libero il campo per la costruzione di tale identità alle forze politiche della destra; per questo motivo, può ben dirsi che il successo della Lega sia stato per le forze della sinistra un autogol, dovuto ai molti pregiudizi ideologici dai quali esse non sono riuscite a liberarsi.
Quale, in particolare, tra questi pregiudizi, ha motivato la sinistra a trascurare il bisogno di un’entità, qual è la nazione che, pur essendo costituita da simboli e di narrazioni non sempre coerenti tra loro, è percepita come una forza in grado di garantire sicurezza, solidarietà e coesione sociale? Sicuramente, il principale è stato – osserva Canevaro – quello di “aver qualificato la nazione come residuo tossico di un’epoca andata”, del quale era meglio liberarsi. E’ stata, questa, una posizione che ha allineato le forze di sinistra alle élite neoliberiste globaliste, avverse a qualsiasi ostacolo che potesse impedire o ritardare l’internazionalizzazione delle economie nazionali. Forze di sinistra e forze cosmopolitiche interessate hanno così spinto a considerare, soprattutto dopo la fine della Guerra Fredda, superata e obsoleta l’idea di identità nazionale.
In questo modo, però, dopo la Grande Recessione dell’economia mondiale del 2007/2008, molti Paesi ad economia di mercato e di antica democrazia si sono trovati a dover vivere una “rinnovata età” del nazionalismo, con rivendicazioni sovraniste (spesso estreme) avanzate dalla maggioranza dei propri cittadini nei confronti di entità sopranazionali ritenute responsabili, assieme alle élite nazionali, della perdita della sicurezza economica e della stabilità dei sistemi politici. Secondo Canevaro, l’errore della sinistra è consistito nel fatto d’aver conservato fideisticamente l’assunto che la lotta politica consistesse, ancora oggi, nella scelta tra “identità nazionale” e “rifiuto cosmopolita dell’identità”, mancando di cogliere che la seconda opzione “è la scelta identitaria delle élite”, che antepongono la soddisfazione dei propri interessi a quella dei bisogni della gran massa impoverita del popolo.
Certo, non è facile per la sinistra concepire un’identità del popolo alternativa a quella della Lega; un tempo le forze di sinistra hanno potuto costruirla per i gruppi sociali più deboli avvalendosi del concetto di classe, che oggi però è stato reso obsoleto dalla globalizzazione. Pertanto, è inevitabile che da sinistra si cessi di scambiare una società accogliente per “una società senza coordinate identitarie, un amalgama di individui atomizzati senza senso di sé [...], una società sfilacciata che rifiuta di immaginarsi comunità”. Le forze di sinistra avevano a disposizione le risorse per immaginare una identità nazionale aperta, tollerante ed accogliente, per opporsi all’”identità rozza, spoglia, semplicistica offerta dalla Lega”. La storia italiana è “piena” di tali risorse, idonee a consentire la concezione di un’identità nazionale in contrapposizione a quella dell’establishment di turno, pensata in funzione dello status “dei più deboli, degli oppressi, del popolo contro chi lo vuole sfruttare”, trascurando di soddisfare i suoi bisogni immediati e i suoi interessi di più lungo periodo.
Bastava che si fosse pensato – osserva Canevaro – all’Italia di Giuseppe Mazzini, “che non era certo l’Italia della monarchia sabauda, né quella del notabilato liberale. Era un’Italia immaginata come patto di popolo per emanciparsi non solo dallo straniero, ma anche [...] dalla miseria, di secoli di umiliazione, di assoggettamento”. Mazzini è stato uno dei pensatori che le forze di sinistra avrebbero fatto bene a riscoprire, perché affermava di amare la propria patria e, nello stesso tempo, riteneva che il sentimento nazionale e il cosmopolitismo dovessero convivere a livello di relazioni tra tutti popoli; era un sentimento, quello di Mazzini, inconciliabile con il nazionalismo rozzo della Lega, perché fondato consapevolezza che l’identità nazionale costituisse la coscienza storica insopprimibile di ogni popolo, dotato di tradizioni consolidate e di irrinunciabili stili di vita. Dello stesso parere era anche Antonio Gramsci che, sia pure dal suo particolare punto di vista, affermava che l’elemento nazionale e quello cosmopolita dovessero convivere, perché, se il miglioramento delle condizioni esistenziali dell’uomo doveva essere orientato verso l’internazionalismo, il punto di partenza doveva pur sempre essere nazionale, e ad esso occorreva rifarsi per perseguire nel modo più conveniente gli obiettivi sopranazionali. I pericoli più grandi per il giusto rapporto che doveva sempre esistere tra nazionalismo e cosmopolitismo era, per Gramsci, il globalismo negatore delle specificità nazionali; questo, infatti, era da considerarsi il vero e proprio pervertimento sia del sentimento nazionale che del cosmopolitismo, aperto alla fratellanza e alla solidarietà tra i popoli.
Sarebbe bastato anche che le forze di sinistra avessero pensato, al di là delle molte affermazioni retoriche, all’Italia dell’antifascismo (che da molti punti di vista si ricollegava al pensiero del Patriota genovese); l’Italia della Resistenza, di Giustizia e Libertà e del Partito d’Azione non era certo l’Italia dei fascisti, né quella della monarchia, ma le istanze democratiche dell’Italia post-fascista sono state “marginalizzate, e la rifondazione dello Stato italiano [...] ha avuto i tratti – nota Canevaro – della restaurazione dello Stato prefascista”. A dire il vero, nella Costituzione repubblicana è stata prefigurata un’altra Italia che offriva la possibilità “di immaginare una comunità nazionale democratica, aperta, votata alla giustizia sociale”, alternativa all’Italia che invece è stata realizzata. Il fatto che ciò non sia accaduto è da imputarsi – prosegue Canevaro – alla scelta della sinistra italiana di abbandonare “la battaglia per l’anima della nazione, inseguendo la chimera del rifiuto di ogni identità nazionale”.
E’ stata, quella delle forze di sinistra, una “scelta fatale, perché ha lasciato il campo aperto al trionfo ideale delle nuove destre”, ponendosi a volte nella condizione di doverne appoggiare le strategie. Occorre perciò, conclude Canevaro, che le forze di sinistra si impegnino ad immaginare un’Italia diversa da quella realizzata, in una continuità ideale con l’Italia immaginata da Mazzini e prefigurata nella Costituzione repubblicana; ovvero un’Italia che, fondata sulla democrazia e la giustizia sociale, si opponga ai soprusi delle élite dominanti.
Per un modello di imprese basato sulla centralità del lavoro

La coesistenza competitiva tra due modelli di impresa
di Nino Lisi
![]()
Sbilanciamoci!, 26 Agosto 2020 | Sezione: Lavoro, primo piano.
Landini e Pennacchi recentemente sono tornati a parlare di un modello economico che abbia il lavoro come baricentro. E ciò fa tornare attuali le riflessioni iniziate ai primi anni Ottanta in ambito Cisl ma anche nella Cgil e nella Convenzione dell’Alternativa sul capitale sociale.
Maurizio Landini, il segretario generale della maggiore confederazione sindacale di lavoratori italiana, intervistato da “La Repubblica” il 6 agosto scorso su “qual è il modello di sviluppo che proponete?”, ha risposto: “Un nuovo modello deve mettere al centro il lavoro e mettere al centro gli investimenti su sanità pubblica, istruzione – con obbligo scolastico sino a 18 anni -, deve prevedere asili nido dove non ci sono e formazione permanente. C’è da gestire la transizione ambientale e produttiva, con addio al carbone alle fonti fossili, gestire la manutenzione del territorio e trasformare cultura, turismo e storia d’Italia in elementi di crescita. Vanno fatti ripartire investimenti fisici su infrastrutture, Mezzogiorno e ferrovie ma dobbiamo anche dotarci di una rete digitale che non abbiamo. E serve un ruolo pubblico che indirizzi investimenti ed indichi le priorità a partire dalla mobilità sostenibile”.
 Difficilmente si sarebbe potuto dire di più e meglio in poche battute per delineare un orizzonte che richiama chiaramente quello descritto da Laura Pennacchi nel libro collettaneo Lavorare è una parola (Donzelli 2020, pag. 214.€ 15,00). Trattando de “Lo Stato nell’economia e nel Lavoro” e delineando una funzione strategica dello Stato nell’economia, Laura Pennacchi propone “una strategia volta a porre le basi di un nuovo modello economico creando direttamente lavoro” (pag. 234). E caratterizza il nuovo modello come quello “in cui gli interrogativi sul “per chi, cosa, come produrre trovano risposta anche in una innovazione piegata a soddisfare domande sociali”. Coerentemente raccomanda di puntare “senza negare l’importanza delle esportazioni sulla domanda interna e sui consumi collettivi” il che consentirebbe per altro di allargare lo spettro delle produzioni, di aprire nuovi campi di ricerca, di sviluppare nuovi bisogni”. Un modello capace di recuperare l’ispirazione autentica dei Piani di Lavoro del New Deal di Roosevelt e farne “non una misura che si aggiunga alle altre” ma “il baricentro dell’intera politica economica”, il pilastro di una “politica della speranza” opposta ad una “politica della paura”.
Difficilmente si sarebbe potuto dire di più e meglio in poche battute per delineare un orizzonte che richiama chiaramente quello descritto da Laura Pennacchi nel libro collettaneo Lavorare è una parola (Donzelli 2020, pag. 214.€ 15,00). Trattando de “Lo Stato nell’economia e nel Lavoro” e delineando una funzione strategica dello Stato nell’economia, Laura Pennacchi propone “una strategia volta a porre le basi di un nuovo modello economico creando direttamente lavoro” (pag. 234). E caratterizza il nuovo modello come quello “in cui gli interrogativi sul “per chi, cosa, come produrre trovano risposta anche in una innovazione piegata a soddisfare domande sociali”. Coerentemente raccomanda di puntare “senza negare l’importanza delle esportazioni sulla domanda interna e sui consumi collettivi” il che consentirebbe per altro di allargare lo spettro delle produzioni, di aprire nuovi campi di ricerca, di sviluppare nuovi bisogni”. Un modello capace di recuperare l’ispirazione autentica dei Piani di Lavoro del New Deal di Roosevelt e farne “non una misura che si aggiunga alle altre” ma “il baricentro dell’intera politica economica”, il pilastro di una “politica della speranza” opposta ad una “politica della paura”.
Il quadro di questo nuovo modello si completa con l’indicazione – data dallo stesso Landini in un’intervista televisiva solo di qualche giorno fa – del sindacato come presidio e garanzia di libertà nel posto di lavoro e fuori di esso non soltanto per il lavoro dipendente ma per tutto il lavoro.
Quella che viene proposta dalla Cgil dunque, come da chiunque – e sono molti in questi giorni – sostiene la necessità di un modello nuovo dell’economia, è una trasformazione economica e sociale assai profonda del Paese e dello stesso sindacato. Alcuni decenni fa per esprimere la qualità e le dimensioni della trasformazione auspicata si sarebbe parlato di riforme di struttura per non usare un termine più esplicito da cui si rifuggiva perché delle parole si può aver paura.
Comunque lo si chiami bisogna avere e dare contezza della imponente sfida che si ha dinanzi proponendo di cambiare modello di società e di economia.
Il primo interrogativo da porsi riguarda il modello di impresa che occorra per realizzare una politica economica che abbia nel lavoro il suo baricentro. Non voglio addentrarmi nella diatriba sulla possibilità o meno che il capitalismo si riformi e di quanti siano i capitalismi esistenti. Vorrei solo provare a trovare una risposta alla domanda posta. Ritengo che l’impresa votata al profitto ed alla sua massimizzazione non rappresenti il modello adatto e provo a spiegarlo. Il profitto si forma e si calcola per sottrazione dei costi di produzione dai ricavi. Minori sono i costi più alto è il profitto e viceversa. Taluni costi sono pressoché incomprimibili, come quelli delle materie prime, dei semilavorati, delle fonti energetiche, etc. Anche i contributi, le imposte e le tasse lo sarebbero se non si facesse troppo spesso ricorso alla elusione e alla evasione. Il lavoro invece è comprimibile sia perché è sostituibile con le tecnologie, sia perché si può riuscire in vari modi a pagarlo meno. Mi sembra quindi evidente che sia inverosimile che un’impresa votata al profitto possa porre il lavoro al centro della propria organizzazione ed attività
Altrettanto inverosimile sarebbe immaginare un’economia senza imprese volte al profitto, tanto più in democrazia. Se quindi si vuole puntare ad un modello economico che “deve mettere al centro il lavoro” non c’è che ricorrere ad un’economia a doppio binario, ovvero con un duplice sistema di imprese: uno di quelle che assumono la centralità del lavoro e l’altro di quelle che assumano come centrale il profitto. Ambedue connessi in una sorta di coesistenza competitiva.
Una stravaganza ferragostana in tempi di coronavirus? Ma no. Imprese non votate al profitto ci sono sempre state. E ci sono. Soltanto che sono tra loro sconnesse e non hanno rilievo.
Quando nel 1983 cominciava ad essere chiaro che il sistema delle imprese non avrebbe più assicurato alti livelli di occupazione e Pierre Carniti lanciò l’idea del prelievo dello 0,5% dei salari, proprio su di un modello di imprese che assumessero come centralità il lavoro e venne imperniato un progetto messo a punto, nella sede nazionale della Cgil in corso d’Italia a Roma, sotto l’egida del Coopsind, da un gruppo di lavoro coordinato da Silvano Levrero. I lavori iniziarono ai primi di gennaio e si conclusero a maggio di quell’anno. Fu prevista la nascita di un “Fondo di Investimenti dei Lavoratori” sull’esempio dei primi Fondi Comuni di Investimento che si andavano formando in quel periodo. Avrebbe dovuto raccogliere il prelievo su base volontaria dello 0,5% dei salari per finanziare la creazione di nuove imprese autogestite, con le quali apprestare su tutto il territorio nazionale una risposta concreta alla richiesta di occupazione e promuovere un’economia fortemente legata ai singoli territori. Il progetto prevedeva anche apposite strutture tecniche in grado di assicurare la progettazione di imprese e la loro assistenza alle start up. A questo riguardo fu anche riservatamente esplorata la disponibilità dell’Eni a supportare il progetto con lo staff dell’Indeni, una finanziaria di sviluppo che si cimentava con il ricollocamento al lavoro, mediante la creazione di nuove imprese, delle maestranze espulse da aziende private in dissesto.
Il progetto venne trasmesso dal presidente del Coopsind, Mario Zigarella, alla segretria confederale della Cgil nel maggio del 1983 e a settembre di quell’anno fu presentato al Convegno che la Cisl tenne al Castello Giusso di Vico Equense in provincia di Napoli sul tema “Fondo di Solidarietà. Una scelta per il Lavoro e lo Sviluppo”. In quella sede si poté constatare che fra il progetto della Cgil e quello della Cisl c’erano molte coincidenze e la medesima ispirazione.
Nessuno dei due Fondi però ebbe vita, perché sulla prospettiva di allentare la presa del Capitale sul Lavoro prevalsero la ritrosia ad effettuare un prelievo sui salari, ancorché su base volontaria e in misura pressoché irrilevante, e la preoccupazione che il sindacato, esorbitando dalle consuete proprie funzioni di tutela, potesse snaturarsi.
Una nuova occasione per riproporre lo sviluppo di imprese che assumessero la centralità del lavoro si presentò esattamente vent’anni dopo, con la crisi dell’area industriale di Marghera.
Negli ambienti della nuova sinistra si pensò di organizzare un convegno da tenersi a Venezia per dibattere su come affrontare il problema del lavoro nelle aree di crisi. Era la sera dell’8 novembre del 1993 quando, in una stanza della redazione de il manifesto, che all’epoca era in via Tomacelli, venne discusso e approvato da un apposito gruppo di lavoro quella che avrebbe potuto essere la relazione di base del convegno. Si era ripromessa di promuoverlo la “Convenzione per l’Alternativa”. Preso atto del passaggio d’epoca in atto e della problematicità con cui si presentava l’occupazione della “forza-lavoro”, il documento sosteneva che non si sarebbe dovuto più lasciare al capitale “l’iniziativa e l’onere di assorbire la forza-lavoro nei suoi cicli produttivi e distributivi in base alla propria logica, ai propri meccanismi di accumulazione, al proprio modo di produzione, ai propri modelli di consumo”, ma che era giunto il momento in cui “le soluzioni che il capitale non è capace di mettere in campo devono essere perseguite per altre vie, dandosi carico di coprire in proprio, ma con una diversa logica, con diversi modelli, con la propria struttura di valori, gli spazi che l’avversario non è in grado di coprire e di gestire o non ha interesse a farlo. Non si tratta – proseguiva il testo – di sostituirsi all’avversario. Si tratta di passare da una coesistenza subalterna (tra lavoro e capitale) ad una coesistenza competitiva” tra due sistemi di imprese.
Il convegno non si tenne per una sopravvenuta crisi di governo che spostò l’attenzione e le tensioni su altri temi. Ma molte cose erano frattanto avvenute. L’onda del neoliberismo aveva investito anche diversi settori della sinistra. Non pochi di essi nutrirono l’illusione di poter cavalcare la “globalizzazione buona” e promuovere la “globalizzazione dei diritti”. Con il duplice risultato del dissolvimento della sinistra, allontanatasi dall’ottica dei lavoratori, e dell’impoverimento dei diritti del lavoro.
A dimostrazione che l’esigenza di un diverso approccio al tema del lavoro permane, al di là dei cambiamenti di epoca e di fase, l’argomento fu riproposto dodici anni dopo da A.R.C.O., Associazione per la Ricerca e la Comunicazione, guidata dal professor Giovanni Battista Montironi, docente di Sociologia del lavoro all’Università degli Studi di Perugia. Montironi, scomparso purtroppo di recente, aveva curato la ristrutturazione organizzativa dell’Alfa Romeo di Arese mostrando che le nuove tecnologie, se favorivano il Capitale riducendo i suoi fabbisogni di lavoro, fornivano però, al Lavoro, l’occasione di modificare a proprio vantaggio i rapporti di forza in fabbrica. Tanto è vero che la Fiat, appena entrata in possesso dello stabilimento di Arese, eliminò la riorganizzazione di Montironi, pur avendone in precedenze adottato nelle proprie scuole per la formazione dei dirigenti, il testo in cui se ne dava conto.
A.R.C.O. presentò le proprie “Idee per un Programma Politico” il 28 ottobre del 2005, ospite nel salone in via Ostiense 152/b della Comunità di Base di San Paolo, sorta da tempo per la spinta profetica di Giovanni Franzoni, già padre conciliare e abate della Basilica di S.Paolo. Pure le “idee” di A.R.C.O. non ebbero però seguito.
Ultimo in ordine di tempo a rilanciare il tema di un modello di impresa che ponesse il lavoro al centro della sua organizzazione è stato il compianto professore Bruno Amoroso, economista dell’Università di Roskild (Danimarca) con il suo Centro studi Federico Caffè di Roma.
Illustrò il progetto sul numero 2 del 2011 della Rivista Giuridica della Cgil sotto il titolo “Lavoro e Redditi – Dagli Ammortizzatori Sociali a Nuove Forme di Organizzazione Economico Sociale”, nel quale sosteneva che la disoccupazione aveva ormai carattere strutturale e che quindi risultava inadeguato il sistema esistente di ammortizzatori sociali, concepito per far fronte agli effetti transitori della congiuntura economica. Per affrontare la disoccupazione di carattere strutturale doveva quindi porsi mano alla creazione di posti di lavoro e a tal fine si sarebbe dovuto ricorrere a “nuove forme di organizzazione economico sociale”, in altri termini si sarebbe dovuto ricorrere ad un modello di imprese che assumessero la centralità del lavoro e portare a sistema il gran numero di imprese esistenti che non facevano del profitto la propria funzione obiettivo. E sono davvero molte le imprese con questo requisito: sono le imprese sociali, quante costituiscono quello che secondo alcuni sociologi ed economisti costituirebbero il cosiddetto capitalismo molecolare che, secondo altri loro colleghi, di capitalistico avrebbero poco o niente. Sono ancora le organizzazioni produttive promosse dalla imprenditoria che Angelo Detragiache definì popolare, sorta per lo più da “spin-off “di imprese ristrutturatesi esternalizzando fasi del proprio processo produttivo o taluni servizi. Sono un’infinità. Non riescono a fare sistema in mancanza di una politica che le sostenga e, così frammentate, restano spesso subordinate, come anche lo sono molte volte alcune forme di lavoro autonomo, alle imprese di tipo capitalistico, quasi alla pari del lavoro dipendente, senza averne però le garanzie, da esso conquistate con le lotte.
Il progetto prevedeva tra l’altro anche la costituzione di un “Fondo Solidale per l’Occupazione”. Si trattava, insomma, dello stesso impianto, ovviamente aggiornato, del progetto del Coopsind del 1983, che non a caso venne citato nel seminario svoltosi nel salone Di Vittorio della sede nazionale della Cgil per illustrare il progetto. Pure quella volta non vi furono sviluppi.
Ora però l’esigenza di un nuovo modello economico, di cui tanti parlano in questi giorni, anche se chiamandolo secondo me impropriamente di sviluppo, e sulla quale autorevolmente insiste molto Maurizio Landini, rende improcrastinabile che ci si renda conto e ci si responsabilizzi del fatto che un nuovo modello economico richiede imprescindibilmente di sottrarre il Lavoro dalla subordinazione al Capitale, sviluppando e portando a sistema il modello di impresa nel quale il Lavoro come funzione obiettivo si affianchi in una proficua coesistenza competitiva nell’impresa avente il profitto come funzione obiettivo.
Che a promuovere lo sviluppo di “formazioni economico sociali” di questo tipo sia il sindacato o siano altri soggetti sotto la spinta di forze politiche che ritrovino nel Lavoro il loro principale riferimento, o ambedue, non importa. Un dato, però, appare certo: senza che il Lavoro entri nello scenario economico come soggetto non subalterno ad alcuno, non vi sarà alcuna riconversione né ambientale né sociale di alcuna economia.
——————-
Lavorare meno un antidoto alla crisi? Le proposte di Germania e Finlandia
di Michele Pignatelli
Sbilanciamoci!, 27 Agosto 2020 | Sezione: Lavoro, Nella rete
Lavorare meno per lavorare tutti, con più produttività. Le proposte di IG Metall e della premier finlandese riportano di attualità il dibattito. Da Il Sole 24 Ore.
[segue]
Quel vento forte di Maestrale che soffia sui Monti di Mola e non tutto cancella.
 Ma nudda si po’ fâ nudda in Gaddura che no lu énini a sapi int’un’ora
Ma nudda si po’ fâ nudda in Gaddura che no lu énini a sapi int’un’ora
di Daniele Madau
“Non basta incidere su una pietra il nome Costa Smeralda per cancellare la memoria di Monti di Mola. Costa Smeralda è nome d’acqua e viene dal mare, dice di un colore e di un approdo. Monti di Mola è voce che risuona nell’oralità del tempo, rimbalza sulla cresta delle rocce, sprofonda nell’abisso della valle, s’interra nelle radici dell’olivastro. E’ nome di terra, nato dalla qualità della pietra con cui si facevano le mole per macinare il grano e per affilare le lame dei coltelli”.
![]()
Sapevo che per parlare della Costa Smeralda – Monti di Mola, quando era solo terra di lavoro, più bella delle altre, però – o meglio, per esprimere il mio stato d’animo a riguardo della crisi sanitaria, le parole più adatte sarebbero state quelle dell’antropologo Bachisio Bandinu, che alla nascita di Porto Cervo e dei suoi corollari ha dedicato tanta parte della sua produzione: precisamente del suo romanzo L’amore del figlio meraviglioso .
Come il corona virus, anche il principe Aga Khan era venuto dal mare, con la sua visionarietà dovuta all’avere la mente libera, al non dover portare al pascolo le greggi e le mandrie, proprio come nella Grecia antica, dove tutto il lavoro manuale ricadeva sugli schiavi, e solo i liberi cittadini potevano dedicarsi alla cultura e alla politica.
Del resto, anche in Lombardia, in Italia, il virus è arrivato da fuori, da lontano: tutti noi, quindi, abbiamo potuto sperimentare il senso di violazione, di aggressione dell’intimità da parte di un agente alieno, esogeno, contro il quale non ci siamo potuti, o non abbiamo voluto, difenderci.
Si potrebbe pensare allora, potremmo pensare noi, sardi, che ora sia più forte l’empatia col Veneto, la Lombardia, l’Emilia, le regioni che maggiormante hanno sofferto nell’ondata epidemica di inizio primavera. Ma non ce n’era bisogno: l’empatia – spesso – sembriamo averla maggiormente verso gli altri che tra di noi, caratterizzati come male unidos dagli spagnoli, sia che l’avesse detto Carlo V che monsignor Antonio Parragues de Castillejo.
Eppure c’è una differenza tra i casi del nord e quello della Costa Smeralda; anzi, a ben vedere, due.
Non si vuole negare la sofferenza per quanto accaduto nelle altre regioni – non sarei degno di scrivere neanche una riga, nel caso – ma esprimere il disagio nel sentire ancora della Sardegna masticata nella bocca dell’informazione come del lontano pseudo–esotico in cui si annida un lato oscuro, diverso, non assimilabile dal resto d’Italia. Ancora. Come in tutto il novecento.
Non solo; questa volta, in più, c’è il fattore lusso e sbruffonaggine, ignoranza e imprenditoria d’assalto, che da ammaliatore e conquistatore del granito e della macchia mediterranea dei paesaggi galluresi, è diventato esportatore d’infezione. Sembra che solo in questo la Sardegna sia diventata esportatrice.
Non si vuole fare, ora, un’analisi politica: per quella serve la lucidità. Solo dare possibilità, ripeto, al disagio di manifestarsi, così da renderlo, forse, catartico.
Disagio, perché, al di là di tutto, dei soldi e dei posti di lavoro (sono cosciente della forza, e forse gravità, di quello che scrivo ma, se servirà, si potrà argomentare meglio), il “Sottovento”, il “Billionaire” e gli altri, sono una cicatrice, un grumo di sangue nero che il maestrale gallurese non è riuscito a cancellare e, forse, mai lo farà.
E’ questo il disagio: si parla di Sardegna ma, è chiaro, Sardegna non è. Non lo è nei nomi, nelle attività vagheggiate e realizzate, nelle relizzazioni architettoniche, nell’approccio ai rapporti umani e alla natura. Io non so se l’epidemia da noi si sarebbe mai diffusa senza i locali di Briatore e degli altri imprenditori, so solo che quella non è la mia Sardegna, né quella di Fabrizio De André (di cui avrete riconosciuto i versi prestati al titolo: ‘Niente si può fare in Gallura, che non si sappia entro un’ora’. Parlava dell’amore scandaloso tra un’asina e un uomo. Anche se puro, il potere lo impedì. Anche lì, purezza perduta), né quella dei protagonisti del romanzo di Bandinu.
Nel rimarcare il massimo rispetto e vicinanza umana ai lombardi, e a tutti gli altri, credo che solo noi sardi avremmo potuto vagheggiare sulla Gallura. Non l’abbiamo fatto, nostra culpa: paghiamo ancora il peccato originale dell’aver accolto, nuovi Montezuma, il principe ismaelita. Ma, come scrisse un altro autore, il più importante della storia delle letterature universali, ‘Non le farà sì bella sepultura, la vipera che Melanesi accampa, com’avria fatto il gallo di Gallura’ (La vipera che costituisce lo stemma dei Milanesi non ornerà il suo sepolcro così bene, come avrebbe fatto il gallo di Gallura, Purgatorio, canto VIII)
America, America


GLI ITALO-AMERICANI, DA WOPS A WASP TRUMPISTI
di Marino de Medici
L’ultimo in ordine di tempo a rinnegare le radici democratiche degli italo-americani è il Postmaster General degli Stati Uniti, Louis DeJoy, che si è messo in luce come fedele esecutore della volontà del presidente Trump di sabotare il voto per posta.
Mr DeJoy è uno dei tanti italiani emigrati in America che hanno cambiato nome per cancellare la loro provenienza italiana. Il bisnonno paterno si chiamava Luigi De Gioia, nato in Italia nel 1875 ed emigrato in America. Il figlio era un meccanico che si fece strada nel campo dei trasporti privati. Louis DeJoy ebbe l’abilità di moltiplicare i profitti di quell’attività. Da buon miliardario repubblicano, contribuiva con un’ingente donazione alla campagna elettorale di Donald Trump. La nomina a Postmaster General era la ricompensa. In quell’incarico, l’oriundo De Gioia procedeva ad azzoppare il sistema postale ai danni di tutti quegli americani che contano sulle poste per ricevere, in aggiunta alle schede di voto, le medicine inviate per posta da consegnare in tempo utile. In pratica, il miliardario italo-americano oggi partecipa attivamente al piano di Trump volto a sopprimere il maggior numero possibile di voti postali che egli sospetta favoriscano il partito democratico.
Il caso di De Gioia è sintomatico di un fenomeno storico, quello della trasformazione di una massa di immigrati, con una maggioranza di poveri e analfabeti provenienti dal derelitto Mezzogiorno, in una minoranza etnica con caratteristiche WASP (bianca e anglosassone), in altre parole affluente. La vera ragione di tale trasformazione, evidente nelle ultime generazioni italo-americane, è però un’altra. Gli italo-americani dei giorni nostri non hanno più bisogno delle loro radici. Di fatto, le hanno rimpiazzate con nuove radici americane. Contrariamente ai loro padri, non lottano per entrare a far parte dell’establishment. Ora sono l’establishment. I De Gioia e tanti altri avevano cambiato nome perché al loro arrivo nutrivano vergogna per il loro nome italiano e di conseguenza rinnegavano la loro eredità di sangue. Di fatto, rinnegavano i connazionali sbarcati in America con le valigie legate con lo spago, sottoposti sin dagli inizi ad un trattamento ostile, da Ellis Island al porto di New Orleans, i derelitti che avevano trovato rifugio nelle organizzazioni sociali che promuovevano l’assimilazione degli immigrati.
Tra queste si distingueva la ILGWU (il sindacato dei lavoratori della moda) capeggiato da Luigi Antonini, una roccaforte democratica con forte ascendente socialista di spirito europeo. Gli italo-americani erano devoti sostenitori del New Deal rooseveltiano. E’ stato osservato che nel giro di due generazioni gli italiani d’America sono passati da Wops – il termine dispregiativo che li bollava come elementi indesiderabili – a WASP.
Agli inizi del ventesimo secolo, l’elite anglosassone era decisa a porre fine al pericoloso afflusso di immigranti che “inquinavano” la pura razza bianca. Nel 1924, quando la percentuale di immigrati era poco al disotto del 15 per cento, il Congresso approvava la legge Johnson-Reed che imponeva quote all’immigrazione. Quella italiana veniva colpita a fondo. Scopo proclamato della legge immigratoria era quello di “preservare l’ideale di omogeneità degli Stati Uniti”.
Passiamo ai giorni nostri, quando governa un’amministrazione repubblicana che ha pratica una politica migratoria che molti non esitano a definire crudele. Incredibile ma vero, tra i funzionari governativi incaricati di mettere alla porta i migranti illegali e clandestini, dopo averli rinchiusi in centri di penosa detenzione e negando loro ogni possibilità di asilo, figurano i discendenti degli immigrati italiani.
Matthew Albence, nipote di Bernardino, è stato direttore dell’ICE (Immigration and Custom Enforcement) ma verrà ricordato per il duro trattamento riservato agli immigrati al punto che è passata alla storia una sua dichiarazione dinanzi ad una commissione congressuale in cui paragonava gli indecenti centri di detenzione delle famiglie illegali a “campi di vacanza”. Albence si è dimesso alla fine di luglio dopo una carriera di funzionario addetto a reprimere l’immigrazione illegale.
Albence era in buona compagnia, in quanto un altro oriundo italiano ricopriva un simile incarico presso il Department of Homeland Security, creato all’indomani dell’11 settembre con funzioni di “pubblica sicurezza”, simili a quelle di un ministero dell’interno europeo. Ken Cuccinelli, vice direttore dell’ente, si era distinto per la sua fede ultra-conservatrice, che lo portava ad osteggiare qualsiasi politica tollerante degli immigrati illegali. Cuccinelli, pronipote di un immigrante italiano analfabeta di nome Luigi, si era messo in luce come Attorney General della
Virginia per la sua fanatica opposizione al matrimonio omosessuale ed alla scienza dedicata al cambio del clima, al punto di accusare di frode gli scienziati impegnati in quegli studi. Della sua feroce opposizione all’immigrazione si ricorda ormai una frase odiosa con cui derideva il famoso poema di Emma Lazarus, simbolo della libertà per gli immigrati. Cuccinelli alterava il poema con vile sarcasmo: “Datemi le vostre genti stanche e i vostri poveri che non riescono a reggersi su due piedi”.
Siamo di fronte insomma ad una straordinaria ironia. Gli italo-americani chiamati dal Presidente Trump a sbarrare le porte dell’America all’immigrazione appartengono alla terza generazione degli immigrati sbarcati in America e vittimizzati dalla elite WASP.
E’ superfluo aggiungere che ora sono tutti ferventi repubblicani, nell’orbita di Donald Trump. Nel fitto stuolo di italo-americani dalle credenziali trumpiste si distingue il segretario di stato Mike Pompeo, pronipote di emigrati originari di Pacentro (Abruzzo). Pompeo verrà ricordato per il suo avvilente attaccamento alla causa di Donald Trump e per il suo completo disinteresse a servire la causa degli interessi nazionali. Il tratto che contraddistingue Pompeo è la sua incapacità ad agire da consigliere presidenziale ed a frenare gli impulsi di un presidente che decide in base ad istinti viscerali senza chiedere od accettare consigli. L’unica preoccupazione
di questa deplorevole figura di capo della diplomazia americana è in apparenza quella di non intralciare in modo alcuno il vanitoso e imprevedibile comportamento del presidente, nell’intento di conservare il posto. E’ notorio infatti che Trump ha licenziato in tronco una miriade di funzionari, tra i quali il predecessore di Pompeo, Rex Tillerson, fatto fuori con un tweet.
Da pervicace servitore del presidente, Pompeo ha lavorato contro l’Unione Europea, le alleanze tradizionali dell’America ed il multilateralismo. Il suo “stile” diplomatico, ispirato al confronto ed al rigetto di ogni compromesso, ha portato gli Stati Uniti ad esercitare una politica fallimentare nel Medio Oriente, con il pericolo di uno scontro con l’Iran e con l’asservimento di principi e valori americani alla protervia del principe saudita Mohamad Bin Salman. Mai prima d’oggi un segretario di stato americano aveva preso le parti di un monarca arabo fino al punto di negare il suo convolgimento nell’assassinio del giornalista della Washington Post Jamal Khashoggi. Ed infine, Pompeo si è guardato bene dal ricorrere al suo stretto rapporto con il presidente al fine di portare sotto controllo l’ingerenza politica di Rudi Giuliani nelle esplosive relazioni con l’Ucraina. Anche in tema di immigrazione, Pompeo si è schierato a favore di dure misure punitive, mirate a bloccare un accesso legale alla cittadinanza ed il rilascio di immigranti illegali a basso rischio.
Tali e tante sono le ambizioni di Mike Pompeo che il segretario di stato non si è sottratto alla convenienza di portare acqua al mulino del presidente con un peana a Trump registrato sul tetto di un palazzo a Gerusalemme e proiettato nel corso della convenzione repubblicana. Si è trattato di violazione di una precisa legge – lo Hatch Act – che vieta a funzionari federali di fare politica interna.
A conti fatti, sono molti a ritenere che Mike Pompeo passerà alla storia come il peggiore segretario di stato dell’ultimo secolo.
La poco edificante storia del contributo degli italo-americani al deterioramento della politica negli Stati Uniti e, quel che peggio, della loro missione stabilizzatrice nel mondo ha molti protagonisti transfughi dalle file democratiche verso quelle repubblicane. La concentrazione di italo-americani ultra-conservatori è ormai tale che i pochi personaggi democratici attivi in politica (segnatamente lo Speaker della Camera Nancy Pelosi ed il governatore dello stato di New York Andrew Cuomo) non alterano il deprimente quadro della metamorfosi pro-repubblicana della
maggioranza degli italo-americani. Tra questi si distinguono due giudici della Corte Suprema: il primo giudice italo-americano Antonin Scalia, un agguerrito conservatore nominato dal presidente Ford e morto nel 2016, ed il Giudice Samuel Alito, nominato da George W. Bush, autore tra l’altro di una tesi sulla Corte Costituzionale italiana.
Alito è associato alla giurisprudenza di destra spinta ed è giudicato negativamente dallo ACLU (American Civil Liberties Union) per le sue sentenze avverse ai diritti e alle libertà civili.
Rudi Giuliani, noto come il sindaco di New York all’epoca della distruzione delle due torri, è un capitolo a parte. Originariamente, era un democratico, sostenitore del presidente Kennedy e addirittura di George Mc Govern. Divenne repubblicano nel 1980. Fu una conversione rapida che lo portò agli estremi del conservatorismo americano. La sua posizione circa l’immigrazione è quanto meno curiosa. Nel 1996, denunciò il governo federale per aver adottato pratiche anticostituzionali ai danni dei migranti. Nel 2006 si dichiarò favorevole ad un progetto dilegge senatoriale di immigrazione che prevedeva uno sbocco in termini di cittadinanza ed esprimeva appoggio all’idea di un aumento dell’immigrazione legale. Col passar del tempo, la sua posizione mutava a favore di una politica fortemente conservatrice abbracciando la filosofia giuridica dei giudici Scalia, Alito e Thomas. Il voltafaccia di Giuliani coincideva con il suo passaggio al servizio del presidente repubblicano e la sua difesa del tentativo di Trump di usare gli ucraini per diffamare Joseph Biden. Donald Trump premiava il suo ruolo di fedelissimo concedendogli uno spezzone oratorio nella convenzione repubblicana.
Rudi continua a svolgere un ruolo misterioso e apparentemente illegale per proteggere sia il presidente sia i propri oscuri interessi finanziari. Il valore di Giuliani per Trump è nel
parallelismo della politica di lotta alla criminalità, al tempo in cui Rudi era sindaco di New
York, con la strategia di “law and order” alla quale si appella il presidente nella campagna
per la rielezione.
Lo sconcertante capitolo storico che vede gli italo-americani plagiati dal trumpismo, una forma di governo autoritario e velleitario che è agli antipodi delle radici liberal-democratiche degli immigrati italiani nello scorso secolo, sciorina un gran numero di personaggi che tra gli altri includono: l’avvocato della Casa Bianca Pat Cipollone, il governatore della Florida Ron De Santis, il Minority Whip della Camera Steve Scalise, il ministro del Lavoro Eugene Scalia (figlio del Giudice Antonin Scalia). A questi va aggiunto Anthony Scaramucci, che ha ricoperto per un bravissimo periodo l’incarico di direttore delle comunicazioni della Casa Bianca, un faccendiere portato alla polemica fino alla provocazione. Non sorprende che gli uomini di Trump lo abbiano rapidamente estromesso. Attualmente Scaramucci è impegnato a “salvare il partito repubblicano” esortando i suoi elettori a votare per Biden. Infine, nella fazione dei trumpisti rientra un altro italo-americano, l’ex senatore repubblicano della Pennsylvania Rick Santorum, il cui nonno Pietro emigrò in America da Riva del Garda nel 1920. Santorum è stato senatore dal 1995 al 2007 ed aspirante alla candidatura presidenziale nel 2012 e 2016. La sua carriera politica di conservatore sociale era fondata sull’opposizione all’aborto ed al matrimonio
omosessuale. In particolare, Santorum ha promosso in varie sedi la teoria anti-evoluzionista dell’intelligent design. Alleato con Trump, ha costantemente inveito contro l’immigrazione illegale, avversando l’amnistia e la concessione di benefici federali ad immigrati illegali.
Resta in fondo un quesito cui è difficile rispondere, quello del perché della sottomissione degli italo-americani ad un uomo, Donald Trump, che nulla ha fatto per loro salvo che far leva sull’abbraccio tipicamente italiano ad un politico forte. Nella storia degli italo-americani c’è sempre stato un sostrato di risentimento, a partire da quel fatale giorno – il 14 Marzo 1891 – in cui undici italiani vennero linciati a New Orleans per l’assassinio del capo della polizia
locale, senza alcun riguardo al fatto che alcuni di essi erano già stati assolti in un processo. Il presidente Benjamin Harrison, ansioso di calmare gli animi degli immigrati italiani e di scongiurare un conflitto con l’Italia, che a quel tempo disponeva di corazzate in grado di bombardare la costa americana, proclamò la giornata celebrativa di Colombo. Particolare interessante: in un momento in cui le statue di Colombo in America vengono abbattute, Trump ha dichiarato a proposito della festività: “Per me, sarà sempre chiamato Columbus Day. A molti può non piacere. A me si”. Se il calcolo di Trump era quello di ricordare agli italo-americani che per un secolo o giù di lì erano stati una classe oppressa, la decisione di una massa di italo-americani di sostenerlo significa che quello sforzo è andato a buon fine. Ma il risultato non è confortante perché l’abbraccio a Donald Trump approfondisce le divisioni etniche e razziali che turbano il panorama politico e culturale dell’America contemporanea. Un’altra conclusione non può che essere questa: in una congiuntura in cui gli italo-americani – che un tempo non venivano neppure raggruppati nella razza bianca – hanno raggiunto lo status di WASP ricchi o benestanti, è fuori luogo parlare di “orgoglio etnico”. Ma è preoccupante che da poveri che erano gli oriundi italiani siano ora indifferenti al grido di dolore delle vittime del razzismo e della diseguaglianza sociale ed economica. La loro metamorfosi da Wops a Wasp sarà anche storica, ma non fa onore a tutti coloro, dagli anarchici ai democratici, che si erano battuti per l’assimilazione nel vecchio schema socio-politico del “melting pot” ossia del crogiolo, superato ormai dalla trionfante diversità di una nuova America al prezzo di una crescente polarizzazione. In ultima analisi, sono questi gli elementi che spiegano il trumpismo assai poco democratico di tanti italo-americani.
Referendum. Campagna per il NO.

Meno parlamentari vuol dire più efficienza democratica?
di Nino Labate*
Pensiamola come vogliamo: votiamo SI o votiamo NO, avviciniamoci con disquisizioni costituzionali o di schieramento, rimaniamo in attesa di una legge elettorale variabile di volta in volta a seconda delle convenienze; ma nel fondo del bicchiere rimane solo una questione di ragionevole buon senso. Che è anche un elementare principio depositato nelle radici della democrazia e nella sua stessa etimologia. Un principio in un certo senso intuitivo, praticato dunque sin dall’antica Grecia: la democrazia cresce e s’irrobustisce, diventa più rappresentativa, più seria e rispettosa delle diversità, solo quando il numero dei rappresentanti presenti in Assemblea cresce, e non quando diminuisce! E diventa più veritiera e difende il pluralismo, solo quando viene permessa una costruttiva, anche se lunga e noiosa, discussione. Con tante grazie all’efficienza.
Ci stiamo ubriacando dell’efficienza. Della velocità. Della rapidità. Un fordismo neofuturista anche con l’essere intransigenti sulla data referendaria, che con il concorso della tragedia pandemica e benché in concomitanza con alcune elezioni regionali, vedrà una presenza al voto ridotta ai minimi termini. E stiamo assimilando il Parlamento italiano a una catena di montaggio che produce birilli e robot, orientata da un taylorismo d’antan.
L’idea di democrazia nascosta dietro la vittoria del SI è un’idea elitaria, modello “meno siamo meglio stiamo”, con l’aggiunta che in pochi si governa meglio senza essere disturbati. Perché ancora una volta stiamo semplificando la complessità e la funzione di un’istituzione centrale riducendola solo ai numeri e alle quantità. Quando sappiamo bene che i numeri e le quantità, presi da soli e se sono proprio questi i colpevoli, si possono governare e gestire con nuove regole e procedure.
Quando si dice che i deputati del nostro Parlamento passeranno da 945 a 600, nessuno ha il coraggio di aggiungere che così votando avremo 1 deputato ogni 150 mila abitanti circa, e un senatore ogni 302 mila. Sarà una democrazia di lontananza e non una democrazia di prossimità. Sarà una democrazia di sconosciuti e di ignoti, dal momento che i nostri rappresentanti saranno lontani dai nostri territori e dalle nostre città, e i cui nomi conosceremo soltanto sulla scheda elettorale al momento del voto. E, se e quando andremo a votare, li voteremo senza neanche sapere chi sono. Caso mai aiutati dalla Rete virtuale della piattaforma Rousseau, con il vago sospetto che la proposta sia stata fatta proprio con queste intenzioni.
Non penso che sia un peccato approcciare ragionevolmente i numeri della rappresentanza, rivedendo il bicameralismo paritario, con nuovi regolamenti e quant’altro. Diventa “peccato” quando, come sta succedendo, questo approccio critico si fa al buio, e con un secco colpo di mannaia, senza collocare questo brusco taglio di parlamentari all’interno di una riforma organica e di sistema, di nuove regole, di nuovi equilibri fra Centro e Periferia, scommettendo per i necessari aggiustamenti solo su prossimi anni.
Mi auguro di sbagliare, ma se sembra scontato che andrà a votare come in tutti i referendum – Covid permettendo e Regionali che addirittura potrebbero aiutare – una netta minoranza degli aventi diritto, e il SI vincerà con netta maggioranza percentuale di questa minoranza, alla fine la riforma sarà approvata da molto meno, del 30/40% di cittadini italiani. Auguri. Io voterò NO!
![]()
*Nino Labate
25 Agosto 2020 by Giampiero Forcesi | su C3dem.
————————–

Considerazioni semplici.
di Franco Meloni.
Dopo i giorni terribili del lockdown riprendiamo a incontrarci tra amici in qualche serata conviviale. Vietate le effusioni, mantenendo le distanze, tuttavia, almeno tra pochi, liberi dalle mascherine. Con cautela e con un certo riaffacciarsi dell’angoscia per l’aumento dei contagi, sperando che non siano necessarie nuove chiusure e soprattutto che il vaccino, quello buono perché scientificamente validato, arrivi presto. Questo è il tema principe delle conversazioni, intramezzato dallo scambio di notizie belle o brutte che siano, in primis la salute: hai saputo del tale? come sta talaltra? Tra i maschi, soprattutto, un po’ di sport. E così via. Di politica niente o poco. Per esempio: di referendum? Qualcosa. Ecco parliamone. In uno di questi incontri ho provato a inserire, seppur con molta cautela, l’argomento. Senza però mascherature: io voto NO, perché, perché… E tu? L’interlocutore, nel mio caso l’interlocutrice – chiamiamola Tommasa – (mi limiterò a due soli attori dell’incontro: bastano per il mio ragionamento) con mia meraviglia rispetto a quanto la conosco (o credevo di conoscerla) dichiara: “Non ho ancora deciso se andare a votare, ma nel caso decidessi di andare voterei SI. Si, senza esitazioni, perché è un’occasione per dare una mazzata a questa classe politica, di cui ho profonda disistima” . Ma così, dico io, riprendendo il discorso d’esordio, favorisci le oligarchie di partito, diminuisci le rappresentanze, magari impedendo l’elezione di qualche persona onesta e competente. “Ma scusa – fa Tommasa – questi che oggi ci rappresentano cosa fanno di buono per noi? Intendo noi cittadini. A proposito, tu li conosci? Dico personalmente. E soprattutto ti hanno mai coinvolto individualmente o come esponente delle organizzazioni in cui sei impegnato, quelle che tu chiami della ‘società civile’?”. Beh! Devo dire che con questa domanda Tommasa mi ha proprio steso. Pensate che sono riuscito a ricordarmi solo due dei nostri parlamentari sardi; precisamente i due che ho votato: Gianni Marilotti, senatore di 5 Stelle e Andrea Frailis, deputato del Pd. E gli altri chi c… sono? Vabbè, è anche colpa mia non essere informato dell’attività dei nostri parlamentari. Ora che mi ricordo Marilotti ha organizzato al Senato la presentazione del libro di Francesco Casula contro Carlo Felice e i Savoia E poi ha anche partecipato a iniziative del CoStat. Di Frailis poco so, salvo qualche dichiarazione, ma lasciamo perdere. Ripeto in parte è colpa mia. “Si? – incalza Tommasa – Ma tu non hai mai smesso di fare attività culturale e, ultimamente, animazione di quartiere. Li hai incontrati i politici, questi o altri che siano, nelle tue iniziative?”. La conversazione è andata per le lunghe e non vi voglio annoiare ulteriormente. Tutti siamo rimasti nelle opinioni di partenza, rispettosamente. Traggo solo alcune semplici conclusioni: 1) resto convinto che tagliare il numero dei parlamentari sia sbagliato, fondamentalmente antidemocratico; 2) non possiamo però accettare lo status quo, urge una reimpostazione delle forme della rappresentanza politica a partire dalla democratizzazione dei partiti e dalla riforma dei sistemi elettorali in chiave proporzionale. È un discorso complesso ma va continuato, come facciamo nel CoStat. E anche nel nostro piccolo della nostra News continueremo a farlo. Per il referendum niente è ancora perduto, nel senso che, nonostante le previsioni contrarie, il NO può ancora vincere, magari se tanti progressisti e di sinistra lo sosterranno. Noi del NO ci siamo oggi e ci saremo comunque le cose vadano.
———————-
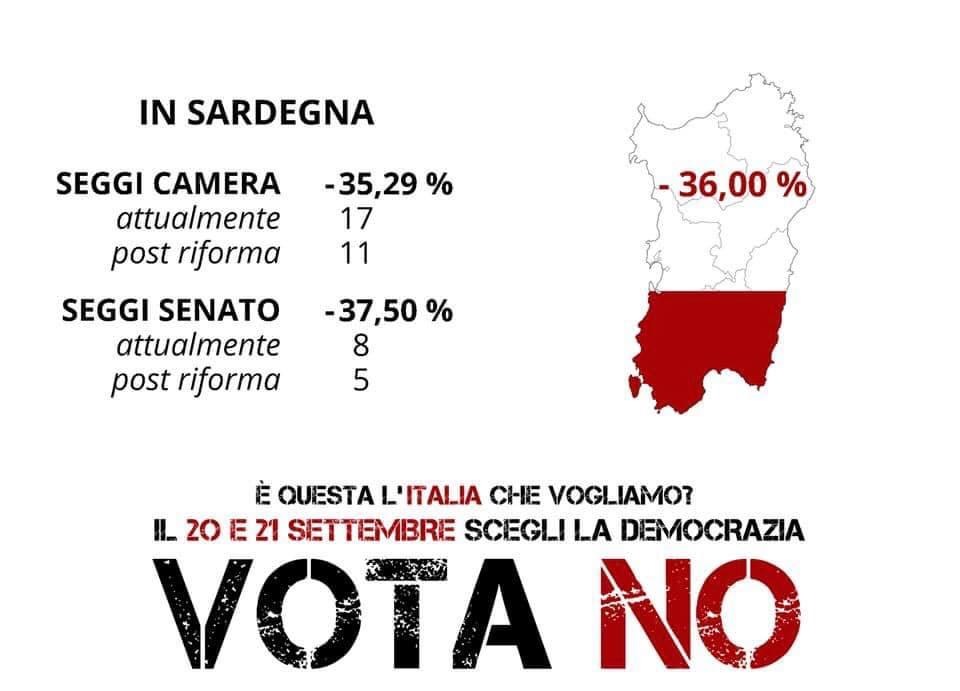
———————-

———

Referendum. Vincere o perdere: tutto è possibile

Considerazioni semplici.
di Franco Meloni.
Dopo i giorni terribili del lockdown riprendiamo a incontrarci tra amici in qualche serata conviviale. Vietate le effusioni, mantenendo le distanze, tuttavia, almeno tra pochi, liberi dalle mascherine. Con cautela e con un certo riaffacciarsi dell’angoscia per l’aumento dei contagi, sperando che non siano necessarie nuove chiusure e soprattutto che il vaccino, quello buono perché scientificamente validato, arrivi presto. Questo è il tema principe delle conversazioni, intramezzato dallo scambio di notizie belle o brutte che siano, in primis la salute: hai saputo del tale? come sta talaltra? Tra i maschi, soprattutto, un po’ di sport. E così via. Di politica niente o poco. Per esempio: di referendum? Qualcosa. Ecco parliamone. In uno di questi incontri ho provato a inserire, seppur con molta cautela, l’argomento. Senza però mascherature: io voto NO, perché, perché… E tu? L’interlocutore, nel mio caso l’interlocutrice – chiamiamola Tommasa – (mi limiterò a due soli attori dell’incontro: bastano per il mio ragionamento) con mia meraviglia rispetto a quanto la conosco (o credevo di conoscerla) dichiara: “Non ho ancora deciso se andare a votare, ma nel caso decidessi di andare voterei SI. Si, senza esitazioni, perché è un’occasione per dare una mazzata a questa classe politica, di cui ho profonda disistima” . Ma così, dico io, riprendendo il discorso d’esordio, favorisci le oligarchie di partito, diminuisci le rappresentanze, magari impedendo l’elezione di qualche persona onesta e competente. “Ma scusa – fa Tommasa – questi che oggi ci rappresentano cosa fanno di buono per noi? Intendo noi cittadini. A proposito, tu li conosci? Dico personalmente. E soprattutto ti hanno mai coinvolto individualmente o come esponente delle organizzazioni in cui sei impegnato, quelle che tu chiami della ‘società civile’?”. Beh! Devo dire che con questa domanda Tommasa mi ha proprio steso. Pensate che sono riuscito a ricordarmi solo due dei nostri parlamentari sardi; precisamente i due che ho votato: Gianni Marilotti, senatore di 5 Stelle e Andrea Frailis, deputato del Pd. E gli altri chi c… sono? Vabbè, è anche colpa mia non essere informato dell’attività dei nostri parlamentari. Ora che mi ricordo Marilotti ha organizzato al Senato la presentazione del libro di Francesco Casula contro Carlo Felice e i Savoia E poi ha anche partecipato a iniziative del CoStat. Di Frailis poco so, salvo qualche dichiarazione, ma lasciamo perdere. Ripeto in parte è colpa mia. “Si? – incalza Tommasa – Ma tu non hai mai smesso di fare attività culturale e, ultimamente, animazione di quartiere. Li hai incontrati i politici, questi o altri che siano, nelle tue iniziative?”. La conversazione è andata per le lunghe e non vi voglio annoiare ulteriormente. Tutti siamo rimasti nelle opinioni di partenza, rispettosamente. Traggo solo alcune semplici conclusioni: 1) resto convinto che tagliare il numero dei parlamentari sia sbagliato, fondamentalmente antidemocratico; 2) non possiamo però accettare lo status quo, urge una reimpostazione delle forme della rappresentanza politica a partire dalla democratizzazione dei partiti e dalla riforma dei sistemi elettorali in chiave proporzionale. È un discorso complesso ma va continuato, come facciamo nel CoStat. E anche nel nostro piccolo della nostra News continueremo a farlo. Per il referendum niente è ancora perduto, nel senso che, nonostante le previsioni contrarie, il NO può ancora vincere, magari se tanti progressisti e di sinistra lo sosterranno. Noi del NO ci siamo oggi e ci saremo comunque le cose vadano.
———————-
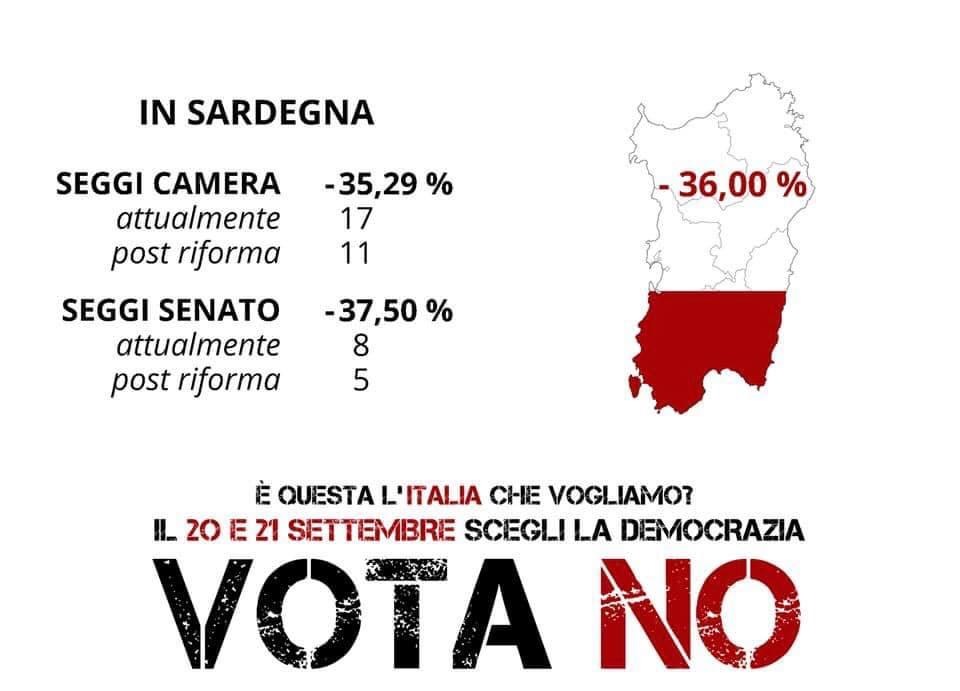
———————-

Campagna per il NO nel Referendum

La posta in gioco nel referendum
Volerelaluna, 21-08-2020 – di Domenico Gallo
Manca meno di un mese: il 20 e 21 settembre saremo chiamati alle urne per approvare o respingere la riforma che modifica gli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione al fine di ridurre il numero dei parlamentari: da 630 a 400 alla Camera dei Deputati, da 315 a 200 al Senato.
Non dimentichiamo che nell’ultima votazione alla Camera l’8 ottobre 2019 la riforma fu approvata quasi all’unanimità in quanto tutti i partiti si espressero a favore, salvo dissensi individuali. Il giorno dell’approvazione dinanzi alla Camera fu inscenata una manifestazione durante la quale il capo politico dei 5Stelle, con delle forbici enormi tagliò platealmente una striscia di poltrone di cartone fra il tripudio generale, com’era avvenuto un anno prima quando lo stesso personaggio aveva annunciato l’abolizione della povertà.
Non v’è dubbio che all’epoca la riforma godeva di una grande popolarità poiché dava l’impressione al cittadino comune di aver messo a segno un risultato importante tagliando le poltrone alla casta. Una popolarità che i partiti, che pure nelle precedenti votazioni avevano votato contro, non avevano voluto sfidare, al punto che la stessa richiesta di sottoporre la riforma al referendum popolare appariva come una sfida al buon senso. Il referendum fu fissato dal governo a tambur battente per il 29 marzo 2020 per evitare che il passare del tempo potesse smorzare l’onda del consenso che aveva cominciato ad affievolirsi, sennonché l’emergenza generata dalla pandemia ha scombinato questi piani.
Il disastro sanitario, economico, politico e sociale provocato dalla pandemia ci ha posto di fronte a problemi drammatici rispetto ai quali emerge tutta la vacuità di una politica che, invece di affrontare i problemi e i bisogni reali della gente, ha cavalcato il disagio sociale per costruirsi un consenso fondato sulle illusioni dell’antipolitica. Questa politica ha creato l’illusione che il disagio sociale sia frutto dei privilegi della casta, che dimezzare le pensioni dei parlamentari sia stato un grande successo popolare, che la nostra vita si possa migliorare discriminando gli immigrati o altre categorie di soggetti deboli, che il disagio politico che nasce dal vuoto della rappresentanza sia colpa delle istituzioni politiche rappresentative, che quindi devono essere ridimensionate, a cominciare dal Parlamento.
La riforma costituzionale che riduce il numero dei parlamentari è il frutto più significativo di questa politica di diseducazione di massa. Quando le illusioni guidano la politica non c’è salvezza: basti pensare al disastro creato un secolo fa dal mito della “vittoria mutilata”, che provocò l’avvento del fascismo.
Adesso è giunto il tempo delle scelte, il tempo di fare i conti con la realtà. Dobbiamo chiederci: avere meno rappresentanti ci consentirà di far sentire meglio la nostra voce quando chiederemo giustizia sociale, investimenti, distribuzione equa delle risorse, un lavoro e una vita decente per tutti?
È vero che è profondamente radicato un sentimento antipolitico, certamente non ingiustificato, ma è una grande menzogna che col taglio del Parlamento si punisca la casta. Rimpicciolendo il Parlamento la casta diventerà ancora più oligarchica e per i cittadini sarà ancora più difficile essere rappresentati. Il taglio dei parlamentari sommato alle norme elettorali in vigore apre una ferita nella capacità di rappresentare i cittadini, i territori, le posizioni politiche esistenti nel paese. Soprattutto al Senato, dove verrà eletto un senatore ogni 302.420 abitanti, ma per i 74 collegi uninominali (a fronte degli attuali 116), il rapporto sarà di un senatore ogni 803.158 abitanti (per fare un esempio in una Regione come la Calabria con una popolazione di 1.959.000 abitanti sono previsti solo 2 collegi uninominali, a fronte dei 4 attuali). Che vantaggio ne trarranno i cittadini italiani?
Il referendum è il momento della verità, abbiamo l’occasione con il nostro voto di far crollare questo castello di illusioni e di costringere la politica a confrontarsi con la realtà dei nostri bisogni. A differenza delle votazioni politiche nelle quali milioni di voti possono andare perduti, nel referendum costituzionale, ogni voto vale, ogni voto può fare la differenza e ogni voto è importante perché il cittadino elettore con il suo voto diviene legislatore costituzionale: scrive la Costituzione. Occorre un impegno di tutti perché venga scritta una pagina di verità.
———————————
Domenico Gallo, magistrato è presidente di sezione della Corte di cassazione. Da sempre impegnato nel mondo dell’associazionismo e del movimento per la pace, è stato senatore della Repubblica per una legislatura ed è componente del comitato esecutivo del Coordinamento per la democrazia costituzionale. Tra i suoi ultimi libri “Da sudditi a cittadini. Il percorso della democrazia” (Edizioni Gruppo Abele, 2013) e “Ventisei Madonne Nere” (Edizioni Delta tre, 2019).
———–

———–
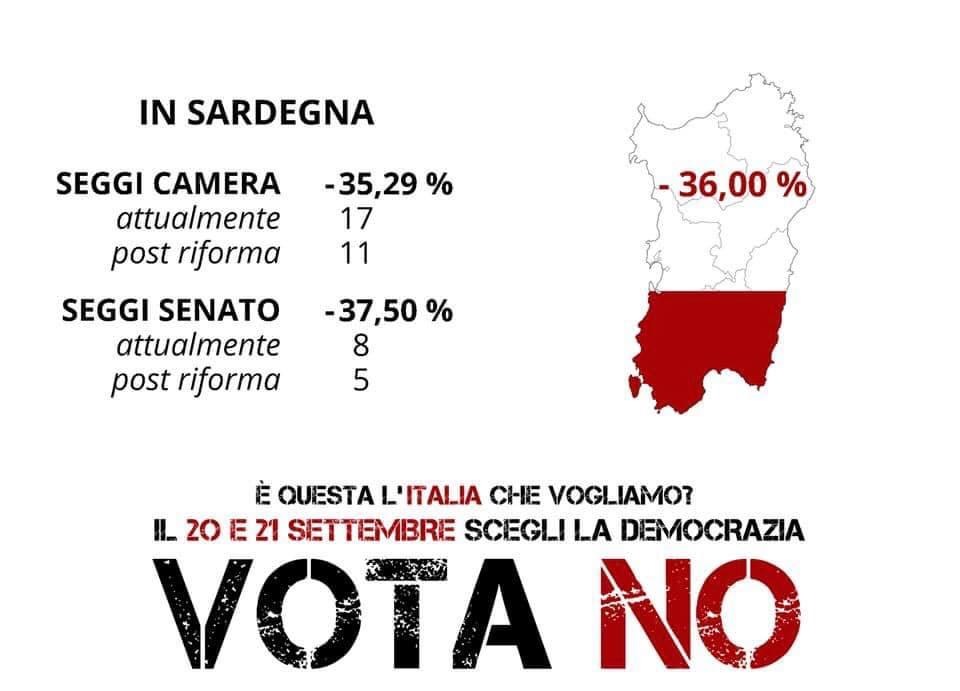
Referendum. Campagna per il NO

Referendum: un po’ di ripasso e qualche conto.
di Tonino Dessì.
Questo è il testo originario degli articoli 56 e 57 della Costituzione promulgata nel 1948.
“Art. 56.
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
Art. 57.
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d’Aosta ha un solo senatore.”.
L’Assemblea Costituente svolse sul tema della rappresentanza parlamentare una discussione specifica, nella quale prevalse, sia sulla base di considerazioni empiriche ed esperienziali, sia sulla base del raffronto comparativo con ordinamenti di altre democrazie contemporanee, il criterio volto ad assicurare a una determinata quota di elettori i propri rappresentanti.
Il testo attuale, che fissa in seicentotrenta i deputati e in trecentoquindici i senatori (più i cinque a vita di nomina presidenziale previsti dall’articolo 60), deriva da una modifica costituzionale apportata al testo originario nel 1963 (l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2). Una successiva modifica è stata introdotta con la revisione del 2001 (l. cost. 23 gennaio 2001, n. 1), che ha riservato alla circoscrizione Estero l’elezione di sei senatori.
La legge costituzionale del 1963 intervenne a boom demografico in pieno svolgimento, per bloccare una crescita continuativa della rappresentanza che appariva in prospettiva controproducente, sia in quanto, potendo dar luogo a un numero di parlamentari pletorico, avrebbe indebolito il Parlamento, anzitutto rispetto al Governo, sia in quanto la variabilità del numero dei seggi in occasione di ogni tornata avrebbe reso meno governabile la vita interna dei partiti e più indeterminate le reciproche relazioni, i rapporti di forza, le stesse maggioranze parlamentari.
Bloccare il numero ai livelli ormai raggiunti costituiva un fattore di stabilizzazione del sistema.
Restava tuttavia un numero di rappresentanti conforme all’esigenza di rispecchiare in Parlamento tanto il pluralismo politico quanto la complessità sociale e persino territoriale della realtà italiana.
Non deve sfuggire che più alto è il numero di elettori necessario per eleggere un parlamentare, più si allarga la distanza del parlamentare stesso dai propri elettori e più bassa è la varietà delle istanze, anche territoriali, che potrà personalmente e direttamente interpretare.
Il Parlamento non è infatti una semplice macchina per la produzione di norme, ma è il principale strumento per la rappresentazione, la conoscenza, la messa a confronto, la ragionevole mediazione nelle rispettive soluzioni, dei problemi del Paese: la rappresentanza elettiva in democrazia a questo serve.
Oggi in Italia ci sono 1 deputato ogni 96.006 abitanti e 1 senatore ogni 188.424 abitanti.
Se venisse confermata la legge costituzionale oggetto di referendum (che riduce da seicentotrenta a quattrocento i deputati e da trecentoquindici a duecento i senatori), si arriverebbe a 1 deputato per ogni 151.210 abitanti e a 1 senatore per ogni 302.420 abitanti, con una drastica riduzione della rappresentanza popolare e quindi con un divario enormemente accresciuto nel rapporto tra elettori ed eletti.
Tutto ciò a fronte dell’unico obiettivo che sarebbe conseguito: una riduzione della spesa pari a 57 milioni di euro annui, cioè allo 0,007 per cento dell’intera spesa pubblica, risultato che potrebbe essere ottenuto alternativamente, se li si ritiene un costo da abbattere, con una riduzione degli emolumenti, oppure riconsiderando alcune altre decisioni di spesa. Un caccia F35 dei novanta che l’Italia ha deciso di acquistare per l’ammodernamento dell’Aeronautica militare costa attualmente fra i 90 e i 106 milioni di euro, per dire.
Ecco: questa è in sintesi la partita in gioco col referendum.
I favorevoli alla revisione costituzionale oligarchica non hanno un solo ragionevole argomento da spendere.
I NO sono il più ragionevole strumento per difendere una soglia decente di democrazia e per mantenere aperte differenti possibilità di un suo miglioramento anche qualitativo.
________
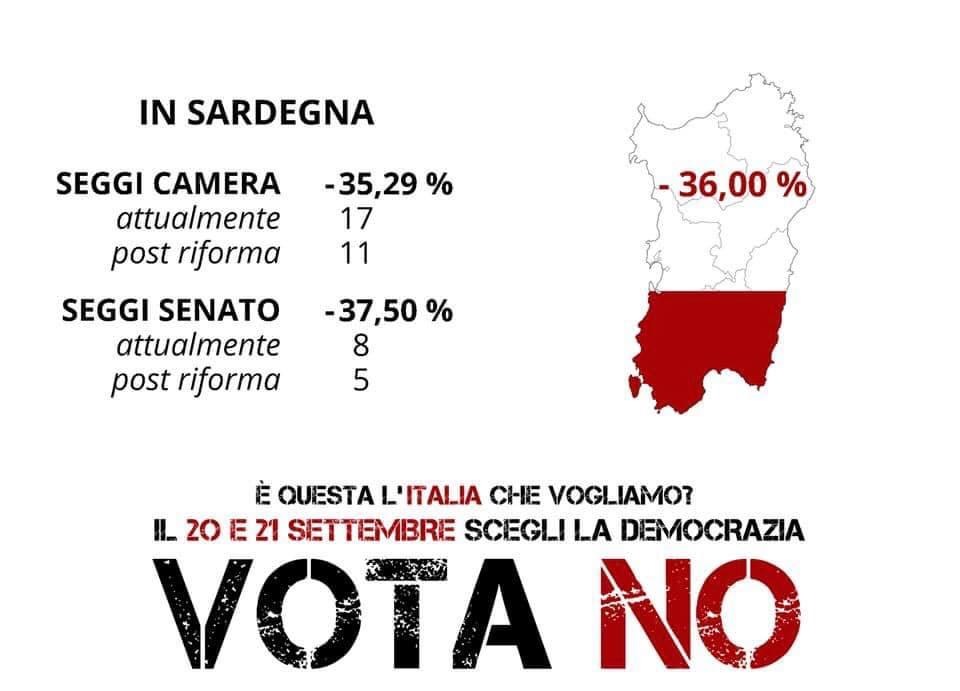
——————-
- Ulteriori informazioni. Su affaritaliani.it.
- Su Money.
———————

————

Da un’idea di Tonino Dessì
——————————————-
Un appello di costituzionalisti per il no al taglio dei parlamentari
[Andrea Fabozzi*]
C’è un appello di un’ottantina di costituzionalisti del No (ma altre firme si stanno ancora raccogliendo) pronto a fare il suo ingresso – nei prossimi giorni – nella campagna referendaria sul taglio dei parlamentari. In prevalenza le firme sono di professori giovani, associati e ricercatori, ma non mancano docenti autorevoli e di esperienza.
Alcuni avevano sostenuto nel 2016 la riforma costituzionale Renzi-Boschi, in qualche caso anche firmando appelli di segno opposto, dunque per il sì. Come Pasquale Costanzo, emerito a Genova, Antonio Ruggeri, emerito a Messina, Marco Plutino, associato a Cassino. Tra le firme anche quella di Massimo Villone, emerito a Napoli e oggi presidente del Comitato nazionale per il No, ruolo che aveva già ricoperto contro la riforma del 2016. Tra le firme in calce al nuovo appello, nato in partenza per rispondere a un asserito «silenzio dei costituzionalisti» (sul manifesto lo ha già fatto l’11 agosto Gaetano Azzariti) quelle di Carlo Amirante, Roberto Borrello, Omar Chessa, Angela Di Gregorio, Michele Della Morte, Silvio Gambino, Enrico Grosso, Laura Lorello, Alberto Lucarelli, Alessandro Morelli, Laura Ronchetti, Laura Trucco, Luigi Ventura. Non ci sono, a parte Villone, le firme che nel 2015 lanciarono, proprio sul manifesto, la campagna per il no al referendum Renzi (Carlassare, Azzariti, Ferrara e ovviamente Rodotà che è venuto a mancare nel 2017).
L’appello mette in testa alle sue critiche gli aspetti economici tanto propagandati dai 5 Stelle – e invece «l’entità dei tagli è irrisoria», «gli strumenti democratici basilari non possono essere sacrificati o depotenziati in base a mere esigenze di risparmio» – e si concentra sulle questioni funzionali – «la riforma riduce in misura sproporzionata e irragionevole la rappresentanza di interi territori», «finirebbe con l’aggravare anziché ridurre i problemi del bicameralismo perfetto» -, ma non trascura che «la riforma appare ispirata da una logica “punitiva” nei confronti dei parlamentari, confondendo la qualità dei rappresentanti con il ruolo stesso dell’istituzione rappresentativa».
Intanto ieri L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha giudicato «ancora insufficiente» lo spazio complessivamente dedicato dall’informazione al referendum. Di conseguenza ha emanato un «ordine» a tutti i fornitori di media audiovisivi, affinché assicurino «un’informazione completa che illustri il merito del quesito referendario e garantisca il bilanciamento delle posizioni favorevoli e contrarie. E ciò sia nei notiziari sia nei programmi di approfondimento». Il consiglio dell’Agcom ha approvato il provvedimento con il voto contrario del consigliere Morcellini e con una settima di anticipo rispetto alla disponibilità dei dati sul periodo 16-22 agosto – e «pur apprezzando il leggero aumento del tempo dedicato al referendum costituzionale» – proprio per l’importanza che nei prossimi giorni sia assicurata la giusta informazione.
Ieri il capo politico reggente dei 5 Stelle Vito Crimi ha voluto fare il suo appello al sì, iniziandolo con l’argomento che il taglio dei parlamentari «È un’occasione straordinaria per ridurre i costi della politica e per rendere più efficiente il nostro parlamento». Malgrado tutte le smentite e i calcoli corretti che sono stati nel frattempo pubblicati, Crimi ha riproposto il conteggio dei risparmi fatto dai 5 Stelle un anno fa, secondo il quale «il taglio ci consentirà di risparmiare 100 milioni di euro l’anno fino ad 1 miliardo in 10 anni, e di poterli restituire ai cittadini investendo in nuovi servizi e attività essenziali». La cifra vera si avvicina alla metà e rappresenta comunque lo 0,007% della spesa pubblica annuale.
Ma soprattutto Crimi ha detto che «il referendum è quel meraviglioso momento di partecipazione, democrazia diretta e libera scelta che può dare ancora più valore e pregio a questo importante cambiamento». Peccato che a gennaio il Movimento abbia attaccato duramente i senatori che si sono fatti promotori del referendum costituzionale. Definendo la loro iniziativa non «un meraviglioso momento di partecipazione» ma «un’ignobile questione di poltrone». Intanto Andrea Colletti non è più l’unico deputato 5S ad essersi espresso apertamente per il no. Anche Elisa Siragusa, eletta all’estero, ha fatto lo stesso.
[*da il manifesto del 21 agosto 2020]
America, America

TRUMP E L’ASSALTO ALLA DILIGENZA POSTALE.
di Marino de Medici
I cultori del Western non possono non eccitarsi dinanzi alle memorabili sequenze dell’assalto alla diligenza con passeggeri e valori postali. Un assalto paragonabile è in atto oggi negli Stati Uniti ad opera del presidente Trump che ha dato ordine al suo lacchè a capo del servizio postale di fare tutto il possibile per ostacolare la consegna dei voti postali con l’infondata motivazione che il suffragio per posta da’ luogo ad una valanga di frodi elettorali. La domanda che molti americani si pongono non può che essere questa: si tratta di malversazioni – dovute alla decisione di sottrarre alle poste i finanziamenti necessari per assicurare il servizio di consegna dei plichi contenenti le schede elettorali – oppure siamo in presenza di un’azione decisamente illegale che ad elezioni concluse giustificherà il rinvio a giudizio del presidente repubblicano? Tutto depone a favore dell’accusa che Donald Trump ha lanciato l’assalto alle diligenza nel timore di essere rovesciato da una valanga, non già di frodi elettorali (che di fatto non si verificano, eccetto che in casi estremamente rari) ma di voti postali deposti a favore del candidato democratico.
In sostanza, Trump ingigantisce in misura perversa l’opposizione repubblicana basata sull’argomento che il servizio postale è inefficiente. Parte integrante di tale opposizione è il mandato congressuale che impone al servizio postale di assicurare a tutti i dependenti benefici di copertura sanitaria per una durata superiore ai 75 anni. I repubblicani, come noto, vogliono abolire i programmi nazionali di assistenza medica, primo fra tutti l’Obamacare. Quel che i repubblicani non vogliono capire è che sin dai tempi di Benjamin Franklin, il primo Postmaster General nominato dal secondo Congresso Continentale nel Luglio 1775, il Postal System è l’emanazione di precisi statuti e non risponde alle esigenze di mercato. Di fatto, fa molto di più perché raggiunge zone che non sono servite dai colossi della distribuzione come UPS e Fed Ex. In particolare assicura l’assistenza medica ai suoi impiegati.
Per queste ed altre ragioni commerciali, il Postal System attraversa da tempo una crisi finanziaria ma il Congresso non ha alzato un dito per aiutarlo. Il problema è sorto nel 1970 quando il Postal Reorganization Act ha fatto del sistema una “corporation” di proprietà governativa. In pratica, costituisce un’entità pubblica ibrida, con elementi amministrativi privati, che risponde comunque al Congresso. I democratici si battono disperatamente per garantire i finanziamenti necessari al sistema postale ma i repubblicani non collaborano. I fondi previsti dallo Heroes Act approvato dalla Camera sono ostaggio dell’ostruzionismo della leadership repubblicana del Senato che nel bel mezzo della controversia ha sospeso i lavori ed è andato a casa. Lo Speaker della Camera, Nancy Pelosi, ha richiamato i deputati per una sessione di emergenza al fine di risolvere la crisi finanziaria che molti
temono finirà con l’influenzare lo svolgimento delle elezioni. Il che è esattamente quello che si propone il presidente nel disperato tentativo di delegittimare la consultazione elettorale rimandando alle calende greche la proclamazione ufficiale del vincitore.
Con un’impudenza che non ha precedenti nella storia americana, Donald Trump ha dichiarato ad un gruppo di sostenitori: “L’unico modo in cui perderemo le elezioni sarà se queste saranno truccate”. Dinanzi a questa sfida, i democratici hanno preso di mira il Postmaster, Louis DeJoy, un servile esponente della macchina elettorale repubblicana, miliardario e donatore del presidente. E per giunta, azionista dei concorrenti privati delle poste. Non appena nominato, il Postmaster si è messo subito all’opera di sabotaggio del normale svolgimento del voto postale. Accampando la giustificazione di voler risparmiare, ha ordinato la rimozione di macchine selezionatrici ed ha ridotto gli orari di servizio al pubblico. In aggiunta, ha licenziato un gran numero di dipendenti. Il risultato è stato immediato, un forte rallentamento dei servizi di distribuzione della posta, che ha colpito in particolare coloro che ricevono medicinali per posta.
Tra questi, in particulare, gli abitanti delle zone rurali, dove vive un americano anziano su cinque, hanno accusato le conseguenze dei ritardi. Il coro di forti proteste di un gran numero di americani, e l’annuncio di un “hearing” presso la Camera, che avrebbe messo il Postmaster su una graticola di duro biasimo parlamentare, sembrano aver arrestato per il momento l’assalto di Trump alla diligenza postale.
Alcune cifre testimoniano l’irresponsabilità del presidente nei confronti del sistema postale, che conta 600.000 dipendenti, 97.000 dei quali sono reduci. Ed ancora, il 40 per cento della forza lavoratrice appartiene a minoranze. Ma il dato di fatto più rilevante è che il Postal Service non riceve fondi federali, ma si regge con la vendita di francobolli, prodotti e servizi postali. Nello scorso anno, è precipitato in rosso per 9 miliardi di dollari. Il coronavirus ha aggravato la situazione, riducendo di un terzo la movimentazione. Con una mossa ansiosa, gli amministratori hanno chiesto al Congresso un sussidio di emergenza di 89
miliardi di dollari. L’amministrazione Trump ha risposto picche. L’irresponsabilità dell’amministrazione è tanto più eclatante in quanto il presidente non fa che ripetere che il servizio postale dovrebbe aumentare sensibilmente il costo della distribuzione di pacchi per i venditori online tra cui Amazon. Il fondatore e padrone di Amazon, Jeff Bezos, è uno degli uomini più odiati da Trump, anche perché Bezos è proprietario della Washington Post, il quotidiano di forte opposizione all’amministrazione repubblicana. Ed ancora, Amazon ha citato in giudizio Trump accusandolo di aver personalmente bocciato un progetto di programmazione per il Pentagono dal valore di dieci miliardi di dollari. Se i magistrati dovessero accogliere la richiesta di Amazon, il presidente sarebbe chiamato a comparire in giudizio.
Non vi è dubbio che la campagna di restrizione del servizio postale perseguita da Trump sta già avendo avversi effetti. Il Segretario di Stato dell’Ohio Frank LaRose ha avvertito gli elettori del suo stato che una tardiva richiesta delle schede postali potrebbe impedire il conteggio dei loro voti. Con una sfrontatezza che riflette i suoi istinti distruttivi Trump ha ridicolizzato gli sforzi dei democratici di sbloccare un fondo straordinario per il servizio postale. Ha detto Trump: “se non giungiamo ad un accordo (su un nuovo stanziamento federale anti-covid 19 alle condizioni imposte dai repubblicani), vuol dire che non avranno i soldi. Questo significa che non potranno ottenere il voto universale per posta. Non lo avranno”.
Sotto un diluvio di accuse e critiche, il presidente si è in parte rimangiato quella dichiarazione comunicando che firmerà una legge che finanzi il servizio postale, ma ha reiterato che si opporrà all’espansione del voto per posta. L’ironia è che il presidente e la moglie hanno già votato per posta nella Florida, dove sono residenti.
Lo stesso Postmaster ha dovuto fare marcia indietro sospendendo le misure che compromettevano il normale funzionamento delle poste, a cominciare da una sporca iniziativa con cui permetteva ai postini sovraccarichi di lavoro di rimandare la consegna dell’eccesso dei carichi postali. Il ricco donatore di Trump preposto alle poste senza il minimo di esperienza in materia insisteva che le modifiche introdotte avevano il solo scopo di “stabilizzare” il disavanzo postale mentre appariva evidente che tali modifiche e il persistente incubo della pandemia minacciavano di ridurre fortemente la consegna e lo spoglio delle schede inviate per posta. La strategia repubblicana di sopprimere il maggior numero possibile di voti per posta ha una sua logica, legata alla recente previsione che il 30 per cento degli elettori voteranno per posta. Tra i democratici, si prevede che il 47 per cento voterà in tal modo. Saranno molti infatti a richiedere e spedire con notevole anticipo le loro schede per assicurarsi che
vengano conteggiate. La conclusione autorizzata dagli ultimi sviluppi è che la feroce reazione alla strategia di Trump di ridurre il più possibile il voto per posta (gli Attorney General di vari stati hanno giù fatto ricorso alla magistratura contro le manovre del Postmaster) ma soprattutto la decisione di un’alta percentuale di democratici di ricorrere al voto postale rappresentano il carico da novanta che seppellirà le speranze di rielezione di Donald Trump.
—————————







 AService Studio
AService Studio