SOCIETÀ
Sussidiarietà leva della rifondazione delle Istituzioni
 Sabato 11 maggio 2024: interessante Convegno promosso dalla Consulta diocesana degli organismi di Carità socio-assistenziali per la promozione umana sul tema “Riforma del terzo settore ed enti ecclesiali”. Motore di tutto il “principio di sussidiarietà”. Torneremo sull’argomento. Intanto un riferimento ai fondamentali.
Sabato 11 maggio 2024: interessante Convegno promosso dalla Consulta diocesana degli organismi di Carità socio-assistenziali per la promozione umana sul tema “Riforma del terzo settore ed enti ecclesiali”. Motore di tutto il “principio di sussidiarietà”. Torneremo sull’argomento. Intanto un riferimento ai fondamentali.
Approfondimenti su Aladinpensiero: https://www.aladinpensiero.it/?p=66146
———————————————————
Campagna Elettorale Europee e Amministrative
Primo Maggio
 1 maggio: il lavoro e i lavoratori prima di tutto
1 maggio: il lavoro e i lavoratori prima di tutto
1 Maggio 2024
A.P. Su Democraziaoggi
Quando il lavoro e i lavoratori saranno al centro dell’ordinamento, allora si avrà vera democrazia. Non a caso l’art. 1 della nostra Costituzione delinea un nesso indissolubile fra democrazia e lavoro. La Repubblica è democratica perché è fondata sul lavoro. Vengono così superati i criteri che per secoli hanno determinato lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo, l’esistenza […]
—————————————————-
Sa Die de Sa Sardigna: Bona festa, a tottus, a is chi funt accanta e a is chi funt attesu, massimmamenti a is giòvunus chi prenint custa sala e a tottus is piccioccus e piccioccas chi si preparant a arregòllirri s’erentzia de custa terra nosta.

Pubblichiamo di seguito l’intervento di Gianni Loy in Consiglio regionale in occasione della manifestazione celebrativa de Sa Die de Sa Sardigna. In precedenza nello spazio editoriale avevamo dato atto del saluto del presidente del Consiglio Piero Comandini e pubblicato una sintesi dell’intervento della presidente della Regione Alessandra Todde.
——————————————-
 Testo in lingua sarda
Testo in lingua sarda
Sa Die de sa Sardigna
– 28 de arbili de su 2024 –
IS SINNUS DE S’IDENTIDADE
Gianni Loy
Bona festa, a tottus, a is chi funt accanta e a is chi funt attesu,
massimmamenti a is giòvunus chi prenint custa sala e a tottus is piccioccus e piccioccas chi si preparant a arregòllirri s’erentzia de custa terra nosta.
E Bona festa a chini – pensu chi siais medas, a dolu mannu, – no podit cumprèndiri, a doveri, unu de is sìmbulus prus importantis de su pòpulu nostru – sa limba chi seu umperendu, – po curpa de s’imbriaghera, de su macchìmini de is generatzionis de prima, chi hant truncau sa costumantzia – una lei naturali – de candu is babbus tramittiant a is fillus sa matessi limba ch’iant imparau de is babbus insoru. Giai de unas cantu generatzionis, medas babbus e mammas hant incumentzau a bos si chistionai cun un’àtera limba, sa limba italiana. Po mori ‘e cussu, bos hant privau de unu de is sinnus prus importantis po unu pòpulu.
D’hant fattu con mei purur, ma mi seu arrenegau, d’happu imparada, e immmoi cun is fillus mius, de candu funt nascius, chistionu, solu e unicamenti, sa limba sarda.
Is istitutzionis, làicas e de sa cresia, po parti insoru, si fiant postu in conca chi a chistionai in sardu fessit cosa mali fatta, finas a erribai a du proibiri in is scolas e in sa liturgia, mancai sa fidi, comenti non imparat Papa Frantziscu – issu che’est istettiu pesau cun su dialettu piemontesu – si podit trasmìttiri fetti cun su dialettu etotu, cun sa limba materna.
Po mori ‘e custu, medas de bosàterus, po cumprèndiri custus fueddus, si depint agiudai cun sa tradutzioni a s’italianu.
Cun tottu, in su matessi tempus, teneis sa furtuna de pigai parti, oi, a una celebratzioni chena prus sa sudditantzia de su passau; giai chi sa bregungia no si da seus lassada a palas e pigat pei – fintzas in is istitutzionis – su recùperu de sa dignidadi de sa limba nosta e sa cuscièntzia de cantu custu sinnu de identidadi siat importanti.
Sa Sardigna tenit una bandera, unu stemma, eredau de una storia chi benit de attesu, mancai su certificau de nascimentu non siat seguru. Sa lei, oi, pretzettada chi sa conca de is cuatru morus depit èssiri bendada e sa cara depit mirai faccias a s’ala de sa pertia chi aguantada sa bandera.
Sa Sardigna tenit un innu, chi su pòpulu hat scioberau de sei, umperendudeddu, fattu fattu, de prus de cent’annusu: su componimentu de Frantziscu Ignatziu Mannu “Su patriota sardu a sos feudatarios“, chi conosceus cun is fueddus de su primu versu: Procurade ‘e moderare.
E sa Sardigna tenit fintzas una festa cosa sua: Sa Die de sa Sardigna, sa dì de oi.
Una festa chi arregodat sa pesada de is casteddaius, chi nci hant stuppau a su visurrei e a is funtzionarius piemontesus.
Ma sa festa no est sa cunseguentzia de cussu fattu. Prus a prestu, rappresèntada s’accabbu de unu camminu – incumentzau in is annus 70 de su sèculu passau – chi hat portau, a primu, a su disigiu e, a pustis, a sa decisioni de istituiri una dì de reflessioni, e de festa, de su pòpulu sardu.
Un processu chi s’accapiada cun sa chistioni, ancora oberta, a pitzus de s’autonomismu chi, a cumentzai de insandus, hat torrau a biri una crèscida manna de su sentimentu de s’identidadi. Sentimentu chi hat deppiu cumbàttiri contras de unu sistema de centralizatzioni politica contraria a is manifestatzionis de sa cultura nosta, tanti chi, a bortas, das hat proibias, atras bortas dis hat postu trampas o das’hat allacanadas is su campu de su sterereòtipu o de su folklori.
Tandu, po cantu a is sinnus de s’identidadi, iaus a deppir’èssiri a postu! Ma is cosas – a dolu mannu – no funt propriu de aicci.
Sa situatzioni de oi de su populu sardu si podit rapresentai cun un’immàgini:
A pustis de su tempus de su peccau – candu, prim’ancora chi su caboniscu cantèssidi, eus arrenegau sa matessi istoria nosta – biveus sa temporada de s’arripentimentu. S’arredimeus a pagu a pagu, cumentzendu a cumprèndiri, a assaborai, a promòviri is sinnus de s’identidadi nosta, de pòpulu, e a nd’èssiri orgogliosus. Su Conciliu plenariu sardu de su 2001, po sa parti chi di toccat, hat torrau a pretziai sa limba sarda comenti “singolare strumento comunicativo della fede” e hat augurau de d’avvalorai in sa liturgia.
Ma non funt is sinnus de foras – is chi castiant a sa forma – sa cosa prus importanti.
Sa pregunta est cali sianta is sinnus, is simbulus de s’dentidadi de anintru. Ita bogliat nai, a sa torrada de is contus, a èssiri unu pòpulu.
Non est tanti sa bandera po issa etotu, a èssiri importanti. Prus a prestu, est su fattu chi sempri de prus, hòminis e fèminas tengiant su disigiu de da bentulai cussa bandera, in dogna logu, in tottu su mundu – siat in is arrugas de is cursas de bicicletta, siat in su sagrau de Santu Perdu in Roma – poita nce dus pappat su pinsighingiu, de du tzerriai a boxi manna chi appartenint a unu pòpulu e disigiant chi tottu su mundu du scipada.
Ma comenti si podit certificai candu una persona fait parti de su pòpulu sardu?
De seguru no poit’esistint un’innu e una bandera, ma po su prexiu, po sa passioni po su gosu etotu de is chi bèntulanta cussa bandera o càntanta cuss’innu.
Si podit nai – forsis – chi siant sardus tottus is chi funt nascius, o bivint, in cust’isula, de sèmpiri vagabunda in su mari mediterraneu? O hant’èssiri is filamentus de su Dna a scoviai chini est sardu de averas e chini nono? O s’artaria, su colori de is pilus, o sa “u” in s’acabbu de su fueddu? O su fattu de sciri chistionai una limba de su logu. O hat a podit èssiri s’origini de s’areu? chi, a bortas, s’attobiat in su sangunau?
Nudda de tottu custu. In primis: non est sa cittadinantzia a definiri unu pòpulu, mancai su fueddu “populu” s’umperit comenti equivalenti de cittadinu de un’Istadu.
Unu populu podit esìstiri, e mantènniri s’identidadi cosa sua, finas anintru de unu sistema statali prus mannu. A bias, comenti capitat a sa Sardigna, s’Istadu etotu podit arreconòsciri sa specialidadi e cuncèdiri poderis de autonomia.
Unu populu, podit esìstiri fintzas chen’e territoriu, coment’est istettiu po Israele, spainau po tottu su mundu, chi hat mantènniu s’identidadi, chena de Istadu, o comenti is pòpulus opprimius de oi, is kurdus, il palestinesus e àterus meda, chi sighint a mantènniri s’dentidadi de pòpulu, cun tottu chi no dis permittinti de creai un’Istadu in su territoriu aunia bìvinti. Calegunu pòpulu, comenti is Rom, spainau po tottu su mundu, sighid’ a mantènniri s’identidadi sua, mancai no tèngiada, e mancu du pretendada, unu territoriu po fundai un’Istadu.
Sa manera de esercitai su dominiu a pitzus de is pòpulus chi reclamant su rispettu de is dirittus insoru, po furtuna, no sèmpiri lompit a su livellu de ferocidadi e de disumanidadi – chi est cosa de non creiri – chi a dì de oi s’umperat contra de su populu palestinesu, tanti de ndi ndi deppiri tènniri bregungia.
Su pòpulu sardu est fattu de personas chi, castiendu a sa terra e a sa storia de sa Sardigna, cundivìdinti sa fatiga de biviri, cundivìdint s’isperantzia in su tempus c’hat a bènniri; cundivìdint sa solidariedadi, funt cuscientis de appartènniri a una collettividadi e trabagliant imparis po su progressu de tottus.
Eccu, su sinnu prus importanti est propriu custu: su coru: m’intendu in coru chi sardu seu!
Nudda nos appartenit. Seus nosus chi appartenus a custa terra, a sa natzione sarda, a su pòpulu sardu. De nosus tottus – francu caleguna rara eccetzioni – su mundu si nd’hat a iscarèsciri prestu meda, e nd’hant erribai àterus, e s’hant a sètziri in su postu chi eus lassaus.
Cun tottu, po su tempus chi feus parti de custa patria nosta – is hòminis e is fèminas tenint duas patrias: una est sa domu insoru e s’atera est su mundu intreu – po custu tempus teneus s’opportunidadi de operai, po beni o po mali, alloghendu e arrichendu su territoriu, oppuru degogliendudeddu; teneus s’opporunidadi de arricai s’istoria sua, oppuru de d’impoberai; teneus s’oportunidadi de agiudai a sa crèscida econòmica, a su benèssiri de tottus, oppure de sdorrobai po cuntentai s’egoismu de dognunu de nosus.
Tottus podint èssiri parti de su pòpulu sardu: tottus is chi – chen’e ponniri in contu de cali corrunconi de su mundu ndi siant erribaus, de su colori de sa peddi, de calichisiat differentzia personali, – pigant parti cun su trabagliu, cun is fainas, cun sa cultura insoru, a su progressu de sa terra chi dus arrìcidi.
In sa storia de sa Sardigna, in contus funt sèmpiri andaus aicci: un’ammistura de personas, de cambaradas, de comunidadis, – a bortas, a su cumentzu, fiant issus etotu invasoris, – ma chi a pustis hant donau s’adesioni a su pattu – no iscrittu – ch’est a fundamentu de su pòpulu nostu.
Sa dì de sa festa de su pòpulu sardu est, e depit sighiri a èssiri s’occasioni po arrenovai cussu pattu de cunbivimentu, s’impegnu a trasmìttiri, a is fillus, sa sienda arricia de is babbus nostus, chena si scarèsciri chi sa cultura e sa limba funt parti inseparabili de s’ambienti naturali chi teneus su doveri de trasmìttiri, intreu, e mancai ammellorau, a is generatzionis chi – o prima o a pustis – hant a pigai su postu nostu.
Sempri chi su coru nos si du cumandit
———————————————————-
Testo in lingua italiana
Sa Die de sa Sardigna
– 28 aprile 2024 –
I SEGNI DELL’IDENTITÀ
Gianni Loy
Buona Festa, a tutti, vicini e lontani,
soprattutto, ai giovani presenti in questa occasione, e a tutti i giovani, e le giovani, che si accingono ad ereditare questa terra.
E buona festa a quanti- penso che siate in molti, purtroppo – non sono in grado di capire, come si deve, uno dei più importanti simboli del nostro popolo, la lingua, la lingua sarda, in tutte le sue varianti, perché una dissennata ubriacatura delle generazioni precedenti ha interrotto l’eterna costumanza – derivata da una legge naturale – per cui i genitori tramettevano ai propri figli la stessa lingua appresa dai loro genitori, semplicemente parlando con essi con la loro lingua – come si fa dappertutto – ed hanno incominciato a parlar loro con un’altra lingua, la lingua italiana, privandoli, così, di una conoscenza, di una risorsa, di uno dei segni più importanti di un popolo.
Una violenza che ho subito anch’io. Ma mi sono ribellato, ho avuto la fortuna di poterla apprendere ugualmente ed è ora l’unica e sola lingua con la quale comunico, sin dal gionro in cui sono nati, con i figli miei.
Le, istituzioni, laiche o religiose, a loro volta, hanno ritenuto disdicevole utilizzare la propria lingua, sino a vietarla nelle scuole, a proibirla nelle celebrazioni religiose, nonostante, come insegna Papa Francesco, cresciuto nel dialetto piemontese, la fede solo si può tramettere nel proprio dialetto, nella lingua materna.
È per questo che una parte di voi, giovani, per comprendere la vostra stessa lingua, in questa occasione, dovrete ricorrere ad una traduzione all’Italiano
Allo stesso tempo, tuttavia, avete oggi la fortuna di partecipare ad una celebrazione che avviene senza più la sudditanza del passato, avendo superato la vergogna, mentre avanza, anche nelle istituzioni, il recupero della dignità della nostra lingua e la consapevolezza di quanto sia importate questo segno di identità del popolo sardo.
La Sardegna ha una sua bandiera, un suo stemma, ereditati da una storia lontana, privi di sicuro certificato di nascita. Pur in presenza di qualche divergenza di opinioni, la legge ribadisce, che la testa di ciascun moro deve apparire bendata e rivolta verso il lato che si fissa all’asta.
La Sardegna ha un suo inno, scelto spontaneamente dal popolo mediante l’uso, e ratificato, e reso inno ufficiale della regione Sardegna, nel 2018, con la legge regionale n. 14 che ha anche individuato le strofe da eseguire nelle cerimonie ufficiali: il componimento di Francesco Ignazio Mannu: “Su patriota sardu a sos feudatarios“, che da oltre un secolo ci tramandiamo con le parole del primo verso: “Procurare e moderare”.
E la Sardegna ha una sua festa, Sa die de sa Sardigna, il 28 aprile, istituita con la legge regionale n. 44 del 1993.
La festa cade nel giorno della rivolta dei cagliaritani – che costrinse alla fuga il viceré e i funzionari sabaudi – ma non è la conseguenza naturale di quell’episodio.
Essa rappresenta, piuttosto, la conclusione simbolica di un percorso, avviatosi negli anni 70 del secolo scorso, sfociato prima nella aspirazione, e poi nella decisione di istituire una giornata di riflessione, di festa, del popolo sardo.
Un processo che si inserisce nella lungo dibattito sull’autonomismo della Sardegna che, a partire da quegli anni, ha visto una forte ripresa del sentimento identitario. Sentimento ostacolato da un processo di centralizzazione politica e culturale che impediva l’espressione delle culture del popolo sardo, vietandole – a volte – ostacolandole, o confinandole all’esteriorità dello stereotipo o del folklore.
Quanto ai simboli della nostra identità abbiamo quindi le carte in regola. Ma le cose – purtroppo – non sono così semplici.
L’attuale situazione del popolo sardo può essere rappresentta con un’immagine: Dopo la stagione del peccato – durante la quale, prima ancora che il gallo cantasse, abbiamo ripetutamente rinnegato la nostra stessa storia – viviamo la stagione del pentimento. Ci redimiamo, a poco a poco, imparando a capire, ad assaporare, a promuovere i segni della nostra identità di popolo, e ad andarne orgogliosi. Il Concilio plenario sardo del 2001 ha rivalutato la lingua sarda quale “singolare strumento comunicativo della fede” e ne ha auspicato la valorizzazione nella liturgia.
Ma non sono i segni esterni, quelli formali, la cosa più importante. Dobbiamo chiederci quali siano i segni, i simboli interiori dell’identità. Cosa significa, in definitiva, essere sardi, essere popolo
Non è la bandiera in sé, ad essere importante. Ma il fatto che, sempre più spesso, uomini e donne avvertano il bisogno di sventolarla, quella bandiera, nelle più disparate manifestazioni , in tutto il mondo, dalle strade delle corse ciclistiche al sagrato di piazza San Pietro, per un bisogno – che viene da dentro – quello di rappresentare la propria appartenenza ad un popolo, di farsi riconoscere e di voler essere riconosciuti.
Ma come può esser certificata l’appartenenza al popolo sardo?
Non certo per l’esistenza di un inno o di una bandiera; semmai per il gusto, la passione e la gioia, di quanti sventolano quella bandiera o cantano quelle strofe.
Sardi sono forse tutti coloro che risiedono in quest’isola che, da sempre, vagabonda nel Mar mediterraneo? O quanti in quell’isola sono nati? O saranno i filamenti del DNA a rivelare chi veramente è sardo e chi non lo è? O saranno la bassa statura, il colore dei capelli, la “u” nella finale delle parole, o la capacità di esprimersi in una delle lingue locali? O potrà essere l’albero genealogico, a volte rappresentato dal cognome?
Niente di tutto ciò. In primo luogo: soprattutto, non è la cittadinanza a definire un popolo, anche se il temine popolo viene usato anche come equivalente dei cittadini di uno Stato.
Un popolo può esistere e mantenere la propria identità culturale anche all’interno di una più ampia realtà statale; a volte, come per la Sardegna, con il riconoscimento da parte dello Stato della sua specialità e l’attribuzione di alcuni poteri di autonomia.
Un popolo può esistere persino in assenza di territorio, come è stato per il popolo di Israele, che ha mantenuto la propria identità di popolo anche senza essere Stato; o come i popoli oppressi, kurdi, palestinesi e tanti altri, vivi e vitali, nonostante venga loro negato il diritto costituire un’entità statale nei territori in cui vivono. Alcuni popoli mantengono la loro forte identità, come i Rom, nonostante neppure abbiano un territorio da rivendicare.
I gradi di esercizio del dominio sui popoli che reclamano i propri diritti, per fortuna, non sempre, raggiungono gli inauditi livelli di ferocia e di inumanità che oggi – con il silenzio complice di troppe persone e troppi Stati, – si consuma contro il popolo palestinese, e che dovrebbe farci vergognare.
Nessuno viene iscritto, d’ufficio, al popolo sardo. Il popolo sardo, è costituito dalle persone che, in riferimento ideale alla terra ed alla storia della Sardegna, condividono la fatica di vivere, condividono la speranza nel futuro, condividono la solidarietà, hanno coscienza di appartenere ad una collettività e collaborano per il suo progresso.
Ecco, il segno più importante è proprio questo: il cuore.
M’intendu in coru chi sardu seu!
Niente ci appartiene, siamo noi ad appartenere alla nostra terra, alla nazione sarda, al popolo sardo. La stragrande maggioranza di noi sarà dimenticata ed altri verranno a prendere il nostro posto.
Tuttavia, per tutto il tempo in cui continuiamo ad appartenere a questa nostra patria – l’uomo ha due patrie: una è la sua casa e altra è il mondo! – abbiamo l’opportunità di operare, nel bene e nel male: conservando ed arricchendo il suo territorio, oppure devastandolo; abbiamo l’opportunità di arricchire la sua storia e la sua cultura, oppure di immiserirla; abbiamo l’opportunità di contribuire alla sua crescita economica e al benessere della collettività, oppure di sottrarre risorse per il nostro egoismo.
Tutti possono far parte del popolo sardo: tutti coloro che, indipendentemente dalla terra d’origine, dal colore della pelle e di ogni altra differenza, hanno eletto la Sardegna quale loro terra e contribuiscono con il lavoro, con le opere, con la loro cultura, al progresso della terra che li accoglie.
Così è sempre stato nella storia della Sardegna: un crogiolo di persone, di gruppi, di comunità, non di rado essi stessi invasori, inizialmente, che hanno poi aderito al patto costitutivo, non scritto, del nostro popolo.
Il giorno della Festa del popolo sardo è, e dovrà continuare ad essere, un’ occasione per rinnovare il patto di convivenza, l’impegno a trasmettere l’eredità ricevuta, ricordando che la cultura e la lingua sono parti inseparabili dell’ambiente naturale che abbiamo il dovere di tramettere intatto, e se possibile migliorato, alle future generazioni.
Se il cuore ce lo comanda.
——————————————————————————
Sa Die de Sa Sardinia – La celebrazione in Consiglio regionale


[Dal sito web della RAS] Cagliari, 28 aprile 2024 – La presidente della Regione Alessandra Todde ha partecipato oggi, in Consiglio regionale, alle celebrazioni della Sa Die de sa Sardigna.

Di seguito la traccia del suo intervento.
Presidente Comandini, consigliere e consiglieri, ragazzi e ragazze, noi sardi abbiamo diritto a festeggiare noi stessi e la nostra storia. Ed è con emozione che prendo la parola per celebrare con voi “Sa Die de sa Sardigna”. Per troppo tempo ci siamo raccontati che di storia non ne avevamo, dando per buono che il nostro passato fosse solo un susseguirsi di dominazioni, un vuoto di vera storia, quella con la S maiuscola, quella prodotta da soggetti attivi che lottano, creano, sognano. Oggi siamo qui a ricordare a noi stessi, e a chiunque ami questa terra, che abbiamo avuto una storia nostra, imbevuta di mondo, intessuta di grandi aspirazioni, certo complicata da cadute ma anche ricca di momenti alti. Siamo un popolo che ha affrontato contraddizioni ma anche depositario di grandi potenzialità che ancora dobbiamo dispiegare totalmente. Conoscendo questa storia, condividendola, meditandola, traducendola giorno dopo giorno noi costruiamo gli strumenti per alimentare il nostro desiderio di unità, libertà e prosperità. Per questo dobbiamo festeggiarci senza incensarci: Sa Die non è e non deve essere un giorno di parole roboanti a compensazione degli altri 364 giorni dell’anno. Sa Die non è e non deve essere una sbornia di fierezza o di rivalsa che ci esime dal fare i conti con la nostra coscienza e la nostra azione politica ogni giorno dell’anno. Sa Die non è il fine ma è un impegno. L’impegno a conoscerci, a fare i conti con noi stessi. Per migliorarci, per agire in modo differente. L’autodeterminazione, lo abbiamo detto, cammina sulle spalle di un popolo istruito. Un popolo consapevole di sé. La nostra coscienza nazionale di sardi è un compito, e Sa Die è l’occasione per assumere l’impegno a svolgere questo compito con slancio rinnovato, costante, convinto, chiamando alla partecipazione ogni donna e uomo di Sardegna. A maggior ragione lo dico parlando a voi giovani, che siete i costruttori del presente e del prossimo futuro.
 Il nostro patto generazionale si è rotto e possiamo ricostruirlo attraverso la conoscenza della nostra storia che ci aiuti a creare una nuova comune coscienza collettiva. Sa Die non è un giorno solitario: non lo fu allora e non deve esserlo oggi. Gli eventi che commemoriamo non iniziarono e non finirono in quel 28 Aprile 1794. Quella giornata di sollevazione – che la parte più timorosa della classe dirigente immediatamente bollò come “emozione popolare” – affondava le sue radici alla metà del Settecento, nella riscoperta da parte dei sardi della loro diversità nazionale, così come nella crescente consapevolezza popolare di una condizione di ingiustizia di cui il feudalesimo era il segno più appariscente. Questa corrente, alimentata carsicamente dalla nostra lunghissima storia di sovranità, testimoniata dal rifiorire della lingua sarda, si alimentava al contempo delle correnti di pensiero illuministe, riformiste, rivoluzionarie che attraversavano l’Europa. Per questo Sa Die fu più di una ribellione estemporanea. Per questo il suo culmine non è la cacciata temporanea della classe dirigente sabauda e la sua esemplarità non risiede nello spirito di rivendicazione che innerva le “cinque domande” che la classe dirigente sarda rivolse con ingenua fiducia al sovrano sabaudo. Sa Die ci parla di tempi costituenti. Tempi in cui un parlamento riprende vita, la virtù patriottica accende gli animi, le nostre comunità sperimentano patti federativi per liberarsi dal giogo feudale, una parte importante della classe dirigente sarda pone la felicità e la dignità della Nazione sarda come suo obbiettivo. “Un Regno non mai Colonia d’alcun altra Nazione, ma separato ed indipendente dalli Stati di Terraferma”, così si esprime il Parlamento sardo una volta autoconvocato nel 1793. “La Nazione Sarda contiene in sé stessa delle grandi risorse per potere sviluppare una grande forza coattiva, onde fare rispettare la sua costituzione politica”, così recita L’Achille della Sarda Liberazione, uno dei pamphlet simbolo del triennio rivoluzionario sardo. Non è questa l’occasione per discutere su come e perché questo spirito si sia infranto, tanto da arrivare a noi offuscato se non completamente dimenticato. L’occasione odierna è piuttosto quella di guardarci nello specchio della storia e capire insieme se, proprio grazie a questa storia, possiamo fare di più e meglio per la nostra gente e la nostra terra. Se possiamo trovare in essa alimento per delle sfide enormi, come quelle di chi deve affrontare le molteplici crisi che sembrano condannare la Sardegna a un destino di spopolamento e spoliazione. Nel 1798, nel suo Essai sur la Sardaigne indirizzato da Parigi al Parlamento Sardo, il grande giurista sassarese Domenico Alberto Azuni scriveva: “Il mio unico scopo è ricordare alla Nazione lo studio dell’economia politica, e di stimolarla a mettere ogni cura nel commercio, nell’industria, nelle manifatture, nella navigazione. La posizione dell’isola al centro del Mediterraneo, tra i due grandi continenti d’Africa e d’Europa; la molteplicità delle sue produzioni, le cui considerevoli eccedenze possono essere annualmente esportate; la sicurezza dei suoi porti; la ricchezza dei suoi mari, dovrebbero renderla consapevole che essa è destinata dalla Natura ad avere un rango distinto fra le Nazioni commercianti dell’Universo”. Nel 1799, nel suo Memoriale scritto dall’esilio, il leader della Sarda Rivoluzione, Giovanni Maria Angioy, diceva: “Malgrado la cattiva amministrazione, l’insufficienza della popolazione e tutti gli intralci che ostacolano l’agricoltura, il commercio e l’industria, la Sardegna abbonda di tutto ciò che è necessario per il nutrimento e la sussistenza dei suoi abitanti. Se la Sardegna in uno stato di languore, senza governo, senza industria, dopo diversi secoli di disastri, possiede così grandi risorse, bisogna concludere che ben amministrata sarebbe uno degli stati più ricchi d’Europa”. Queste parole di fiducia forse suonano lontane. E ancor più lontano suona forse il loro presupposto: “testimoniare pubblicamente l’attaccamento alla patria”, contribuire alla “felicità della Nazione sarda”, fare della Sardegna uno Stato d’Europa. Il punto non è risolvere la distanza fra noi e quel passato in un giorno, tantomeno con un discorso. Il punto è non aver paura a ricordare queste parole e quello spirito, anche queste parole e quello spirito, per cui tanti sacrificarono la loro vita. Se avremo la forza di fare i conti, da domani, nel nostro concreto operare – come Governo, come Parlamento, come classe dirigente, come società sarda nella sua interezza -, con questo lascito, allora apriremo davvero una via, difficile ma necessaria, ad una diversità consapevole, effettiva, produttiva. In altre parole, mentre celebriamo, abbiamo l’occasione di domandarci se sia meglio proseguire con una storia di rivendicazione, in cui noi sardi chiediamo ad altri di farsi carico dei nostri problemi e delle loro soluzioni, o se non sia il caso di entrare in una fase di reale autodeterminazione, in cui plasmare una nuova politica sarda, in cui costruire con tutta la passione e l’intelligenza possibile delle istituzioni al pieno servizio dei sardi e della Sardegna. Il primo modo per cambiare la propria storia è raccontarla in modo diverso. È raccontarci in modo diverso. Anche a costo di mettere in discussione quegli stereotipi e quell’orgoglioso senso di identità che dietro un velo di confortante abitudinarietà nasconde la difficoltà a darsi valori alti e obbiettivi chiari. Motivi di unità. Motivi per avanzare. Da troppo tempo siamo intrappolati in un racconto che è “contro”. Un racconto in cui altri hanno il potere di decidere della nostra vita e a noi non rimane che ribellarci per rivendicare un trattamento meno opprimente. Ma questa non è la nostra storia. Non è l’unica che il nostro passato ci ha lasciato in eredità. Non è la migliore che possiamo raccontare a noi stessi e, soprattutto, ai nostri figli e alle nostre figlie. C’è una storia di autodeterminazione tutta da scrivere, tutta da fare. E allora quando cantiamo le strofe di ‘Su patriota sardu a sos feudatarios”, scritto da Francesco Ignazio Mannu nel 1795, durante i moti rivoluzionari e dal 2018 inno della Sardegna,
Il nostro patto generazionale si è rotto e possiamo ricostruirlo attraverso la conoscenza della nostra storia che ci aiuti a creare una nuova comune coscienza collettiva. Sa Die non è un giorno solitario: non lo fu allora e non deve esserlo oggi. Gli eventi che commemoriamo non iniziarono e non finirono in quel 28 Aprile 1794. Quella giornata di sollevazione – che la parte più timorosa della classe dirigente immediatamente bollò come “emozione popolare” – affondava le sue radici alla metà del Settecento, nella riscoperta da parte dei sardi della loro diversità nazionale, così come nella crescente consapevolezza popolare di una condizione di ingiustizia di cui il feudalesimo era il segno più appariscente. Questa corrente, alimentata carsicamente dalla nostra lunghissima storia di sovranità, testimoniata dal rifiorire della lingua sarda, si alimentava al contempo delle correnti di pensiero illuministe, riformiste, rivoluzionarie che attraversavano l’Europa. Per questo Sa Die fu più di una ribellione estemporanea. Per questo il suo culmine non è la cacciata temporanea della classe dirigente sabauda e la sua esemplarità non risiede nello spirito di rivendicazione che innerva le “cinque domande” che la classe dirigente sarda rivolse con ingenua fiducia al sovrano sabaudo. Sa Die ci parla di tempi costituenti. Tempi in cui un parlamento riprende vita, la virtù patriottica accende gli animi, le nostre comunità sperimentano patti federativi per liberarsi dal giogo feudale, una parte importante della classe dirigente sarda pone la felicità e la dignità della Nazione sarda come suo obbiettivo. “Un Regno non mai Colonia d’alcun altra Nazione, ma separato ed indipendente dalli Stati di Terraferma”, così si esprime il Parlamento sardo una volta autoconvocato nel 1793. “La Nazione Sarda contiene in sé stessa delle grandi risorse per potere sviluppare una grande forza coattiva, onde fare rispettare la sua costituzione politica”, così recita L’Achille della Sarda Liberazione, uno dei pamphlet simbolo del triennio rivoluzionario sardo. Non è questa l’occasione per discutere su come e perché questo spirito si sia infranto, tanto da arrivare a noi offuscato se non completamente dimenticato. L’occasione odierna è piuttosto quella di guardarci nello specchio della storia e capire insieme se, proprio grazie a questa storia, possiamo fare di più e meglio per la nostra gente e la nostra terra. Se possiamo trovare in essa alimento per delle sfide enormi, come quelle di chi deve affrontare le molteplici crisi che sembrano condannare la Sardegna a un destino di spopolamento e spoliazione. Nel 1798, nel suo Essai sur la Sardaigne indirizzato da Parigi al Parlamento Sardo, il grande giurista sassarese Domenico Alberto Azuni scriveva: “Il mio unico scopo è ricordare alla Nazione lo studio dell’economia politica, e di stimolarla a mettere ogni cura nel commercio, nell’industria, nelle manifatture, nella navigazione. La posizione dell’isola al centro del Mediterraneo, tra i due grandi continenti d’Africa e d’Europa; la molteplicità delle sue produzioni, le cui considerevoli eccedenze possono essere annualmente esportate; la sicurezza dei suoi porti; la ricchezza dei suoi mari, dovrebbero renderla consapevole che essa è destinata dalla Natura ad avere un rango distinto fra le Nazioni commercianti dell’Universo”. Nel 1799, nel suo Memoriale scritto dall’esilio, il leader della Sarda Rivoluzione, Giovanni Maria Angioy, diceva: “Malgrado la cattiva amministrazione, l’insufficienza della popolazione e tutti gli intralci che ostacolano l’agricoltura, il commercio e l’industria, la Sardegna abbonda di tutto ciò che è necessario per il nutrimento e la sussistenza dei suoi abitanti. Se la Sardegna in uno stato di languore, senza governo, senza industria, dopo diversi secoli di disastri, possiede così grandi risorse, bisogna concludere che ben amministrata sarebbe uno degli stati più ricchi d’Europa”. Queste parole di fiducia forse suonano lontane. E ancor più lontano suona forse il loro presupposto: “testimoniare pubblicamente l’attaccamento alla patria”, contribuire alla “felicità della Nazione sarda”, fare della Sardegna uno Stato d’Europa. Il punto non è risolvere la distanza fra noi e quel passato in un giorno, tantomeno con un discorso. Il punto è non aver paura a ricordare queste parole e quello spirito, anche queste parole e quello spirito, per cui tanti sacrificarono la loro vita. Se avremo la forza di fare i conti, da domani, nel nostro concreto operare – come Governo, come Parlamento, come classe dirigente, come società sarda nella sua interezza -, con questo lascito, allora apriremo davvero una via, difficile ma necessaria, ad una diversità consapevole, effettiva, produttiva. In altre parole, mentre celebriamo, abbiamo l’occasione di domandarci se sia meglio proseguire con una storia di rivendicazione, in cui noi sardi chiediamo ad altri di farsi carico dei nostri problemi e delle loro soluzioni, o se non sia il caso di entrare in una fase di reale autodeterminazione, in cui plasmare una nuova politica sarda, in cui costruire con tutta la passione e l’intelligenza possibile delle istituzioni al pieno servizio dei sardi e della Sardegna. Il primo modo per cambiare la propria storia è raccontarla in modo diverso. È raccontarci in modo diverso. Anche a costo di mettere in discussione quegli stereotipi e quell’orgoglioso senso di identità che dietro un velo di confortante abitudinarietà nasconde la difficoltà a darsi valori alti e obbiettivi chiari. Motivi di unità. Motivi per avanzare. Da troppo tempo siamo intrappolati in un racconto che è “contro”. Un racconto in cui altri hanno il potere di decidere della nostra vita e a noi non rimane che ribellarci per rivendicare un trattamento meno opprimente. Ma questa non è la nostra storia. Non è l’unica che il nostro passato ci ha lasciato in eredità. Non è la migliore che possiamo raccontare a noi stessi e, soprattutto, ai nostri figli e alle nostre figlie. C’è una storia di autodeterminazione tutta da scrivere, tutta da fare. E allora quando cantiamo le strofe di ‘Su patriota sardu a sos feudatarios”, scritto da Francesco Ignazio Mannu nel 1795, durante i moti rivoluzionari e dal 2018 inno della Sardegna,

 andiamo oltre la rivendicazione e sforziamoci di costruire, progettare, inventare ciò che vogliamo la nostra isola diventi.
andiamo oltre la rivendicazione e sforziamoci di costruire, progettare, inventare ciò che vogliamo la nostra isola diventi.




Sa Die de Sa Sardigna è l’occasione per ricordarlo a noi stessi.
—————————-

- Su La Nuova Sardegna.
Europa, Europa

Europa, Europa: dove vai?
Alfonso Gianni
La costruzione di un sistema di guerra nella Ue
Ora se nel mondo c’è una cosa che conviene affrontare con esitazione – ma che dico, che bisogna in tutti i modi evitare, scongiurare, tenere lontana – di sicuro è la guerra: non c’è iniziativa più empia e dannosa, più largamente rovinosa, più persistente e tenace, più squallida e nell’insieme più indegna di un uomo, per non dire di un cristiano. Invece – chi lo crederebbe? – oggi si entra in guerra di qua, di là, dappertutto, con estrema leggerezza, per le ragioni più futili; e la condotta di guerra è caratterizzata da un’estrema crudeltà e barbarie.
Erasmo da Rotterdam
Sono trascorsi cinque secoli abbondanti da quando le parole del grande intellettuale olandese, poste in esergo, uscirono a stampa dai torchi di Aldo Manuzio. Se può esserci ancora qualche dubbio sulla validità delle teorie sul progresso più o meno lineare della civiltà umana, la loro falsificazione trova conferma nei terribili avvenimenti di questi ultimi mesi. La guerra continua, si incancrenisce e si allarga. I vari pezzetti della guerra mondiale descritta da papa Francesco, si congiungono tra loro in un mostruoso puzzle. Da ultimo Israele conduce un attacco “mirato” contro il consolato iraniano a Damasco, uccidendo comandanti dei “guardiani della rivoluzione”; l’Iran riempie il cielo di droni e missili; aerei statunitensi, francesi e britannici, unitamente a quelli israeliani, si alzano in volo per abbatterli. Nel contempo la guerra “dimenticata” in Sudan assomma un bilancio di 12mila morti e oltre sette milioni di sfollati. Ogni appello alla moderazione, per non dire alla trattativa e alla pace, viene immediatamente travolto, per quanto sia alto lo scranno dal quale è stato rivolto.
L’anonima sentenza latina, Si vis pacem para bellum, che ingenuamente consideravamo ormai persino impensabile, esce con sempre maggiore frequenza dalla bocca dei leader europei. Fra questi non poteva mancare Giorgia Meloni che ha voluto fare sfoggio di cultura, pronunciandola nel febbraio del 2022, pochi giorni dopo l’invasione russa dell’Ucraina, davanti ad una platea di conservatori riuniti in Florida per l’annuale Conservative Political Action Conference (Cpac), per poi ripeterla in altre più recenti occasioni nella veste di Presidente del Consiglio. La stessa frase, per quanto abusata, è stata utilizzata dall’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrel, nel commentare il documento conclusivo emerso dal Consiglio europeo del 21-22 marzo. E non si può certo dire che si sia trattato di un uso improprio.
Per quanto trita e ritrita la vecchia sentenza è in grado di fare da sintesi di quanto si è detto e deciso in quella riunione, che può ben dirsi essere propria di un Consiglio di guerra. Una riunione, cui seguirà quella di metà aprile dedicata ai temi dell’economia, che è solo un passaggio dentro una escalation di decisioni e comportamenti che conducono l’Europa in un’unica direzione: la guerra. Il passaggio da una “guerra grande” – come l’ha denominata Limes -, da una guerra “allargata” – come l’ha definita Alberto Negri guardando al teatro mediorientale – dalla più volte citata guerra mondiale a pezzetti secondo la celebre definizione di papa Francesco, ad una guerra globale vera e propria, tale da non escludere l’uso di armi nucleari, non è più solo una distopia.
Le conclusioni del Consiglio europeo
Quanto deciso nel recente Consiglio europeo non basta. Lo ha detto con chiarezza il premier polacco Donald Tusk, uscito vincitore dalle elezioni dello scorso ottobre, che in una intervista rilasciata a diversi quotidiani europei, fra cui un quotidiano italiano, avverte che la guerra è “alle porte”, che per la prima volta dal 1945 non è più un concetto del passato ma è un fatto “reale”, che dunque “dobbiamo abituarci mentalmente all’arrivo di una nuova era. L’era prebellica.” Rispetto alla quale però la Ue non è ancora pronta e quindi bisognerebbe fare di più, anche rispetto alle decisioni del Consiglio europeo di marzo.
Eppure quelle decisioni non sono lievi. Basta scorrere il documento conclusivo per accorgersene, al di là di qualche espressione retorica o fumosa, che appare proprio per questo inquietante per quello che può nascondere e per quello che ci aspetta. Per quanto riguarda il fronte russo-ucraino il testo non fa il pur minimo accenno alla possibilità di cessare il fuoco, di aprire una trattativa, di muoversi in una direzione di pace. Quest’ultimo termine non compare mai, se non con un significato completamente stravolto, si potrebbe dire, con ironico cinismo. Infatti il Consiglio europeo chiede di lavorare all’ottavo pacchetto di sostegno per l’Ucraina nell’ambito dello strumento europeo per la pace. Invita a prendere in considerazione la possibilità di “destinare a beneficio dell’Ucraina, compresa la possibilità di finanziare il sostegno militare, le entrate straordinarie derivanti dai beni russi bloccati”, quindi superando i dubbi sollevati anche da commentatori mainstream sul rischio che un simile atto porti un indesiderato scompiglio nelle “regole” che tutelano il mercato e il movimento dei capitali. Spinge per un rafforzamento ed una piena attuazione delle sanzioni alla Russia, anche colpendo paesi terzi che ne facilitano l’elusione. Pur nella impossibilità di impedirlo totalmente – rendendosi conto della complessità e dell’intreccio degli interessi economici in gioco – il documento raccomanda di limitare “al massimo” l’accesso della Russia “a prodotti e tecnologie sensibili che hanno rilevanza nel campo di battaglia”. Ribadisce la richiesta agli Stati membri di aumentare la spesa militare. Prospetta apertamente l’utilizzo della Banca europea per gli investimenti per fornire risorse e strumentazione finanziaria al fine di supportare l’ingente aumento delle spese belliche.
Come si vede le previsioni e gli strumenti di intervento economico si concentrano sulle spese militari. Con un facile, quanto terribile, scambio di consonanti, i famosi Eurobond, di cui si era tanto parlato, si tramutano di colpo in Eurobomb. E’ l’intero sistema delle imprese europee che deve rispondere alle nuove esigenze belliche. Lo chiariscono in particolare tre punti importanti sottolineati dal documento conclusivo. Il primo riguarda l’incentivazione della “ulteriore integrazione del mercato europeo della difesa in tutta l’Unione, agevolando l’accesso alle catene di approvvigionamento della difesa, in particolare per le Pmi e le società a media capitalizzazione, riducendo la burocrazia”. Il secondo punto riguarda la necessità di “garantire che la regolamentazione dell’Ue non costituisca un ostacolo allo sviluppo dell’industria della difesa”. Il terzo invita a “investire nella manodopera qualificata per fare fronte alle prevalenti carenze di manodopera e di competenze nell’industria della difesa”. Quindi via tutti i rimanenti lacci e lacciuoli ed ogni regolamentazione d’impaccio al fare presto se non subito. Il tutto – si preoccupano di precisare gli estensori del documento – deve risultare “complementare alla Nato, che rimane il fondamento della difesa collettiva per i suoi membri”
Come era considerata nel mondo la Ue
La puntualizzazione è tutt’altro che rituale, anche perché la costruzione di un simile sistema di guerra europeo mal si acconcia con la definizione un po’ riduttiva di Wolfgang Streeck per cui l’Ue sarebbe semplicemente “un ausiliario economico della Nato”. Appare più convincente dal punto di vista dell’analisi dinamica delle forze in campo la conclusione cui perviene Lucio Caracciolo e cioè che il ruolo della Nato e quello della Ue tendono negli ultimi anni a sovrapporsi, come risulta ancora più evidente in relazione al conflitto russo-ucraino. L’una prepara il terreno per l’avanzata dell’altra e viceversa. Anche se lascia un po’ straniti l’idea che Caracciolo ha recentemente avanzato, quella di “un’intesa bilaterale speciale fra Italia e Stati Uniti” al fine di tenere il nostro paese “sopra la linea di galleggiamento durante la Guerra Grande e prefigurare equilibri meno instabili nell’immediato dopoguerra”. Una idea che lo stesso autorevole direttore di Limes definisce “controintuitiva” e rispetto alla quale sollecita egli stesso “critiche e controproposte”. Ma prima è forse opportuno fare qualche passo indietro.
Certamente la guerra russo-ucraina non ha solo risuscitato la Nato da una condizione che aveva autorizzato Macron a stilare un affrettato certificato di morte cerebrale, ma ha messo in moto un’accelerazione dell’armamento europeo ad ogni livello. Tuttavia sarebbe sbagliato cogliere solo la tempistica di quest’ultima vigorosa corsa alle armi e non vederne i passaggi precedenti, pur se più lenti nel loro svolgersi, nel corso dei quali l’Ue è riuscita persino ad abbattere l’immagine che si era fatta nel mondo. Anche se si trattava di un’immagine più dettata da un forte wishful thinking che da una rigorosa analisi del processo di costruzione dell’Unione europea.
Per un non breve periodo in America latina molti vedevano nell’Europa la proiezione dei propri desideri di costruire l’utopia bolivariana, dove contrasti e confini sarebbero stati superati da intese politiche ed economiche nel nome del Sud del mondo. Se ne ha prova leggendo, in un recente libro, le parole dell’ex presidente uruguayano José “Pepe” Mujica, che manifesta il suo stupore e il suo spavento per l’impotenza dell’Europa di fronte al conflitto russo-ucraino: “Quello che più mi spaventa è l’impotenza dell’Europa, che è diventata un polo senza alcun potere decisionale autonomo. È incredibile. Ovviamente, la pace in Europa avrebbe dovuto includere la Russia e non segregarla, e invece quello che hanno fatto è stato spingerla dall’altra parte, la stanno regalando alla Cina. Da un punto di vista geopolitico, sono dei salami [ride], dei salami… Sì. Sono sbalordito dal declino politico dell’Europa, al punto da guardare con «nostalgia», tra virgolette, ai vecchi conservatori europei, che almeno vedevano un po’ più lungo e avevano un po’ più di dignità. Proprio come De Gaulle, il quale pensava che l’Europa dovesse arrivare fino agli Urali e intuì che un processo di pace doveva inevitabilmente includere anche la Russia all’interno dell’Europa. La stupida rottura da parte della Nato del Patto di Varsavia fu un passo privo della benché minima lungimiranza politica. Penso anche che, dietro tutto questo, vi sia una sorta di duello in cui gli Stati Uniti temono di perdere la supremazia a favore della Cina.”
Le radici del processo di militarizzazione europeo
E’ bene quindi non dimenticare che l’attuale fase di intensa militarizzazione della Ue che stiamo attraversando in questo sciagurato presente, affonda le sue radici in alcune tappe fondamentali che hanno determinato la costituzione materiale dell’unità europea. Una buona e non trascurabile parte del prolisso Trattato di Maastricht del 1992 è costituita dalla cosiddetta nuova Politica estera di sicurezza comune (Pesc). Una manciata di anni dopo, il Trattato di Amsterdam istituì il ruolo di Alto rappresentante per la Pesc. Il primo a ricoprire tale carica fu Javier Solana, che la condusse per dieci anni fino al 2009, dopo essere stato Segretario generale della Nato tra il 1995 e il 1999, incarnando così la fluidità delle cariche apicali fra Ue e Nato.
Il vero banco di prova delle effettive capacità della Ue di intervenire sullo scenario internazionale per mettere in atto quei principi e quei valori di pace, libertà, giustizia e democrazia così enfaticamente richiamati nei suoi atti costitutivi e ancor più nelle dichiarazioni dei suoi massimi esponenti, furono senz’altro le tragiche vicende dei Balcani a cavallo del secolo. E fu un disastro. Le parole di Perry Anderson esprimono un giudizio tanto severo quanto giusto e inequivocabile: “Beneficiaria della Pax americana piuttosto che progenitrice della stessa, l’Unione ha affrontato la sua prima prova come vero e proprio custode della pace in Europa dopo la guerra fredda. Fallì miseramente, non impedendo ma alimentando la guerra nei Balcani, poiché la Germania appoggiò la secessione slovena dalla Jugoslavia, il colpo che innescò i successivi conflitti omicidi che la Ue, trascinata sulla scia di Helmut Kohl, si dimostrò incapace di moderare o di far cessare. Ancora una volta non è stata Bruxelles, ma Washington a decidere finalmente il destino della regione. Anche l’allargamento dell’Unione agli ex paesi del Patto di Varsavia, la sua grande conquista storica, ha seguito le orme degli Stati Uniti, la loro inclusione nella Nato prima del loro ingresso nella Ue”
I bombardamenti sulla Serbia
Infatti l’intervento aereo contro la Serbia costituì una rottura delle già fragili regole che in qualche modo caratterizzavano l’ordine mondiale di allora. A tal punto che un fine giurista come Luigi Ferrajoli poteva mettere in fila tutte le violazioni che venivano commesse nei confronti di Costituzioni, Trattati, Carte costitutive, Convenzioni, fino a profilare una sorta di colpo di stato internazionale: “Innanzitutto la violazione della Costituzione italiana che all’articolo 11 bandisce la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e all’articolo 78 richiede che la guerra (di difesa) sia deliberata dalle Camere. In secondo luogo la violazione della Carta dell’Onu, che non solo vieta la guerra ma prescrive ‘mezzi pacifici’ volti ‘a conseguire la composizione e la soluzione delle controversie internazionali, a cominciare dal negoziato ad oltranza … In terzo luogo la violazione del trattato istitutivo della Nato, che configura l’alleanza come esclusivamente difensiva e vincolata alla carta dell’Onu … In quarto luogo [la violazione] dello statuto della Corte penale internazionale … Infine le violazioni delle convenzioni di Ginevra, in base alle quali sono crimini di guerra i bombardamenti delle popolazioni civili”.
Tutto ciò, è bene ribadirlo, non sarebbe potuto avvenire senza la direzione diretta, non solo supervisione, da parte degli Usa. Come ha giustamente sottolineato Domenico Gallo “Il retroterra dell’attacco dell’Alleanza atlantica alla Serbia, scattato il 24 marzo 1999, era costituito dal nuovo ruolo strategico militare che gli Stati Uniti avevano concepito per la Nato dopo la fine della Guerra fredda”.
Per quanto riguarda il nostro paese il via libera all’utilizzo delle basi italiane per il decollo dei bombardieri, venne offerto dal governo D’Alema. L’insieme dell’operazione venne guidata da Francesco Cossiga che riteneva che la sinistra, quella rappresentata allora dai Ds, avrebbe fatto cose che neppure la destra avrebbe potuto compiere senza provocare e attirarsi contro, se non una sollevazione popolare, certamente una lunga e forte contrapposizione nelle istituzioni e soprattutto nelle piazze. Lo dice esplicitamente Carlo Scognamiglio, allora ministro della Difesa, in una dichiarazione a un quotidiano, in polemica con James Rubin, ex portavoce di Madeleine Albright : “A Rubin sfugge che in Italia avevamo dovuto cambiare governo proprio per fronteggiare gli impegni politico-militari che si delineavano … Prodi ad ottobre aveva espresso una disponibilità di massima all’uso delle basi italiane, ma per la presenza di Rifondazione nella sua maggioranza non avrebbe potuto impegnarsi in azioni militari. Per questo il senatore Cossiga ed io ritenemmo che occorreva un accordo chiaro con l’on. D’Alema” e l’accordo in sintesi si articolava in due parti: “la prima era il rispetto dell’impegno per l’euro […] la seconda era il vincolo di lealtà alla Nato: l’Italia avrebbe dovuto fare esattamente ciò che la Nato avrebbe deciso di fare”. E così fu.
La guerra dei Balcani convinse le elite europee che era necessario imprimere una nuova svolta nel campo della difesa comune, naturalmente senza uscire dal quadro della sudditanza nei confronti della Nato e degli Usa. Così nel 2004 nasce L’Agenzia europea per la difesa (Aed), attualmente presieduta da Josep Borrel con sede a Bruxelles, il cui compito è quello di permettere ai 27 Stati membri dell’Ue di sviluppare le loro risorse militari, di stabilire accordi anche con paesi extra Ue (come è avvenuto per Norvegia, Serbia, Svizzera e Ucraina), avendo concluso un accordo amministrativo con il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti che prevede una maggiore cooperazione transatlantica nel campo della difesa in settori specifici, compreso lo scambio di informazioni. [segue]
Promesse non mantenute
 Questa sera ci siamo recati a Sant’Elia per controllare se il Comune di Cagliari avesse provveduto a installare il cartello stradale della piazzetta Franco Oliverio, come promesso dall’Assessore uscente Alessio Mereu: niente di niente. Ci rivolgeremo alla Commissaria straordinaria dott.ssa Luisanna Marras. Confidiamo sulla sua sensibilità.
Questa sera ci siamo recati a Sant’Elia per controllare se il Comune di Cagliari avesse provveduto a installare il cartello stradale della piazzetta Franco Oliverio, come promesso dall’Assessore uscente Alessio Mereu: niente di niente. Ci rivolgeremo alla Commissaria straordinaria dott.ssa Luisanna Marras. Confidiamo sulla sua sensibilità.
Ite remiras o partigianu

 Successo di pubblico e di critica della manifestazione teatrale e musicale “Ite remiras o partigianu”, promossa dall’ANPI e dalla CGIL in occasione della Festa di Liberazione del 25 aprile. Testi di Gianni Loy, regia di Cristina Maccioni, con le letture di Lia Careddu, Stefano Ledda, Gisella Vacca, con la partecipazione del Coro Città di Cagliari, diretto dal maestro Fabrizio Cungui. Per gentile concessione dell’Autore Gianni Loy di seguito pubblichiamo il secondo capitolo del testo della piece. A corredo alcune foto tratte dal servizio fotografico di Dietrich Steinmetz, che ringraziamo, pubblicato sulla sua pagina fb. Al termine dell’evento sono intervenute Simona Fanzecco, segretaria provinciale della CGIL e Lidia Roversi, ANPI Cagliari.
Successo di pubblico e di critica della manifestazione teatrale e musicale “Ite remiras o partigianu”, promossa dall’ANPI e dalla CGIL in occasione della Festa di Liberazione del 25 aprile. Testi di Gianni Loy, regia di Cristina Maccioni, con le letture di Lia Careddu, Stefano Ledda, Gisella Vacca, con la partecipazione del Coro Città di Cagliari, diretto dal maestro Fabrizio Cungui. Per gentile concessione dell’Autore Gianni Loy di seguito pubblichiamo il secondo capitolo del testo della piece. A corredo alcune foto tratte dal servizio fotografico di Dietrich Steinmetz, che ringraziamo, pubblicato sulla sua pagina fb. Al termine dell’evento sono intervenute Simona Fanzecco, segretaria provinciale della CGIL e Lidia Roversi, ANPI Cagliari.

(…)
2. Giaime era sardo.
Giaime era sardo. Aveva trascorso l’adolescenza nelle pendici di Cagliari, giocando con le cerbottane con Luigi, suo fratello maggiore, prima di volare nel continente per dare sfogo alla sua vocazione letteraria.
Mi sono chiesto cosa avrebbe potuto fare Giaime, se il 1° dicembre del 1943 non fosse stato dilaniato da una mina, a Castelnuovo al Volturno. Quel giorno, Giaime cercava di attraversare le linee tedesche per raggiungere le organizzazioni partigiane che operavano nel Lazio. Ma i tedeschi, proprio il giorno prima, avevano minato l’area lungo il Garigliano. Solo che Giaime non poteva saperlo. E così è morto, a 24 anni.
Ma perché Giaime – Giaime Pintor – si trovava lì, quella notte, in compagnia di un gruppo di giovani, con la missione di portare ai rifugiati laziali armi e istruzioni?
In occasione del 25 aprile ricordiamo Franco Boi
 Nella manifestazione del 25 aprile abbiamo sentito tutti l’assenza del compagno e amico Franco Boi, morto di recente. E’ stato ricordato dal palco e la piazza ha risposto con un caloroso e prolungato applauso. Lo ricordiamo con commozione e affetto.
Nella manifestazione del 25 aprile abbiamo sentito tutti l’assenza del compagno e amico Franco Boi, morto di recente. E’ stato ricordato dal palco e la piazza ha risposto con un caloroso e prolungato applauso. Lo ricordiamo con commozione e affetto.
Castello sorcesco: una storia infinita…
 Su L’Unione Sarda di oggi Andrea Artizzu riprende la questione del cd “castello sorcesco”, ricuperato dopo una annosa e costosa ristrutturazione, ma rimasto inutilizzato ormai da molti anni. Su questa incredibile vicenda siamo intervenuti più volte su Aladinpensiero, come testimoniano gli articoli sotto linkati. Il problema vero è che Cagliari non dispone di un regolamento sulla cogestione dei beni comuni urbani da parte dei cittadini organizzati nelle associazioni di partecipazione civica. Risolverà la questione la prossima amministrazione? Ce lo auguriamo, intanto lo poniamo come argomento della campagna elettorale per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Cagliari. Come ripete senza stancarsi il prof. Ivan Blečić dell’Università di Cagliari: nella nostra città ci sono tanti spazi in cerca di utilizzazione e tante associazioni in cerca di spazi da utilizzare. Si tratta di adottare gli strumenti regolamentari per fare incontrare queste esigenze. Al riguardo sarebbe utile e opportuna una legge regionale per la promozione dell’amministrazione condivisa dei beni comuni (vedasi la legge del Lazio). Ci vuole soprattutto una coerente volontà politica risolutiva della questione.
Su L’Unione Sarda di oggi Andrea Artizzu riprende la questione del cd “castello sorcesco”, ricuperato dopo una annosa e costosa ristrutturazione, ma rimasto inutilizzato ormai da molti anni. Su questa incredibile vicenda siamo intervenuti più volte su Aladinpensiero, come testimoniano gli articoli sotto linkati. Il problema vero è che Cagliari non dispone di un regolamento sulla cogestione dei beni comuni urbani da parte dei cittadini organizzati nelle associazioni di partecipazione civica. Risolverà la questione la prossima amministrazione? Ce lo auguriamo, intanto lo poniamo come argomento della campagna elettorale per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Cagliari. Come ripete senza stancarsi il prof. Ivan Blečić dell’Università di Cagliari: nella nostra città ci sono tanti spazi in cerca di utilizzazione e tante associazioni in cerca di spazi da utilizzare. Si tratta di adottare gli strumenti regolamentari per fare incontrare queste esigenze. Al riguardo sarebbe utile e opportuna una legge regionale per la promozione dell’amministrazione condivisa dei beni comuni (vedasi la legge del Lazio). Ci vuole soprattutto una coerente volontà politica risolutiva della questione.
- Una storia infinita 27/11/2019: https://www.aladinpensiero.it/?p=102385;
- Università e beni comuni: https://www.aladinpensiero.it/?p=102369.
———————————————
Agostino Frate Francescano Conciliare
 Agostino, uomo di Dio, frate francescano al servizio delle donne e degli uomini della nostra Terra.
Agostino, uomo di Dio, frate francescano al servizio delle donne e degli uomini della nostra Terra.
Gli amici di padre Agostino Pirri, OFM (17/4/1930 – 21/6/2023), propongono una serata in suo ricordo, venerdì 28 giugno 2024, alle ore 17 – 19,30 presso la sala convegni della Fondazione di Sardegna a Cagliari. in via San Salvatore da Horta 1.
Organizzazione: Fondazione di Sardegna – Amici sardi della Cittadella Laudato si’ di Assisi – Aladinpensiero News online – Gulp Cagliari.



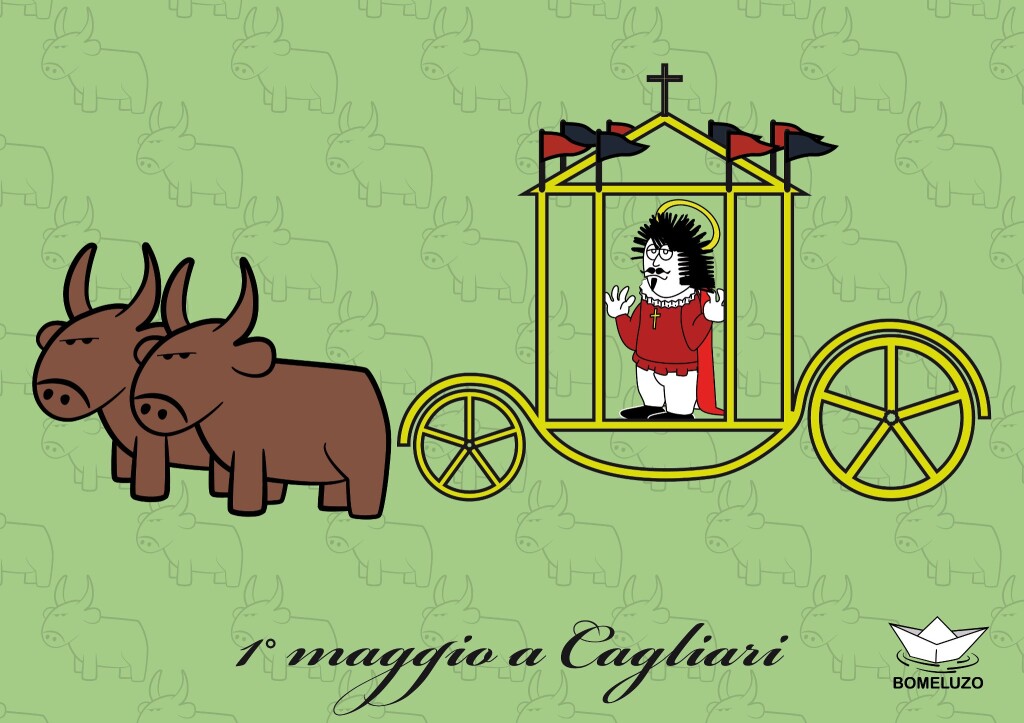





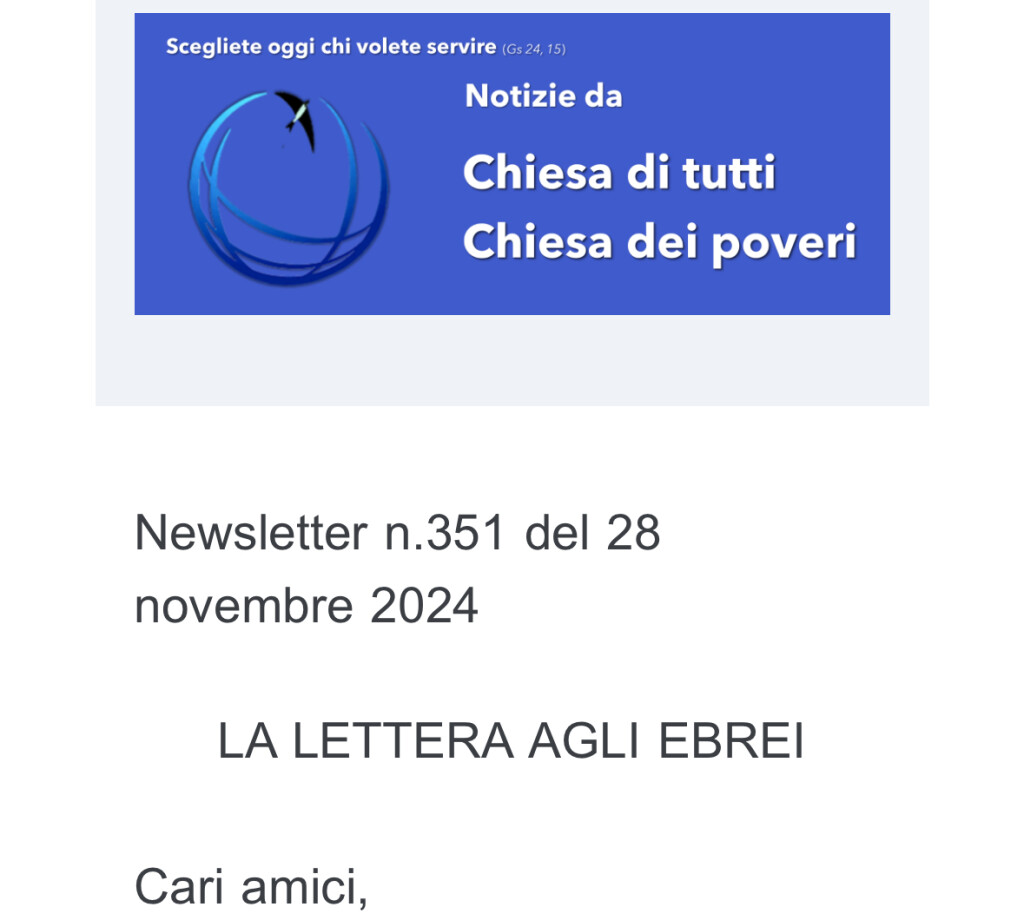









 AService Studio
AService Studio