SARDEGNA
FRANCESCO CILOCCO: un grande eroe e patriota sardo, sconosciuto e dimenticato. Est ora de l’amentare!
 Francesco Cilocco, un eroe dimenticato. Patriota ed eroe nazionale sardo (Cagliari 1769 –Sassari 1802).
Francesco Cilocco, un eroe dimenticato. Patriota ed eroe nazionale sardo (Cagliari 1769 –Sassari 1802).
di Francesco Casula
Figlio di Michele e fratello di Antonio, poi implicato nella Rivolta di Palabanda. Notaio della Reale Udienza. Repubblicano convinto, pur avendo combattuto contro i rivoluzionari francesi nel 1793, per difendere Cagliari e la Sardegna dalla loro aggressione e tentativo di conquista. Fu seguace e amico di Giovanni Maria Angioy e, insieme a lui protagonista nelle lotte e nelle ribellioni antifeudali e nazionali dei Sardi contro il feudalesimo e il dominio tirannico e poliziesco dei Savoia. Nel novembre del 1795, col notaio Antonio Manca e con l’avvocato Giovanni Falchi, seguaci dell’Angioy, fu inviato dagli Stamenti nel Capo di Sopra, per la pubblicazione e diffusione, nei villaggi, del pregone viceregio del 23 ottobre che contraddice la circolare del governatore di Sassari Santuccio del 12 dello stesso mese, che ordinava di sospendere tutti gli ordini provenienti da Cagliari. Un vero e proprio tentativo “secessionista” del governatore stesso e dei baroni, che avevano la loro roccaforte proprio a Sassari. “L’invio dei tre commissari, secondo la Storia dei torbidi, ripresa dal Manno, è preceduta da una riunione a Cagliari alla quale prendono parte, oltre ai «capi cagliaritani della congiura» anche gli avvocati Mundula e Fadda di Sassari e altri «innovatori» sassaresi, in tale riunione si stabiliscono le linee d’azione per il futuro: mobilitazione dei villaggi del Logudoro, assedio di Sassari, arresto dei reazionari, loro traduzione a Cagliari”(1). Nonostante il viceré, venuto a conoscenza del piano, cerchi di dissuadere Cilocco dal pubblicare e diffondere il pregone, il Nostro non solo lo pubblica e lo diffonde ma diviene l’anima dei moti, insieme agli altri due commissari, Manca e Falchi, riuscendo a coinvolgere e mobilitare nella sua battaglia antifeudale non solo il popolo (contadini e villici in genere), particolarmente colpito dalla scarsità dei raccolti negli anni 1793-95, ma anche settori della piccola nobiltà e del clero: di qui la partecipazione alle lotte antifeudali di numerosi sacerdoti come i parroci Gavino Sechi Bologna (rettore di Florinas), Aragonez (rettore di Sennori), Francesco Sanna Corda (rettore di Torralba) e Francesco Muroni, (rettore di Semestene) che “conoscevano le miserie e talvolta subivano le stesse angherie dai baroni e dai loro ministri” (2). Annota inoltre lo storico Girolamo Sotgiu che “direttamente investiti dalla massa degli zappatori affamati, i proprietari coltivatori, che costituiscono l’altro cardine della società rurale, sollecitavano anch’essi la fine del sistema feudale. Anche i proprietari coltivatori erano notevolmente aumentati come aumentata era la produzione complessiva. Ma a questo aumento della produzione non aveva fatto riscontro un aumento del benessere, proprio per gli impedimenti posti dal sistema feudale”(3).Di qui la lotta antifeudale e antibaronale ma anche di liberazione nazionale. Racconta Francesco Sulis che “Il Ciloccco nel villaggio di Thiesi intesosi con Don Pietro Flores amico dell’Angioy, da un terrazzo della Casa Flores eccitò quelli popolani a insorgere contro i feudatari; e di subito essi tennero l’invito, ed a furia, con tutta sorta di stromenti percotendo le mura del palazzo feudale, lo rovinarono e l’adequarono al suolo”(4) A Osilo, Sedini e Nulvi, tre centri dell’Anglona i vassalli si rifiutarono di pagare i diritti feudali. Mentre a Ittiri, Uri, Thiesi, Pozzomaggiore e Bonorva e ad Ozieri e Uri i contadini s’impossessarono dei granai dei feudatari. Una lotta che assume però anche caratteri più squisitamente politici, prefigurando in qualche modo un nuovo ordine e una nuova organizzazione sociale, attraverso una trasformazione non violenta dell’assetto esistente. Sempre a Thiesi infatti, il 24 novembre davanti al notaio Francesco Sotgiu Satta le ville di Thiesi, Bessude e Cheremule, del marchesato di Montemaggiore, appartenente al duca dell’Asinara, con sindaci, consiglieri, prinzipales, capi famiglia, firmano il primo atto confederativo, cui seguirono nei mesi successivi altri patti d’alleanza. E con esso giurano di non riconoscere più alcun feudatario, ma anche di voler “ricorrere prontamente a chi spetta per essere redenti pagando a tal effetto quel tanto, che da’ Superiori sarà creduto giusto e ragionevole”(5). I cosiddetti “strumenti di unione” ovvero “patti” fra ville e paesi segnano un salto di qualità della lotta antifeudale, facendole assumere una cifra più squisitamente politica: le federazioni di comunità infatti assurgono al ruolo di soggetto primario, di protagonista fondamentale nell’evoluzione sociale dell’Isola. Esse si moltiplicano e si diffondono in tutto il Sassarese: dopo quelli del 24 novembre se ne stipula un altro a Thiesi il 17 marzo 1796 fra i rappresentanti di 32 paesi fra i quali Bonorva, Ittiri, Osilo, Sorso, Mores, Bessude, Banari, Santu Lussurgiu, Semestene e Rebeccu. “Il patto – scrive Vittoria Del Piano – vincola le popolazioni a spendere fin l’ultima goccia di sangue, piuttosto che obbedire in avvenire ai loro baroni” (6). Lo sbocco di questo ampio movimento, autenticamente rivoluzionario e sociale, perché metteva radicalmente in discussione i capisaldi del sistema vigente nelle campagne, fu l’assedio di Sassari. A migliaia – 13 mila secondo le fonti ufficiali e secondo Francesco Sulis, un esercito di contadini armati, proveniente dal Logudoro ma anche dal Meilogu e da paesi più lontani, accorse a Sassari, stringendola d’assedio. Secondo invece lo storico Giuseppe Manno “Sommavano quegli armati a meglio di tremila, non numerando le donne che in copioso numero erano venute anch’esse a guerra, o per assistere i congiunti o per comunione d’odio ed eransi partiti da Osilo, Sorso, Sennori, Usini, Tissi, Ossi, Thiesi, Mores, Sedilo, Ploaghe e altri luoghi posti in quelle circostanze”(7). Il numero di tremila è poco credibile: vista la massiccia e ubiquitaria mobilitazione soprattutto dei paesi del Logudoro e dell’Anglona ma anche del Meilogu, del Goceano e non solo. Il Manno, storico conservatore e filosavoia, tende a minimizzare e sminuire l’ampiezza, l’organizzazione e la qualità di una lotta di migliaia e migliaia di contadini, uomini e donne, che dopo secoli di rassegnazione, usi a chinare il capo e a curvare la schiena, si ribellano, si armano per dire basta e per porre fine a un duro stato di servitù, di rapina e di sfruttamento inaudito. Il Manno non è dunque credibile. La sua, più che una Storia della Sardegna è infatti una Storia regia della Sardegna. E non è un caso che il magistrato sassarese Ignazio Esperson nei suoi Pensieri sulla Sardegna dal 1789 al 1848, definisca il Manno “l’antesignano della scuola delle penne partigiane e cortigianesche che vergognano le patrie storie”. A migliaia, comunque, al di là del numero, a piedi e a cavallo circondarono Sassari, pare al canto di Procurade ‘e moderare, Barones, sa tirannia di Francesco Ignazio Mannu. Così l’esercito dei contadini, guidato dal Cilocco e da Gioachino Mundula, costrinse la città alla resa dopo uno scambio di fucilate con la guarnigione. Quindi, mentre il famigerato duca dell’Asinara, il conte d’Ittiri e alcuni feudatari, erano riusciti a scappare precipitosamente in tempo, prima dell’assedio, rifugiandosi in Corsica prima e nel Continente poi, Cilocco e Mundula arrestarono il governatore don Antioco Santuccio e l’arcivescovo Giacinto Vincenzo Della Torre, portandoli a Cagliari verso cui si dirigono con 500 uomini armati. Gli Stamenti d’accordo col viceré, per porre rimedio alla piega, secondo loro pericolosa e “sovversiva” che avevano preso gli avvenimenti, inviarono loro incontro altri tre commissari, che li raggiunsero con un manipolo di guardie il 4 gennaio 1796 a Oristano, ed ingiunsero loro dì liberare gli ostaggi e rimandare ai villaggi d’origine i loro uomini, nel frattempo ridottisi di numero. Ad un primo rifiuto, due giorni dopo, a Sardara, i commissari viceregi risposero con un atto di forza. Cilocco, per paura di essere arrestato, consegna il governatore Santuccio e l’arcivescovo Della Torre ai tre inviati del vicerè: l’avvocato Ignazio Musso, l’abate Raffaele Ledà e Efisio Luigi Pintor Sirigu, ex democratico, uno dei protagonisti della cacciata dei Piemontesi da Cagliari il 28 aprile 1794, ma ormai “pentito” e da vero e proprio voltagabbana, rientrato, opportunisticamente, in cambio di onori, uffizi e privilegi, nell’alveo filo sabaudo. Era il segnale della svolta moderata che stava maturando negli Stamenti e che avrebbe di lì a poco provocato anche la caduta di Angioy: si concludeva infatti così quella che, a posteriori, sarebbe apparsa come la prova generale della sfortunata marcia di G. M. Angioy. “Non sembra – scrive Bruno Anatra – che il Cilocco facesse parte del gruppo che nel corso dello stesso anno, seguì Angioy nella sua missione a Sassari e nella successiva, rapidamente abortita, spedizione su Cagliari. È certo invece che, appena la repressione da strisciante si fece palese, anche il Cilocco prese la via dell’esilio e raggiunse il gruppo giacobino sardo a Parigi. Di qui, nella convinzione dell’imminenza di una azione francese in direzione della Sardegna, nella primavera del 1799, gran parte di essi si trasferivano in Corsica. Del gruppo faceva parte il Cilocco che nel gennaio 1801 risulta fosse ad Ajaccio” (8). E’ comunque certo che il 21 maggio del 1802 si trasferisce in Corsica, insieme a Mundula, Sanna Corda e altri. Con Sanna Corda in particolare collabora per preparare il progetto di una insurrezione in Sardegna: che avrebbe dovuto contare questa volta – dopo i tentativi sempre falliti di coinvolgere truppe francesi – esclusivamente sui Sardi ancora fedeli ad Angioy e comunque nemici giurati del feudalesimo e dei governanti piemontesi, per fondare una repubblica sarda indipendente. Negli ultimi mesi del 1799 c’era stata la rivolta, sanguinosamente repressa, di Thiesi e Santulussurgiu, segno agli occhi di Cilocco che lo spirito antifeudale nel Logudoro era ancora vivo. E dunque si poteva dare un corso diverso alla storia della Sardegna. Nonostante la monarchia sabauda con i suoi scherani, avesse “già raso al suolo più di un villaggio, inaugurato la forca itinerante, tagliato molte teste, ingalerato a piacimento innocenti e sospetti, seviziato donne e frustato bambini”(9). Essi inoltre contavano, per costituire una solida base di appoggio, sull’irriducibile banditismo dei pastori galluresi. All’uopo presero contatto con un famigerato bandito e contrabbandiere, Pietro Mamia, e per suo tramite con i pastori del circondario di Aggius, prospiciente la sponda corsa. Fu una scelta imprudente e suicida: il Mamia farà il doppio gioco: interessato com’era più a ottenere la cancellazione dei suoi delitti da parte delle autorità galluresi che alla proclamazione della repubblica sarda. Il progetto prevedeva lo sbarco in Gallura che avrebbe dovuto provocare la sollevazione della Sardegna. Un primo tentativo nel maggio 1802 fallì. Ripetuto in giugno con un manipolo di uomini, prevedeva lo sbarco del Sanna Corda ai piedi della torre di Longonsardo (l’attuale Santa Teresa di Gallura) e del Cilocco presso la torre dell’Isola Rossa. La spedizione ebbe un esito tragico: il Sanna Corda che aveva espugnato la torre e alzato la bandiera della libertà, inviando alle autorità galluresi lettere in nome della repubblica francese, fu attaccato da un piccolo corpo di spedizione inviato da La Maddalena e cadde combattendo sotto le mura della torre (19 giugno). Cilocco, tradito da Mamia, cui si era affidato soprattutto per la conoscenza dei luoghi, fu narcotizzato (con un vino oppiato) o, comunque sorpreso nel sonno e consegnato ai soldati inviati da Sassari il 25 luglio del 1802. Secondo Giovanni Siotto Pintor invece, braccato per le campagne, con una taglia sul capo di 500 scudi, fu catturato da numerosi banditi, ecco cosa scrive in proposito “fu fermo da quattordici malandrini intesi a procacciarsi l’impunità, trascinato a d’orso d’asino insino a Sassari, flagellato orribilmente dal boia, afforcato”(10). L’eroe sardo, fu così umiliato (fu infatti messo, sanguinante e pesto, su un asino e fatto entrare prima a Tempio e poi a Sassari, – dopo aver attraversato molti altri paesi sempre sul dorso di un asino – fra la folla accorsa a vedere lo spettacolo e una ciurma di giovinastri prezzolati che fischiavano e gridavano), colpito da una frusta, di doppia suola intessuta con piombo, a tal punto che non può rimanere né in piedi né coricato ma carpone. Una fustigazione deprecata persino da uno storico conservatore come il Manno che scrive ”alla mano del manigoldo non fu lasciato l’arbitrio di quella naturale umanità che poteva sorgere anche nel cuore di un carnefice. Egli fu talmente aizzato da quei notabili andategli incontro, che il carnefice stesso ebbe a mostrarsene indispettito. Il barone maggiore soprannominato il Duca dell’Asinara, dal balcone del suo palazzo lanciava parole di crudele beffa contro l’infelice frustato…” La supplica che gli venga comminata la pena del carcere perpetuo o il perpetuo esilio è respinta da Placido Benedetto di Savoia, Conte di Moriana, (fratello del re di Sardegna Carlo Emanuele IV). Cedendo – scrive Carta Raspi – ai suoi istinti sbirreschi. Insieme all’altro fratello, Carlo Felice, vice re e re ottuso e famelico, (sarà soprannominato Carlo Feroce dal poeta e patriota piemontese Angelo Brofferio) l’infame Conte di Moriana ricorrerà dopo il generoso tentativo del Cilocco e del Sanna Corda, a una repressione violenta e brutale nei confronti dei Sardi patrioti, anche vagamente sospettati di aver preso parte alla tentata insurrezione. Il Cilocco fu quindi condannato a morte l’11 agosto del 1802, e il 30 pur disfatto per le torture subite, recuperata la propria lucidità, con animo forte – scrive il Martini – saliva sulla forca. “Non gli fu neppure risparmiata la tortura della corda e delle tenaglie infuocate. Il corpo verrà bruciato e le ceneri saranno disperse al vento, la testa conficcata sul patibolo i beni confiscati” (11). “Questo supplizio – ricorda Fabritziu Dettori in una bella ricostruzione della figura dell’eroe sardo – gli fu inferto con così zelo che dalle spalle e dalla schiena gli aguzzini riuscivano a strappargli la pelle a «lische sanguinanti». Sollevato sul patibolo semi vivo, fu impiccato e, da morto, decapitato. Il suo corpo fu bruciato e le ceneri sparse al vento. Ma la malvagità savoiarda, non sazia, sancì, in tributo alla causa antisarda, che la testa del Patriota sardo fosse rinchiusa dentro una gabbia di ferro ed esposta, a scopo intimidatorio, all’ingresso di «Postha Noba», mentre nelle altre «Porte» della città i lembi della sua carne completavano l’orrore. Il macabro monito rimase esposto per giorni e giorni…” (12). “Giustizia sabauda e spettacolo per la popolazione sassarese che assistè in bestiale gazzarra alla fustigazione e alla impiccagione”(13), commenta amaramente Raimondo Carta Raspi. Macabro ammonimento, aggiungo io, nei confronti dei Sardi, da parte dei più crudeli, spietati, insipienti, famelici e ottusi (s)governanti che la Sardegna abbia avuto nella sua storia, i Savoia. Cilocco aveva 33 anni. Un grande eroe e patriota sardo, sconosciuto e dimenticato, Est ora de l’amentare!
——————-
Note bibliografiche
1. Vittoria Del Piano, Giacobini moderati e reazionari in Sardegna- Saggio di un dizionario biografico 1793-1812, Edizioni Castello, Cagliari 1996, pagina 155.
2. Raimondo Carta Raspi, Storia della Sardegna, Edizioni U. Mursia, Milano 1971, pagina 846.
3. Girolamo Sotgiu, Storia della Sardegna sabauda, (1720-1847), Editori Laterza, Roma-Bari 1984, pagina 193.
4. Francesco Sulis, Dei moti politici dell’isola di Sardegna dal 1793 al 1821, Tip. Nazionale di G. Biancardi, Torino 1857, pagina 64.
5. Luigi Berlinguer, Alcuni documenti sul moto antifeudale sardo del 1795-96, in AA.VV., La Sardegna del Risorgimento, Ed. Gallizzi, Sassari, 1962, pagine 123-124.
6. Vittoria Del Piano, Giacobini moderati e reazionari in Sardegna- Saggio di un dizionario biografico 1793-1812, Edizioni Castello, Cagliari 1996, pagina 156.
7. Giuseppe Manno, Storia moderna della Sardegna-Dall’anno 1773 al 1799, a cura di Antonello Mattone, Ilisso edizioni, Nuoro 1998, pagina 294.
8. Bruno Anatra, Dizionario Biografico degli Italiani, Ed.Treccani, Volume 25 (1981).
9. Eliseo Spiga, La sardità come utopia – Note di un cspiratore, Cuec, Cagliari 2006, pagina 105.
10. Giovanni Siotto Pintor, Storia civile dei popoli sardi dal 1798 al 1848, Casanova, Torino 1887, pagina 45.
11. Vittoria Del Piano, Giacobini moderati e reazionari in Sardegna- Saggio di un dizionario biografico 1793-1812, Edizioni Castello, Cagliari 1996, pagina 159.
12. Fabritziu Dettori, Francesco Cilocco, un eroe dimenticato, in Sotziu Limba sarda, 10-5-2005.
13. Raimondo Carta Raspi, Storia della Sardegna, Edizioni U. Mursia, Milano 1971, pagina 847.
——————————-
Giovanni Maria Angioy
 Un Comitato denominato “SPOSTIAMO LA STATUA DI CARLO FELICE” di Piazza Yenne a Cagliari, propone di sostituire la statua di Carlo Felice con altro monumento idoneo a ricordare invece qualche eroe della lotta per la liberazione del popolo sardo dalle vessazioni dei dominatori succedutisi nei secoli, quale per esempio, lo stesso Giovanni Maria Angioy.
Un Comitato denominato “SPOSTIAMO LA STATUA DI CARLO FELICE” di Piazza Yenne a Cagliari, propone di sostituire la statua di Carlo Felice con altro monumento idoneo a ricordare invece qualche eroe della lotta per la liberazione del popolo sardo dalle vessazioni dei dominatori succedutisi nei secoli, quale per esempio, lo stesso Giovanni Maria Angioy.
Qui di seguito una breve scheda sull’eroe antifeudale, cui io propongo di dedicare una statua che sostituisca quella attuale di Carlo Feroce.
Giovanni Maria Angioy e la fine di un sogno
di Francesco Casula
 - Angioy coltivatore ed imprenditore, professore di diritto canonico, giudice della Reale Udienza.
- Angioy coltivatore ed imprenditore, professore di diritto canonico, giudice della Reale Udienza.
La vita dell’Angioy non è solo una traccia, un frammento, nella storia sotterranea delle longues durées e dei processi di trasformazione che hanno attraversato la società sarda. La sua vicenda politica ed umana assume infatti un valore emblematico perché riflette la parabola di un’intera generazione di sardi, vissuta fra le realizzazioni del cosiddetto «riformismo» (senza riforme) sabaudo, un decennio di sconvolgimenti rivoluzionari e la spietata restaurazione e violenta repressione dei primi anni dell’Ottocento. In quel contesto si inserisce anche l’attività di Angioy, nato a Bono il 21 ottobre 1751, dopo aver studiato a Sassari nel Collegio Campoleno ed essersi addottorato in Legge, nel 1773 a Cagliari inizia la pratica forense.
Imprenditore agrario e manifatturiero oltre che professore di diritto canonico, è un alto funzionario dello Stato (fra l’altro giudice della Reale Udienza) colto ed efficiente oltre che intellettuale aperto agli stimoli e agli influssi dei “lumi” e delle riforme.
Come giudice della Reale Udienza fa parte della Giunta stamentaria costituita di due membri di ciascuno dei bracci parlamentari. Pur rimanendo nell’ombra negli anni delle sommosse cittadine e dei moti antipiemontesi, – anche se il Manno, cercando di metterlo in cattiva luce, insinua che egli tramasse dietro le quinte anche in quelle circostanze e dunque fosse coinvolto nella cacciata dei piemontesi – secondo molti storici sardi – ad iniziare dal Sulis – si affermerebbe come il capo più autorevole del Partito democratico e come l’esponente più importante di un gruppo di intellettuali largamente influenzato dall’illuminismo e dal Giacobinismo: fra i più importanti Gioachino Mundula, Gavino Fadda, Gaspare Sini, il rettore di Semestene Francesco Muroni con il fratello speziale Salvatore, il rettore di Florinas Gavino Sechi Bologna e altri.
- Angioy: “Alternos”
Mentre nel capo di sopra divampa l’incendio antifeudale, con le agitazioni che continuano e si diffondono in paesi e ville del Sassarese, gli Stamenti propongono al viceré Vivalda di nominare l’Angioy alternos con poteri civili, militari e giudiziari pari a quelli del viceré. Il canonico Sisternes si sarebbe poi vantato di aver proposto il nome dell’Angioy per allontanarlo da Cagliari e indebolire il suo partito. Certo è che il suo nome venne fatto perché persona saggia e perché solo lui, grazie al potere e al prestigio che disponeva nonché alla competenza in materia di diritto feudale ma anche perché originario della Sardegna settentrionale, avrebbe potuto ristabilire l’ordine nel Logudoro. L’intellettuale di Bono accettò, ritenendo che con quel ruolo avrebbe rafforzato le proprie posizioni ma anche quelle della sua parte politica incentrate sicuramente nella abolizione del feudalesimo in primis. Il viaggio a Sassari fu un vero e proprio trionfo: seguaci armati ed entusiasti si unirono con lui nel corso del viaggio, vedendolo come il liberatore dall’oppressione feudale. E giustamente. Anche perché riuscì a comporre conflitti e agitazioni, a riconciliare molti personaggi, a liberare detenuti che giacevano – scrive Vittorio Angius – “in sotterranee oscure fetentissime carceri”.

- L’Angioy a Sassari
Accolto a Sassari dal popolo festante ed entusiasta – persino i monsignori lo ricevettero nel Duomo al canto del Te Deum di ringraziamento – in breve tempo riordinò l’amministrazione della giustizia e della cosa pubblica, creò un’efficiente polizia urbana e diede dunque più sicurezza alla città, predispose lavori di pubblica utilità creando lavoro per molti disoccupati, si fece mandare da Cagliari il grano che era stato inutilmente richiesto quando più vivo era il contrasto fra le due città: per questa sua opera ottenne una vastissima popolarità. Nel frattempo i vassalli, impazienti nel sospirare la liberazione dalla schiavitù feudale (ovvero “de si bogare sa cadena da-e su tuiu” come diceva il rettore Murroni, amico e sostenitore di Angioy) e di ottenere il riscatto dei feudi, proseguirono nella stipulazione dei patti dell’anno precedente: il 17 marzo 1796 ben 40 villaggi del capo settentrionale, confederandosi, giuravano solennemente di non riconoscere più né voler dipendere dai baroni.
Angioy non poteva non essere d’accordo con loro e li riconobbe: in una lettera spedita il 9 giugno 1796 al viceré da Oristano, nella sfortunata marcia su Cagliari che tra poco intraprenderà, giustificò l’azione degli abitanti delle ville e dei paesi riconoscendo la drammaticità dell’oppressione feudale che non era possibile più contenere e gestire e assurdo e controproducente cercare di reprimere. Non faceva però i conti con la controparte: i baroni. Che tutto voleva fuorché l’abolizione dei feudi: ad iniziare dal viceré. Tanto che i suoi nemici organizzarono durante la sua stessa permanenza a Sassari una congiura, scoperta ad aprile. Si decise perciò di “impressionare gli stamenti con una dimostrazione di forza, – scrive Natale Sanna – che facesse loro comprendere come il moto antifeudale era seguito da tutta la popolazione e che era ormai inarrestabile”. Lasciò dunque Sassari e si diresse a Cagliari.
- L’Angioy e la marcia verso Cagliari, la sua fine e la fine di un sogno…
Il 2 Giugno 1796 l’Alternos si dirige verso Cagliari, accompagnato da gran seguito di dragoni, amici e miliziani: nel Logudoro si ripetono le scene di consenso entusiastico dell’anno precedente. A Semestene però ebbe una comunicazione da Bosa circa i preparativi che erano in atto per fronteggiare ogni sua mossa e a San Leonardo, “fatta sequestrare la posta diretta a Sassari, ebbe conferma delle misure che venivano prese contro di lui”, scrivono Lorenzo e Vittoria Del Piano. Difatti a Macomer popolani armati, sobillati pare da ricchi proprietari, cercarono di impedirgli il passaggio, sicché egli dovette entrare con la forza. Poiché anche Bortigali gli si mostrava ostile, si diresse verso Santu Lussurgiu e l’8 giugno giunse in vista di Oristano. Nella capitale la notizia che un esercito si avvicinava spaventò il viceré che radunò gli Stamenti. Tutti furono contro l’Angioy: anche quelli che erano stati suoi partigiani come il Pintor, il Cabras, il Sulis. Ahimè ritornati subito, da veri e propri ascari, sotto le grandi ali del potere in cambio di prebende e uffici.
 Così il generoso tentativo dell’Angioy si scontra con gli interessi di pochi: fu rimosso dalla carica di Alternos, si posero 1.500 lire di taglia sulla sua testa e da leader prestigioso e carismatico, impegnato nella lotta antifeudale, per i diritti dei popoli e, in prospettiva nella costruzione in uno stato sardo repubblicano, divenne un volgare “ricercato”. Occorre infatti dire e sostenere con chiarezza che l’Angioy aveva in testa – come risulta dal suo Memoriale – non solo la pura e semplice abolizione del feudalesimo ma una nuova prospettiva istituzionale: la trasformazione dell’antico Parlamento in Assemblea Costituente e uno stato sardo indipendente che “doveva comporsi di quattro dipartimenti (Sassari, Oristano, Cagliari e Orani) suddivisi a loro volta in cantoni ricalcanti le micro-regioni storiche dell’Isola”.
Così il generoso tentativo dell’Angioy si scontra con gli interessi di pochi: fu rimosso dalla carica di Alternos, si posero 1.500 lire di taglia sulla sua testa e da leader prestigioso e carismatico, impegnato nella lotta antifeudale, per i diritti dei popoli e, in prospettiva nella costruzione in uno stato sardo repubblicano, divenne un volgare “ricercato”. Occorre infatti dire e sostenere con chiarezza che l’Angioy aveva in testa – come risulta dal suo Memoriale – non solo la pura e semplice abolizione del feudalesimo ma una nuova prospettiva istituzionale: la trasformazione dell’antico Parlamento in Assemblea Costituente e uno stato sardo indipendente che “doveva comporsi di quattro dipartimenti (Sassari, Oristano, Cagliari e Orani) suddivisi a loro volta in cantoni ricalcanti le micro-regioni storiche dell’Isola”.
Premio Letterario Montanaru
 La Montagna Produce Desulo
La Montagna Produce Desulo
Premio Letterario Montanaru: un evento che ci accompagna da 24 anni e che premia le migliori poesie e racconti in lingua sarda. Un modo per incentivare e stimolare all’uso della nostra bellissima lingua, che niente e nessuno ci potrà mai togliere! Vi aspettiamo domani domenica 1 novembre a partire dalle h. 10 (Lucia Cossu)
 - Su Montanaru e la lingua sarda un articolo di Francesco Casula su Aladinews.
- Su Montanaru e la lingua sarda un articolo di Francesco Casula su Aladinews.
Po “sa die de sa Sardigna” 2015

 .
.
Il significato. La storia. Il programma: Sa die in Casteddu, sa die in totu sa Sardigna.
- Sul sito della Fondazione Sardinia
http://www.fondazionesardinia.eu/ita/?p=10319#more-10319
————————
La guerra dei nostri nonni. La Brigata Sassari in musica
 Sassari – L’orchestra della Scuola Media n° 5 celebra il centenario della Prima Guerra Mondiale.
Sassari – L’orchestra della Scuola Media n° 5 celebra il centenario della Prima Guerra Mondiale.
“La guerra dei nostri nonni – la Brigata Sassari in musica”
![]() di Vanni Tola
di Vanni Tola
- segue -
Tra storia e mito, il romanzo come opportunità
 La Relazione è stata elaborata per l’iniziativa “Alla ricerca della storia perduta”. La storia vera di Diego Henares de Astorga di Nicolò Migheli Hombres Y Dinero di Pietro Maurandi Le Carte del re di Pietro Picciau sono i tre romanzi che hanno animato il II° secondo appuntamento organizzato dalla Delegazione e dal FAI Giovani di Cagliari con la Presidenza regionale FAI lunedì 2 marzo 2015 alla Fondazione Banco di Sardegna via S. Salvatore da Horta, Cagliari.
La Relazione è stata elaborata per l’iniziativa “Alla ricerca della storia perduta”. La storia vera di Diego Henares de Astorga di Nicolò Migheli Hombres Y Dinero di Pietro Maurandi Le Carte del re di Pietro Picciau sono i tre romanzi che hanno animato il II° secondo appuntamento organizzato dalla Delegazione e dal FAI Giovani di Cagliari con la Presidenza regionale FAI lunedì 2 marzo 2015 alla Fondazione Banco di Sardegna via S. Salvatore da Horta, Cagliari.
di Nicolò Migheli
Nell’incontro precedente “Alla ricerca della storia perduta”, Vindice Lecis sosteneva che spesso il romanzo storico si nutre di dettagli, di particolari che a volte vengono trascurati dagli storici di professione. Nel caso del mio romanzo cinquecentesco è stato così, però solo in parte. Proprio in questi giorni si celebra il centenario della costituzione della brigata Sassari, un reparto militare composto interamente da sardi che si sacrificò sui fronti della Prima Guerra Mondiale.
L’epica della Brigata ha avuto due ragioni, la prima trasformare lo stigma lombrosiano sui sardi da “etnia delinquente” in “etnia combattente”; la seconda come catalizzatore del nostro riconoscimento in nazione, diventando una delle ragioni principali delle rivendicazioni autonomistiche. Grande storia e storia locale che si intrecciano creando mito in cui riconoscersi. Prima della Brigata, un altro reparto ha segnato l’immaginario dei sardi, il tercio de Cerdeña. Secondo la tradizione unità militare composta interamente da sardi, con quattrocento archibugieri imbarcati nell’ammiraglia Real di don Juan de Austria, avrebbe guadagnato la vittoria contro Alì- Paschà a Lepanto nel 1571 determinando l’esito dello scontro. Battaglia a cui partecipò anche Cervantes riportandone un braccio dilaniato da una proiettile turco.
L’aver contribuito ad un evento epico per le sorti della cristianità nel Mediterraneo, l’aver bloccato il pericolo ottomano, fu motivo di orgoglio per le èlite sarde; quel fatto d’arme sconfessava ai loro occhi la loro marginalità percepita, e quella della Sardegna. I fatti sono riportati da Salvador Vidal nel 1636 in Annales Sardinae, riprendendo la cronica dello spagnolo Jeronimo de Costial, il quale riferì che nell’ottobre del 1571 la flotta spagnola di rientro da Lepanto fece tappa a Cagliari , e che un corteo di soldati sardi e di popolo, portò in trionfo nella chiesa di San Domenico la bandiera del tercio, deponendola nella cappella di Nostra Signora del Rosario. Stendardo oggi conservato nella sagrestia di quella chiesa.
Peccato che non sia una bandiera con le insegne di Filippo II, croce borgognona rossa in campo giallo, bensì uno stendardo con le barre catalane. – Visto che siamo ospiti di una fondazione bancaria, faccio appello affinché il Banco di Sardegna stanzi un finanziamento per il restauro di quelle insegne, oggi sono in condizioni pietose, esposte alla luce stanno per scomparire i colori ed il tessuto si sta stramando -
Il mito del primo tercio, percorse la storia sarda, ne parlarono lo stesso Lussu ed altri. Qualche anno fa Gian Paolo Tore dopo lunghe ricerche negli archivi di Madrid e Barcellona, pubblicò con il Cnr uno studio accurato sulle vicende di quel reparto che ebbe vita brevissima: dal 1565 al 1568. La ricerca rivelò che il tercio de Cerdeña, composto esclusivamente da soldati nativi di Spagna, aveva combattuto in Corsica, Malta e Fiandre e che poi era stato sciolto per ignominia dopo il saccheggio ed incendio di Jemmingen nei Paesi Bassi, villaggio forse protestante, ma facente parte dei domini di Filippo II.
Il duca d’Alba, comandante dell’esercito imperiale, si vide costretto a punire il reparto e chi si era macchiato del delitto. Se sardi hanno combattuto a Lepanto, non potevano essere certo inquadrati in quel tercio. Vi fu un secondo tercio de Cerdeña, reclutato negli anni Trenta del Seicento dal marchese di Sedilo che operò in Fiandre, quello sì totalmente composto da sardi. L’unico contatto, oltre alla denominazione, tra il primo tercio e la nostra isola, è il suo acquartieramento nel’inverno del 1565 in Stampace. La permanenza non fu facile. I soldati spagnoli si rifiutarono di onorare i contratti di affitto delle case, pretesero sconti nell’acquisto dei viveri, spesso non pagandoli. Si ebbero scontri continui con gli stampacini che non faticarono molto a tenere alta la loro fama di essere “cucurus cotus”, teste calde incline alla rissa.
Il Cinquecento sardo non ha prodotto solo il mito del tercio, è anche fonte di uno stigma negativo diventato presto autostigma. È il noto “pocos locos y mal unidos”. Attribuito a Carlo V, in realtà forse scritto in una lettera ad un amico spagnolo dal vescovo di Cagliari Parraguez de Castellejo. Il prelato per ragioni politiche venne denunciato all’Inquisizione come protestante. Accusa da cui venne scagionato. Parraguez de Castellejo se mai scrisse quelle parole, si riferiva ai nobili di Cagliari, tutti di origine spagnola, non certo ai sardi naturals che ai suoi occhi, come a quelli di qualsiasi aristocratico del tempo, non contavano nulla. Potenza però delle parole, se ancora oggi in molti le vogliono come tratto caratteristico dell’essere sardi. In realtà noi non siamo né locos, né mal unidos, più di altri. Tutti i fenomeni di solidarietà reciproca e le iniziative comunitarie del nostro tempo lo dimostrano.
Scrivere romanzi storici è imbattersi nel mito, è far dialogare personaggi reali con quelli di finzione, con il risultato che anche chi è vissuto allora diventa personaggio da romanzo, e quello creato dallo scrittore personaggio “storico”. Entrambi protagonisti di vicende coeve. Nel caso del Cinquecento poi, la ricchezza di documentazione, gli studi fatti da storici di professione, permettono di calarsi anche nel loro pensiero; capirne la quotidianità, le relazioni, il loro porsi davanti al mondo. In fin dei conti erano moderni, non molto lontani da come siamo noi. Il romanzo permette di sfatare il luogo comune della marginalità della Sardegna allora facente parte dell’impero più grande del mondo, dove non tramontava mai il sole. Il racconto permette di capire che si era centrali, terra di confine nella faglia tra cristianesimo ed islam. Tema tragicamente d’attualità se, proprio oggi, Domenico Quirico sulla Stampa scrive dell’Isis intitolando l’articolo sul ritorno della Storia nel Mediterraneo.
La Sardegna di quegli anni era dentro il pensiero europeo, anche nella nostra terra vi era un piccolo movimento protestante, filiazione degli Alumbrados valenziani, bruciato dall’Inquisizione di Diego Calvo. Allo stesso tempo la tragica vicenda di Sigismondo Arquer rivela il suo legame con i circoli luterani di Basilea. Il filo rosso delle vicende di Diego Henares de Astorga è racconto di allora che serve all’oggi. Serve a capire ad esempio la multiculturalità, lo scontro tra classi, le forme del potere e del clientelismo. Temi del Cinquecento e temi di oggi. Se le vicende sono inserite in un romanzo d’avventura, un feuilleton scritto oggi, vi è anche la presunzione dell’autore che ricerche di carattere specialistico diventino accessibili anche al grande pubblico. In fin dei conti un tentativo di costruire un’epica per una terra che se n’è privata, una piccola pietra nell’edificio di un immaginario collettivo.
Per fare ciò occorre anche demitizzare, dando ai fatti lettura positiva senza indulgere nella vanagloria, evitando comunque di accarezzare quei sentimenti di impotenza e di risentimento che sono da sempre così popolari tra di noi. Se il romanzo può essere utile, ben venga. È chiaro che sono di parte, ma è quel che penso indipendentemente dall’essere anche l’autore di La storia vera di Diego Henares de Astorga.
D’altronde il tempo degli intellettuali organici non è ancora tramontato sul Mar di Sardegna. Per fortuna.
————————————–

* L’articolo di Nicolò Migheli viene pubblicato anche sui siti di FondazioneSardinia, Vitobiolchini, Tramasdeamistade, Madrigopolis, Sportello Formaparis, Tottusinpari e sui blog EnricoLobina e RobertoSerra, SardegnaSoprattutto.
——————————————–
Il BILINGUISMO di GRAZIA DELEDDA

di Francesco Casula
Specie in occasione della presentazione della mia Letteratura e civiltà della Sardegna (2 volumi, Edizioni Grafica del Parteolla, 2011-2013) spesso mi si chiede :”come mai Deledda per i suoi racconti e romanzi non ha usato la lingua sarda, che pur conosceva bene”?
Per comprendere bene la lingua che utilizza la Deledda nei suoi scritti occorre partire da questa premessa: la lingua sarda non è un dialetto italiano – come purtroppo ancora molti affermano e pensano, in genere per ignoranza – ma una vera e propria lingua. Noi sardi dunque, siamo bilingui perché parliamo contemporaneamente il Sardo e l’Italiano. Anche la Deledda era bilingue. Era una parlante sarda e i suoi testi in Italiano rispecchiano, quale più quale meno le strutture linguistiche del sardo, non tanto o non solo in senso tecnico quanto nei contenuti valoriali, nei giudizi, nei significati esistenziali, nelle struttura di senso magari inespresse ma presenti nel corso della narrazione. Voglio sostenere che la Deledda struttura il suo vissuto personale, la fenomenologia delle sue sensazioni e del profondo in lingua sarda ma lo riversa nella lingua italiana che risulta così semplice lingua strumentale. In tal modo opera un transfert del suo universo interiore nuorese, dell’inconscio, della fantasmatica.
Poteva non operare tale transfert e scrivere in Sardo? Certamente. Se non lo ha fatto è stato perché non vi era in quel momento storico (siamo a fine Ottocento-inizio Novecento) la cultura, la sensibilità, l’abitudine da parte degli scrittori, specie di romanzi, di utilizzare il sardo. Prima con i Savoia e poi con lo Stato unitario e ancor più con il fascismo, la lingua sarda viene infatti proibita negata criminalizzata.
Dopo il passaggio della Sardegna dalla Spagna al Piemonte (per un baratto di guerra) i Savoia (che parlano il francese!) introducono (e impongono) formalmente l’italiano al posto dello spagnolo, proibendo il sardo. Scriverà Carlo Baudi di Vesme, uno spocchioso storico di Cuneo, amico di Carlo Alberto (in Considerazioni politiche ed economiche sulla Sardegna, Torino 1848) che “In materia d’incivilimento della Sardegna e d’instruzione pubblica, innovazione importantissima si è quella di proibire severamente in ogni atto pubblico civile l’uso dei dialetti sardi, prescrivendo l’esclusivo impiego della lingua italiana”. E ancora ripete e insiste: ”E’ necessario inoltre scemare l’uso del dialetto sardo e introdurre quello della lingua italiana per incivilire alquanto quella nazione…”.
Insieme alla lingua verrà proibita e negata la storia sarda, perché – risposero le autorità governative piemontesi a Pietro Martini che voleva introdurre fra gli studenti dell’Isola l’insegnamento della Storia – “nelle scuole dello Stato debbasi insegnare la storia antica e moderna, non di una provincia ma di tutta la nazione e specialmente d’Italia”.
Tale concezione, da ricondurre a un progetto di omogeneizzazione culturale, – che per l’Isola significherà dessardizzazione – la ritroviamo pari pari nelle Leggi sull’istruzione elementare obbligatoria nell’Italia pre e post unitaria con i programmi scolastici, impostati secondo una logica rigidamente statalista e italocentrica, finalizzati a creare una coscienza “unitaria“, uno spirito “nazionale“, capace di superare i limiti – così si pensava – di una realtà politico-sociale estremamente composita sul piano storico, linguistico e culturale. Questo paradigma fu enfatizzato nel periodo fascista, con l’operazione della “nazionalizzazione-italianizzazione” dell’intera storia italiana. Non c’è quindi da meravigliarsi che, una volta negata e proibita, gli scrittori – anche per avere una maggiore visibilità e diffusione delle loro opere – scrivano in italiano: la Deledda come tanti altri. Ma – dicevo – Deledda rimane bilingue: pensa in sardo e traduce, spesso meccanicamente in italiano, soprattutto “nel parlare dialogico” – lo sostiene il linguista Massimo Pittau e io sono d’accordo – come in: ”Venuto sei? – che traduce il sardo: Bennidu ses?; o “Trovato fatto l’hai? – Accatadu fattu l’as?; o ancora “A Luigi visto l’hai? – A Luisu bidu l’as?; o “Quando è così, andiamo – Cando est gai, andamus.
Vi sono poi innumerevoli vocaboli tipicamente sardi e solamente sardi che Deledda inserisce nelle sue opere quando attengono all’ambiente sardo: pensiamo a tanca (terreno di campagna chiuso da un recinto fatto in genere di sassi), socronza, usatissima in Elias Portolu (consuocera), corbula (cesta), bertula (bisaccia), tasca (tascapane), leppa (coltello a serramanico), cumbessias o muristenes (stanzette tipiche delle chiese di campagna un tempo utilizzate per chi dormiva là per le novene della Madonna o di Santi), domos de janas (tombe rupestri e letteralmente “case delle fate”).
O addirittura intere frasi in sardo come: frate meu (fratello mio), Santu Franziscu bellu (San Francesco bello), su bellu mannu (il bellissimo, letteralmente il bello grande), su cusinu mizadu (il borghese con calze), a ti paret? (ti sembra?), corfu ‘e mazza a conca (colpo di mazza in testa), ancu non ch’essas prus (che tu non ne esca più: è un’imprecazione).
Qualche volta Deledda ricorre a frasi italiane storpiate in sardo o frasi sarde storpiate in italiano: Come ho ammaccato questo cristiano così ammaccherò te (…) o Avete compriso?”.
Occorre però chiarire che i sardismi linguistici della Deledda, non solo lessicali ma anche sintattici, non derivano dalla sua incapacità di utilizzare correttamente la lingua italiana. Scrive a questo proposito la critica sarda Paola Pittalis: ”L’uso dei sardismi linguistici da parte della Deledda anche nelle opere della maturità – è il caso di Elias Portolu – è consapevole e voluto. Rappresenta anzi una chiara e decisa scelta di linguaggio letterario, di canone stilistico e fa parte del suo essere bilingue”. E aggiunge: ”La sintassi prevalentemente paratattica, non equivale alla mancanza di stile: deriva dal trasferimento nella scrittura di modalità anche linguistiche di costruzione del racconto orale… ed è il contributo modernizzante di Deledda allo snellimento della lingua letteraria italiana costruita sul modello della frase manzoniana”.



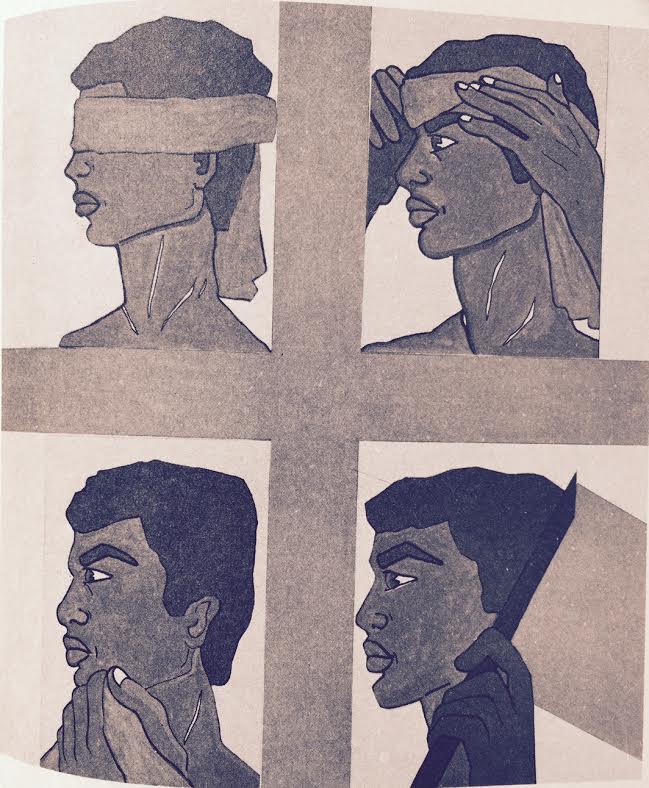




 AService Studio
AService Studio